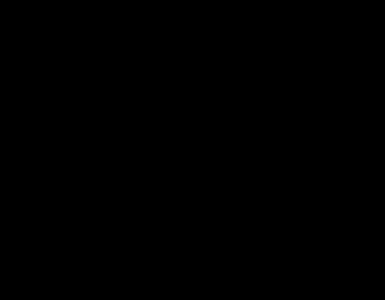La conoscenza scientifica, le sue specifiche e i suoi metodi sono brevi. Cosa faremo con il materiale ricevuto? Metodi di ricerca teorica
In generale, possiamo parlare della molteplicità delle forme di conoscenza: scientifica, artistica, religiosa, quotidiana, mistica, ecc. La scienza differisce dalle altre sfere dell'attività spirituale umana in quanto la componente cognitiva in essa è dominante. Si distinguono le seguenti caratteristiche della conoscenza scientifica:
- razionalità dell'attività cognitiva scientifica. Tradizionalmente, la razionalità è intesa come un appello primario agli argomenti della ragione e della ragione e la massima esclusione di emozioni, passioni e opinioni personali quando si prendono decisioni. La razionalità è solitamente associata al rispetto di determinate regole. Sebbene la razionalità classica sia solitamente opposta all’empirismo e al sensazionalismo, la razionalità scientifica include l’esperienza sensoriale e l’esperimento. Tuttavia, a loro volta, sono soggetti agli argomenti e alle leggi della logica scientifica.
- evidenziare le componenti teoriche ed empiriche della conoscenza scientifica
- attività concettuale
- prova
- consistenza
Ciò consente alla scienza di svolgere funzioni cognitive di base:
- descrizione
- spiegazione
- previsione dei fenomeni (sulla base di modelli identificati)
Si distinguono le seguenti fasi di sviluppo delle idee sulla razionalità scientifica:
- classica S → O (fino alla metà del XIX secolo)
- non classico S ↔ O (fino alla metà del XX secolo)
- S post-non classico →↔ O (ad oggi)
La razionalità classica è associata al modello deduttivo (Euclide, Aristotele, Cartesio) e al modello induttivo (F. Bacon). Le sue capacità furono esaurite entro la metà del diciannovesimo secolo.
L'emergere di idee non classiche sulla razionalità fu facilitato sia dallo sviluppo della filosofia irrazionale (nella seconda metà del XIX secolo) sia dallo sviluppo del positivismo.
La fase post-non classica è associata al fatto che i problemi della conoscenza scientifica hanno acquisito una nuova prospettiva nel nuovo paradigma della razionalità, in connessione con lo sviluppo della civiltà scientifica e tecnologica e l'identificazione delle conseguenze disumane di tale sviluppo . Ciò ha dato origine a un'attiva opposizione al culto della razionalità scientifica e si è manifestato in una serie di approcci delle scuole del moderno irrazionalismo. Nell'irrazionalismo, i principi fondamentali dell'epistemologia del razionalismo sono criticati per la loro natura intrinsecamente astratta e disumana. Nel razionalismo, l'oggetto della conoscenza è estraneo alla coscienza del ricercatore. l'attività mentale del soggetto è percepita solo come una tecnica per ottenere un risultato specifico. Inoltre, al soggetto conoscente non importa quale applicazione troverà questo risultato. La ricerca della verità oggettiva nel razionalismo ha una connotazione di antisoggettività, antiumanità e un atteggiamento senz'anima nei confronti della realtà. Al contrario, i rappresentanti dell'irrazionalismo si oppongono alla rottura dell'azione cognitiva nelle relazioni soggetto-oggetto. Ad esempio, nel concetto personalistico di cognizione (N.A. Berdyaev), la cognizione è considerata come un coinvolgimento, come un movimento onnicomprensivo che unisce il soggetto con l'intero mondo circostante. La teoria della conoscenza include i fattori emotivo-sensuali ed emotivo-volitivi dell'amore e della fede come principali mezzi cognitivi. I personalisti sottolineano gli aspetti personali, valoriali, emotivi e psicologici della cognizione, la presenza in essa di momenti di scelta volitiva, soddisfazione, ecc.
Poiché il positivismo gioca un ruolo speciale nello sviluppo della metodologia della conoscenza scientifica, considereremo questo movimento filosofico in modo più dettagliato. Il positivismo emerge negli anni 30-40. XIX secolo in Francia. Fondatore - O. Kont. Il positivismo (dal latino positivus - positivo) è da lui considerato lo stadio più alto nello sviluppo del pensiero, muovendosi lungo il percorso dal mitologico al metafisico e raggiungendo il livello più alto - nel positivismo. Il positivismo richiede di abbandonare le astrazioni metafisiche e di rivolgersi allo studio della conoscenza positiva, reale, accurata e concreta. Il positivismo nasce dal riconoscimento di un dato, cioè della realtà positiva, ciò che può essere verificato con mezzi empirici o logico-matematici. Questo controllo (verifica) deve avere carattere generalmente valido. Il positivismo affermava seriamente di essere una “filosofia della scienza”. I sistemi positivisti di Comte, Spencer e Mill hanno creato una certa immagine scientifica del mondo, basata sul principio dell'interpretazione meccanica della realtà.
Ma lo sviluppo della fisica quantistica a cavallo tra il XIX e il XX secolo. mise in discussione la metodologia meccanicistica basata sui principi della fisica newtoniana e distrusse la precedente immagine del mondo. Anche la metodologia empirica della conoscenza scientifica è stata messa in discussione, poiché la ricerca ha rivelato la dipendenza dei risultati degli esperimenti scientifici dagli strumenti e dai sensi umani. L'intenso sviluppo della ricerca psicologica ha messo all'ordine del giorno la questione della connessione di questa scienza con altre scienze che studiano l'uomo e il mondo che lo circonda. Una nuova immagine del mondo cominciò a prendere forma. Quando, ad esempio, R. Feynman sviluppò idee sulle interazioni delle cariche senza "intermediari sul campo", non fu imbarazzato dal fatto che nella teoria creata era necessario introdurre, insieme a quelli ritardati, potenziali avanzati, che in l'immagine fisica del mondo corrispondeva all'emergere di idee sull'influenza delle interazioni del presente non solo per il futuro, ma anche per il passato. "A questo punto", scrisse R. Feynman, "ero già abbastanza fisico da non dire: "Bene, no, questo non può essere". Infatti oggi, dopo Einstein e Bohr, tutti i fisici sanno che a volte un’idea che a prima vista sembra del tutto paradossale può rivelarsi corretta dopo averla compresa nei minimi dettagli e fino alla fine e aver trovato la sua connessione con l’esperimento. Ma “essere un fisico” del XX secolo. - qualcosa di diverso dall'“essere un fisico” del XIX secolo.
A seguito dei cambiamenti in corso, il positivismo sta attraversando una grave crisi, che coincide con la crisi della razionalità classica in generale, contribuendo così alla transizione verso idee non classiche e post-non classiche sulla razionalità.
Sorge la seconda fase nello sviluppo del positivismo: l'empiriocritica (critica dell'esperienza) E. Mach, R. Avenarius, che presto diventa troppo grande
nella terza fase, in un movimento serio: il neopositivismo, associato all'analisi logica del linguaggio (B. Russell, L. Wittgenstein). Anche in questo caso viene applicato il principio della verifica (verifica della verità), ma ora in relazione ad affermazioni e generalizzazioni scientifiche, cioè alle espressioni linguistiche. Questa fase ha dato un grande contributo allo studio filosofico del linguaggio.
La quarta fase del positivismo, il neopositivismo - "razionalismo critico" è associato ai nomi di K. Popper, T. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend. È caratterizzato dal fatto che l'oggetto di studio era la scienza come sistema di sviluppo integrale. Gli autori hanno proposto vari modelli per lo sviluppo della scienza, considereremo i principali nella prossima domanda.
2. Rivoluzioni scientifiche e cambiamenti nelle tipologie di razionalità
Considerando i modelli di sviluppo della scienza come un sistema integrale, il fondatore del razionalismo critico K. Popper è giunto alla conclusione che le leggi della scienza non sono espresse da giudizi analitici e non sono riducibili a osservazioni, cioè non sono verificabili. La scienza, quindi, non ha bisogno del principio di verifica (poiché c'è sempre la tentazione di tenere conto dei fatti che confermano una teoria e di non tenere conto dei fatti che la confutano), ma del principio di falsificazione, cioè non di conferma della verità, ma confutazione della verità.
Il principio di falsificazione non è un metodo di verifica empirica, ma un certo atteggiamento della scienza verso un'analisi critica del contenuto della conoscenza scientifica, verso la costante necessità di una revisione critica di tutte le sue conquiste. Popper sostiene che la scienza è un sistema in costante cambiamento in cui è costantemente in atto un processo di ristrutturazione della teoria, e questo processo deve essere accelerato
Questa idea è stata ulteriormente sviluppata da T. Kuhn, il quale ha sottolineato che lo sviluppo della scienza è portato avanti da una comunità di scienziati professionisti che agiscono secondo regole non scritte che regolano le loro relazioni.
Il principale principio unificante della comunità degli scienziati è un unico stile di pensiero, il riconoscimento da parte di questa comunità di alcune teorie e metodi di ricerca fondamentali. Kuhn ha definito paradigma queste disposizioni che uniscono le comunità di scienziati. “Per paradigma intendo le conquiste scientifiche universalmente riconosciute che, nel tempo, forniscono alla comunità scientifica un modello per porre problemi e risolverli”. Ogni teoria scientifica viene creata nel quadro di uno o di un altro paradigma scientifico.
Kuhn presenta lo sviluppo della scienza come un processo rivoluzionario spasmodico, la cui essenza si esprime in un cambiamento di paradigmi.
Il periodo di “scienza normale” con un certo paradigma viene sostituito da un periodo di rivoluzione scientifica, durante il quale viene stabilito un nuovo paradigma scientifico e la scienza si trova nuovamente per qualche tempo in uno stato di “scienza normale”. Il passaggio dal vecchio paradigma al nuovo non può basarsi su argomentazioni puramente razionali, sebbene questo elemento sia significativo. Richiede anche fattori volitivi: convinzione e fede. È necessario credere che il nuovo paradigma riuscirà a risolvere una gamma di problemi più ampia rispetto a quella vecchia.
La posizione più radicale nel razionalismo critico è occupata dal filosofo americano P. Feyerabend. Basandosi sul presupposto che una vecchia teoria viene prima o poi confutata da una nuova, avanzò il principio metodologico della proliferazione (riproduzione) delle teorie, che a suo avviso dovrebbe promuovere la critica e accelerare lo sviluppo della scienza: le nuove teorie non dovrebbero essere confrontati con quelli vecchi e ciascuno di essi dovrebbe stabilire i propri standard. Afferma inoltre il principio dell'anarchismo metodologico, secondo il quale lo sviluppo della scienza è irrazionale e vince la teoria la cui attività propagandistica è maggiore.
1. Integrativo La funzione (sintetica) della filosofia è una generalizzazione sistemica e olistica e una sintesi (unificazione) di varie forme di conoscenza, pratica, cultura - l'intera esperienza dell'umanità nel suo insieme. La generalizzazione filosofica non è una semplice unificazione meccanica ed eclettica di manifestazioni particolari di questa esperienza, ma una conoscenza qualitativamente nuova, generale e universale. La filosofia, così come tutta la scienza moderna, è caratterizzata da processi sintetici e integrativi: intradisciplinari, interdisciplinari, tra scienze naturali e scienze sociali e umanistiche, tra filosofia e scienza, tra forme di coscienza sociale, ecc. 2. Critico la funzione della filosofia, che in questa funzione si concentra su tutte le sfere dell'attività umana - non solo sulla conoscenza, ma anche sulla pratica, sulla società, sulle relazioni sociali delle persone. Critica- un metodo di attività spirituale, il cui compito principale è fornire una valutazione olistica di un fenomeno, identificarne le contraddizioni, i punti di forza e di debolezza. Esistono due forme principali di critica: a) negativa, distruttiva, “negazione totale”, rifiutando tutto e tutti; b) costruttivo, creativo, non distruggendo tutto “fino alle fondamenta”, ma preservando tutto ciò che è positivo del vecchio nel nuovo, offrendo modi specifici per risolvere i problemi, metodi reali per risolvere le contraddizioni, modi efficaci per superare le idee sbagliate. In filosofia esistono entrambe le forme di critica, ma la più produttiva è la critica costruttiva. Criticando le idee del mondo esistente, il filosofo critica, volenti o nolenti, questo mondo stesso. La mancanza di un approccio critico si traduce inevitabilmente in un'apologetica difesa parziale, che elogia qualcosa invece di un'analisi obiettiva. 3. La filosofia sviluppa alcuni “modelli” della realtà, attraverso il “prisma” del quale lo scienziato guarda il suo oggetto di ricerca ( funzione ontologica). La filosofia fornisce l'immagine più generale del mondo nelle sue caratteristiche oggettive universali, rappresenta la realtà materiale nell'unità di tutti i suoi attributi, forme di movimento e leggi fondamentali. Questo sistema olistico di idee sulle proprietà generali e sui modelli del mondo reale si forma come risultato della generalizzazione e sintesi di concetti e principi scientifici particolari e generali di base. La filosofia dà una visione generale del mondo non solo com'era prima (passato) e com'è adesso (presente). La filosofia, svolgendo il suo lavoro cognitivo, offre sempre all'umanità alcune possibili opzioni per il suo mondo della vita. E in questo senso ha funzioni predittive. Pertanto, lo scopo più importante della filosofia nella cultura è comprendere non solo cosa è il mondo umano esistente nelle sue strutture e fondamenti profondi, ma cosa può e dovrebbe essere. 4. La filosofia “dota” il ricercatore della conoscenza delle leggi generali del processo cognitivo stesso, della dottrina della verità, dei modi e delle forme della sua comprensione ( epistemologico funzione). La filosofia (soprattutto nella sua versione razionalistica) fornisce allo scienziato le prime linee guida epistemologiche sull'essenza della relazione cognitiva, sulle sue forme, livelli, prerequisiti iniziali e fondamenti universali, sulle condizioni della sua affidabilità e verità, sul contesto socio-storico della conoscenza, ecc. Sebbene tutte le scienze private svolgano il processo di conoscenza del mondo, nessuna di esse ha come oggetto immediato lo studio delle leggi, delle forme e dei principi della conoscenza in generale. La filosofia (più precisamente l'epistemologia, come uno dei suoi rami principali) si occupa specificamente di questo, basandosi su dati di altre scienze che analizzano singoli aspetti del processo cognitivo (psicologia, sociologia, scienza, ecc.). Inoltre, qualsiasi conoscenza del mondo, compresa la conoscenza scientifica, in ogni epoca storica viene effettuata secondo una certa "griglia di categorie logiche". Il passaggio della scienza all'analisi di nuovi oggetti porta al passaggio a una nuova griglia categoriale. Se una cultura non ha sviluppato un sistema categorico corrispondente a un nuovo tipo di oggetti, allora questi ultimi verranno riprodotti attraverso un sistema di categorie inadeguato, che non consente di rivelarne le caratteristiche essenziali. Sviluppando le sue categorie, la filosofia prepara così per le scienze naturali e per le scienze sociali una sorta di programma preliminare per il loro futuro apparato concettuale. L'uso delle categorie sviluppate in filosofia nella ricerca scientifica concreta porta ad un nuovo arricchimento delle categorie e allo sviluppo del loro contenuto. Tuttavia, come osserva il moderno filosofo americano R. Rorty, “dobbiamo liberarci dall'idea che la filosofia (con tutta la sua “griglia di categorie”. - V.K.) possa spiegare ciò che la scienza lascia inspiegato”*. 5. La filosofia dà alla scienza i principi metodologici più generali, formulati sulla base di alcune categorie. Questi principi in realtà funzionano nella scienza sotto forma di regolamenti universali, norme universali, requisiti che il soggetto della conoscenza deve attuare nella sua ricerca( metodologico funzione). Studiando le leggi più generali dell'esistenza e della conoscenza, la filosofia funge da metodo ultimo e più generale di ricerca scientifica. Questo metodo, tuttavia, non può sostituire i metodi speciali delle scienze private; non è una chiave universale che schiude tutti i segreti dell’universo; non determina a priori né i risultati specifici delle scienze private né i loro metodi unici. Un programma filosofico e metodologico non dovrebbe essere uno schema rigido, un “modello”, uno stereotipo secondo il quale “i fatti vengono tagliati e rimodellati”, ma solo una “guida generale” per la ricerca. I principi filosofici non sono un “insieme di norme” meccanico, un “elenco di regole” e una semplice “imposizione” esterna di una griglia di definizioni e principi categorici universali su un piano specificamente scientifico. Materiale. Totalità filosofico i principi- un sistema flessibile, mobile, dinamico e aperto, non può “fornire in modo affidabile” mosse di pensiero di ricerca pre-misurate, pienamente garantite e ovviamente “destinate al successo”. Al giorno d'oggi, un numero crescente di specialisti comincia a rendersi conto che nelle condizioni dell'esplosione informativa che sta vivendo la nostra civiltà, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai metodi di orientamento nel vasto materiale fattuale della scienza, ai metodi della sua ricerca e applicazione. 6. Dalla filosofia, lo scienziato riceve determinati atteggiamenti ideologici, valoriali e linee guida sul significato della vita, che - a volte in misura significativa (soprattutto nelle discipline umanistiche) - influenzano il processo della ricerca scientifica e i suoi risultati finali ( funzione assiologica).Il pensiero filosofico rivela non solo universali intellettuali (razionali), ma anche morali-emotivi, estetici e altri universali umani, sempre legati a specifici tipi storici di culture, e allo stesso tempo appartenenti all'umanità nel suo insieme (valori universali). 7. La filosofia influenza nella massima misura la conoscenza scientifica nella costruzione delle teorie (soprattutto quelle fondamentali). Questo selettivo (qualificante) funzione Si manifesta più attivamente durante i periodi di “brusco cambiamento” nei concetti e nei principi durante le rivoluzioni scientifiche. Ovviamente, questa influenza può essere sia positiva che negativa, a seconda del tipo di filosofia - "buona" o "cattiva" - da cui è guidato lo scienziato e del tipo di principi filosofici che utilizza. A questo proposito, è nota l’affermazione di W. Heisenberg secondo cui “la cattiva filosofia distrugge gradualmente la buona fisica”. UN. Einstein credeva giustamente che se la filosofia è intesa come ricerca della conoscenza nella sua forma più completa e ampia, allora la filosofia è senza dubbio la “madre di ogni conoscenza scientifica”. Più specificamente, l'influenza della filosofia sul processo di ricerca scientifica speciale e di costruzione della teoria risiede, in particolare, nel fatto che i suoi principi, durante il passaggio dalla ricerca speculativa a quella teorica fondamentale, svolgono una funzione selettiva unica. Quest'ultimo consiste in in particolare, nel fatto che delle tante combinazioni speculative, il ricercatore mette in atto solo quelle coerenti con la sua visione del mondo. Ma non solo con lui, ma anche con gli orientamenti filosofici e metodologici dello scienziato. La storia della scienza ne offre numerosi esempi. I principi filosofici “funzionano” come selettori, ovviamente, solo quando sorge il problema della scelta e c'è qualcosa da cui scegliere (alcuni costrutti speculativi, ipotesi, teorie, diversi approcci alla risoluzione dei problemi, ecc.). Se ci sono molte opzioni per risolvere un particolare problema scientifico e sorge la necessità di sceglierne una, allora “partecipano” dati sperimentali, principi teorici precedenti e coesistenti, “considerazioni filosofiche”, ecc.* 8. La filosofia ha un'influenza significativa sullo sviluppo della conoscenza speculativo -predittivo funzione. Riguarda Queste, in particolare, sono le idee dell'atomismo antico, che divenne un fatto scientifico naturale solo nei secoli XVII-XVIII. Questo è ciò che si sviluppa in filosofia Leibniz apparato categoriale che esprime alcune caratteristiche generali dei sistemi autoregolanti. Tale è l'apparato dialettico hegeliano, che "anticipava" le caratteristiche essenziali dei sistemi complessi di autosviluppo - comprese le idee di sinergetica, per non parlare della meccanica quantistica (complementarità, attività del soggetto, ecc.). Facendo riferimento a questa circostanza, M. Born ha sottolineato che “la filosofia prevedeva molto di ciò a cui pensa la fisica”. Ecco perché è molto utile studiare la filosofia (nelle sue forme e direzioni più diverse) da parte di rappresentanti di scienze speciali, come hanno fatto i grandi creatori della scienza. 9. I principi filosofici e metodologici – nella loro unità – trovano realizzazione in numerosi casi funzione ausiliario, derivativamente L'influenza dei principi filosofici sul processo di ricerca scientifica viene sempre effettuata non direttamente e direttamente, ma in modo indiretto e complesso - attraverso metodi, forme e concetti di livelli metodologici “inferiori”. Il metodo filosofico non è un “passepartout universale”; da esso è impossibile ottenere direttamente risposte a certi problemi di scienze particolari attraverso un semplice sviluppo logico di verità generali. Non può essere un "algoritmo di scoperta", ma fornisce allo scienziato solo l'orientamento più generale per la ricerca, aiuta a scegliere il percorso più breve verso la verità ed evita linee di pensiero errate. Metodi filosofici non sempre si fanno sentire esplicitamente durante il processo di ricerca; possono essere presi in considerazione e applicati sia spontaneamente che consapevolmente. Ma in ogni scienza ci sono elementi di significato universale (ad esempio leggi, categorie, concetti, principi, ecc.), che rendono ogni scienza “logica applicata”. In ognuno di essi “regna la filosofia”, perché l'universale (l'essenza, la legge) è ovunque (anche se si manifesta sempre in modo specifico). I migliori risultati si ottengono quando la filosofia è “buona” e viene applicata nella ricerca scientifica in modo abbastanza consapevole. Va detto che lo sviluppo diffuso nella scienza moderna metodologico intrascientifico riflessi non “cancella” i metodi filosofici, non li elimina dalla scienza. Questi metodi sono sempre presenti, in un modo o nell'altro, in quest'ultimo, qualunque sia il grado di maturità raggiunto dai suoi stessi mezzi metodologici. Metodi filosofici, principi, categorie “permeano” la scienza in ogni fase del suo sviluppo. L'implementazione dei principi filosofici nella conoscenza scientifica significa allo stesso tempo il loro ripensamento, approfondimento e sviluppo. Pertanto, il modo di attuare la funzione metodologica della filosofia non è solo un modo per risolvere i problemi fondamentali della scienza, ma anche un modo per sviluppare la filosofia stessa, tutti i suoi principi metodologici. |
SULLA DIGNITÀ DELLA FILOSOFIA
Secondo Kant, la dignità della filosofia è determinata dal suo “concetto mondiale”, in quanto scienza sugli obiettivi ultimi della ragione umana. Nel contesto di quanto sopra, è la conoscenza degli scopi ultimi della nostra ragione da parte della stessa mente umana che determina il “valore assoluto” della filosofia. Di conseguenza è la filosofia, in quanto scienza dotata di valore intrinseco assoluto, che può fungere da sorta di “qualificazione” per altri tipi di conoscenza. Quest’ultima, a sua volta, detterà, e nella filosofia sistemica in un modo o nell’altro dettata, l’organizzazione tridimensionale della filosofia come scienza “censuratrice”: la conoscenza, la sua unità sistematica, l’adeguatezza di questa unità in relazione agli obiettivi finali. L'organizzazione determinata della struttura della filosofia darà origine anche a problemi propri, puramente interni, che in termini generali possono essere definiti come la discrepanza tra la conoscenza, presa sistematicamente, e gli obiettivi finali.
Va notato che gli obiettivi, a seconda del livello di sviluppo della mente e della sua cultura, possono agire come “superiori” e “ultimi” e solo in senso strettamente oggettivo. In questo caso parleremo degli obiettivi che formano la filosofia della coscienza ordinaria e, di conseguenza, della logica ordinaria delle azioni. Il valore interno di questi obiettivi e la filosofia che li esprime può essere caratterizzato come un unico valore soggettivo, che può acquisire i tratti di un valore “assoluto” solo per la coscienza concreta che lo professa.
Un altro tipo di obiettivi soggettivi possono essere obiettivi soggettivi più elevati. Di conseguenza, qui parleremo degli obiettivi finali e più alti della personalità e dell'individualità, che definiscono il campo problematico dell'etica e dell'estetica. Gli obiettivi soggettivi più alti, in linea di principio, dovrebbero essere considerati come obiettivi associati agli obiettivi ultimi della filosofia mondiale, poiché quest'ultima, secondo le opinioni di Kant, è anche una scienza pratica, una scienza sui principi dell'uso della ragione, o la “massima più alta” dell’uso di quest’ultimo.
La ricerca dell'unità sistematica per una conoscenza rinnovata e la ricerca della conformità con obiettivi più elevati possono essere considerate componenti dinamiche della filosofia. La conoscenza degli obiettivi finali è la sua costante interna. Pertanto, l’ignoranza degli obiettivi più elevati è una situazione che priva la filosofia mondiale del suo fondamento “assoluto” e della sua dignità mondiale. Inoltre, in questa situazione, l'organizzazione della struttura interna della filosofia come valori e disciplina sistematizzante crolla.
Cosa significa che la mente non si sforza di conoscere i suoi obiettivi ultimi?
La conoscenza da parte della mente umana degli obiettivi più alti e finali, secondo Kant, è la sua libertà. Di conseguenza, l'assenza del desiderio della nostra mente di conoscere i suoi obiettivi finali non è altro che la morte della libertà della mente e, di conseguenza, la morte della filosofia in quanto tale.
Ma Kant non parla solo della libertà della ragione, ma anche del suo libero utilizzo. Il libero uso della ragione è il suo uso non come analogo dell'istinto nell'ambito della certezza naturale, ma nel campo della libertà come principio autonomo. Di conseguenza, il libero uso della ragione è anche la determinazione da parte di quest'ultima della volontà di “azione” per creare l'“oggetto” del fine finale. Pertanto, la conoscenza degli scopi ultimi dovrebbe essere intesa non solo come una libera determinazione, ma sempre anche come una determinazione della volontà di crearli. E quindi dobbiamo parlare sia della più alta certezza qualitativa del pensiero, sia della più alta certezza “qualitativa” della volontà.
La conoscenza dei fini ultimi risulta quindi, in linea di principio, una posizione nel soprasensibile. Di conseguenza, la filosofia che definisce questi obiettivi deve necessariamente essere pensata come metafisica. Ma la metafisica, come definita da Kant in relazione alla nostra mente, è il livello della cultura più alta dell'organizzazione di quest'ultima. Di conseguenza, è la metafisica che corrisponderà allo status della più alta certezza qualitativa del pensiero. Inoltre, poiché nell’ambito delle disposizioni di cui sopra pensiamo allo stesso tempo con un orientamento volitivo, la metafisica stessa appare come una “disciplina” anche pratica. Inoltre, sulla base dei dati iniziali, la metafisica come disciplina esclusivamente teorica è generalmente impossibile.
Se in termini di soggetto riflessivo che determina gli obiettivi finali è l'io del filosofo, allora in termini di considerazione metafisica questo soggetto, in teoria, dovrebbe essere la personalità come persona intelligibile e soggetto della libertà pratica. Quindi, il fatto stesso dell'impegno della mente per la conoscenza di obiettivi più elevati è una manifestazione di orientamento volitivo e la definizione di questi obiettivi, la loro visione è un'azione intelligibile.
Inoltre, se accettiamo che la conoscenza dei fini ultimi è sempre anche un'azione intelligibile, allora il ragionamento metafisico non ragionerà su costanti o “realtà” “metafisiche”, ma sul “divenire” soprasensibile. Oppure, il discorso metafisico è riflessione, che è preceduta da una certa visione di ciò che non è dato; la chiarezza della contemplazione dell’“ultraterreno” aumenta con il progresso della riflessione. Di conseguenza, una diminuzione del grado di chiarezza di ciò che viene percepito indicherà che il corso del ragionamento è distruttivo. Pertanto, gli scopi ultimi della mente umana possono essere pensati anche come un soprasensibile eternamente determinato, ma indefinito, che ha solo la mente creativa come realtà “assoluta” e sfera di libertà.
Da quanto sopra possiamo concludere che la metafisica incontrerà le contraddizioni più profonde e, di conseguenza, i problemi interni più profondi, non dal lato della conoscenza del mondo fenomenico o fisico, ma dal lato della “conoscenza” del mondo soprasensibile. , a meno che, ovviamente, non si assuma che ciò possa verificarsi.
La filosofia mondiale incontra idee che pretendono di essere caratterizzate come conoscenza del soprasensibile sotto forma di esperienza religiosa e pratiche esoteriche. Entrambe le idee forniscono informazioni sulle specificità del soprasensibile, definite in un modo o nell'altro. Ma la specificità del soprasensibile, presa in termini di considerazione filosofica, è l'area della metafisica immanente, con tutta l'"incomprensibilità", e nel linguaggio della filosofia - la falsa trascendenza del suo contenuto. In questa situazione, la metafisica dei fini ultimi non deve solo comprendere i “dati” del soprasensibile, ma anche collegare una certa organizzazione di “altri mondi” con la possibilità di fini più alti della ragione. Tuttavia, sia la filosofia religiosa che le visioni esoteriche toccano da parte loro le stesse polemiche e, in un modo o nell'altro, pretendono anche di conoscere gli obiettivi finali. Di conseguenza, entrambe queste “discipline” metteranno in discussione le pretese della filosofia sia riguardo alla dignità del mondo sia, di conseguenza, al suo valore interno “assoluto”.
Svantaggi: questo concetto non può rispondere alla domanda su come nasce la coscienza. Il positivismo nega quasi tutti gli sviluppi precedenti della filosofia e insiste sull'identità di filosofia e scienza, e questo non è produttivo, poiché la filosofia è un campo di conoscenza indipendente, basato sull'intera gamma della cultura, compresa la scienza.
La filosofia di Auguste Comte (1798-1857) (il fondatore del positivismo, introdusse questo concetto negli anni '30 del XIX secolo), Mill, Spencer - 1 forma storica di positivismo. Secondo Comte: nella scienza il primo posto dovrebbe essere la descrizione dei fenomeni. I metodi delle scienze naturali sono applicabili all'analisi della società, la sociologia è la scienza di supporto in cui il positivismo può mostrare tutte le sue capacità, contribuendo al miglioramento del linguaggio della scienza e al progresso della società, uno sguardo allo sviluppo mentale generale dell’umanità, di cui è il risultato il positivismo, indica che esiste una legge fondamentale. Secondo questa legge, ci sono tre fasi dello sviluppo umano:
1. teologico (stato di finzione) – un punto di partenza necessario per la mente umana.
2. metafisico (astratto). Un tentativo di costruire un quadro generale dell'esistenza, una transizione dal primo al terzo.
3. positivo (scientifico, positivo). – stato solido e finale.
Svantaggi: caratterizzato da un approccio non critico alla scienza, dai suoi elogi e da conclusioni affrettate.
La seconda forma di positivismo unisce il machismo (Mach) e l’empiriocriticismo (Avenarius) sotto il nome generale di “la più nuova filosofia delle scienze naturali del XX secolo”. L’obiettivo principale dei machisti era spiegare gli elementi “fisici” e “mentali” del mondo nell’esperienza umana, nonché “migliorare il linguaggio “positivo” della scienza. Avenarius ha cercato di costruire una nuova filosofia come scienza rigorosa ed esatta, simile alla fisica, alla chimica e ad altre scienze specifiche, giustificando la filosofia come un metodo per risparmiare pensiero, sprecando meno sforzi. Mach prestò maggiore attenzione alla liberazione delle scienze naturali dalla filosofia metafisica e logico-speculativa.
Concetto di Neoposit n. Gli insegnamenti sulla fn degli eminenti pensatori del XX secolo L. Wittgenstein e K. Popper appartengono al terzo stadio del filpositivismo, chiamato “positivismo linguistico” o “neopositivismo”. Le idee principali del pensatore nel campo della fn sono le seguenti: n ha bisogno di purificare il suo linguaggio. L. Wittgenstein ha avanzato il principio di "verifica", secondo il quale qualsiasi affermazione in n è verificabile, cioè soggetto a verifica sperimentale della verità.
K. Popper, nel corso dello studio dell'essenza di n, delle sue leggi e dei suoi metodi, arrivò a idee incompatibili con il principio di verifica. Nelle sue opere "Logic of Discovery" (1959), "Assunzioni e confutazioni" (1937) e altre, propone l'idea che è impossibile ridurre il contenuto della logica e le sue leggi solo ad affermazioni basate sull'esperienza, ad es. all’osservazione, all’esperimento, ecc. H non può essere ridotto ad affermazioni verificabili. Ma la conoscenza, credeva il pensatore, appare sotto forma di un insieme di ipotesi sulle leggi del mondo, sulla sua struttura, ecc. Allo stesso tempo, è molto difficile stabilire la verità delle ipotesi e le false ipotesi sono facilmente dimostrabili. PR, il fatto che la Terra sia piatta e il Sole si muova sopra la Terra è facile da capire, ma il fatto che la Terra sia rotonda e giri intorno al Sole era difficile da stabilire, nella lotta con la chiesa e con un certo numero di scienziati.
La scienza post-positivista del XX secolo è rappresentata dalle opere di T. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend, M. Polanyi, che mostrano un atteggiamento generale nei confronti dell'analisi del ruolo dei fattori socioculturali nelle dinamiche della modernità. T. Kuhn è riuscito a superare alcune carenze inerenti alle visioni positiviste della scienza. Non esiste un progresso continuo e un accumulo di conoscenza. Ogni paradigma forma una comprensione unica del mondo e non presenta vantaggi particolari rispetto a un altro paradigma. Il progresso è meglio inteso come evoluzione: un aumento della conoscenza all’interno di un paradigma. N è sempre determinato socioculturalmente. Per comprendere n è necessario un nuovo approccio storico-evolutivo. Le verità sono piuttosto relative e operano nel quadro di un paradigma. Queste idee hanno influenzato la moderna filosofia della scienza.
La scienza moderna parla a nome delle scienze naturali e umanistiche, cerca di comprendere il posto della civiltà moderna nelle sue diverse relazioni con l’etica, la politica e la religione. La fn svolge quindi anche una funzione culturale generale, evitando che gli scienziati diventino degli ignoranti che assolutizzano un approccio strettamente professionale ai fenomeni e ai processi. Richiede di prestare attenzione alla filosofia di qualsiasi problema, all'atteggiamento e al pensiero nei confronti della realtà in tutta la sua completezza e multidimensionalità, e appare come un diagramma dettagliato di opinioni sul problema della crescita e della conoscenza.
3. Scienza (dal latino - conoscenza) come parte della cultura. Il rapporto della scienza con l'arte, la religione e la filosofia. La scienza nel mondo moderno può essere considerata sotto vari aspetti: come conoscenza e attività per la produzione della conoscenza, come sistema di formazione del personale, come forza produttiva diretta, COME PARTE DELLA CULTURA SPIRITUALE.
Filosofia. Problemi filosofici della conoscenza scientifica
Aggiungi alle note |
Domande e risposte sulla filosofia, in particolare sui corsi “Problemi filosofici della conoscenza scientifica”.
Cos'è la scienza?
La scienzaè un'attività finalizzata all'acquisizione della vera conoscenza.
Cosa comprende la scienza?
La scienza include:
1. Scienziati nelle loro conoscenze, qualifiche ed esperienze.
2. Organizzazioni e istituzioni scientifiche, scuole e comunità scientifiche.
3. Base sperimentale e tecnica dell'attività scientifica.
4. Sistema di informazione scientifica ben consolidato ed efficace.
5. Sistema di formazione e certificazione del personale.
Funzioni della scienza.
La scienza svolge le seguenti funzioni:
1. Determina i processi sociali.
2. È la forza produttiva della società.
3. Svolge una funzione ideologica.
Quali tipi di conoscenza esistono?
1. Ordinario
2. Scientifico
3. Mitologico
4. Religioso
5. Filosofico
6. Artistico
Le caratteristiche più caratteristiche della cognizione quotidiana
1. Si sviluppa spontaneamente sotto l'influenza dell'esperienza quotidiana.
2. Non comporta la definizione di compiti che andrebbero oltre la pratica quotidiana.
3. A causa delle caratteristiche sociali, professionali, nazionali e di età del trasportatore.
4. Il trasferimento della conoscenza implica la comunicazione personale con il portatore di questa conoscenza
5. Non pienamente cosciente
6. Basso livello di formalizzazione.
Cos'è la conoscenza mitologica?
Conoscenza mitologica- questo è un tipo speciale di conoscenza olistica all'interno della quale una persona si sforza di creare un'immagine olistica del mondo basata su un insieme di informazioni empiriche, credenze e varie forme di esplorazione figurativa del mondo.
La conoscenza mitologica ha un carattere di visione del mondo.
La fonte dei miti è la conoscenza incompleta.
Cos’è la conoscenza religiosa?
Conoscenza religiosa– questa conoscenza olistica della visione del mondo è determinata dalla forma emotiva dell’atteggiamento delle persone nei confronti delle forze superiori (naturali e sociali) che le dominano.
La conoscenza religiosa si basa sulla fede nel soprannaturale. La conoscenza religiosa è di natura dogmatica.
Che cos'è la conoscenza artistica?
Conoscenza artistica– questa è la conoscenza basata sull’esperienza artistica – questa è la conoscenza visiva.
Caratteristiche della conoscenza scientifica
1. Evidenza rigorosa, validità, affidabilità dei risultati
2. Orientamento verso la verità oggettiva, penetrazione nell'essenza delle cose
3. Carattere transpersonale universale
4. Riproducibilità del risultato
5. Logicamente organizzato e sistematico
6. Ha un linguaggio speciale e altamente formalizzato
Struttura della conoscenza scientifica
Nella struttura della conoscenza scientifica, a seconda dell'oggetto e del metodo di ricerca, si distinguono:
1. Storia naturale o scienza della natura
2. Scienze sociali o conoscenze sociali e umanitarie
3. Scienze tecniche
4. Matematica
5. Filosofia
In base alla distanza dalla pratica, la scienza può essere divisa in:
1. Fondamentale
2. Applicato
Livelli di ricerca scientifica
1. Metateorico
2. Teorico
3. Empirico
Caratteristiche del livello empirico di conoscenza
1. Oggetto di ricerca: aspetti esterni dell'oggetto di studio
2. Metodi di ricerca: osservazione, esperimento
3. Focus epistemologico dello studio: ricerca dei fenomeni
4. Natura e tipologia delle conoscenze acquisite: fatti scientifici
5. Funzioni cognitive: descrizioni di fenomeni
Cos'è l'osservazione?
Osservazione- questa è una percezione pianificata, mirata e sistematica di oggetti e fenomeni del mondo esterno.
L'osservazione può essere:
1. Diretto
2. Indiretto (utilizzando vari dispositivi)
Limitazioni del metodo di osservazione:
1. Gamma ristretta di percezione dei vari sensi
2. Passività del soggetto della cognizione, vale a dire registrare ciò che sta accadendo in un processo reale senza interferire con esso.
Cos'è un esperimento?
Sperimentareè un metodo di ricerca mediante il quale i fenomeni vengono studiati in condizioni controllate e controllate.
Un esperimento scientifico prevede:
1. Disponibilità di obiettivi di ricerca
2. Basato su alcuni presupposti teorici iniziali
3. Richiede un certo livello di sviluppo dei mezzi tecnici di cognizione
4. Condotto da persone con qualifiche sufficientemente elevate
Vantaggi dell'esperimento:
1. È possibile isolare l'oggetto dall'influenza di oggetti secondari che ne oscurano l'essenza
2. Modificare sistematicamente le condizioni del processo
3. Riproduzione ripetuta
Tipi di esperimento:
1. Motore di ricerca
2. Prova
3. Dimostrativo
Tipi di esperimenti:
1. A grandezza naturale
2. Matematico
3. Informatica
Cos'è un fatto scientifico?
Fatto scientifico– si tratta sempre di informazioni attendibili e obiettive – un fatto espresso in linguaggio scientifico e incluso nel sistema della conoscenza scientifica.
Caratteristiche del livello teorico della conoscenza scientifica
1. Oggetto della ricerca: oggetti idealizzati formati come risultato dell'idealizzazione.
2. Orientamento epistemologico: conoscenza dell'essenza, cause
3. Metodi: modellazione
4. Funzioni cognitive: spiegazione, previsione
5. Natura e tipologia delle conoscenze acquisite: ipotesi, teoria
Forme di conoscenza di base a livello teorico della conoscenza
1. Ipotesi
2. Teoria
Cos'è un'ipotesi?
Ipotesi– un presupposto logico non dimostrato basato sui fatti.
Ipotesiè un presupposto scientificamente fondato basato sui fatti.
Ipotesi– conoscenza probabilistica, una ipotetica soluzione ad un problema.
Modi per formare un'ipotesi:
1. Basato sull'esperienza sensoriale
2. Utilizzando il metodo delle ipotesi matematiche
Requisiti di base per un'ipotesi
1. Un'ipotesi deve essere compatibile con tutti i fatti che riguarda.
2. Deve essere soggetto a verifica empirica o prova logica.
3. Deve spiegare i fatti e avere la capacità di prevedere nuovi fatti
Cos'è una teoria?
Teoriaè un sistema di conoscenza affidabile, conoscenza oggettiva, conoscenza provata, testata nella pratica, caratteristiche essenziali di un certo frammento di realtà.
Teoriaè un sistema complesso di conoscenze che comprende:
1. La base empirica iniziale è un insieme di fatti registrati in quest'area.
2. La base teorica iniziale: un insieme di presupposti, assiomi, leggi che descrivono un oggetto idealizzato.
3. Regole di inferenza logica e dimostrazione accettabili nel quadro della teoria
4. Leggi di vario grado di generalità che esprimono connessioni essenziali, stabili, ripetitive e necessarie tra i fenomeni coperti da questa teoria
Rapporto tra livello teorico ed empirico della ricerca
1. La conoscenza empirica è sempre carica di teoria
2. La conoscenza teorica è testata empiricamente
Livello metateorico della conoscenza scientifica
La conoscenza metateorica è una condizione e un prerequisito per determinare il tipo di attività teorica per spiegare e sistematizzare il materiale empirico.
Conoscenza metateorica- questo è un insieme di norme del pensiero scientifico, ideali e norme della conoscenza scientifica, modi accettabili per ottenere conoscenze affidabili per una determinata epoca.
Struttura del livello metateorico della cognizione
1. Ideali e norme di ricerca
2. Quadro scientifico del mondo
3. Fondamenti filosofici
Gli ideali e le norme della ricerca sono un insieme di determinati atteggiamenti metodologici basati sul valore concettuale caratteristici della scienza in ogni fase storica specifica del suo sviluppo.
Gli ideali e le norme di ricerca includono:
1. Ideali e standard di evidenza e fondatezza della conoscenza.
2. Descrizione spiegazione della conoscenza
3. Costruzione della conoscenza
Gli ideali e le norme della ricerca sono determinati da:
1. Specifiche degli oggetti oggetto di studio
2. L'immagine dell'attività cognitiva: l'idea di procedure obbligatorie che garantiscono la comprensione della verità.
3. Strutture della visione del mondo che sono alla base della fondazione della cultura di una particolare epoca storica.
Che cos'è un'immagine scientifica del mondo (SPM)?
Quadro scientifico del mondoè un sistema olistico di idee sulle proprietà generali e sui modelli della realtà.
Il quadro scientifico del mondo è costruito come risultato di una generalizzazione di concetti scientifici fondamentali.
Il quadro scientifico del mondo garantisce la sistematizzazione della conoscenza nel quadro della scienza pertinente, stabilisce un sistema di atteggiamenti e priorità per lo sviluppo teorico del mondo nel suo insieme e cambia sotto l'influenza diretta di nuove teorie e fatti.
Tipi di immagine scientifica del mondo:
1. Classico
2. Non classico
3. Post-non classico
I tratti più caratteristici della conoscenza filosofica
1. Di natura puramente teorica.
2. Ha una struttura complessa (include ontologia, epistemologia, logica e così via).
3. L'oggetto dello studio della filosofia è più ampio dell'oggetto dello studio di qualsiasi scienza; si sforza di scoprire le leggi del mondo intero.
4. La conoscenza filosofica è limitata dalle capacità cognitive umane. Quelli. ha problemi intrattabili che oggi non possono essere risolti logicamente.
5. Studia non solo l'oggetto della conoscenza, ma anche il meccanismo della conoscenza stessa.
6. Porta l'impronta della personalità e della visione del mondo dei singoli filosofi.
In cosa differisce la conoscenza filosofica dalla conoscenza scientifica?
Ci sono due differenze principali tra loro:
1. Qualsiasi scienza si occupa di un'area tematica fissa (la fisica scopre le leggi della realtà fisica; la chimica - chimica, la psicologia - psicologica).
La filosofia, a differenza della scienza, esprime giudizi universali e si sforza di scoprire le leggi del mondo intero.
2. La scienza cerca la verità senza discutere se ciò che trova sia buono o cattivo, o se tutto ciò abbia un significato. In altre parole, la scienza risponde principalmente alle domande “perché?” "Come?" e “da dove?”, non pone le domande “perché?” e per cosa?".
La filosofia, risolvendo gli eterni problemi dell'esistenza, si concentra non solo sulla ricerca della verità, ma anche sulla conoscenza e sull'affermazione dei valori.
Fondamenti filosofici della scienza
Fondamenti filosofici della scienzaè un sistema di idee filosofiche che stabiliscono linee guida generali per l'attività cognitiva.
I fondamenti filosofici della scienza garantiscono l’“aggancio” della nuova conoscenza scientifica alla visione del mondo dominante, compreso il contesto socio-culturale dell’epoca.
Come si chiama la prima forma storica di rapporto tra scienza e filosofia?
Filosofia naturale.
Cos'è la filosofia naturale?
Filosofia naturale- questo è un modo di comprendere il mondo, basato su alcuni principi generali stabiliti speculativamente e che fornisce un quadro generale che copre tutta la natura nel suo insieme.
Filosofia naturale– questa è una forma di rapporto tra scienza e filosofia (la cultura dell’Europa occidentale fino all’inizio del XIX secolo)
Filosofia naturale- un tentativo di spiegare la natura, sulla base dei risultati ottenuti con metodi scientifici, al fine di trovare risposte ad alcune domande filosofiche.
Ad esempio, scienze come la cosmogonia e la cosmologia, che a loro volta si basano su fisica, matematica e astronomia, cercano di rispondere alla domanda filosofica sull’origine dell’Universo.
Le ragioni principali della morte della filosofia naturale:
1. La formazione della scienza come istituzione sociale
2. Formazione dell'organizzazione disciplinare delle scienze
3. Critica della speculatività delle costruzioni filosofiche da parte dei maggiori scienziati naturali.
Cos'è il positivismo?
Positivismoè una dottrina filosofica che nel XIX secolo dichiarò le scienze empiriche specifiche come l'unica fonte della vera conoscenza e negò il valore cognitivo della ricerca filosofica tradizionale.
Il positivismo cerca di ridurre tutta la conoscenza scientifica a un insieme di dati sensoriali ed eliminare l’inosservabile dalla scienza.
Secondo il positivismo, il compito della filosofia è trovare un metodo universale per ottenere una conoscenza affidabile e un linguaggio universale della scienza. Tutte le funzioni della scienza si riducono alla descrizione, non alla spiegazione.
La tesi iniziale del positivismo: la metafisica, come dottrina dell'essenza dei fenomeni, va scartata. La scienza deve limitarsi a descrivere l'apparenza esterna dei fenomeni. La filosofia deve svolgere il compito di sistematizzazione, ordinamento e classificazione dei risultati scientifici.
Fondatori del positivismo: Comte, Spencer, Mill
Cos'è la metafisica?
Metafisica- Questa è la dottrina delle cause prime, delle essenze primarie.
Cos'è il machismo?
Machismo O empiriocritica- Questa è una forma modificata di positivismo (60-70 anni del XIX secolo).
Cos’è il neopositivismo?
Neopositivismo- Questa è una forma di positivismo modificata negli anni '20 del XX secolo.
Ragioni per cambiare la forma del positivismo:
1. La necessità di comprendere il ruolo dei mezzi segni-simbolici del pensiero scientifico in connessione con la matematizzazione della ricerca scientifica
2. La necessità di comprendere il rapporto tra conoscenza teorica ed empirica
3. La necessità di separare scienza e metafisica.
Fondatori della scuola del neopositivismo: Vitnshtein.
Oggetto della ricerca del neopositivismo sono le forme linguistiche della conoscenza.
Secondo il neopositivismo, lo scopo della filosofia si riduce alla chiarificazione logica del pensiero. La filosofia non è una teoria, ma un'attività di analisi della conoscenza scientifica e della possibilità della sua espressione nel linguaggio.
La distinzione tra conoscenza scientifica e non scientifica è possibile in base all'uso principio di verifica, la cui essenza è la necessità di confrontare affermazioni scientifiche e dati empirici.
La crisi del neopositivismo è dovuta a:
1. L'impossibilità di ridurre la conoscenza teorica a quella empirica
2. L'incapacità di formalizzare pienamente il linguaggio della scienza
Cos'è il pragmatismo?
Pragmatismo- questa è una forma di positivismo modificata alla fine del XIX secolo
Rappresentanti del pragmatismo: Peirce, Dune, James.
La filosofia non dovrebbe essere una riflessione sull'esistenza originaria, ma un metodo generale per risolvere i problemi che le persone affrontano in varie situazioni di vita.
Lo scopo del metodo: trasformare una situazione problematica in una risolta, e la sua verità dipende da quanto contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo.
Il razionalismo critico di Karl Popper
Rifiuto di cercare una base di conoscenza assolutamente affidabile, poiché la base empirica della conoscenza dipende dalla teoria.
La distinzione tra conoscenza scientifica e non scientifica è possibile sulla base del principio di falsificazione, cioè la possibilità fondamentale di confutare affermazioni legate alla scienza.
La crescita della conoscenza, dal punto di vista di Popper, consiste nel proporre ipotesi audaci e nel confutarle, a seguito delle quali vengono risolti i problemi scientifici.
Programma di ricerca (SRP)è una formazione metateorica all'interno della quale si svolge l'attività teorica.
Un programma di ricerca è un insieme di teorie successive, unite da un certo insieme di idee e principi di base.
La struttura dell'NPC comprende:
1. Nocciolo duro
2. Cintura protettiva
3. Un sistema di regole metodologiche o “euristiche”
Ci sono 2 fasi nello sviluppo del NIP:
1. Progressivo
2. Regressivo
Il concetto di cambiamento di paradigma di Kuhn
Dal punto di vista di Kuhn, la scienza è l'attività delle comunità scientifiche, i cui membri aderiscono a un determinato paradigma.
Cos'è un paradigma?
Paradigmaè un sistema di norme della comunità scientifica, visioni teoriche di base, metodi, fatti fondamentali, esempi di attività scientifica, che sono riconosciuti e condivisi da tutti i membri di questa comunità scientifica.
Qual è il quadro scientifico del mondo?
Quadro scientifico del mondoè un sistema di idee sulle proprietà generali e sui modelli della realtà, costruito come risultato della generalizzazione e sintesi di concetti e principi scientifici fondamentali.
Il quadro scientifico del mondo si sviluppa sotto l'influenza diretta di nuove teorie e fatti, dei valori culturali dominanti, esercitando su di essi un'influenza inversa.
Qual è l'immagine classica del mondo?
Immagine classica del mondo considera il mondo come un sistema meccanico costituito da molti atomi indivisibili e la loro interazione avviene come un trasferimento istantaneo di forze in linea retta. Gli atomi e i corpi da essi formati si muovono nello spazio assoluto nel tempo assoluto. Il comportamento degli oggetti è soggetto ad un rapporto di causa-effetto inequivocabile, cioè il passato determina inequivocabilmente il futuro.
Cos’è il riduzionismo?
Riduzionismo– si tratta di una tradizione filosofica che afferma la possibilità di ridurre l’intera diversità del mondo strutturale ad un unico livello fondamentale.
Tipi di riduzionismo:
1. Il meccanicismo è il desiderio di spiegare tutto usando la meccanica classica
2. Fisicismo – spiega gli aspetti dell'esistenza, sulla base delle leggi della meccanica quantistica
Cos'è la formalizzazione?
Formalizzazioneè il processo di traduzione di frammenti significativi di conoscenza in linguaggi artificiali, simbolici, logico-matematici, matematici, soggetti a regole chiare, attraverso la costruzione di formule e la loro trasformazione.
Quali sono i problemi assiologici della scienza?
I problemi assiologici della scienza sono problemi nell'orientamento sociale, morale, estetico, culturale, valoriale della ricerca scientifica e dei suoi risultati.
Orientamenti valoriali della scienza
1. Scientismo
2. Antiscientismo
Cos'è lo scientismo?
Scientismo– orientamento valoriale della scienza, che considera la scienza come un valore assoluto, esagerandone il ruolo e le capacità nella risoluzione dei problemi sociali.
Lo scientismo è la base del determinismo tecnologico.
Cos’è il determinismo tecnologico?
Il determinismo tecnologico è una dottrina che afferma che la scienza e la tecnologia determinano in modo univoco i processi di sviluppo sociale.
Cos'è il determinismo?
Determinismoè una dottrina che afferma che tutti i fenomeni sono collegati da una relazione causale con fenomeni precedenti.
Cos'è l'indeterminismo?
Indeterminismo– nega in tutto o in parte l'esistenza di tale collegamento.
Cos'è il determinismo laplaceano?
Lo scienziato francese Pierre Simon Laplace, cita:
“Qualsiasi fenomeno non può sorgere senza che una causa lo produca. Lo stato attuale dell’universo è la conseguenza del suo stato precedente e la causa di quello successivo”.
Tutti i processi nel mondo sono reversibili nel tempo, prevedibili e retroattivamente prevedibili per un certo periodo di tempo. Non c'è posto per la casualità nell'universo, poiché la traiettoria di qualsiasi oggetto è determinata in modo univoco dalle condizioni iniziali.
Lo stesso può essere scritto come una formula:
L(U(ti)) = U(ti +1)
Legge l, agendo su U(ti), porta all'emergenza U(ti+1). ti- un certo punto nel tempo.
Cos’è l’antiscientismo?
Antiscientismo- questo è l'orientamento valoriale della scienza, che valuta la scienza come una forza ostile all'uomo, rifiutandola.
Orientamenti di valore di uno scienziato
1. Cognitivo: i valori della conoscenza scientifica come un tipo speciale di attività.
2. I valori che guidano lo scienziato come individuo
Qual è l’etica della scienza?
Etica della scienza– si tratta di orientamenti di valore che costituiscono la base dell'attività professionale di uno scienziato.
L’etica della scienza comprende:
1. Versatilità
2. Universalità
3. Altruismo
4. Scetticismo organizzato
Quali idee includono i fondamenti della scienza (secondo V.S. Stepin)?
1. Ideali e norme di ricerca
2. Quadro scientifico del mondo
3. Fondamenti filosofici della scienza
Chi ha sviluppato e sostanziato l’importanza dell’induzione nella conoscenza scientifica?
Induzione- un metodo di ragionamento dal particolare al generale. Vengono ricercati i fatti su cui si basa la prova. Il contrario della detrazione.
Il concetto di induzione è stato sviluppato e suffragato dal filosofo britannico Karl Popper.
Come comprende la scienza moderna il ruolo del caos nel processo di sviluppo?
Il caos può portare all’ordine. Facciamo un esempio chiaro.
Diciamo che esiste un sistema chiuso in cui si osserva il movimento caotico delle particelle. Quanto maggiore è il caos in questo sistema, tanto più sicuro possiamo dire che il sistema ha un equilibrio termodinamico.
Cos'è la sinergia?
Sinergetica- Questa è la dottrina della possibilità di transizione dal caos all'ordine.
L'intuizione da un punto di vista filosofico
Nella storia della filosofia, il concetto Intuizione includeva contenuti diversi. L'intuizione era intesa come una forma di conoscenza intellettuale diretta o contemplazione (intuizione intellettuale). Pertanto, Platone sosteneva che la contemplazione delle idee (prototipi delle cose nel mondo sensoriale) è un tipo di conoscenza diretta che si presenta come un'intuizione improvvisa, che richiede una preparazione della mente a lungo termine.
Nella storia della filosofia, le forme sensoriali della cognizione e del pensiero sono state spesso contrapposte. R. Descartes, ad esempio, sosteneva: “Per intuizione non intendo la fede nella traballante evidenza dei sensi e non nel giudizio ingannevole di un'immaginazione disordinata, ma il concetto di una mente chiara e attenta, così semplice e distinta da lasciare non c'è dubbio che stiamo pensando." , o, che è la stessa cosa, un concetto forte di una mente chiara e attenta, generata solo dalla luce naturale della ragione e, grazie alla sua semplicità, più affidabile della stessa deduzione... ".
G. Hegel nel suo sistema combinava dialetticamente la conoscenza diretta e quella mediata.
L'intuizione veniva interpretata anche come conoscenza sotto forma di contemplazione sensoriale (Intuizione sensuale): "... incondizionatamente indubbia, chiara come il sole... solo sensuale", e quindi il segreto della conoscenza intuitiva è "... concentrata nella sensualità " (Feuerbach L.).
L'intuizione era intesa sia come un istinto che determina direttamente, senza previo apprendimento, le forme di comportamento di un organismo (A. Bergson), sia come un primo principio nascosto e inconscio della creatività (S. Freud).
In alcune correnti filosofiche l'Intuizione viene interpretata come una rivelazione divina, come un processo del tutto inconscio, incompatibile con la logica e la pratica della vita (intuizionismo). Varie interpretazioni dell'intuizione hanno qualcosa in comune: enfatizzano il momento di immediatezza nel processo cognitivo, in contrasto (o in contrasto) con la natura mediata e discorsiva del pensiero logico.
La dialettica materialistica vede la grana razionale del concetto di Intuizione nella caratteristica del momento di immediatezza nella cognizione, che rappresenta l'unità del sensuale e del razionale.
Il processo di conoscenza scientifica, così come le varie forme di esplorazione artistica del mondo, non sempre si svolgono in una forma probatoria dettagliata, logica e fattuale. Spesso il soggetto coglie nel pensiero una situazione complessa, ad esempio durante una battaglia militare, determinando una diagnosi, la colpevolezza o l'innocenza dell'accusato, ecc. Il ruolo dell'intuizione è particolarmente importante laddove è necessario andare oltre i metodi cognitivi esistenti penetrare nell'ignoto. Ma l’intuizione non è qualcosa di irragionevole o superintelligente. Nel processo di cognizione intuitiva, tutti i segni con cui si giunge alla conclusione e le tecniche con cui si giunge non vengono realizzati. L'intuizione non costituisce un percorso speciale di conoscenza che bypassa sensazioni, idee e pensiero. Rappresenta un tipo di pensiero unico, in cui i singoli collegamenti del processo di pensiero attraversano la coscienza più o meno inconsciamente, ed è il risultato del pensiero che è realizzato in modo estremamente chiaro - percepito come "verità", con una maggiore probabilità di determinare il verità rispetto al caso, ma meno elevato del pensiero logico.
L'intuizione è sufficiente per discernere la verità, ma non è sufficiente per convincere se stessi e gli altri di questa verità. Ciò richiede una prova.
B) Il problema “natura e società” è risolto diversamente dai diversi movimenti filosofici. Ad esempio, gli idealisti oggettivi ignorano la connessione tra società e natura, considerando la storia dell'umanità non come lo sviluppo della produzione materiale sulla terra, ma come lo sviluppo della mente mondiale, l'idea assoluta. Gli idealisti soggettivi considerano la natura stessa un complesso di sensazioni umane.
Dal lato quantitativo, la società è determinata dai suoi numeri, e dal lato qualitativo, dalla natura delle relazioni tra le persone. La società è un insieme di persone unite da forti legami.
Natura (ambiente geografico) e società formano un'unità dialettica. Sta nel fatto che la forma sociale del movimento della materia è la forma più alta di movimento, che (come altre) è soggetta alle leggi della dialettica.
Religione (dal latino religio - pietà, pietà, santuario) -
visione del mondo animata dalla fede in Dio. Non è solo fede o
un insieme di punti di vista. La religione è anche un sentimento di connessione, dipendenza
e obblighi in relazione al potere segreto superiore che fornisce supporto e
degno di culto. Questo è il modo in cui molti saggi e filosofi intendevano la religione
Zoroastro, Lao Tzu, Confucio, Buddha, Socrate, Cristo, Maometto
L'arte è una forma di riflessione della realtà nella mente umana in immagini artistiche. Riflettendo il mondo che ci circonda, l'arte aiuta le persone a capirlo e funge da potente mezzo di educazione politica, morale e artistica. L'arte (cognizione artistica) è un'attività creativa nel processo in cui vengono create immagini artistiche che riflettono la realtà e incarnano il pensiero di una persona atteggiamento estetico nei suoi confronti Esistono vari tipi di arte, distinti dalla struttura speciale dell'immagine artistica. Alcuni di essi raffigurano direttamente i fenomeni della vita (pittura, scultura, grafica, narrativa, teatro, cinema), altri esprimono lo stato ideologico ed emotivo dell'artista generato da questi fenomeni (musica, coreografia, architettura), il desiderio di studiare gli oggetti. del mondo reale e, su questa base, anticipare i risultati. La sua trasformazione pratica è caratteristica non solo della scienza, ma anche della conoscenza quotidiana, che si intreccia nella pratica e si sviluppa sulla sua base. Poiché lo sviluppo della pratica oggettiva le funzioni umane in strumenti e crea le condizioni per la scomparsa degli strati soggettivi e antropomorfici nello studio degli oggetti esterni, compaiono nella conoscenza quotidiana alcuni tipi di conoscenza della realtà, generalmente simili a quelli che caratterizzano la scienza.
La conoscenza scientifica nella sua essenza rappresenta un processo di riflessione con tutte le proprietà attributive. Il processo cognitivo è storicamente e logicamente inseparabile dall’attività umana. Non è un caso che l'oggetto dell'attività sia posto all'inizio. Il fatto è che il soggetto dell'attività non diventa tale finché non è consapevole di certi fenomeni e processi come possibili oggetti della sua attività, non li riflette nella sua coscienza e non determina in relazione ad essi un piano per la loro opportuna trasformazione (immagine ideale di il futuro).
Riso. 3. La struttura della connessione tra attività umana e cognizione
Consideriamo la struttura generale della connessione tra attività umana e cognizione nel contesto della conoscenza scientifica (Fig. 3).
L'ideale è un riflesso del materiale, il soggettivo è oggettivo. Pertanto “non esiste soggetto senza oggetto”.
Il soggetto dell'attività è primario solo in relazione al fatto che nell'oggetto che è già diventato un prodotto, rappresenta l'incarnazione dell'ideale.
Sulla base dell'analisi effettuata si possono individuare i seguenti elementi del processo di conoscenza scientifica.
L'oggetto dell'attività sono i processi naturali e sociali, la loro interazione.
Oggetto dell'attività sono le comunità scientifiche, le scuole.
Il prodotto dell'attività sono le leggi dello sviluppo della natura e della società e la loro interazione, la metodologia scientifica della cognizione e della trasformazione dell'oggetto dell'attività.
Metodi di attività - sviluppati sulla base dello studio delle leggi della natura e della società e testati nella pratica, tecniche, metodi, tecnologie di cognizione e trasformazione opportuna del mondo circostante della società e delle persone.
L'obiettivo dell'attività è la trasformazione opportuna del mondo circostante, della società e delle persone.
Filosofia e conoscenza scientifica
L'orientamento della scienza verso lo studio delle leggi oggettive del funzionamento e dello sviluppo della natura e della società costituisce la prima caratteristica principale della conoscenza scientifica. Questa è la coincidenza tra scienza e filosofia, non solo nel corso dei millenni di sviluppo della società “tradizionale”, la New Age (scienza classica), ma anche oggi.
Le differenze tra filosofia e scienza, emerse solo al momento della loro separazione nel XVII secolo, iniziano proprio dal tema:
la filosofia studia leggi universali e principi di sviluppo, scienza - generale e specifica:
le leggi e i principi filosofici sono la metodologia/metodi generali della scienza - generale (per un dato oggetto) e specifica (per vari aspetti dell'oggetto);
l'obiettivo della filosofia è la conoscenza delle leggi universali e dei principi di sviluppo, l'obiettivo della scienza è una trasformazione opportuna (pratica).
Nella sua conferenza “The Art of Philosophizing”, B. Russell ha definito il rapporto tra filosofia e scienza: “Vorrei iniziare con una breve risposta alla domanda “Che cos’è la filosofia?” Questa non è conoscenza concreta, che è scienza. Ma questa non è la fede incondizionata caratteristica dei popoli primitivi. La filosofia è qualcosa che si trova tra questi poli. Forse può essere chiamata “l’arte della speculazione razionale”. Secondo questa definizione, la filosofia ci dice cosa fare se vogliamo trovare la verità, o ciò che più le somiglia, nei casi in cui è impossibile sapere con certezza quale sia la verità”.
Il legame tra filosofia e scienza cambia con lo sviluppo storico dell'attività umana e, di conseguenza, della conoscenza scientifica concreta.
Tre fasi storiche nello sviluppo della connessione e del rapporto tra filosofia e scienza sono già state evidenziate e analizzate sopra.
Nella prima fase (VII secolo aC - XVI secolo), le scienze speciali fanno parte di un'unica conoscenza filosofica. La differenziazione dell'attività in questa fase non raggiunge una tale importanza da far apparire una significativa differenziazione della cognizione.
Nella seconda fase (XVII secolo - metà del XIX secolo) in Europa si verifica un cambiamento qualitativo nella produttività del lavoro, dovuto allo sviluppo dell'uso di nuove attrezzature e tecnologie nella produzione industriale emergente. Le esigenze dello sviluppo produttivo richiedono l’istituzione delle scienze naturali, e i cambiamenti fondamentali nel sistema di gestione della società e il conseguente cambiamento nel sistema sociale – le rivoluzioni borghesi – richiedono prima una revisione delle norme applicate (diritto, teoria politica), e poi le discipline umanistiche fondamentali (filosofia, psicologia, sociologia).
Nella terza fase (dalla metà del XIX secolo ad oggi), prima la rivoluzione industriale e poi quella scientifica e tecnologica portano a una crescita e una differenziazione senza precedenti delle conoscenze scientifiche concrete nelle scienze naturali, umanistiche e tecniche. Tutto ciò aumenta incommensurabilmente il ruolo ideologico e metodologico integrativo della filosofia in relazione allo sviluppo della conoscenza scientifica concreta e di tutte le sfere dell'attività umana.
Conoscenza artistica ed estetica
La specificità della conoscenza artistica ed estetica è che ha una base emotiva e figurativa. Qui il pensiero segue le orme del sentimento. La definizione delle caratteristiche distintive dell'ARTE e del suo ruolo nella vita delle persone ha causato forti disaccordi nel corso della storia culturale.
Possiamo evidenziare le seguenti opzioni più comuni per interpretare l'essenza e, quindi, la funzione dell'arte.
Interpretazioni dell'essenza dell'arte:
“imitazione della natura” - “creazione di forme libere”;
^riproduzione della realtà” - “conoscenza di sé dell'Assoluto”;
“autoespressione dell'artista” - “linguaggio dei sentimenti”;
Un tipo speciale di gioco è un tipo speciale di preghiera.
Tali disaccordi sono spiegati da molte ragioni: la differenza nelle posizioni filosofiche dei teorici (materialisti o idealisti), i loro atteggiamenti ideologici, la dipendenza da diversi tipi di arte e metodi creativi (ad esempio, letteratura o architettura, classicismo o realismo), e infine , la complessità oggettiva della struttura stessa dell'arte.
Questa complessità e versatilità della struttura dell'arte non sono realizzate da alcuni teorici, che definiscono l'essenza dell'arte come epistemologica, ideologica, estetica, creativa, ecc. L'insoddisfazione per tali definizioni unilineari ha portato alcuni critici d'arte ad affermare che nell'arte diverse i momenti sono organicamente interconnessi: conoscenza e valutazione della realtà, riflessione e creazione, modello e segno.
Ma anche tali interpretazioni bidimensionali dell’essenza dell’arte non ricreano adeguatamente la sua struttura complessa.
Nello studio della natura dell'arte, la scienza ha iniziato a rivolgersi a metodi di analisi del sistema, che consentono di avvicinarsi alla rivelazione dell'essenza dell'arte da altri punti di vista, in particolare:
a) identificare quelle qualità e funzioni dell'arte che sono necessarie e sufficienti per descriverne la struttura interna;
b) mostrare che la combinazione di queste qualità e funzioni non è la loro semplice “somma”, non un conglomerato meccanico, ma un'unità organicamente integrale, che genera l'effetto artistico specifico dell'arte;
c) rivelare la capacità della struttura dell'arte di essere modificata, formando, da un lato, tipi, varietà, generi e generi d'arte, e dall'altro, vari tipi storici d'arte (metodi creativi, stili, movimenti, scuole ). Sebbene l’estetica sia lungi dall’essere una soluzione definitiva a questo problema, alcuni aspetti di esso possono essere chiariti con sufficiente certezza.
In contrasto con la scienza, il linguaggio e altre forme di attività sociale specializzata progettate per soddisfare i vari bisogni delle persone, l'arte si è rivelata necessaria per l'umanità come mezzo di educazione sociale olistica dell'individuo, del suo sviluppo emotivo e intellettuale, della sua familiarità con l'esperienza collettiva accumulata dall'umanità, con la saggezza secolare, a specifici interessi, aspirazioni, ideali storico-sociali. Ma per poter svolgere questo ruolo di potente strumento di socializzazione dell’individuo, l’arte deve essere simile alla vita umana reale, deve cioè ricreare (modellare) la vita nella sua reale integrità e complessità strutturale. L'arte dovrebbe "raddoppiare" l'attività della vita reale di una persona, essere la sua continuazione e aggiunta immaginaria, e quindi espandere l'esperienza di vita dell'individuo, permettendole di "vivere" molte "vite" illusorie in "mondi" creati da scrittori, musicisti, pittori , eccetera.
Allo stesso tempo (questo è l'aspetto più importante della dialettica dell'arte), essa appare allo stesso tempo simile alla vita reale e allo stesso tempo diversa da essa: fittizia, illusoria, come un gioco di immaginazione, come una creazione delle mani umane (questo la coscienza della “fabbricazione umana” è l'atteggiamento dell'uomo nei confronti dell'arte, secondo l'osservazione di L. Feuerbach, fondamentalmente diverso dal suo atteggiamento nei confronti della religione).
Un'opera d'arte suscita allo stesso tempo le esperienze più profonde, simili alle esperienze di eventi reali, e il piacere estetico derivante dalla sua percezione proprio come opera d'arte, come modello di vita creato dall'uomo. Affinché questa influenza contraddittoria abbia luogo, l'arte deve essere isomorfa all'attività della vita reale di una persona, cioè non deve copiarla, ma riprodurne la struttura.
La vera attività della vita umana, essendo organicamente integrale, consiste nell'interazione di quattro componenti principali: lavoro, cognizione, orientamento al valore e comunicazione. Di conseguenza, l'arte, le cui opere sono a modo loro ugualmente organicamente integrali, adotta questa struttura della vita umana. Agisce principalmente come un modo specifico (fantasioso) di comprendere la realtà, ma allo stesso tempo è anche un modo specifico e fantasioso di valutarla, un'affermazione di un certo sistema di valori; le opere d'arte vengono create sulla base della riflessione, della consapevolezza del mondo reale, ma la coscienza non solo riflette il mondo oggettivo, ma lo crea anche, creando qualcosa che in realtà non era, non è e talvolta non può essere (immagini fantastiche, grottesco, ecc.); Pertanto, l’arte crea “mondi” immaginari che sono più o meno vicini al mondo reale e più o meno diversi da esso, cioè rappresenta, nelle parole di K. Marx, un metodo di “padronanza pratico-spirituale” della realtà , che è diverso anche dal suo sviluppo puramente spirituale, caratteristico della conoscenza teorica, e dalla pratica puramente materiale.
Pertanto, l'arte come fenomeno sociale specifico è un sistema complesso di qualità, la cui struttura è caratterizzata dalla combinazione di aspetti (o sottosistemi) cognitivi, valutativi, creativi (spiritualmente e materialmente) e segnico-comunicativi.
Tra le principali funzioni dell'arte, quindi, spiccano le seguenti: 1) edonistica (dal greco ke (1ope - piacere);
comunicativo; 3) epistemologico; 4) assiologico (valore); 5) educativo.
Grazie a ciò, l'arte agisce sia come mezzo di comunicazione tra le persone, sia come strumento per la loro illuminazione, arricchendo la loro conoscenza del mondo e di se stessi, e come un modo per educare una persona sulla base dell'uno o dell'altro sistema di valori e come fonte di elevate gioie estetiche. Sebbene tutte queste funzioni dell'arte, fuse insieme, siano solo aspetti diversi di un tutto - l'impatto artistico dell'arte su una persona - la loro relazione può essere molto diversa, e talvolta una delle funzioni viene alla ribalta e acquisisce un'importanza predominante.
Nel processo di esplorazione artistica della realtà, gli oggetti inclusi nell'attività umana non sono separati da fattori soggettivi, ma sono presi con essi in una sorta di “collante”. Qualsiasi riflessione di oggetti del mondo oggettivo nell'arte esprime contemporaneamente l'atteggiamento di valore di una persona nei confronti dell'oggetto. Un'immagine artistica è un riflesso di un oggetto che contiene l'impronta della personalità dell'autore, i suoi orientamenti di valore, fusi nelle caratteristiche della realtà riflessa. Escludere questa compenetrazione significa distruggere l'immagine artistica. Nella scienza, le peculiarità dell'attività vitale dell'individuo che crea conoscenza, i suoi giudizi di valore non sono direttamente inclusi nella composizione della conoscenza generata (le leggi di Newton non ci consentono di giudicare ciò che Newton amava e odiava, mentre, ad esempio, in ritratti di Rembrandt viene catturata la personalità dello stesso Rembrandt, la sua visione del mondo e il suo atteggiamento personale nei confronti dei fenomeni sociali raffigurati: un ritratto dipinto da un grande artista funge sempre da autoritratto).
Ma tutto può essere dichiarato arte, opera d'arte?
Come in tutte le altre forme di riflessione, LA RIFLESSIONE NELL'ARTE È SEMPRE AUTORIFLESSIONE. Ma non si può affermare che l'arte cesserebbe di essere un riflesso della realtà, ma sarebbe solo un'autoriflessione, l'autoespressione dell'autore. La funzione dell’arte è principalmente edonistica; dovrebbe portare piacere ed esperienza.
L’arte è la sfera della conoscenza soggettiva. La verità non è lo scopo dell’arte. "L'oscurità delle verità basse ci è più cara dell'inganno elevato." "Verserò lacrime per la finzione", ha scritto A. S. Pushkin a questo proposito. Tuttavia, proprio per quanto detto, l'arte è la via non verso la verità, ma verso la verità...
Conoscenza scientifica e quotidiana
È necessario distinguere tra conoscenza scientifica e non scientifica. Non tutta la conoscenza può essere classificata come scientifica. Inoltre “vero” e “scientifico” non coincidono. A questo proposito, la conoscenza ordinaria e quella scientifica possono essere paragonate.
La cognizione ordinaria prende gli oggetti così come il soggetto li percepisce. Il pensiero ingenuo-realistico si basa su questa premessa. Naturalmente, questo pensiero non dovrebbe essere respinto in toto. Einstein diceva che il realismo ingenuo è il punto di partenza di tutte le scienze, soprattutto delle scienze naturali. B. Russell ha scritto che il materialismo ingenuo porta alla fisica, ma la fisica, se vera, mostra che il materialismo ingenuo è falso.
La conoscenza ordinaria associata alla vita quotidiana e alle attività delle persone è una registrazione di fatti e dipendenze individuali, consiste di affermazioni disparate, è formulata in linguaggio naturale, spesso approssimativamente, non strettamente, ed è formata da tutte le persone.
Il soggetto della scienza non si riduce agli oggetti dell’esperienza quotidiana. La conoscenza scientifica è focalizzata sulla conoscenza delle leggi e sull'essenza dei fenomeni. Le attività scientifiche sono svolte da scienziati professionisti utilizzando un complesso di mezzi materiali e tecnici, informazioni scientifiche e metodi scientifici. La conoscenza scientifica è una conoscenza oggettivamente vera, sistematizzata, dimostrativa, logicamente coerente, formulata utilizzando linguaggi artificiali, con la massima accuratezza.
La capacità della conoscenza empirica spontanea di generare una conoscenza sostanziale e oggettiva sul mondo solleva la questione della differenza tra essa e la ricerca scientifica. I tratti che distinguono la scienza dalla conoscenza quotidiana possono essere convenientemente classificati secondo lo schema categoriale in cui è caratterizzata la struttura dell'attività (tracciando la differenza tra scienza e conoscenza ordinaria per soggetto, mezzi, prodotto, metodi e oggetto di attività).
Proviamo nella tabella. 1 per mostrare la differenza e l'unità della conoscenza scientifica e quotidiana.
Tabella 1. Differenza e unità della conoscenza scientifica e quotidiana
Condizioni e struttura della ricerca scientifica
Le condizioni necessarie per la ricerca scientifica sono:
oggetto di studio (area tematica);
soggetto di ricerca (scienziati);
strumenti di ricerca.
Il rapporto epistemologico tra soggetto e oggetto presuppone innanzitutto la presenza di un oggetto di conoscenza. In termini filosofici generali, è necessario distinguere tra i concetti di realtà oggettiva (materia) e oggetto di conoscenza. Sebbene potenzialmente, man mano che la pratica si espande e si sviluppa, l'“intero” mondo materiale può essere un oggetto di conoscenza, tuttavia, in ogni specifica epoca storica, l'oggetto di conoscenza è solo una “parte” della realtà oggettiva. L'oggetto della conoscenza nel caso generale è una determinata area tematica, un insieme di fenomeni che hanno caratteristiche simili.
L'oggetto della conoscenza esiste prima, al di fuori e indipendentemente dalla coscienza del ricercatore e dalle sue attività. Ma d'altra parte l'oggetto della conoscenza è sempre correlato al soggetto della conoscenza. La “trasformazione” degli oggetti materiali in oggetti di conoscenza si attua inserendo i primi nell'attività cognitiva. Se il concetto di realtà oggettiva esprime il fatto dell'indipendenza dell'esistenza dalla coscienza del soggetto, allora il concetto di oggetto di conoscenza significa quella “parte” della realtà oggettiva con cui il soggetto è entrato in relazioni pratiche e cognitive.
Storicamente il primo oggetto della ricerca scientifica è stata la natura. Successivamente l'oggetto della conoscenza diventa la società, la cognizione e la coscienza stessa. Ciò significa che il concetto di oggetto di conoscenza dovrebbe essere ampliato, non limitandolo solo ai fenomeni naturali. Oggetto della conoscenza in senso lato è tutto ciò verso cui è diretta l'attività cognitiva del soggetto.
Il soggetto della cognizione è inteso come portatore dell'attività cognitiva, conoscendo le persone. Ma qui va notato un punto importante. Il soggetto individuale della cognizione è un essere vivente, corporeo, una persona con gli organi di senso appropriati e la capacità di pensare. Ma un individuo specifico diventa soggetto di conoscenza, poiché padroneggia l'esperienza storica dell'umanità, oggettivata in strumenti, linguaggio, opere d'arte, poiché padroneggia le forme e i metodi dell'attività di ricerca, la conoscenza sviluppata dall'umanità in una determinata epoca.
L'uomo è il prodotto di una determinata epoca storica. La capacità di lavorare, preoccuparsi, ascoltare musica, impegnarsi nella ricerca scientifica, ecc.: tutto questo si forma nella società. Il soggetto conoscente non è un individuo isolato dagli altri (“Robinson epistemologico”), ma una personalità inserita nella vita sociale. La natura sociale del soggetto cognitivo è determinata dal suo posto nel sistema delle relazioni sociali e dalla sua appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Il fatto che la scienza fornisca previsioni della pratica a lunghissimo termine, andando oltre gli stereotipi esistenti della produzione e dell'esperienza quotidiana, significa che si occupa di un insieme speciale di oggetti della realtà che non possono essere ridotti a oggetti dell'esperienza ordinaria. Se la conoscenza quotidiana riflette solo quegli oggetti che, in linea di principio, possono essere trasformati in metodi e tipi di azione pratica esistenti storicamente stabiliti, allora la scienza è in grado di studiare tali frammenti di realtà che possono diventare oggetto di padronanza solo nella pratica del lontano futuro. Va costantemente oltre la struttura dei tipi esistenti di strutture oggettive e metodi di esplorazione pratica del mondo e apre nuovi mondi oggettivi per l'umanità delle sue possibili attività future.
Queste caratteristiche degli oggetti scientifici rendono i mezzi utilizzati nella cognizione quotidiana insufficienti per la loro padronanza.
Gli oggetti della conoscenza scientifica e quotidiana differiscono negli aspetti spaziali e temporali. Sono questi due aspetti che caratterizzano i limiti dell'oggetto della conoscenza quotidiana. È limitato nello spazio, perché riguarda le attività di piccoli gruppi sociali e produttivi. È limitato nel tempo, poiché è collegato solo a compiti e obiettivi immediati.
BIGLIETTO N. 4
La conoscenza è una realtà oggettiva data nella coscienza di una persona che, nella sua attività mentale, riflette e riproduce idealmente le connessioni naturali oggettive del mondo reale. In relazione alla filosofia della scienza e della tecnologia, dobbiamo parlare di conoscenza da tre prospettive: in primo luogo, la conoscenza è l'abilità, abilità, abilità che vengono acquisite dalle persone nel processo della loro vita; in secondo luogo, qualsiasi informazione che contenga il massimo di informazioni plausibili (adeguate) sull'oggetto; in terzo luogo, una speciale quantità di conoscenza, che è una forma cognitiva della relazione di una persona con la realtà, esistente in parallelo con un'altra: una relazione pratica. Va sottolineato che la filosofia della scienza si occupa del secondo e del terzo aspetto.
La conoscenza può essere definita come un tipo di realtà oggettiva che si forma nella coscienza di una persona nel corso della sua attività e che riproduce idealmente le connessioni realmente esistenti del mondo esterno.
Conoscenza scientificaè un tipo di conoscenza oggettiva che soddisfa i seguenti requisiti: certezza, evidenza, coerenza, verificabilità, utilità, riflessività, metodologicità, apertura alla critica, capacità di cambiare e migliorare. La conoscenza (informazione) che non soddisfa questi criteri non ha il diritto di essere nel sistema della conoscenza scientifica e non è scientifica.
La comprensione delle specificità della conoscenza scientifica deriva da come viene definita la scienza stessa e da cosa è. Tutti i movimenti filosofici (non solo la “filosofia della scienza” come specifica direzione neopositivista che ha preso forma all'inizio del XX secolo) riflettono sui problemi della scienza e della scienza stessa e sul suo posto nella cultura nella filosofia moderna. Dalla comprensione di cosa sia la scienza, segue la vera questione filosofica: se la filosofia stessa è una scienza o è qualche altra attività spirituale specifica. Da un lato, i filosofi della New Age cercarono di avvicinare la filosofia alla scienza, considerando la filosofia stessa un'attività scientifica (Kant, Hegel), dall'altro nel XIX secolo emersero molte tendenze filosofiche che facevano una netta distinzione tra filosofia e scienza (movimenti irrazionalisti - filosofia della vita, esistenzialismo, ermeneutica filosofica). Già nel XX secolo queste tendenze hanno continuato il loro sviluppo e alla fine di questo secolo continua ad esistere anche la separazione e il riavvicinamento tra filosofia e scienza: i filosofi della scienza vedono l'obiettivo della filosofia nell'analisi dei principi della conoscenza scientifica , il suo sviluppo ed evoluzione, nella considerazione della metodologia della conoscenza (analisi dei modi e dei mezzi per ottenere la conoscenza nella teoria della conoscenza), nell'analisi dei paradigmi e delle rivoluzioni scientifiche, mentre le tendenze dell'approccio non razionalistico alla filosofia portano a nuove interpretazioni della filosofia come attività letteraria (un genere di letteratura simile e parallelo ad altri generi letterari), come libera creatività e comprensione, indipendente dai rigidi principi delle scienze naturali.
In generale, il rapporto tra scienza e filosofia è complesso: oltre all'interpretazione della visione del mondo dei risultati della scienza, la filosofia è unita alla scienza anche dal desiderio di costruire la conoscenza in forma teorica, per dimostrare logicamente le sue conclusioni. La specificità della scientificità in filosofia è concettualizzata come segue:
La scienza è una sfera dell'attività umana, la cui funzione è lo sviluppo e la sistematizzazione teorica della conoscenza oggettiva sulla realtà. Nel corso dello sviluppo storico, la scienza si trasforma in una forza produttiva della società e nella più importante istituzione sociale. Il concetto di "scienza" comprende sia l'attività di acquisizione di nuove conoscenze sia il risultato di questa attività: la somma delle conoscenze scientifiche acquisite fino ad oggi, che insieme formano un quadro scientifico del mondo. Lo scopo immediato della scienza è descrivere, spiegare e prevedere i processi e i fenomeni della realtà che costituiscono l'oggetto del suo studio, sulla base delle leggi che scopre, cioè. in senso lato: un riflesso teorico della realtà.
Essendo inseparabile dal modo pratico di esplorare il mondo, la scienza come produzione di conoscenza rappresenta anche una forma specifica di attività. Se nella produzione materiale la conoscenza viene utilizzata come mezzo per aumentare la produttività del lavoro, nella scienza viene ottenuta sotto forma di descrizione teorica, diagramma del processo tecnologico, sintesi di dati sperimentali, formula per un farmaco, ecc. - costituisce l'obiettivo principale e immediato. A differenza dei tipi di attività, il cui risultato è, in linea di principio, noto in anticipo, l'attività scientifica fornisce un aumento di nuove conoscenze. Ecco perché la scienza agisce come una forza che rivoluziona costantemente altre attività.
L'emergere della scienza risale al VI secolo. aC, quando in Dr. La Grecia ha le condizioni adeguate. La formazione della scienza richiedeva la critica e la distruzione dei sistemi mitologici; perché emergesse era necessario anche un livello sufficientemente elevato di sviluppo della produzione e delle relazioni sociali, che portasse alla divisione del lavoro mentale e fisico e aprisse così la possibilità di una formazione sistematica.
Lo sviluppo della scienza è caratterizzato da un carattere cumulativo (collettivo): in ogni fase storica riassume in forma concentrata le sue conquiste passate e ogni risultato della scienza è parte integrante del suo fondo generale; non viene cancellato dai successivi progressi della conoscenza, ma viene solo ripensato e chiarito. Il processo di sviluppo scientifico influenza l’intera struttura della scienza. In ogni fase storica, la conoscenza scientifica utilizza un certo insieme di forme cognitive: categorie e concetti fondamentali, metodi, principi e schemi di spiegazione, ad es. tutto ciò che è accomunato dal concetto di stile di pensiero.
Tutta la storia della scienza è permeata da una complessa e dialettica combinazione di processi di differenziazione (separazione) e di integrazione (connessione): lo sviluppo di ambiti sempre nuovi della realtà e l'approfondimento della conoscenza portano alla differenziazione della scienza, alla sua frammentazione in aree di conoscenza sempre più specializzate; allo stesso tempo, l'esigenza di sintesi delle conoscenze si esprime costantemente nella tendenza all'integrazione delle scienze.
Secondo il loro focus, secondo il loro rapporto diretto con la pratica, le singole scienze sono solitamente suddivise in fondamentali e applicate. Il compito delle scienze fondamentali (fisica, chimica, biologia) è comprendere le leggi che governano il comportamento e l'interazione delle strutture fondamentali della natura, della società e del pensiero. L'obiettivo immediato delle scienze applicate è applicare i risultati delle scienze fondamentali per risolvere problemi non solo cognitivi, ma anche sociali e pratici. La ricerca scientifica fondamentale determina le prospettive per lo sviluppo della scienza.
Lo sviluppo del metodo scientifico è stato per lungo tempo privilegio della filosofia, che anche oggi continua a svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo dei problemi metodologici (cioè metodi, modi per ottenere conoscenza), essendo la metodologia generale della scienza (nel “ filosofia della scienza”). Nel 20 ° secolo I mezzi metodologici stanno diventando sempre più differenziati e, nella loro forma specifica, sono sempre più sviluppati dalla scienza stessa.
La formazione della scienza come istituzione sociale avvenne tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo, quando in Europa si formarono le prime società e accademie scientifiche e iniziò la pubblicazione di riviste scientifiche. A cavallo tra il XIX e il XX secolo. Sta emergendo un nuovo modo di organizzare la scienza: grandi istituti e laboratori scientifici con una potente base tecnica, che avvicina l'attività scientifica alle forme del moderno lavoro industriale. Fino alla fine. 19esimo secolo la scienza ha svolto un ruolo di supporto in relazione alla produzione. Quindi lo sviluppo della scienza inizia a superare lo sviluppo della tecnologia e della produzione e prende forma un sistema unificato "Scienza - Tecnologia - Produzione", in cui la scienza gioca un ruolo di primo piano.
Le complessità e le contraddizioni associate al ruolo crescente della scienza danno origine nella società moderna a forme diverse e spesso contraddittorie della sua valutazione ideologica.
La filosofia, essendo conoscenza scientifica, studia il mondo a livello dei suoi fondamenti universali o livello teorico. La filosofia non è solo lo studio del mondo, ma l'acquisizione della conoscenza del mondo, rifrangeta nell'aspetto della sua comprensione per una persona. Questa conclusione significa che la filosofia esiste contemporaneamente come un tipo di conoscenza scientifica e allo stesso tempo agisce come il nucleo di una visione del mondo.
Consideriamo la filosofia come un tipo di conoscenza scientifica. L'essenza di questa comprensione è stata chiaramente espressa da B. Spinoza, ritenendo che il compito della filosofia non sia piangere o ridere dei dolori e delle gioie della vita, ma comprendere le leggi del mondo e la sua conoscenza da parte dell'uomo, nascoste agli altri scienze.
Ma in cosa differisce, ad esempio, la filosofia dalle scienze naturali? Inizialmente, si è formato sulla base delle contraddizioni tra la visione mitologica del mondo e i rudimenti della conoscenza scientifica, che richiedevano di spiegare le relazioni di causa-effetto in natura, e non i miti regolari. Successivamente, in conformità con ciò, includeva nel suo contenuto quasi tutta la conoscenza scientifica esistente (da cui il nome pranascienza, protoscienza) nei secoli XVII-XVIII. e anche all'inizio del XIX secolo. filosofia chiamata meccanica teorica, biologia e altre scienze (I. Newton “Principi matematici della filosofia naturale”).
Dalla metà del XVII secolo. la scienza comincia a prendere forma come un campo di conoscenza separato e indipendente, come un tipo speciale di attività sociale. La meccanica, l'astronomia, la matematica e le altre scienze naturali acquisiscono un proprio statuto concettuale. C'è un chiarimento dei temi delle scienze speciali emersi dalla conoscenza filosofica. Sembrava che, a seguito della demarcazione, la filosofia avesse perso la propria materia di studio. “La filosofia è come Re Lear, che diede via tutte le sue proprietà ai suoi figli e fu gettato in strada come un mendicante.”
Fino ad ora, alcuni autori ritengono che la filosofia non abbia un proprio oggetto di studio, nella migliore delle ipotesi, il suo ruolo è ridotto all'analisi del linguaggio o della metodologia scientifica. Tuttavia, a una conclusione simile si può giungere se, fin dall'inizio, si parte dal presupposto che l'oggetto della filosofia comprende tutta la conoscenza sulla vita, compresa la conoscenza di tutte le altre scienze nel loro insieme. In certi stadi di sviluppo, la filosofia rappresentava veramente la protoconoscenza. Ma ciò non avvenne a causa della vastità della materia filosofica, ma a causa del sottosviluppo delle scienze particolari, e anzi della filosofia stessa, che a quel tempo non ne aveva ancora determinato lo statuto concettuale. Basti ricordare Aristotele. Da un lato, secondo Aristotele, la filosofia è proto-conoscenza, dall'altro parla della cosiddetta filosofia “prima”, la scienza dell'universale.
Ma non solo ciò presuppone la definizione della filosofia come scienza. Vediamo quali sono i criteri della conoscenza scientifica. Obiettività. Si manifesta nel desiderio di studiare gli oggetti della realtà, presi nella propria logica di sviluppo. Razionalità. Validità, prova delle affermazioni, che richiede affidamento sulla ragione, sui fondamenti logici del pensiero. Orientamento essenzialista. Divulgazione delle leggi e dei modelli di esistenza, identificazione delle dipendenze di causa-effetto tra fenomeni e processi. Conoscenza sistematica. Mirando a creare una teoria di una forma sviluppata di conoscenza scientifica che dia un'idea olistica dei modelli e delle connessioni essenziali di una particolare area della realtà. Testabilità o verificabilità affermazioni avanzate in pratica.
Conoscenza scientifica - Si tratta di un tipo e livello di conoscenza finalizzato a produrre la vera conoscenza della realtà, la scoperta di leggi oggettive basate su una generalizzazione di fatti reali. Si eleva al di sopra della cognizione ordinaria, cioè della cognizione spontanea associata all'attività vitale delle persone e alla percezione della realtà a livello di fenomeno.
Epistemologia - Questa è la dottrina della conoscenza scientifica.
Caratteristiche della conoscenza scientifica:
in primo luogo, il suo compito principale è scoprire e spiegare le leggi oggettive della realtà: naturale, sociale e pensante. Da qui il focus della ricerca sulle proprietà generali ed essenziali di un oggetto e sulla loro espressione in un sistema di astrazione.
In secondo luogo, lo scopo immediato e il valore più alto della conoscenza scientifica è la verità oggettiva, compresa principalmente con mezzi e metodi razionali.
Terzo, in misura maggiore rispetto ad altri tipi di conoscenza, è orientata a incarnarsi nella pratica.
In quarto luogo, la scienza ha sviluppato un linguaggio speciale, caratterizzato dall'accuratezza dell'uso di termini, simboli e diagrammi.
In quinto luogo, La conoscenza scientifica è un processo complesso di riproduzione della conoscenza che forma un sistema integrale e in via di sviluppo di concetti, teorie, ipotesi e leggi.
Al sesto, La conoscenza scientifica è caratterizzata sia da prove rigorose, validità dei risultati ottenuti, affidabilità delle conclusioni, sia dalla presenza di ipotesi, congetture e presupposti.
Settimo, la conoscenza scientifica richiede e ricorre a speciali strumenti (mezzi) di conoscenza: attrezzature scientifiche, strumenti di misura, dispositivi.
Ottavo, la conoscenza scientifica è caratterizzata dalla processualità. Nel suo sviluppo attraversa due fasi principali: empirica e teorica, che sono strettamente correlate tra loro.
Nono, Il campo della conoscenza scientifica consiste in informazioni verificabili e sistematizzate su vari fenomeni dell'esistenza.
Livelli di conoscenza scientifica:
Livello empirico la cognizione è uno studio sperimentale diretto, per lo più induttivo, di un oggetto. Comprende l'ottenimento dei fatti iniziali necessari: dati sui singoli aspetti e connessioni dell'oggetto, la comprensione e la descrizione dei dati ottenuti nel linguaggio della scienza e la loro sistematizzazione primaria. La cognizione in questa fase rimane ancora al livello del fenomeno, ma sono già stati creati i prerequisiti per penetrare nell'essenza dell'oggetto.
Livello teorico caratterizzato da una profonda penetrazione nell'essenza dell'oggetto studiato, non solo identificando, ma anche spiegando i modelli del suo sviluppo e funzionamento, costruendo un modello teorico dell'oggetto e la sua analisi approfondita.
Forme di conoscenza scientifica:
fatto scientifico, problema scientifico, ipotesi scientifica, prova, teoria scientifica, paradigma, quadro scientifico unificato del mondo.
Fatto scientifico - questa è la forma iniziale della conoscenza scientifica, in cui si registra la conoscenza primaria su un oggetto; è un riflesso nella coscienza del soggetto di un fatto della realtà. In questo caso il fatto scientifico è soltanto quello che può essere verificato e descritto in termini scientifici.
Problema scientifico - è una contraddizione tra fatti nuovi e conoscenza teorica esistente. Un problema scientifico può anche essere definito come una sorta di conoscenza dell'ignoranza, poiché sorge quando il soggetto conoscente si rende conto dell'incompletezza di una particolare conoscenza su un oggetto e si pone l'obiettivo di eliminare questa lacuna. Il problema comprende la questione problematica, il progetto di risoluzione del problema e il suo contenuto.
Ipotesi scientifica - Questo è un presupposto scientificamente fondato che spiega alcuni parametri dell'oggetto studiato e non contraddice i fatti scientifici noti. Deve spiegare in modo soddisfacente l'oggetto studiato, essere verificabile in linea di principio e rispondere alle domande poste dal problema scientifico.
Inoltre, il contenuto principale dell'ipotesi non dovrebbe contraddire le leggi stabilite in un dato sistema di conoscenza. I presupposti che compongono il contenuto dell'ipotesi devono essere sufficienti affinché con il loro aiuto sia possibile spiegare tutti i fatti su cui viene avanzata l'ipotesi. I presupposti dell'ipotesi non dovrebbero essere logicamente contraddittori.
Lo sviluppo di nuove ipotesi nella scienza è associato alla necessità di una nuova visione del problema e all'emergere di situazioni problematiche.
Prova - questa è una conferma dell'ipotesi.
Tipi di prove:
Esercitati a servire come conferma diretta
Prova teorica indiretta, inclusa la conferma mediante argomentazioni che indicano fatti e leggi (percorso induttivo), derivazione di un'ipotesi da altre disposizioni più generali e già provate (percorso deduttivo), confronto, analogia, modellizzazione, ecc.
L’ipotesi provata serve come base per la costruzione di una teoria scientifica.
Teoria scientifica - questa è una forma di conoscenza scientifica affidabile su un determinato insieme di oggetti, che è un sistema di affermazioni e prove interconnesse e contiene metodi per spiegare, trasformare e prevedere i fenomeni di una determinata area dell'oggetto. In teoria, sotto forma di principi e leggi, si esprime la conoscenza delle connessioni essenziali che determinano l'emergere e l'esistenza di determinati oggetti. Le principali funzioni cognitive della teoria sono: sintetizzante, esplicativa, metodologica, predittiva e pratica.
Tutte le teorie si sviluppano all’interno di determinati paradigmi.
Paradigma - è un modo speciale di organizzare la conoscenza e di vedere il mondo, influenzando la direzione di ulteriori ricerche. Paradigma
può essere paragonato ad un dispositivo ottico attraverso il quale osserviamo un particolare fenomeno.
Molte teorie vengono costantemente sintetizzate un quadro scientifico unificato del mondo, cioè un sistema olistico di idee sui principi generali e sulle leggi della struttura dell'essere.
Metodi di conoscenza scientifica:
Metodo(dal greco Metodos - percorso verso qualcosa) - è un modo di attività in qualsiasi forma.
Il metodo comprende tecniche che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi, regolano l'attività umana e i principi generali da cui nascono queste tecniche. I metodi dell'attività cognitiva formano la direzione della cognizione in una fase particolare, l'ordine delle procedure cognitive. Nel loro contenuto, i metodi sono oggettivi, poiché in definitiva sono determinati dalla natura dell'oggetto e dalle leggi del suo funzionamento.
Metodo scientifico - Si tratta di un insieme di regole, tecniche e principi che garantiscono la cognizione logica di un oggetto e la ricezione di una conoscenza affidabile.
Classificazione dei metodi di conoscenza scientifica può essere fatto per vari motivi:
Primo motivo. In base alla loro natura e al ruolo nella cognizione, si distinguono metodi - tecniche, che consistono in regole, tecniche e algoritmi di azione specifici (osservazione, esperimento, ecc.) e metodi - approcci, che indicano l'indirizzo e il metodo generale della ricerca (analisi di sistema, analisi funzionale, metodo diacronico, ecc.).
Secondo motivo. Per scopo funzionale si distinguono:
a) metodi di pensiero umani universali (analisi, sintesi, confronto, generalizzazione, induzione, deduzione, ecc.);
b) metodi empirici (osservazione, esperimento, indagine, misurazione);
c) metodi di livello teorico (modellazione, esperimenti mentali, analogia, metodi matematici, metodi filosofici, induzione e deduzione).
Terza baseè il grado di generalità. Qui i metodi sono suddivisi in:
a) metodi filosofici (dialettici, formali-logici, intuitivi, fenomenologici, ermeneutici);
b) metodi scientifici generali, cioè metodi che guidano il corso della conoscenza in molte scienze, ma a differenza dei metodi filosofici, ciascun metodo scientifico generale (osservazione, esperimento, analisi, sintesi, modellazione, ecc.) risolve il proprio problema, caratteristico solo per questo ;
c) metodi speciali.
Alcuni metodi di conoscenza scientifica:
Osservazione - questa è una percezione mirata e organizzata di oggetti e fenomeni per raccogliere fatti.
Sperimentare - è una ricreazione artificiale di un oggetto conoscibile in condizioni controllate e controllate.
Formalizzazione è un riflesso della conoscenza acquisita in un linguaggio formalizzato inequivocabile.
Metodo assiomatico - questo è un modo di costruire una teoria scientifica quando si basa su determinati assiomi, dai quali si deducono logicamente tutte le altre disposizioni.
Metodo ipotetico-deduttivo - creazione di un sistema di ipotesi interconnesse deduttivamente, da cui derivano in ultima analisi le spiegazioni dei fatti scientifici.
Metodi induttivi per stabilire la relazione causale dei fenomeni:
metodo di somiglianza: se due o più casi del fenomeno studiato hanno una sola circostanza precedente comune, allora questa circostanza in cui sono simili tra loro è probabilmente la causa del fenomeno ricercato;
metodo della differenza: se il caso in cui si verifica il fenomeno che ci interessa e il caso in cui non si verifica sono simili in tutto, tranne una circostanza, allora questa è l'unica circostanza in cui differiscono tra loro, ed è probabilmente la causa del fenomeno desiderato;
metodo di modifica accompagnatoria: se il verificarsi o il cambiamento di un fenomeno precedente provoca ogni volta il verificarsi o il cambiamento di un altro fenomeno che lo accompagna, allora il primo di essi è probabilmente la causa del secondo;
metodo residuo: Se è stabilito che la causa di una parte di un fenomeno complesso non è causata da circostanze precedenti note, tranne una di esse, allora possiamo supporre che questa unica circostanza sia la causa della parte del fenomeno in studio che ci interessa.
Metodi di pensiero universali:
- Confronto- stabilire le somiglianze e le differenze tra oggetti della realtà (ad esempio confrontiamo le caratteristiche di due motori);
- Analisi- dissezione mentale di un oggetto nel suo insieme
(scomponiamo ogni motore nelle caratteristiche dei suoi componenti);
- Sintesi- unificazione mentale in un unico insieme degli elementi identificati a seguito dell'analisi (mentalmente combiniamo le migliori caratteristiche ed elementi di entrambi i motori in uno - virtuale);
- Astrazione- evidenziare alcune caratteristiche di un oggetto e distrarre da altre (ad esempio studiamo solo il design del motore e temporaneamente non teniamo conto del suo contenuto e funzionamento);
- Induzione- movimento del pensiero dal particolare al generale, dai dati individuali alle disposizioni più generali e, infine, all'essenza (prendiamo in considerazione tutti i casi di guasto di un motore di questo tipo e, sulla base di ciò, giungiamo a conclusioni sul prospettive per il suo ulteriore funzionamento);
- Deduzione- movimento del pensiero dal generale allo specifico (sulla base dei modelli generali di funzionamento del motore, facciamo previsioni sull'ulteriore funzionamento di un particolare motore);
- Modellazione- costruzione di un oggetto mentale (modello) simile a quello reale, il cui studio consentirà di ottenere le informazioni necessarie alla comprensione dell'oggetto reale (creazione di un modello di un motore più avanzato);
- Analogia- conclusione sulla somiglianza degli oggetti in alcune proprietà, basata sulla somiglianza in altre caratteristiche (conclusione sul guasto del motore basato su un colpo caratteristico);
- Generalizzazione- combinare singoli oggetti in un determinato concetto (ad esempio, creando il concetto "motore").
La scienza:
- Questa è una forma di attività spirituale e pratica delle persone finalizzata al raggiungimento della conoscenza oggettivamente vera e alla sua sistematizzazione.
Complessi scientifici:
UN)Scienze naturaliè un sistema di discipline il cui oggetto è la natura, cioè una parte dell'esistenza che esiste secondo leggi non create dall'attività umana.
B)Scienze sociali- questo è un sistema di scienze sulla società, cioè una parte dell'esistenza che viene costantemente ricreata nelle attività delle persone. Le scienze sociali comprendono le scienze sociali (sociologia, teoria economica, demografia, storia, ecc.) e le discipline umanistiche che studiano i valori della società (etica, estetica, studi religiosi, filosofia, scienze giuridiche, ecc.)
V)Scienza tecnica- queste sono scienze che studiano le leggi e le specificità della creazione e del funzionamento di sistemi tecnici complessi.
G)Scienze antropologiche- questo è un insieme di scienze sull'uomo in tutta la sua integrità: antropologia fisica, antropologia filosofica, medicina, pedagogia, psicologia, ecc.
Inoltre, le scienze si dividono in fondamentali, teoriche e applicate, che hanno un collegamento diretto con la pratica industriale.
Criteri scientifici: universalità, sistematizzazione, coerenza relativa, relativa semplicità (è considerata buona una teoria che spiega la più ampia gamma possibile di fenomeni sulla base di un numero minimo di principi scientifici), potenziale esplicativo, potere predittivo, completezza per un dato livello di conoscenza.
La verità scientifica è caratterizzata da obiettività, evidenza, sistematicità (ordine basato su determinati principi) e verificabilità.
Modelli di sviluppo scientifico:
teoria della riproduzione (proliferazione) di P. Feyerabend, che afferma l'origine caotica dei concetti, paradigma di T. Kuhn, convenzionalismo di A. Poincaré, psicofisica di E. Mach, conoscenza personale di M. Polanyi, epistemologia evolutiva di S. Toulmin, programma di ricerca di I. Lakatos, analisi tematica della scienza di J. Holton.
K. Popper, considerando la conoscenza sotto due aspetti: statico e dinamico, ha sviluppato il concetto di crescita della conoscenza scientifica. Secondo lui, crescita della conoscenza scientifica - questo è il ripetuto rovesciamento delle teorie scientifiche e la loro sostituzione con altre migliori e più perfette. La posizione di T. Kuhn è radicalmente diversa da questo approccio. Il suo modello comprende due fasi principali: la fase della “scienza normale” (il dominio dell’uno o dell’altro paradigma) e la fase della “rivoluzione scientifica” (il crollo del vecchio paradigma e l’istituzione di uno nuovo).
Rivoluzione scientifica globale - questo è un cambiamento nel quadro scientifico generale del mondo, accompagnato da cambiamenti negli ideali, nelle norme e nei fondamenti filosofici della scienza.
Nel quadro della scienza naturale classica si distinguono due rivoluzioni. Primo associato alla formazione delle scienze naturali classiche nel XVII secolo. Secondo La rivoluzione risale alla fine del XVIII - inizio del XIX secolo. e segna il passaggio alla scienza disciplinare organizzata. Terzo La rivoluzione scientifica globale copre il periodo che va dalla fine del XIX secolo alla metà del XX secolo. ed è associato alla formazione di scienze naturali non classiche. Alla fine del 20° - inizio del 21° secolo. nuovi cambiamenti radicali stanno avvenendo nei fondamenti della scienza, che possono essere caratterizzati come il quarto rivoluzione globale. Nel corso di esso nasce una nuova scienza post-non classica.
Tre rivoluzioni (su quattro) hanno portato alla creazione di nuovi tipi di razionalità scientifica:
1. Tipo classico di razionalità scientifica(secoli XVIII-XIX). A quel tempo furono stabilite le seguenti idee sulla scienza: apparve il valore della vera conoscenza universale oggettiva, la scienza fu considerata un'impresa affidabile e assolutamente razionale, con l'aiuto della quale tutti i problemi dell'umanità potevano essere risolti, fu considerata la conoscenza scientifica naturale il risultato più alto, l'oggetto e il soggetto della ricerca scientifica sono stati presentati in termini rigidi di confronto epistemologico, la spiegazione è stata interpretata come una ricerca di cause e sostanze meccaniche. Nella scienza classica si credeva che solo le leggi di tipo dinamico potessero essere vere e proprie leggi.
2. Tipo non classico di razionalità scientifica(XX secolo). Le sue caratteristiche: la coesistenza di concetti alternativi, la complicazione delle idee scientifiche sul mondo, l'assunzione di fenomeni probabilistici, discreti, paradossali, la dipendenza dalla presenza irriducibile del soggetto nei processi studiati, l'assunzione dell'assenza di un concetto inequivocabile connessione tra teoria e realtà; la scienza inizia a determinare lo sviluppo della tecnologia.
3. Razionalità scientifica di tipo post-non classico(fine del 20° - inizio del 21° secolo). È caratterizzato dalla comprensione dell'estrema complessità dei processi studiati, dall'emergere di una prospettiva basata sui valori nello studio dei problemi e da un alto grado di utilizzo di approcci interdisciplinari.
Scienza e società:
La scienza è strettamente interconnessa con lo sviluppo della società. Ciò si manifesta principalmente nel fatto che è in definitiva determinato, condizionato dalla pratica sociale e dai suoi bisogni. Tuttavia, ogni decennio aumenta l’influenza inversa della scienza sulla società. La connessione e l'interazione tra scienza, tecnologia e produzione sta diventando sempre più forte: la scienza si sta trasformando in una forza produttiva diretta della società. Come viene mostrato?
in primo luogo, La scienza sta ora superando lo sviluppo della tecnologia e sta diventando la forza trainante nel progresso della produzione materiale.
In secondo luogo, La scienza permea tutte le sfere della vita pubblica.
Terzo, La scienza è sempre più focalizzata non solo sulla tecnologia, ma anche sull'uomo stesso, sullo sviluppo delle sue capacità creative, sulla cultura del pensiero e sulla creazione di prerequisiti materiali e spirituali per il suo sviluppo olistico.
In quarto luogo, lo sviluppo della scienza porta all'emergere della conoscenza parascientifica. Questo è un nome collettivo per concetti e insegnamenti ideologici e ipotetici caratterizzati da un orientamento antiscientifico. Il termine "parascienza" si riferisce ad affermazioni o teorie che si discostano in misura maggiore o minore dagli standard della scienza e contengono sia proposizioni fondamentalmente errate che possibilmente vere. Concetti più spesso attribuiti alla parascienza: concetti scientifici obsoleti, come l'alchimia, l'astrologia, ecc., che hanno svolto un certo ruolo storico nello sviluppo della scienza moderna; la medicina popolare e altri insegnamenti “tradizionali”, ma in una certa misura opposti alla scienza moderna; “scienze” sportive, familiari, culinarie, lavorative, ecc., che sono esempi di sistematizzazione dell'esperienza pratica e della conoscenza applicata, ma non corrispondono alla definizione di scienza in quanto tale.
Approcci per valutare il ruolo della scienza nel mondo moderno. Primo approccio - scientismo afferma che con l'aiuto delle conoscenze scientifiche naturali e tecniche è possibile risolvere tutti i problemi sociali
Secondo approccio - antiscientismo, Basandosi sulle conseguenze negative della rivoluzione scientifica e tecnologica, rifiuta la scienza e la tecnologia, considerandole forze ostili alla vera essenza dell'uomo. La pratica storico-sociale mostra che è ugualmente sbagliato assolutizzare in modo esorbitante la scienza e sottovalutarla.
Funzioni della scienza moderna:
1. Cognitivo;
2. Visione culturale e del mondo (fornire alla società una visione del mondo scientifica);
3. Funzione di forza produttiva diretta;
4. Funzione del potere sociale (le conoscenze e i metodi scientifici sono ampiamente utilizzati per risolvere tutti i problemi della società).
Modelli di sviluppo della scienza: continuità, una complessa combinazione di processi di differenziazione e integrazione delle discipline scientifiche, approfondimento ed espansione dei processi di matematizzazione e informatizzazione, teorizzazione e dialettalizzazione della conoscenza scientifica moderna, alternanza di periodi di sviluppo relativamente calmi e periodi di “brusco cambiamento” (scientifico rivoluzioni) di leggi e principi.
La formazione della moderna NCM è in gran parte associata alle scoperte della fisica quantistica.
Scienze e tecnologia
Tecnica nel senso ampio del termine - è un artefatto, cioè tutto ciò che è creato artificialmente. Gli artefatti sono: materiali e ideali.
Tecnica nel senso stretto del termine - si tratta di un insieme di dispositivi e mezzi materiali, energetici e informativi creati dalla società per svolgere le proprie attività.
La base per l’analisi filosofica della tecnologia era l’antico concetto greco di “techne”, che significava abilità, arte e capacità di creare qualcosa da materiale naturale.
M. Heidegger credeva che la tecnologia fosse il modo di essere di una persona, un modo di autoregolamentarsi. J. Habermas credeva che la tecnologia unisse tutto ciò che è “materiale” che si oppone al mondo delle idee. O. Toffler ha dimostrato la natura ondulatoria dello sviluppo della tecnologia e il suo impatto sulla società.
Il modo in cui la tecnologia si manifesta è la tecnologia. Se ciò con cui una persona influenza è la tecnologia, allora lo è anche il modo in cui influenza tecnologia.
Tecnosfera- questa è una parte speciale del guscio terrestre, che è una sintesi di artificiale e naturale, creata dalla società per soddisfare i suoi bisogni.
Classificazione delle apparecchiature:
Per tipo di attività distinti: materiale e produzione, trasporti e comunicazioni, ricerca scientifica, processo di apprendimento, medicina, sport, casa, militare.
Per tipo di processo naturale utilizzato Esistono apparecchiature meccaniche, elettroniche, nucleari, laser e altri tipi.
Per livello di complessità strutturale Sorsero le seguenti forme storiche di tecnologia: pistole(lavoro manuale, lavoro mentale e attività umana), automobili E mitragliatrici. La sequenza di queste forme di tecnologia, in generale, corrisponde alle fasi storiche dello sviluppo della tecnologia stessa.
Tendenze nello sviluppo tecnologico nella fase attuale:
La dimensione di molti mezzi tecnici è in costante crescita. Quindi, la benna di un escavatore nel 1930 aveva un volume di 4 metri cubi, e ora è di 170 metri cubi. Gli aerei da trasporto trasportano già 500 o più passeggeri e così via.
E' emersa una tendenza di natura opposta, verso la riduzione delle dimensioni delle attrezzature. Ad esempio, la creazione di personal computer in microminiatura, registratori senza cassette, ecc. è già diventata una realtà.
Le innovazioni tecniche si ottengono sempre più attraverso l’applicazione della conoscenza scientifica. Un esempio lampante di ciò è la tecnologia spaziale, che è diventata l'incarnazione degli sviluppi scientifici di oltre due dozzine di scienze naturali e tecniche. Le scoperte nella creatività scientifica danno slancio alla creatività tecnica con le sue invenzioni caratteristiche. La fusione di scienza e tecnologia in un unico sistema che ha cambiato radicalmente la vita dell’uomo, della società e della biosfera si chiama rivoluzione scientifica e tecnologica(NTR).
C'è una fusione sempre più intensa di mezzi tecnici in sistemi e complessi complessi: fabbriche, centrali elettriche, sistemi di comunicazione, navi, ecc. La prevalenza e la scala di questi complessi ci permettono di parlare dell'esistenza di una tecnosfera sul nostro pianeta.
Il campo dell'informazione sta diventando un'area di applicazione importante e in costante crescita della tecnologia moderna.
Informatizzazione - è il processo di produzione, archiviazione e diffusione delle informazioni nella società.
Forme storiche di informatizzazione: discorso colloquiale; scrivere; tipografia; apparecchi riproduttivi elettrici – elettronici (radio, telefono, televisione, ecc.); Computer (computer).
L'uso diffuso dei computer ha segnato una fase speciale dell'informatizzazione. A differenza delle risorse fisiche, l'informazione come risorsa ha una proprietà unica: quando viene utilizzata, non si restringe, ma, al contrario, si espande. L'inesauribilità delle risorse informative accelera bruscamente il ciclo tecnologico “conoscenza - produzione - conoscenza”, provoca una crescita a valanga del numero di persone coinvolte nel processo di acquisizione, formalizzazione ed elaborazione della conoscenza (negli Stati Uniti, il 77% dei dipendenti è coinvolti nel campo delle attività e dei servizi di informazione) e ha un impatto sulla prevalenza dei sistemi mass media e sulla manipolazione dell’opinione pubblica. Sulla base di queste circostanze, molti scienziati e filosofi (D. Bell, T. Stoneier, Y. Masuda) hanno proclamato l'avvento della società dell'informazione.
Segni della società dell'informazione:
Accesso gratuito per chiunque, ovunque e in qualsiasi momento a qualsiasi informazione;
La produzione dell'informazione in questa società deve essere realizzata nei volumi necessari ad assicurare la vita dell'individuo e della società in tutte le sue parti e direzioni;
La scienza dovrebbe occupare un posto speciale nella produzione dell'informazione;
Automazione e funzionamento accelerati;
Sviluppo prioritario della sfera delle attività e dei servizi di informazione.
Indubbiamente la società dell'informazione apporta alcuni vantaggi e benefici. Tuttavia non si possono non notare i suoi problemi: il furto di computer, la possibilità di una guerra informatica basata sull’informazione, la possibilità di instaurare una dittatura dell’informazione e il terrore delle organizzazioni dei fornitori, ecc.
Atteggiamento umano verso la tecnologia:
Da un lato, fatti e idee di sfiducia e ostilità alla tecnologia. Nell'antica Cina, alcuni saggi taoisti negavano la tecnologia, motivando le loro azioni dal fatto che quando usi la tecnologia diventi dipendente da essa, perdi la libertà di azione e diventi tu stesso un meccanismo. Negli anni '30 del XX secolo, O. Spengler, nel suo libro "L'uomo e la tecnologia", sosteneva che l'uomo era diventato schiavo delle macchine e da esse sarebbe stato portato alla morte.
Allo stesso tempo, l’apparente indispensabilità della tecnologia in tutte le sfere dell’esistenza umana dà talvolta luogo a un’apologia sfrenata della tecnologia, una sorta di ideologia del tecnicismo. Come viene mostrato? Innanzitutto. Nell'esagerare il ruolo e l'importanza della tecnologia nella vita umana e, in secondo luogo, nel trasferire le caratteristiche inerenti alle macchine all'umanità e alla personalità. I sostenitori della tecnocrazia vedono prospettive di progresso nella concentrazione del potere politico nelle mani dell’intellighenzia tecnica.
Conseguenze dell'influenza della tecnologia sull'uomo:
Utile componente include quanto segue:
l’uso diffuso della tecnologia ha contribuito a quasi raddoppiare l’aspettativa media di vita umana;
la tecnologia ha liberato l'uomo dalle circostanze costrittive e ha aumentato il suo tempo libero;
la nuova tecnologia dell'informazione ha ampliato qualitativamente la portata e le forme dell'attività intellettuale umana;
la tecnologia ha portato progressi nel processo educativo; la tecnologia ha aumentato l’efficienza dell’attività umana in vari ambiti della società.
Negativo l'impatto della tecnologia sull'uomo e sulla società è il seguente: alcuni dei suoi tipi di tecnologia rappresentano un pericolo per la vita e la salute delle persone, è aumentata la minaccia di disastri ambientali, è aumentato il numero di malattie professionali;
una persona, diventando una particella di un sistema tecnico, viene privata della sua essenza creativa; una quantità crescente di informazioni provoca una tendenza decrescente nella quota di conoscenza che una persona è in grado di possedere;
la tecnologia può essere utilizzata come mezzo efficace di soppressione, controllo totale e manipolazione di una persona;
L’impatto della tecnologia sulla psiche umana è enorme, sia attraverso la realtà virtuale, sia attraverso la sostituzione della catena “simbolo-immagine” con un’altra “immagine-immagine”, che porta ad un arresto nello sviluppo del pensiero figurativo e astratto, come così come la comparsa di nevrosi e malattie mentali.
Ingegnere(dal francese e dal latino significa "creatore", "creatore", "inventore" in senso lato) è una persona che crea mentalmente un oggetto tecnico e controlla il processo di produzione e funzionamento. Attività di ingegneria - Questa è l'attività di creazione mentale di un oggetto tecnico e di gestione del processo di produzione e funzionamento. L'attività ingegneristica è emersa dall'attività tecnica nel XVIII secolo durante la Rivoluzione Industriale.
Filosofia classica conoscenza identificata con la conoscenza scientifica. La moderna teoria della conoscenza distingue anche la conoscenza ordinaria, mitologica, religiosa, artistica e quasi scientifica. Questi tipi di conoscenza sono considerati necessari e importanti per comprendere l'essenza dell'attività cognitiva. In generale, la conoscenza può essere prescientifica (protoscientifica), extrascientifica (ordinaria, quasi scientifica, religiosa) e scientifica. La scienza è il tipo più alto di forme storiche di conoscenza del mondo.
Per molto tempo la conoscenza si è sviluppata in forme prescientifiche, rappresentate dalla conoscenza quotidiana, artistica, mitologica e religiosa. Hanno permesso solo di affermare e descrivere superficialmente i fatti. La conoscenza scientifica presuppone non solo la descrizione, ma anche la spiegazione, l'identificazione dell'intero complesso di cause che danno origine a un fenomeno. La scienza si impegna per la massima accuratezza e obiettività della conoscenza ottenuta, la sua indipendenza dall'argomento. Nessun’altra componente della cultura si pone un simile obiettivo. La conoscenza moderna si basa sulle conquiste della scienza.
Conoscenza ordinaria basato sull'esperienza umana quotidiana e coerente con il buon senso, si tratta di un'affermazione e di una descrizione dei fatti. È la base per tutti gli altri tipi di conoscenza.
Conoscenza artisticaè una questione artistica e non cerca di essere probatorio o motivato. La forma di esistenza della conoscenza è un'immagine artistica, una finzione.
Conoscenza religioso-mitologicaè una sintesi della riflessione razionale ed emotiva della realtà. È rappresentato nel misticismo, nella magia e in vari insegnamenti esoterici.
Conoscenza quasi scientifica (parascientifica). svolge funzioni compensative, pretendendo di spiegare quei fenomeni che la scienza nega o non può ancora spiegare. È rappresentato nell'ufologia e in varie scienze occulte (alchimia, astrologia, Kabbalah).
Conoscenza scientifica- l'area più profonda e affidabile della conoscenza umana. Secondo M. Weber (1864-1920), la scienza è il massimo pulito incarnazione del principio di razionalità.
La conoscenza scientifica non ha limiti. La scienza è il prodotto spirituale più alto della società: la base della visione del mondo e della produzione materiale, uno strumento del dominio dell'uomo sulla natura e della conoscenza di sé. La conoscenza scientifica determina il mondo spirituale dell'uomo moderno. La maggior parte della cultura materiale è creata sulla base della scienza. L'intera civiltà europea è costruita sugli ideali di un atteggiamento scientifico e razionale nei confronti della realtà.
La scienza– una forma di cognizione finalizzata a produrre una conoscenza oggettiva della realtà che abbia prova e verifica empirica.
Scientificità non significa verità assoluta, ma movimento verso di essa. Non esiste un confine rigido tra conoscenza scientifica e non scientifica; è flessibile. Ad esempio, l'alchimia e l'astrologia facevano parte della scienza medievale. La vera scienza comprende ciò che è provato e ciò che non lo è; in essa si intrecciano il razionale e l’irrazionale. Si pone il problema dei criteri per separare la conoscenza scientifica da quella non scientifica.
Criteri scientifici Sono:
-razionalità(espressività logica, generalità, coerenza e semplicità),
-obiettività(indipendenza dall’arbitrarietà del soggetto),
-apodittico(validità teorica e pratica),
-consistenza(organizzazione della conoscenza scientifica sotto forma di fatti, metodi, teorie, ipotesi concordati di comune accordo),
-verificabilità(osservabilità, disponibilità al pubblico).
Questi criteri sono di natura profondamente materialistica e sono diretti contro l’introduzione nella scienza di vari tipi di “cose in sé” misteriose e sfuggenti. In una forma semplificata, il loro significato può essere trasmesso dai principi di osservabilità e semplicità. Esiste solo ciò che colpisce direttamente o indirettamente i sensi o gli strumenti. Per tutto il resto vale il rasoio di Occam: le entità non vanno introdotte oltre il necessario.
Le principali funzioni della scienza sono descrizione, spiegazione e previsione di oggetti e fenomeni della realtà. La struttura e il futuro dell’Universo, della vita e della società rientrano nella competenza diretta della scienza. Una funzione importante della scienza è fondamentale: insegna a una persona ad avvicinarsi a tutto con dubbio, senza dare nulla per scontato, senza prove.
Lo scopo della scienza– scoperta di modelli e principi generali di conoscenza e padronanza della realtà.
La scienza comprende un sistema di discipline correlate. Le discipline scientifiche, a seconda del grado di distanza dalla pratica, sono classificate in fondamentali, non direttamente finalizzate alla pratica, e applicate. Per materia e metodo, le scienze si dividono in naturali, tecniche e pubbliche (sociali e umanitarie).
Il compito delle scienze fondamentali è comprendere le leggi alla base dell'esistenza e dell'interazione delle strutture di base della natura, della società e del pensiero. Le scienze applicate mirano ad applicare i risultati delle scienze fondamentali per risolvere problemi industriali e socio-pratici.
Le scienze fondamentali comprendono: scienze filosofiche, scienze matematiche, scienze naturali (meccanica, astronomia, fisica, chimica, geologia, geografia, biologia, zoologia, antropologia, ecc.), scienze sociali (storia, archeologia, etnografia, economia, scienze politiche, diritto ed ecc.), discipline umanistiche (psicologia, logica, linguistica, ecc.). La filosofia è la scienza (anche se non completamente) delle leggi più generali della realtà. Le scienze applicate includono: informatica, scienze tecniche (tecnologia delle macchine, resistenza dei materiali, metallurgia, ingegneria elettrica, energia nucleare, astronautica, ecc.), scienze agricole, mediche, pedagogiche, ecc.
Il processo di conoscenza scientifica comprende due livelli principali: empirico e teorico, le cui differenze sono determinate dall'oggetto e dai metodi di ricerca.
Un oggetto empirico si forma come risultato dell'esperienza sensoriale. Metodi specifici a livello empirico sono osservazione E sperimentare(intervento controllato del soggetto nell'oggetto in studio). Le forme caratteristiche della conoscenza scientifica a livello empirico sono fatto empirico(una frase che cattura l'esperienza) e legge empirica(descrizione empirica).
Metodi specifici del livello teorico sono idealizzazione(selezionando un oggetto nella sua forma pura, astraendo da proprietà non importanti: punto, corpo nero assoluto, gas ideale) e Formalizzazione(passaggio dall'operare con concetti all'operare con simboli). L'idea ben nota di I. Kant (1724-1804) è che nella dottrina della natura c'è tanta scienza quanta matematica [Kant I. Principi metafisici delle scienze naturali // Kant I. Opere. In 6 volumi M.: Mysl, 1963. T.6. P.53-76, P.58].
Forme caratteristiche della conoscenza teorica: ipotesi(proposta ragionevole ma non confermata) e teoria(la più alta forma di organizzazione della conoscenza, che dà un'idea olistica delle leggi di una certa area della realtà); gli elementi principali della teoria sono fatti, leggi, regole di inferenza logica e prove.
Il livello empirico e quello teorico hanno metodi e forme comuni. Metodi generali: analisi e sintesi, induzione e deduzione, astrazione e concretizzazione, modellazione (creazione di un oggetto con determinate proprietà). Forme generali: modello, domanda (frase che richiede spiegazione, risposta) e problema (insieme di domande).
Lo sviluppo della scienza non è solo un processo cumulativo. La conoscenza scientifica comprende anche momenti di salto. Si distinguono: principali periodi di sviluppo della scienza:
-scienza normale(paradigmatico) - un periodo di sviluppo cumulativo e graduale della scienza, miglioramento della conoscenza scientifica nell'ambito di un determinato paradigma;
-scienza rivoluzionaria(rivoluzione scientifica) - un periodo di cambiamento di paradigma sotto la pressione di una serie di fatti empirici.
Paradigma(Greco esempio) – un insieme di fatti fondamentali, teorie, ipotesi, problemi, metodi, criteri scientifici, esempi di risoluzione di problemi, stili di pensiero scientifico, ecc., che garantiscono il funzionamento della conoscenza scientifica.
Nella storia della scienza, tali paradigmi sono aristotelici, classici (newtoniani) e non classici. Un cambiamento di paradigmi è un processo psicologicamente difficile per la comunità scientifica, che può essere paragonato a un cambiamento di fede religiosa, poiché le rivoluzioni scientifiche influenzano la logica della conoscenza scientifica.
Il concetto centrale del “paradigma” della storia della scienza è stato sviluppato da uno dei principali rappresentanti del postpositivismo, Thomas Kuhn (1922-1996) nella sua opera “La struttura delle rivoluzioni scientifiche” (1962). T. Kuhn ha aderito alla filosofia della scienza esternalismo, A differenza di internalismo affermando che la direzione, il ritmo di sviluppo e il contenuto della conoscenza scientifica sono determinati non dalla logica interna dello sviluppo della scienza, ma dal suo ambiente socioculturale.
Capitolo 14. COSCIENZA
©2015-2019 sito
Tutti i diritti appartengono ai loro autori. Questo sito non ne rivendica la paternità, ma ne fornisce l'uso gratuito.
Data di creazione della pagina: 22-07-2016