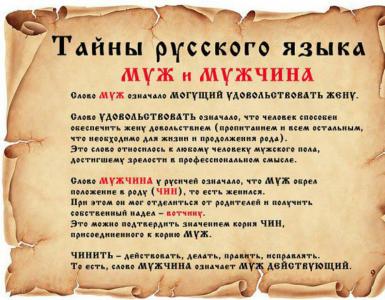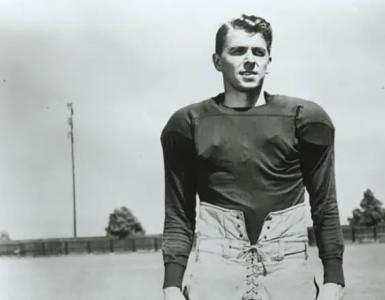Cos'è l'essudazione? Qual è la differenza tra trasudato ed essudato? Infiammazione essudativa: caratteristiche dei fluidi essudativi specifici
L'essudazione è il rilascio della parte liquida del sangue attraverso la parete vascolare nel tessuto infiammato. Il fluido che lascia i vasi - essudato - permea il tessuto infiammato o si accumula nelle cavità (pleurica, peritoneale, pericardica, ecc.).
A seconda delle caratteristiche della composizione cellulare e biochimica, si distinguono i seguenti tipi di essudato:
1. L'essudato sieroso, quasi trasparente, è caratterizzato da un contenuto proteico moderato (3-5%, principalmente albumina), basso peso specifico (1015-1020), pH compreso tra 6 e 7. Il sedimento contiene granulociti singoli segmentati e cellule desquamate delle membrane sierose.
L'essudato sieroso si forma durante l'infiammazione delle membrane sierose (pleurite sierosa, pericardite, peritonite, ecc.), nonché durante ustioni, infiammazioni virali o allergiche. L'essudato sieroso viene facilmente assorbito e non lascia tracce né forma un leggero ispessimento delle membrane sierose.
2. L'essudato fibrinoso è caratterizzato da un alto contenuto di fibrinogeno che, a contatto con i tessuti danneggiati, si trasforma in fibrina, a seguito della quale l'essudato si addensa. La fibrina si deposita sulla superficie delle membrane sierose sotto forma di masse villose e sulla superficie delle mucose sotto forma di pellicole. In relazione a queste caratteristiche, l'infiammazione fibrinosa è divisa in difterite (film ben posizionati) e lobare (film sciolti). L'infiammazione cronica si sviluppa nello stomaco, nell'intestino, nei bronchi e nella trachea. L'infiammazione difterica è caratteristica dell'esofago, delle tonsille e della cavità orale. L'infiammazione fibrinosa può essere causata da agenti patogeni di dissenteria, tubercolosi, difterite, virus, tossine di origine endogena (ad esempio uremia) o esogena (avvelenamento sublimato).
La prognosi dell'infiammazione fibrinosa è in gran parte determinata dalla localizzazione e dalla profondità del processo.
Sulle membrane sierose, le masse di fibrina subiscono parzialmente l'autolisi, e la maggior parte è organizzata, cioè ricoperta di tessuto connettivo, e quindi possono formarsi aderenze e cicatrici, interrompendo la funzione dell'organo.
Sulle mucose, i film fibrinosi subiscono autolisi e vengono respinti, lasciando un difetto nella mucosa - un'ulcera, la cui profondità è determinata dalla profondità della perdita di fibrina. La guarigione delle ulcere può avvenire rapidamente, ma in alcuni casi (nell'intestino crasso in caso di dissenteria) viene ritardata a lungo.
3. L'essudato purulento è un liquido infiammatorio torbido di colore verdastro, viscoso, contenente albumine, globuline, fili di fibrina, enzimi, prodotti di proteolisi tissutale e un gran numero di leucociti polimorfonucleati, per lo più distrutti (corpi purulenti).
L'infiammazione purulenta può verificarsi in qualsiasi tessuto, organo, cavità sierose, pelle e manifestarsi sotto forma di ascesso o flemmone. L'accumulo di essudato purulento nelle cavità corporee è chiamato empiema.
I fattori eziologici dell'infiammazione purulenta sono vari; può essere causata da stafilococchi, streptococchi, meningococchi, gonococchi, micobatteri, funghi patogeni, ecc.
5. L'essudato putrefattivo (icoro) si sviluppa con la partecipazione di anaerobi patogeni nel processo infiammatorio. I tessuti infiammati subiscono una decomposizione putrefattiva con formazione di gas maleodoranti ed essudato verde sporco.
6. L'essudato emorragico è caratterizzato dal contenuto di quantità variabili di globuli rossi, a seguito dei quali acquisisce un colore rosato o rosso.
Qualsiasi tipo di essudato può assumere carattere emorragico; ciò dipende dal grado di permeabilità dei vasi coinvolti nel processo infiammatorio. L'essudato misto a sangue si forma durante l'infiammazione causata da microrganismi altamente virulenti: agenti patogeni della peste, dell'antrace, del vaiolo, dell'influenza tossica. L'essudato emorragico si osserva anche nell'infiammazione allergica e nelle neoplasie maligne.
7. Forme miste di essudato - sieroso-fibrinoso, sieroso-purulento, sieroso-emorragico, purulento-fibrinoso e altri - si verificano quando si verifica un'infezione secondaria, quando le difese del corpo diminuiscono o la progressione di un tumore maligno.
Con l'infiammazione delle mucose si forma un essudato con un alto contenuto di muco, leucociti, linfociti e cellule epiteliali desquamate. Tale essudato scorre lungo la mucosa, quindi l'infiammazione è chiamata catarrale (katarrheo - flusso verso il basso). Queste sono rinite catarrale, gastrite, rinosinusite, enterocolite. In base alla natura dell'essudato si parla di catarro sieroso, mucoso o purulento. Di solito, l'infiammazione della mucosa inizia con il catarro sieroso, che poi si trasforma in mucoso e purulento.
L'essudazione funge da uno dei segni di iperemia venosa e allo stesso tempo determina la natura dei cambiamenti tissutali nel sito di infiammazione.
Il fattore principale nell'essudazione è un aumento della permeabilità vascolare nell'area dell'infiammazione. L’aumento della permeabilità vascolare avviene in due fasi. La prima fase è precoce, immediata, si sviluppa in seguito all'azione dell'agente alterante e raggiunge il massimo nel giro di alcuni minuti. Questa fase è causata dall'azione dell'istamina, del leucotriene E4, della serotonina, della bradichinina su venule di diametro non superiore a 100 micron. La permeabilità dei capillari rimane praticamente invariata. L'aumento della permeabilità nel territorio delle venule è associato alla contrazione delle cellule endoteliali del vaso, all'arrotondamento delle cellule e alla formazione di spazi interendoteliali attraverso i quali esce la parte liquida del sangue e delle cellule. La seconda fase è tardiva, lenta, si sviluppa gradualmente nell'arco di diverse ore, giorni e talvolta dura fino a 100 ore. Questa fase è caratterizzata da un persistente aumento della permeabilità vascolare (arteriole, capillari, venule), causato dal danno alla parete vascolare da parte degli enzimi lisosomiali, dei metaboliti attivi dell'ossigeno, delle prostaglandine, del complesso dei leucotrieni (MLC) e degli ioni idrogeno.
Nei meccanismi di sviluppo dell'essudazione, oltre all'aumento della permeabilità vascolare, un certo ruolo appartiene alla pinocitosi, il processo di cattura attiva e passaggio di minuscole goccioline di plasma sanguigno attraverso la parete endoteliale. A questo proposito, l'essudazione può essere considerata come una sorta di processo microsecretorio fornito da meccanismi di trasporto attivi. L'attivazione della pinocitosi nell'endotelio microvascolare nel sito dell'infiammazione precede un aumento della permeabilità della parete vascolare dovuto alla riduzione delle cellule endoteliali.
Di grande importanza nello sviluppo dell'essudazione sono i fattori osmotici e oncotici.
Nei tessuti infiammati la pressione osmotica aumenta, mentre la pressione osmotica del sangue rimane praticamente invariata. L'iperosmia dei tessuti è causata da un aumento della concentrazione di particelle osmoattive al loro interno: ioni, sali, composti organici a basso peso molecolare. I fattori che causano l'iperosmia comprendono l'aumento della dissociazione dei sali dovuta all'acidosi tissutale (acidosi lattica di tipo A), il rilascio di potassio e dei relativi anioni macromolecolari dalle cellule, l'aumento della degradazione dei composti organici complessi in composti meno complessi e finemente dispersi, nonché la compressione e la trombosi del sistema linfatico. vasi, impedendo la rimozione degli osmoli dalla fonte dell'infiammazione.
Contemporaneamente all'aumento della pressione osmotica si verifica un aumento della pressione oncotica nei tessuti della sede dell'infiammazione, mentre nel sangue diminuisce la pressione oncotica. Quest'ultimo è dovuto al rilascio dai vasi nei tessuti, prima di tutto, di proteine finemente disperse - albumine, e con l'aumento della permeabilità dei vasi - globuline e fibrinogeno (Serov V.V., Paukov V.S., 1995).
Inoltre, nel tessuto stesso, sotto l'influenza delle proteasi lisosomiali, si verifica la disgregazione di macromolecole proteiche complesse, che contribuisce anche ad un aumento della pressione oncotica nei tessuti del focolaio infiammatorio.
Un fattore che contribuisce all'essudazione è un aumento della pressione idrostatica nel microcircolo e nell'area di filtrazione della parte liquida del sangue.
Il significato biologico dell'essudato come componente dell'infiammazione è che insieme all'essudato, le immunoglobuline, i componenti attivi del complemento, gli enzimi plasmatici, le chinine e le sostanze biologicamente attive rilasciate dalle cellule del sangue attivate vengono rilasciate nel tessuto alterato. Entrando nel sito dell'infiammazione, insieme ai mediatori tissutali, forniscono l'opsonizzazione dell'agente patogeno, stimolano le cellule fagocitiche, partecipano ai processi di uccisione e lisi dei microrganismi, assicurano la pulizia della ferita e la successiva riparazione dei tessuti. Nell'essudato si trovano prodotti metabolici, tossine, fattori di patogenicità tossici rilasciati dal flusso sanguigno, ad es. il focus dell'infiammazione svolge una funzione di drenaggio. A causa dell'essudato, il flusso sanguigno nel sito dell'infiammazione prima rallenta e poi si interrompe completamente quando i capillari, le venule e i vasi linfatici vengono compressi. Quest'ultimo porta alla localizzazione del processo e impedisce la diffusione dell'infezione e lo sviluppo di una condizione settica.
Allo stesso tempo, l'accumulo di essudato può portare allo sviluppo di forti dolori dovuti alla compressione delle terminazioni nervose e dei conduttori. Come risultato della compressione delle cellule parenchimali e dell'interruzione della microcircolazione in esse, possono verificarsi disfunzioni di vari organi. Quando si organizza l'essudato, si possono formare aderenze che causano spostamento, deformazione e patologia delle funzioni di varie strutture. In alcuni casi, il decorso del processo infiammatorio è complicato dall'ingresso dell'essudato negli alveoli e nelle cavità del corpo e porta allo sviluppo di edema polmonare, pleurite, peritonite e pericardite.
A seconda delle cause dell'infiammazione e delle caratteristiche dello sviluppo del processo infiammatorio, si distinguono i seguenti tipi di essudati:
emorragico.
sieroso,
fibrinoso,
Di conseguenza, si osserva un'infiammazione sierosa, fibrinosa, purulenta ed emorragica. Esistono anche tipi combinati di infiammazione: zolfo-fibrinosa, fibrinosa-purulenta, purulenta-emorragica. Qualsiasi essudato dopo essere stato infettato da microbi putrefattivi è chiamato putrefattivo. Pertanto non è consigliabile separare tale essudato in una sezione separata. Gli essudati contenenti un gran numero di goccioline di grasso (chilo) sono chiamati chilosi o chiloidi. Va notato che l'ingresso di goccioline di grasso nell'essudato è di uno qualsiasi dei tipi sopra indicati. Può essere causato dalla localizzazione del processo infiammatorio in luoghi in cui si accumulano grandi vasi linfatici nella cavità addominale e da altri effetti collaterali. Pertanto, è difficilmente consigliabile individuare il tipo di essudato chiloso come indipendente. Un esempio di essudato sieroso durante l'infiammazione è il contenuto di una vescica derivante da un'ustione sulla pelle (ustione di secondo grado).
Un esempio di essudato fibrinoso o infiammazione è la placca fibrinosa nella faringe o nella laringe nella difterite. L'essudato fibrinoso si forma nell'intestino crasso durante la dissenteria, negli alveoli polmonari durante l'infiammazione lobare.
Essudato sieroso. Le sue proprietà e meccanismi di formazione sono riportati nel § 126 e nella tabella. 16.
Essudato fibrinoso. Una caratteristica della composizione chimica dell'essudato fibrinoso è il rilascio di fibrinogeno e la sua precipitazione sotto forma di fibrina nel tessuto infiammato. Successivamente la fibrina precipitata si dissolve per l'attivazione dei processi fibrinolitici. Le fonti di fibrinolisina (plasmina) sono sia il plasma sanguigno che il tessuto infiammato stesso. L’aumento dell’attività fibrinolitica del plasma sanguigno durante il periodo di fibrinolisi nella polmonite lobare, ad esempio, è facile da osservare determinando questa attività nell’essudato di una vescica artificiale creata sulla pelle del paziente. Pertanto, il processo di sviluppo dell'essudato fibrinoso nel polmone si riflette, per così dire, in qualsiasi altro luogo del corpo del paziente, dove si verifica un processo infiammatorio in una forma o nell'altra.
Essudato emorragico si forma durante un'infiammazione in rapido sviluppo con grave danno alla parete vascolare, quando i globuli rossi entrano nel tessuto infiammato. L'essudato emorragico si osserva nelle pustole di vaiolo con il cosiddetto vaiolo. Si verifica con il carbonchio dell'antrace, con l'infiammazione allergica (fenomeno di Arthus) e altri processi infiammatori in rapido sviluppo e in rapido sviluppo.
Essudato purulento e l'infiammazione purulenta sono causate da microbi piogeni (strepto-stafilococchi e altri microbi patogeni).
Durante lo sviluppo dell'infiammazione purulenta, l'essudato purulento entra nel tessuto infiammato e i leucociti lo permeano e lo infiltrano, situati in gran numero attorno ai vasi sanguigni e tra le cellule proprie dei tessuti infiammati. Il tessuto infiammato in questo momento è solitamente denso al tatto. I medici definiscono questo stadio di sviluppo dell'infiammazione purulenta come lo stadio dell'infiltrazione purulenta.
La fonte degli enzimi che causano la distruzione (fusione) del tessuto infiammato sono i leucociti e le cellule danneggiate durante il processo infiammatorio. I leucociti granulari (neutrofili) sono particolarmente ricchi di enzimi idrolitici. I granuli di neutrofili contengono proteasi, catepsina, chimotripsina, fosfatasi alcalina e altri enzimi. Quando i leucociti e i loro granuli (lisosomi) vengono distrutti, gli enzimi entrano nel tessuto e causano la distruzione delle sue proteine, proteine-lipidi e altri componenti.
Sotto l'influenza degli enzimi, il tessuto infiammato diventa morbido e i medici definiscono questo stadio come lo stadio della fusione purulenta o dell'ammorbidimento purulento. Un'espressione tipica e chiaramente visibile di questi stadi di sviluppo dell'infiammazione purulenta è l'infiammazione della sacca peripelina della pelle (foruncolo) o la fusione di molte bolle in un focolaio infiammatorio: un carbonchio e un'infiammazione purulenta acuta e diffusa del tessuto sottocutaneo - flemmone. L'infiammazione purulenta non è considerata completa, “matura” fino a quando non si verifica la fusione purulenta del tessuto. Come risultato della fusione purulenta dei tessuti, si forma un prodotto di questa fusione: il pus.
Pus solitamente è un liquido denso e cremoso di colore giallo-verde, sapore dolciastro e odore specifico. Una volta centrifugato, il pus viene diviso in due parti:
sedimento costituito da elementi cellulari,
la parte liquida è siero purulento. In posizione eretta, il siero purulento a volte coagula.
Le cellule del pus vengono chiamate corpi purulenti. Sono leucociti del sangue (neutrofili, linfociti, monociti) in vari stadi di danno e decadimento. Il danno al protoplasma dei corpi purulenti è evidente sotto forma di comparsa di un gran numero di vacuoli al loro interno, interruzione dei contorni del protoplasma e offuscamento dei confini tra il corpo purulento e il suo ambiente. Con macchie speciali, nei corpi purulenti si trova una grande quantità di glicogeno e goccioline di grasso. La comparsa di glicogeno libero e grasso nei corpi purulenti è una conseguenza della rottura dei complessi polisaccaridi e dei composti proteici-lipidici nel protoplasma dei leucociti. I nuclei dei corpi purulenti diventano più densi (picnosi) e si disgregano (cariorressi). Si osservano anche fenomeni di gonfiore e graduale dissoluzione del nucleo o di sue parti nel corpo purulento (cariolisi). La disintegrazione dei nuclei dei corpi purulenti provoca un aumento significativo della quantità di nucleoproteine e acidi nucleici nel pus.
Il siero purulento non differisce significativamente nella composizione dal plasma sanguigno (Tabella 17).
|
Tabella 17 |
||
|
Componenti |
Siero di pus |
Plasma del sangue |
|
Solidi | ||
|
Grassi e lipidi con colesterolo | ||
|
Sali inorganici | ||
Il contenuto di zucchero negli essudati in generale e nell'essudato purulento in particolare è solitamente inferiore a quello del sangue (0,5-0,6 g/l), a causa degli intensi processi di glicolisi. Di conseguenza, l'essudato purulento contiene una quantità significativamente maggiore di acido lattico (0,9-1,2 g/l e superiore). Intensi processi proteolitici nel fuoco purulento causano un aumento del contenuto di polipeptidi e aminoacidi.
A seconda della composizione qualitativa si distinguono i seguenti tipi di essudati: sieroso, fibrinoso, purulento, putrefattivo, emorragico
Essudato sierosoÈ caratterizzato da un contenuto proteico moderato (3-5%), per lo più finemente disperse (albumina) e da una piccola quantità di PML ed è abbastanza trasparente. Il suo peso specifico è 1015-1020. In termini di composizione e proprietà fisico-chimiche, l'essudato sieroso differisce poco dal trasudato, un liquido che si accumula nei tessuti durante l'edema stagnante. Un esempio di essudato sieroso è il contenuto di una bolla sulla pelle con un'ustione di secondo grado, nonché con infiammazioni virali e allergiche.
Se la fibrina è mescolata con l'essudato sieroso, allora essudato fibroso. Un esempio è la placca fibrinosa nella faringe o nella laringe durante la difterite. Inoltre, l'essudato fibrinoso può essere osservato nella tubercolosi e nella dissenteria. Quando l'infiammazione si risolve, i film di fibrina vengono sciolti dalla plasmina-fibrinolisina. In questo processo, un ruolo importante è svolto dagli attivatori del plasminogeno: enzimi lisosomiali dell'essudato dei leucociti.
Quando i globuli rossi e i loro prodotti di degradazione iniziano a mescolarsi con l’essudato sieroso, essudato emorragico, avere un colore rosa o rosso. Qualsiasi tipo di infiammazione può diventare emorragica. Caratteristico delle lesioni tubercolari, della peste, dell'antrace, del vaiolo, dell'influenza tossica e dell'infiammazione allergica, ad es. nei casi in cui vi è un aumento della permeabilità e persino la distruzione dei vasi sanguigni.
Nel caso in cui ci siano molti fagociti nel sito dell'infiammazione, ma sono funzionalmente difettosi. Conseguenze particolarmente gravi si verificano se, per ragioni genetiche, i neutrofili producono scarsamente fattori microbicidi - H2O2, O2 - e altri bioossidanti. In questo caso, qualsiasi infiammazione può portare allo sviluppo di ascessi e seguire un decorso prolungato. L'infiammazione purulenta si trascinerà anche in una situazione in cui i monociti arrivati nel sito disinibiscono debolmente i processi di recupero.
Parte della PML nel sito dell'infiammazione muore durante la fagocitosi. La causa della morte cellulare è l'eccessiva attivazione degli enzimi lisosomiali e la ridotta permeabilità delle membrane lisosomiali. Di conseguenza, gli enzimi dei granuli entrano nel citoplasma e la cellula subisce l'autodigestione (autolisi). Questo processo è spesso chiamato figurativamente “suicidio” della cellula. La permeabilità delle membrane lisosomiali nei neutrofili fagocitici aumenta sotto l'influenza di bioossidanti - O 2 -, H 2 O 2, OH", che uccidono i microbi. Pertanto, il neutrofilo deve sacrificarsi per il bene del corpo per ripristinare omeostasi.Una percentuale particolarmente elevata di neutrofili muore durante l'infiammazione purulenta acuta, causata da cocchi piogeni (strepto, stafilococchi, pneumococchi, gonococchi, ecc.) A seguito della morte attiva dei leucociti e di altri tipi di cellule in questi casi , la formazione essudato purulento o pus. Se non c'è drenaggio, l'essudato purulento può diffondersi in sempre più nuovi territori. Ad esempio, possiamo citare una situazione in cui i focolai di infiammazione del follicolo pilifero della pelle (foruncolo) si fondono tra loro e danno origine a un focolaio più ampio di infiammazione purulenta: un carbonchio. Se non viene drenato in modo tempestivo, si svilupperà un'infiammazione purulenta diffusa del tessuto sottocutaneo: flemmone.
Putrefattivo (icoro) l'essudato si distingue per la presenza di prodotti di decomposizione del tessuto putrefattivo. Ha un colore verde sporco e un odore sgradevole. Formato dall'aggiunta di anaerobi patogeni.
Si osservano essudati misti durante l'infiammazione che si verifica sullo sfondo di difese indebolite del corpo e, di conseguenza, un'infezione secondaria. Ci sono sieroso-fibrinoso, sieroso-purulento, sieroso-emorragico, purulento-fibrinoso.
Significato biologico dell'essudato:
L'essudato riduce la concentrazione delle tossine e quindi indebolisce il loro effetto sul tessuto.
L'essudato contiene enzimi che distruggono le sostanze tossiche e lisano il tessuto necrotico.
L'essudato rilascia nel tessuto immunoglobuline che hanno un effetto antitossico (e antimicrobico) e hanno anche un effetto protettivo generale per la presenza di fattori protettivi aspecifici: lisozima, complemento, interferone, beta-lisina, ecc.
Con l'essudato nel tessuto viene rilasciata una grande quantità di fibrinogeno, che si trasforma in fibrina e quindi ha un effetto protettivo, impedendo la diffusione del fattore patogeno, principalmente attraverso gli spazi intercellulari.
L'essudato è un liquido infiammatorio pieno di proteine e contenente proteine del sangue formate.
Nel corpo umano ha il suo carattere e si forma durante l'infiammazione. Un processo come il rilascio e il movimento dell'effusione infiammatoria nelle cavità e nei tessuti del corpo è chiamato essudazione.
Navigazione nell'articolo
Tipi di essudato
Le tipologie dipendono direttamente dalla composizione qualitativa e quantitativa delle proteine presenti nel liquido.
Si distinguono i seguenti tipi di essudati:
- fibrinoso;
- sieroso;
- emorragico;
- purulento;
- putrefattivo;
- misto.
Composizione dell'essudato
La composizione dipende dalla causa della formazione del liquido infiammatorio, dall'organo o dal tessuto in cui si forma.
Essudato sieroso
La composizione è costituita principalmente da albumina e acqua. Appare quando il processo infiammatorio della pelle e delle mucose è ancora in una fase iniziale.
Potrebbe trattarsi, ad esempio, di vesciche sui palmi dopo un lavoro prolungato con i remi o con una pala. Se le cavità sierose e le mucose si infiammano: pericardite, peritonite, pleurite sierosa.
Essudato fibrinoso
Si forma con un danno sufficientemente grave all'endotelio ed è accompagnato dalla perdita di fibrinogeno ad alto peso molecolare. Questo tipo è caratteristico dell'infiammazione del peritoneo, del tratto respiratorio superiore, del colon e del pericardio.
Essudato purulento
Formato nella maggior parte dei casi durante infezioni causate da batteri piogeni: streptococchi, pneumococchi, stafilococchi.
Il versamento purulento contiene frammenti di tessuto necrotico, lisati mediante digestione enzimatica, la stragrande maggioranza dei leucociti normali e distrutti.
Essudato emorragico
Caratteristico della polmonite influenzale acuta, avvelenamento da fosgene, antrace.
Proprietà dell'essudato
La formazione di versamento è considerata una componente significativa della risposta infiammatoria. Grazie all'essudazione, la concentrazione delle tossine esistenti, la cui formazione avviene nel sito dell'infiammazione, viene ridotta e vengono distrutte dagli enzimi proteolitici provenienti dal plasma sanguigno.
Tuttavia, l'essudato può anche avere conseguenze negative. Ad esempio, se il gonfiore della laringe è causato dall'essudazione, una persona può morire per soffocamento; Con l'infiammazione delle meningi può verificarsi un aumento della pressione intracranica potenzialmente letale.
Il liquido sieroso si accumula nelle cavità pleuriche (liquido pleurico), nella cavità peritoneale (liquido ascitico), nella cavità pericardica (liquido pericardico) e viene rimosso mediante puntura o incisione di queste cavità. Per prevenire la coagulazione, è possibile aggiungere al liquido di prova una soluzione di citrato di sodio al 5% (2-5 ml di soluzione per 100 ml di liquido) o sciacquare con questa soluzione le pareti del recipiente in cui verrà raccolto il liquido sieroso. Per i test, tutto il liquido sieroso raccolto viene inviato al laboratorio in contenitori puliti. A seconda del meccanismo di formazione, si distinguono due tipi di fluido sieroso: trasudato ed essudato.
Trasudato
Il trasudato (liquido non infiammatorio) appare in caso di disturbi della circolazione generale e locale (insufficienza ventricolare destra del cuore, ipertensione portale dovuta a trombosi della vena porta, cirrosi epatica, pericardite adesiva, ecc.), diminuzione della pressione oncotica nei vasi (ipoproteinemia di varia origine), alterato metabolismo degli elettroliti ( il più delle volte con un aumento della concentrazione di sodio, un aumento della produzione di aldosterone), ecc. Il trasudato è solitamente di colore giallo chiaro, trasparente, la sua densità relativa varia da 1005-1015 (determinata allo stesso modo della densità relativa dell'urina, cioè mediante un urometro). La quantità di proteine nel fluido sieroso è determinata dalla torbidità che si forma quando viene aggiunto l'acido solfosalicilico o con il metodo Brandberg-Roberts-Stolnikov. Il trasudato contiene da 5 a 10 g/l di proteine.
Essudato
L'essudato è un fluido infiammatorio. L'essudato sieroso è di colore giallo chiaro e trasparente. In tutti gli altri casi, l'essudato è torbido e il suo colore dipende dalla natura (sanguinoso, purulento, ecc.). La densità relativa dell'essudato è 1,018 e superiore. Contiene da 30 a 80 g/l di proteine.
Non è sempre facile distinguere tra trasudato ed essudato, poiché esistono liquidi che sono simili nelle loro proprietà sia all'essudato che al trasudato, ed essudato con una bassa densità relativa e un contenuto proteico relativamente basso. Per differenziare questi liquidi viene utilizzata la reazione di Rivalta.
Metodologia. Un cilindro stretto con una capacità di 200 ml viene riempito con acqua, vengono aggiunte 2-3 gocce di acido acetico glaciale e agitate. Quindi aggiungere 1-2 gocce del liquido di prova da una pipetta nella soluzione debole di acido acetico risultante e osservare su uno sfondo nero la comparsa di una torbidità simile a una nuvola, che ricorda il fumo di sigaretta. Nell'essudato la torbidità aumenta man mano che la goccia scende e raggiunge il fondo del cilindro (reazione positiva); nel trasudato una leggera torbidità si dissipa e scompare prima di raggiungere il fondo del cilindro (reazione negativa).
Dopo aver sistemato il liquido sieroso consegnato per l'esame
Dopo 1-2 ore, il sedimento viene raccolto con una provetta di vetro per la centrifugazione (come quando si esamina l'urina). Se c'è molto liquido, il sedimento viene raccolto in più provette da centrifuga (fino a 10). Dopo la centrifugazione per 5-10 minuti a 1500-3000 giri al minuto, tutti i sedimenti risultanti vengono versati in una provetta e centrifugati nuovamente. Di conseguenza, si ottiene un precipitato concentrato, dal quale vengono preparati preparati nativi per l'esame microscopico.
Se nel liquido sono presenti circonvoluzioni fibrinose, brandelli o coaguli, la loro quantità e volume vengono descritti nell'analisi. I fasci e gli scarti vengono selezionati con una spatola stretta e un ago dal liquido versato in una capsula Petri, quindi da essi vengono separati dei pezzi per la preparazione di preparati nativi, poiché gli elementi formati si trovano solitamente nel fascio. Il fascio posto su un vetrino viene allungato con un ago e una spatola. In caso contrario il risultato sarà un preparato denso, inadatto all'esame microscopico (in esso gli elementi sagomati saranno indistinguibili).
Dopo l'esame microscopico, i preparati nativi vengono colorati secondo Romanovsky - Giemsa o Pappenheim. Tempo di verniciatura: non più di 5 minuti. In presenza di liquido sieroso di pus, dal sedimento vengono preparati strisci per la colorazione di Ziehl-Neelsen e di Gram.
Tipi di essudato
A seconda del tipo di processo patologico, si distinguono diversi tipi di essudato.
Essudato sieroso e sieroso-fibrinoso
L'essudato sieroso e sieroso-fibrinoso si osserva nelle infezioni da stafilococco, streptococco, tubercolosi, sifilide e reumatismi. I coaguli fibrinosi sono solitamente presenti nell'essudato sieroso-fibrinoso. La microscopia rivela un piccolo numero di elementi cellulari. Predominano i linfociti. A volte viene rilevato un numero significativo di granulociti neutrofili, o monociti, o macrofagi, o granulociti eosinofili, o tutti questi elementi in qualsiasi rapporto. Nelle forme prolungate di pleurite il citogramma è caratterizzato dalla presenza di plasmacellule. Spesso, all'inizio della pleurite tubercolare, viene rivelato un citogramma variegato (granulociti eosinofili e neutrofili, istiociti, elementi di tubercoloma, ecc.), Per cui a volte deve essere differenziato dalla linfogranulomatosi.
Essudato sieroso-purulento e purulento
L'essudato sieroso-purulento e purulento è torbido, denso, giallo-verde, a volte brunastro o color cioccolato; osservato con infezione batterica. I citogrammi sono caratterizzati da un gran numero di granulociti neutrofili, spesso con alterazioni degenerative, presenza di macrofagi, singole cellule giganti di corpi estranei e detriti.
Essudato putrido
L'essudato putrido ha un odore putrido e un colore verdastro. Nei citogrammi c'è una grande quantità di detriti di cellule disintegrate, aghi di acidi grassi, a volte si trovano cristalli di ematoidina e colesterolo e molti microrganismi, compresi quelli anaerobici.
Essudato eosinofilo
L'essudato eosinofilo è caratterizzato da un gran numero di granulociti eosinofili, che possono raggiungere più del 90% della composizione cellulare del versamento. A volte si osserva con tubercolosi o altre infezioni, ascessi, traumi, metastasi multiple di cancro ai polmoni, migrazione di larve di nematodi nei polmoni, ecc. Per natura, l'essudato eosinofilo può essere sieroso, emorragico e purulento.
Essudato emorragico
L'essudato emorragico compare nel mesotelioma, nelle metastasi tumorali, nella diatesi emorragica e nelle ferite al torace. Quando l'infezione penetra nella cavità con essudato emorragico, può trasformarsi in purulento-emorragico. Una presenza di pus nell'essudato viene rilevata utilizzando il test di Petrov: quando viene aggiunta acqua, l'essudato sterile diventa limpido per emolisi dei globuli rossi, mentre quello infetto rimane torbido per la presenza di leucociti.
Durante l'esame microscopico, l'attenzione viene prestata ai globuli rossi. Se l'emorragia si è già fermata, si possono identificare solo vecchie forme di eritrociti con vari segni della loro morte (microforme, "gelsi", ombre di eritrociti, poichilociti, schizociti, eritrociti vacuolati, frammentati, ecc.). La comparsa di globuli rossi invariati sullo sfondo di quelli vecchi e modificati indica un nuovo sanguinamento. La presenza solo di globuli rossi invariati indica un nuovo sanguinamento. Quando l'essudato emorragico si trasforma in purulento o in un'altra forma, compaiono gli elementi cellulari corrispondenti. Durante il periodo di riassorbimento dell'essudato emorragico, a volte fino all'80% dei suoi elementi cellulari sono granulociti eosinofili, il che è un segno favorevole.
Essudato di colesterolo.
Qualsiasi essudato incistato che persiste a lungo (diversi anni) può trasformarsi in colesterolo. L'essudato di colesterolo è denso, di colore giallastro o brunastro, con una lucentezza perlescente, a volte color cioccolato (a seconda del numero di globuli rossi disintegrati). Sulle pareti di una provetta inumidita con essudato sono macroscopicamente visibili calchi di cristalli di colesterolo sotto forma di minuscole scintille. L'esame microscopico rivela cellule grasse degenerate, prodotti di decadimento cellulare, goccioline di grasso e cristalli di colesterolo.
Essudato lattiginoso.
Esistono tre tipi di tale essudato.
Essudato chiloso appare quando una quantità significativa di linfa entra nella cavità sierosa da grandi vasi linfatici. Questo liquido contiene un gran numero di piccole goccioline di grasso, che è colorato di rosso dal Sudan III e di nero dall'osmio. Stando nel liquido si forma uno strato cremoso che galleggia verso l'alto.
Per chiarire il liquido, aggiungere all'essudato 1-2 gocce di alcali caustici con etere. A seconda della causa che ha provocato la rottura del vaso linfatico, gli elementi cellulari dell'essudato possono essere diversi. Se un tumore si è sviluppato in un vaso e lo ha distrutto, è possibile trovare cellule tumorali nel fluido.
Essudato simile al chilo osservato con la rottura intensiva delle cellule grasse degenerate. L'esame microscopico rivela un'abbondanza di cellule grasso-degenerate, detriti grassi e goccioline di grasso di varie dimensioni. Non c'è microflora. L'essudato simile al chilo si osserva nella pleurite cronica purulenta, nella cirrosi epatica atrofica, nelle neoplasie maligne, ecc.
Essudato pseudochilico macroscopicamente somiglia anche al latte, ma le particelle sospese nell'essudato non vengono colorate dal Sudan III e dall'osmio e non si dissolvono se riscaldate. La microscopia rivela mesoteliociti e singole goccioline di grasso. L'essudato pseudochilico si verifica nella degenerazione lipoide e lipoide-amiloide dei reni.
Guida alla formazione pratica in diagnostica clinica di laboratorio / Ed. prof. MA Bazarnova, prof. VT Morozova.- K.: Vyshcha School, 1988.- 318 p., 212 ill.