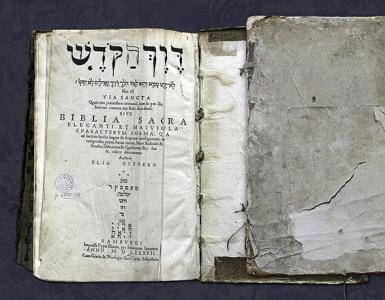Chursin V.V. Fisiologia clinica della circolazione sanguigna (materiale metodologico per lezioni frontali ed esercitazioni). Fisiopatologia della perdita ematica acuta Determinazione del volume sanguigno
È piuttosto difficile definire il concetto di “volume sanguigno circolante”, poiché è una quantità dinamica e cambia costantemente in un ampio intervallo.
A riposo, non tutto il sangue entra in circolazione, ma solo una certa quantità, che completa la circolazione in un periodo di tempo relativamente breve, necessario per mantenere la circolazione sanguigna. Su questa base il concetto è entrato nella pratica clinica "volume di sangue circolante."
Negli uomini giovani il volume del sangue è di 70 ml/kg. Diminuisce con l'età fino a 65 ml/kg di peso corporeo. Nelle donne giovani il BCC è pari a 65 ml/kg e tende anch'esso a diminuire. In un bambino di due anni, il volume del sangue è di 75 ml/kg di peso corporeo. In un uomo adulto, il volume plasmatico è in media pari al 4-5% del peso corporeo.
Pertanto, un uomo che pesa 80 kg ha un volume sanguigno medio di 5600 ml e un volume plasmatico di 3500 ml. Valori più accurati dei volumi di sangue si ottengono tenendo conto della superficie corporea, poiché il rapporto tra volume di sangue e superficie corporea non cambia con l'età. Nei pazienti obesi, il volume del volume sanguigno per 1 kg di peso corporeo è inferiore a quello dei pazienti con peso normale. Ad esempio, nelle donne obese il BCC è pari a 55-59 ml/kg di peso corporeo. Normalmente il 65-75% del sangue è contenuto nelle vene, il 20% nelle arterie e il 5-7% nei capillari (Tabella 10.3).
Una perdita di 200-300 ml di sangue arterioso nell'adulto, pari a circa 1/3 del suo volume, può provocare marcate alterazioni emodinamiche; la stessa perdita di sangue venoso ammonta solo a 1/10-1/13 e non comporta ad eventuali disturbi circolatori.
Distribuzione dei volumi di sangue nel corpo
Una diminuzione del volume del sangue durante la perdita di sangue è dovuta alla perdita di globuli rossi e plasma, durante la disidratazione - a causa della perdita di acqua, durante l'anemia - a causa della perdita di globuli rossi e durante il mixedema - a una diminuzione del numero di globuli rossi e volume plasmatico. L'ipervolemia è caratteristica della gravidanza, dell'insufficienza cardiaca e della poliglobulia.
Quanti litri di sangue ci sono in una persona a cui difficilmente sarai interessato se non necessario. Tuttavia, questo indicatore è molto importante in condizioni di perdita di sangue per qualsiasi motivo. Ci sembra di capire che il sangue gioca un ruolo importante, che senza di esso non c'è vita. E fino a che punto la sua perdita è accettabile?
La quantità di sangue nel corpo di un adulto è, in media, da quattro a sei litri. Il volume del sangue circolante dipende dall'età, dal sesso, dal peso corporeo, dall'altezza e dalla massa muscolare (il volume del sangue di una persona che pratica attivamente uno sport è maggiore di quello di chi conduce uno stile di vita sedentario).
La quantità di sangue nel corpo delle donne è leggermente inferiore a quella degli uomini e solitamente varia da 3,5 a 4,5 litri. Tuttavia, durante la gravidanza, il volume del sangue circolante nelle donne aumenta in modo significativo.
Il sangue nel corpo umano svolge funzioni essenziali. Fornisce:
- trasporto di gas (O2, CO2), nutrienti, ormoni, neurotrasmettitori, vitamine, enzimi, elettroliti, ecc.;
- saturazione dei tessuti con ossigeno (il trasferimento dell'ossigeno è assicurato dall'emoglobina presente nei globuli rossi);
- saturazione di tutte le cellule e tessuti con nutrienti essenziali;
- consegna dei prodotti finali metabolici al luogo del loro smaltimento (reni, ghiandole sudoripare, sistema respiratorio, tratto gastrointestinale);
- proteggere il corpo dagli agenti infettivi a causa della presenza di fattori battericidi, anticorpi, complessi immunitari, ecc. nel sangue;
- mantenimento della termoregolazione e della pressione sanguigna;
- regolazione del funzionamento di organi e ghiandole attraverso il trasporto di sostanze biologicamente attive.
Il volume del sangue varia leggermente da persona a persona. Tuttavia, è possibile calcolare approssimativamente quanti litri di sangue ha una persona conoscendo il suo peso.
Quanti litri di sangue ha un adulto?
Il volume del sangue nel corpo umano varia dal 6 all'8% del peso corporeo. Nei neonati, il volume del sangue è leggermente maggiore rispetto a quello di un adulto e ammonta a circa il 15% del peso corporeo.
Entro il primo anno di vita, la quantità di sangue in una persona ammonta a circa l'1% del peso corporeo totale.
Esempio di calcolo
- 70*0,06 (sei per cento di 70 kg) = 4,2 litri;
- 70*0,08 (otto per cento di 70 kg) = 5,6 litri.
Pertanto, una persona che pesa 70 kg ha un volume sanguigno medio compreso tra 4,2 e 5,6 litri.
Tuttavia, questo calcolo consente solo di calcolare approssimativamente quanti litri di sangue ci sono in una persona. Per calcoli più accurati, dovresti concentrarti sulle formule utilizzate in terapia intensiva.
Quanto sangue c'è in una persona in litri: calcolo esatto utilizzando la formula
Il volume del sangue circolante nelle donne viene calcolato utilizzando la formula: 
60 millilitri* per peso corporeo in chilogrammi.
Quanti litri di sangue nei pazienti di sesso maschile sono determinati dalla formula:
70 millilitri* per peso corporeo in chilogrammi.
Sulla base di questo criterio, tutti i sanguinamenti sono divisi in due tipi principali: esterni e interni.
Nei casi in cui il sangue da una ferita fuoriesce nell'ambiente esterno, si parla di all'aperto sanguinamento. Tale sanguinamento è evidente e viene rapidamente diagnosticato. Il sanguinamento esterno comprende anche il sanguinamento attraverso il drenaggio da una ferita postoperatoria.
Interno chiamato sanguinamento in cui il sangue entra nel lume di organi cavi, tessuti o cavità interne del corpo. Sono presenti emorragie interne evidenti e nascoste. Interno ovvio sono quei sanguinamenti in cui il sangue, anche in forma alterata, compare all'esterno dopo un certo periodo di tempo, e quindi la diagnosi può essere fatta senza un esame complesso e l'identificazione di sintomi particolari. Ad esempio, quando si sanguina da un'ulcera allo stomaco, il sangue entra nel suo lume e, se si accumula a sufficienza, si verifica il vomito. Quando il sangue nello stomaco entra in contatto con l'acido cloridrico, cambia colore e consistenza: si verifica il cosiddetto vomito da "fondi di caffè". Se il sanguinamento non è massiccio o l'ulcera è localizzata nel duodeno, il sangue segue la via naturale del contenuto intestinale ed esce dall'ano sotto forma di feci nere (melena). Il sanguinamento interno evidente include anche il sanguinamento dal sistema biliare - emobilia, dai reni e dal tratto urinario - ematuria.
A nascosto Nell'emorragia interna il sangue entra in varie cavità e quindi non è visibile. Viene chiamato il flusso di sangue nella cavità addominale emoperitoneo, nel petto - emotorace, In
cavità pericardica - emopericardio, nella cavità articolare - emartrosi. Quando si sanguina nelle cavità sierose, la fibrina plasmatica si deposita sulla copertura sierosa, il sangue versato si defibrina e di solito non si coagula.
La diagnosi di emorragia nascosta è difficile. Allo stesso tempo vengono determinati i sintomi locali e generali e vengono utilizzati metodi diagnostici speciali.
Per momento in cui si è verificato
A seconda del momento in cui si verifica, il sanguinamento può essere primario o secondario.
Emergenza primario il sanguinamento è associato a un danno diretto alla nave durante l'infortunio. Appare immediatamente o nelle prime ore dopo il danno.
Secondario il sanguinamento può essere precoce (di solito da alcune ore a 4-5 giorni dopo l'infortunio) e tardivo (più di 4-5 giorni dopo l'infortunio).
Ci sono due ragioni principali per lo sviluppo Presto sanguinamento secondario:
Scivolamento della legatura applicata per arrestare l'emorragia primaria dal vaso;
Eliminazione di un coagulo sanguigno da un vaso a causa di un aumento della pressione sistemica e di un'accelerazione del flusso sanguigno o a causa di una diminuzione della contrazione spastica del vaso che si verifica durante una perdita di sangue acuta.
Tardi secondario, o arrogante, il sanguinamento è associato alla distruzione della parete vascolare a seguito dello sviluppo di un processo infettivo nella ferita. Tali casi sono tra i più difficili, poiché l'intera parete vascolare in quest'area è modificata e il sanguinamento ricorrente è possibile in qualsiasi momento.
Con il flusso
Tutti i sanguinamenti possono essere acuti o cronici. A acuto sanguinamento, il sanguinamento si verifica in un breve periodo di tempo e quando cronico- avviene gradualmente, in piccole porzioni, a volte minori, si osserva sanguinamento periodico per molti giorni. Il sanguinamento cronico può verificarsi con ulcere gastriche e duodenali, tumori maligni, emorroidi, fibromi uterini, ecc.
Secondo la gravità della perdita di sangue
Valutare la gravità della perdita di sangue è estremamente importante, poiché determina la natura dei disturbi circolatori nel corpo del paziente e il pericolo di sanguinamento per la vita del paziente. La morte durante il sanguinamento avviene a causa di disturbi circolatori (insufficienza cardiovascolare acuta) e anche, molto meno frequentemente, a causa della perdita delle proprietà funzionali del sangue (trasferimento di ossigeno, anidride carbonica, sostanze nutritive e prodotti metabolici). Due fattori sono di importanza decisiva nello sviluppo dell'esito del sanguinamento: il volume e la velocità della perdita di sangue. Una perdita improvvisa di circa il 40% del volume sanguigno circolante (CBV) è considerata incompatibile con la vita. Allo stesso tempo, ci sono situazioni in cui, sullo sfondo di sanguinamento cronico o periodico, i pazienti perdono una quantità significativa di sangue, il numero dei globuli rossi diminuisce drasticamente e il paziente si alza, cammina e talvolta lavora. Importanti sono anche le malattie somatiche, contro le quali si verifica il sanguinamento [presenza di shock (traumatico), anemia, esaurimento, insufficienza cardiovascolare], nonché il sesso e l'età.
Esistono diverse classificazioni della gravità della perdita di sangue. È conveniente distinguere quattro gradi di gravità della perdita di sangue:
Grado lieve - perdita fino al 10% di bcc (fino a 500 ml);
Grado medio - perdita del 10-20% di bcc (500-1000 ml);
Grado grave - perdita del 21-30% di bcc (1000-1500 ml);
Massiccia perdita di sangue - perdita di oltre il 30% del volume del sangue (più di 1500 ml). Determinare la gravità della perdita di sangue è estremamente importante per decidere sulla scelta delle tattiche di trattamento.
La quantità di sangue circolante nel corpo è un valore abbastanza stabile e la gamma dei suoi cambiamenti è piuttosto ristretta. Se il valore della gittata cardiaca può cambiare di un fattore pari o superiore a 5, sia normalmente che in condizioni patologiche, le fluttuazioni del volume del sangue sono meno significative e di solito si osservano solo in condizioni patologiche (ad esempio con perdita di sangue). La relativa costanza del volume sanguigno circolante indica, da un lato, la sua importanza incondizionata per l'omeostasi e, dall'altro, la presenza di meccanismi abbastanza sensibili e affidabili per regolare questo parametro. Quest'ultimo è evidenziato anche dalla relativa stabilità del bcc sullo sfondo di un intenso scambio di fluidi tra il sangue e lo spazio extravascolare. Secondo Pappenheimer (1953), il volume del fluido che si diffonde dal flusso sanguigno ai tessuti e viceversa entro 1 minuto supera la gittata cardiaca di 45 volte.
I meccanismi di regolazione del volume totale del sangue circolante sono ancora meno studiati rispetto ad altri indicatori dell'emodinamica sistemica. È noto solo che i meccanismi di regolazione del volume del sangue si attivano in risposta ai cambiamenti di pressione in varie parti del sistema circolatorio e, in misura minore, ai cambiamenti nelle proprietà chimiche del sangue, in particolare della sua pressione osmotica. È l’assenza di meccanismi specifici che rispondono alle variazioni del volume sanguigno (i cosiddetti “recettori del volume” sono barocettori), e la presenza di meccanismi indiretti, che rendono la regolazione del BCC estremamente complessa e multifase. In definitiva, si tratta di due principali processi fisiologici esecutivi: il movimento del fluido tra il sangue e lo spazio extravascolare e i cambiamenti nella rimozione del fluido dal corpo. Va tenuto presente che nella regolazione del volume sanguigno un ruolo maggiore spetta ai cambiamenti del contenuto plasmatico piuttosto che al volume globulare. Inoltre, il “potere” dei meccanismi regolatori e compensatori attivati in risposta all’ipovolemia supera quello dell’ipervolemia, il che è comprensibile dal punto di vista della loro formazione nel processo di evoluzione.
Il volume del sangue circolante è un indicatore molto informativo che caratterizza l'emodinamica sistemica. Ciò è dovuto innanzitutto al fatto che determina la quantità di ritorno venoso al cuore e, di conseguenza, il suo rendimento. In condizioni di ipovolemia, il volume minuto della circolazione sanguigna è in diretta dipendenza lineare (fino a certi limiti) dal grado di diminuzione del volume sanguigno (Shien, Billig, 1961; S. A. Seleznev, 1971a). Tuttavia, lo studio dei meccanismi dei cambiamenti nel volume del sangue e, prima di tutto, della genesi dell'ipovolemia può avere successo solo nel caso di uno studio completo del volume del sangue, da un lato, e dell'equilibrio del fluido extravascolare extra e intracellulare , dall'altra; In questo caso è necessario tenere conto dello scambio di liquidi nella sezione “vaso-tessuto”.
Questo capitolo è dedicato all'analisi dei principi e dei metodi per determinare solo il volume del sangue circolante. Dato che i metodi per determinare il BCC sono stati ampiamente trattati nella letteratura degli ultimi anni (G. M. Solovyov, G. G. Radzivil, 1973), compresi i manuali per gli studi clinici, ci è sembrato opportuno prestare maggiore attenzione ad una serie di questioni controverse questioni teoriche, tralasciando alcune particolari tecniche metodologiche. È noto che il volume del sangue può essere determinato sia con metodi diretti che indiretti. I metodi diretti, che attualmente sono solo di interesse storico, si basano sulla perdita totale di sangue, seguita dal lavaggio del cadavere dal sangue rimanente e dalla determinazione del suo volume in base al contenuto di emoglobina. Naturalmente, questi metodi oggi non soddisfano i requisiti per un esperimento fisiologico e praticamente non vengono utilizzati. A volte vengono utilizzati per determinare le frazioni regionali della BCC, di cui si parlerà nel Capitolo IV.
Il volume sanguigno circolante (CBV) è di 2,4 litri per 1 m2 di superficie corporea nelle donne e di 2,8 litri per 1 m2 di superficie corporea negli uomini, che corrisponde al 6,5% del peso corporeo delle donne e al 7,5% del peso corporeo degli uomini. Shuster XP et al., 1981].
Il valore BCC può essere calcolato in millilitri per chilogrammo di peso corporeo. Negli uomini sani il volume del sangue è in media di 70 ml/kg, nelle donne sane è di 65 ml/kg. G. A. Ryabov (1982) consiglia di utilizzare la tabella di calcolo compilata da Moore per determinare il valore BCC corretto.
Per il lavoro pratico, soprattutto in casi di emergenza, quando si tratta la perdita di sangue acuta, è più conveniente calcolare la quantità di perdita di sangue in relazione al volume del sangue. Pertanto, la BCC media di un adulto con un peso corporeo di 70 kg è di 5 l, di cui 2 l sono elementi cellulari: globuli rossi, leucociti, piastrine (volume globulare) e 3 l sono plasma (volume plasmatico). Pertanto, in media, il bcc è di 5-6 litri, ovvero il 7% del peso corporeo Klimansky V. A., Rudaev Ya. A., 1984].
Volume del sangue circolante in persone sane (in millilitri)
| Peso corpo,kg |
Uomini | Donne | ||||||
| normostenici (7.0)* | iperstenico (6.0) | ipostenica (6.5) | con muscoli sviluppati (7.5) | normostenica (6.5) | iperstenici (5.5) | ipostenica (6.0) | con sviluppato muscolo (7.0) |
|
| 40 | 2800 | 2400 | 2600 | 3000 | 2600 | 2200 | 2400 | 2800 |
| 45 | 3150 | 2700 | 2920 | 3370 | 2920 | 2470 | 2700 | 3150 |
| 50 | 3500 | 3000 | 3250 | 3750 | 3250 | 2750 | 3000 | 3500 |
| 55 | 3850 | 3300 | 3570 | 4120 | 3570 | 3020 | 3300 | 3850 |
| 60 | 4200 | 3600 | 3900 | 4500 | 3900 | 3300 | 3600 | 4200 |
| 65 | 4550 | 3900 | 4220 | 4870 | 4220 | 3570 | 3900 | 4550 |
| 70 | 4900 | 4200 | 4550 | 5250 | 4550 | 3850 | 4200 | 4900 |
| 75 | 5250 | 4500 | 4870 | 5620 | 4870 | 4120 | 4500 | 5250 |
| 80 | 5600 | 4800 | 5200 | 6000 | 5200 | 4400 | 4800 | 5600 |
| 85 | 5950 | 5100 | 5520 | 6380 | 5520 | 4670 | 5100 | 5950 |
| 90 | 6300 | 5400 | 5850 | 6750 | 5850 | 4950 | 5400 | 6300 |
| 95 | 6650 | 5700 | 6170 | 7120 | 6170 | 5220 | 5700 | 6650 |
Il 70-80% del sangue circola nelle vene, il 15-20% nelle arterie e il 5-7,5% nei capillari [Malyshev V.D., 1985]. In generale, l'80% del volume sanguigno totale circola nel sistema cardiovascolare e il 20% negli organi parenchimali.
BCC è caratterizzato da relativa costanza. Ciò è garantito da meccanismi di autoregolamentazione. La regolazione del BCC è un processo complesso e articolato in più fasi, ma alla fine si riduce al movimento del fluido tra il sangue e lo spazio extravascolare e ai cambiamenti nella rimozione del fluido dal corpo [Levite E. M. et al., 1975; Seleznev S.A. et al., 1976; Kletskin S. 3., 1983].
Allo stesso tempo, il BCC è un valore molto variabile anche per una persona, a seconda del suo stato fisico e dello stato di omeostasi. Le persone che praticano regolarmente sport hanno un grande bcc. Il valore BCC è influenzato da età, sesso, professione, temperatura ambiente, pressione atmosferica e altri fattori.
In risposta alla perdita acuta di sangue, nel corpo si sviluppano cambiamenti fisiopatologici, che sono inizialmente di natura compensatoria e protettiva e garantiscono la conservazione della vita. Ne esamineremo alcuni di seguito.
"Terapia infusionale-trasfusionale delle perdite ematiche acute"
E.A. Wagner, V.S. Zaugolnikov
L'effetto venomotore compensa la perdita del 10-15% di bcc (500-700 ml) in un adulto, se non soffre di alcuna malattia cronica e non presenta segni di shock ipovolemico o deficit di bcc. Questa "centralizzazione" della circolazione sanguigna è biologicamente opportuna, poiché l'afflusso di sangue agli organi vitali (cervello, cuore, polmoni) viene mantenuto per qualche tempo. Tuttavia, di per sé può causare lo sviluppo di gravi...
La risposta del flusso sanguigno sistemico durante la perdita ematica acuta e lo shock emorragico fornisce inizialmente un effetto protettivo. Tuttavia, la vasocostrizione prolungata dovuta allo sviluppo di acidosi e all'accumulo di maggiori concentrazioni di metaboliti tissutali - vasodilatatori - porta a cambiamenti considerati responsabili dello sviluppo di shock scompensato reversibile e irreversibile. Pertanto, la contrazione delle arteriole porta ad una diminuzione del flusso sanguigno e dell'ossigenazione dei tessuti, causando una diminuzione del pH...
Le reazioni che si sviluppano in risposta ad una diminuzione del volume sanguigno portano ad una diminuzione del flusso sanguigno volumetrico nei tessuti e allo sviluppo di meccanismi compensatori volti a correggere il flusso sanguigno ridotto. Uno di questi meccanismi compensatori è l’emodiluizione, ovvero l’ingresso di liquido extravascolare ed extracellulare nel letto vascolare. Nello shock emorragico si osserva una progressiva emodiluizione, che aumenta con la gravità dello shock. L'ematocrito serve come indicatore del livello di emodiluizione. IN…
Il ripristino della carenza di proteine plasmatiche avviene a causa della mobilitazione della linfa da tutti i vasi linfatici. Sotto l'influenza dell'aumento delle concentrazioni di adrenalina e della stimolazione del sistema nervoso simpatico, si sviluppa uno spasmo di piccoli vasi linfatici. La linfa in essi contenuta viene spinta nei collettori venosi, cosa facilitata dalla bassa pressione venosa. Il volume della linfa nel dotto toracico aumenta rapidamente dopo il sanguinamento. Questo aiuta ad aumentare il BCC...
Il flusso sanguigno periferico dipende non solo dalla pressione arteriosa di perfusione, dal volume sanguigno e dal tono vascolare. Un ruolo importante appartiene alle proprietà reologiche del sangue e, prima di tutto, alla sua viscosità. La stimolazione simpatico-surrenale porta alla vasocostrizione pre e post capillare, con conseguente significativa diminuzione della perfusione tissutale. Il flusso sanguigno nei capillari rallenta, creando le condizioni per l'aggregazione dei globuli rossi e delle piastrine e lo sviluppo...
I disturbi circolatori durante la perdita di sangue acuta e lo shock emorragico e la terapia infusionale massiccia possono causare insufficienza respiratoria, che aumenta diverse ore dopo l'intervento. Si manifesta con una violazione della permeabilità della membrana capillare polmonare - edema polmonare interstiziale, ad es. una delle varianti di "shock polmonare". Traumi e perdite acute di sangue causano iperventilazione. Nello shock emorragico, la ventilazione minuto è solitamente di 1 1/2-2...
Studi sperimentali e clinici hanno dimostrato che la perdita ematica acuta determina una riduzione del 50-70% del flusso sanguigno renale, con una riduzione selettiva del flusso sanguigno corticale. Il flusso sanguigno corticale rappresenta circa il 93% del flusso sanguigno renale. Una riduzione selettiva del flusso sanguigno renale dovuta alla vasocostrizione arteriosa preglomerulare riduce la pressione glomerulare a un livello al quale la filtrazione glomerulare diminuisce o si arresta e si sviluppa oliguria o anuria. Emodinamica…
La perdita acuta di sangue, soprattutto massiccia, spesso causa disfunzione epatica. Sono causati principalmente da una diminuzione del flusso sanguigno epatico, principalmente arterioso. La conseguente ischemia epatica porta allo sviluppo della necrosi centrolobulare (IRauber, Floguet, 1971). La funzionalità epatica è compromessa: aumenta il contenuto delle transaminasi, diminuisce la quantità di protrombina, si osservano ipoalbuminemia e iperlaccidemia. A causa del riassorbimento di un ematoma o come risultato di un massiccio...
Un indicatore di un cambiamento nel metabolismo è la formazione di acido lattico come prodotto finale invece del normale prodotto finale del metabolismo aerobico: CO2. Di conseguenza, si sviluppa acidosi metabolica. La quantità di basi tampone diminuisce progressivamente e, sebbene il compenso respiratorio si sviluppi precocemente, è spesso inadeguato nello shock emorragico. Studiando i cambiamenti nel metabolismo in pazienti con perdita di sangue e shock, A. Labori (1980) trovò che...
La perdita acuta di sangue dovuta alla ridotta età venosa (ipovolemia assoluta o relativa) porta a una diminuzione della gittata cardiaca. In connessione con il rilascio di catecolamine nelle terminazioni dei nervi simpatici postgangliari delle parti precapillari e postcapillari del sistema vascolare, si verifica la massima stimolazione della secrezione surrenale. Reazioni del corpo alla perdita acuta del livello "Terapia infusionale-trasfusionale della perdita di sangue acuta", E.A. Wagner, V.S. Zaugolnikov