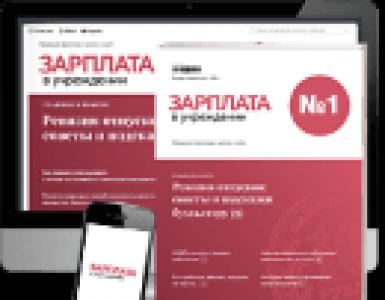Budda 4 verità. Quattro nobili verità. Samyak vaca: discorso perfetto
Il Buddismo è uno degli insegnamenti religiosi del mondo, che diventa ogni anno più popolare e conquista nuovi cuori. Un cambiamento radicale avviene nella coscienza di coloro che arrivano a questa direzione religioso-filosofica, poiché il buddismo guarda alla vita e alle sue manifestazioni in modo diverso. Il Cristianesimo, l'Ebraismo e l'Islam prevedono la leadership indiscussa dell'essenza divina sulla volontà umana. Dio ha potere assoluto e la sottomissione a Lui è il sacro dovere di ogni credente. In queste religioni, i pensieri e le aspirazioni umane sono diretti verso l'esterno, da se stessi come persona a un dio ideale, che deve essere servito mediante sottomissione, preghiere, offerte e una vita retta costruita secondo i canoni dettati dalla chiesa. Il Buddismo prevede ricerche spirituali dirette all’interno della propria coscienza alla ricerca della verità e dell’unità con il principio spirituale comune a tutte le cose.
Quali sono le quattro nobili verità fondamentali del Buddismo?
Gli insegnamenti buddisti (Dharma) si basano su quattro postulati o verità fondamentali. Eccoli brevemente elencati:
- Dukkha, o sofferenza.
- Samudaya o la causa di Dukkha.
- Nirodha, o cessazione di Dukkha.
- Magga, o la strada verso la cessazione di Dukkha.
Tutte le verità sono quattro fasi superate sul percorso verso il Nirvana.
Dukkha
Dobbiamo subito riservare che la “sofferenza” nell'interpretazione buddista è priva del significato che le viene dato nel cristianesimo. Per noi la sofferenza è dolore, perdita, sventura, morte. Nel Buddismo questo concetto è molto più ampio e comprende tutte le sfere della vita, senza essere direttamente correlato alle sue manifestazioni fisiche. Sì, dukkha è sofferenza, ma non necessariamente fisica, ma spirituale, associata all'imperfezione dell'esistenza umana. Le persone hanno sempre una disarmonia tra ciò che vogliono e ciò che realmente vogliono. In parole povere, la vita ha sempre qualche inconveniente: se vivi riccamente, perdi i tuoi cari, i parenti sono vivi, ma qualcuno è malato, la salute non significa benessere finanziario e così via all'infinito. Dal punto di vista del buddismo, la sofferenza è l'insoddisfazione di ciò che si ha, l'incapacità di raggiungere un ideale. A questo proposito, la sofferenza riempie la vita, cioè “tutto è Dukkha”. L'uomo non può cambiare le leggi della natura, ma può mettersi d'accordo con se stesso. La fase successiva nella comprensione delle quattro verità è realizzare le cause dei tuoi problemi.
Samudaya
La causa della sofferenza è l'insoddisfazione, cioè l'incapacità di ottenere ciò che si desidera. Desideriamo la ricchezza, la otteniamo, ma comprendiamo che dopo aver raggiunto il nostro obiettivo, iniziamo a desiderare appassionatamente qualcos'altro. Ottenere ciò che cerchi non elimina la sofferenza, ma la aumenta solo. Più desideri, più rimani deluso o stufo di ciò che hai ottenuto. Anche lo stato di felicità è inseparabile dall’insoddisfazione. Mettendo un bambino in questo mondo, una donna è assolutamente felice, mentre sperimenta il tormento fisico e spirituale dovuto alla paura per il futuro del suo bambino.
Non solo non c'è stabilità nella vita, ma non c'è nemmeno costanza nella comprensione globale di questo termine. Tutto è in costante movimento, cambia costantemente, si trasforma e si trasforma. Anche i desideri umani cambiano e vengono ripensati nel tempo. Ciò che abbiamo desiderato e cercato appassionatamente con tutta la nostra anima e con tutte le nostre forze si rivela inutile e poco interessante nella fase successiva della vita. Di conseguenza, proviamo delusione, uno dei tipi di sofferenza dal punto di vista del buddismo. In questo senso, la causa della sofferenza siamo noi stessi, o meglio ciò che risiede nel profondo di noi, le nostre passioni, desideri, aspirazioni e sogni.
Nirodha

Questa parola stessa significa controllo. L'unico modo per cambiare la tua condizione e liberarti del tormento è smettere di soffrire. Per fare questo, devi sbarazzarti della ragione che dà origine a questi sentimenti. Questi sono i nostri desideri, passioni, affetti, sogni. Anche la proprietà è fonte di insoddisfazione, poiché è associata al timore di perderla, alla speranza di aumentarla e al bisogno di mantenerla in condizioni dignitose. I sogni creano problemi sia quando si realizzano, sia quando crollano. Per smettere di provare tormento, devi sbarazzarti dei sogni infruttuosi e goderti ciò che hai: il fatto stesso dell'esistenza. Le passioni devono essere controllate, perché il fuoco del desiderio è la causa della più grande frustrazione e insoddisfazione in questa vita. Quante volte ci sforziamo di impossessarci di una persona cara e quanto velocemente l'amore e l'affetto a volte entusiastici si trasformano nel suo completo opposto: negazione e odio. C'è un modo per non soffrire di passioni: subordinarle al tuo controllo.
La cessazione della sofferenza attraverso il controllo delle proprie passioni, desideri e attaccamenti libera il seguace del Buddismo dalla schiavitù e lo immerge in uno stato speciale chiamato “nirvana”. Questa è la beatitudine più alta, libera da Dukkha, che si fonde con lo spirito divino e il sé universale. Una persona cessa di sentirsi una persona specifica e diventa parte dell'Universo spirituale e materiale, un pezzo della divinità totale.
Magga
Cercando di sbarazzarsi di Dukkha, una persona si precipita nell'abisso delle passioni, cercando di soffocare il dolore delle perdite e delle delusioni con nuove connessioni, cose e sogni. Un altro, avendo costante paura di Dukkha, abbandona del tutto tutto e diventa un asceta, estenuando e torturando la sua carne in vani tentativi di sfuggire a una serie di perdite e dolori e di trovare la felicità. Entrambi questi percorsi sono estremi che non portano altro che autodistruzione e moltiplicano solo dolori e dispiaceri. I veri buddisti scelgono la cosiddetta via di mezzo, che corre tra due estremi. Non mira a manifestazioni esterne, ma a concentrare le proprie forze interne. Viene anche chiamato diversamente, poiché è composto da otto stati, attraverso i quali è possibile raggiungere lo stato del nirvana. Tutti questi stati possono essere suddivisi in tre fasi, che devono essere attraversate gradualmente e sistematicamente: sila (moralità), samadhi (disciplina) e panya (saggezza).
Il Nobile Ottuplice Sentiero
 Ci sono molti ostacoli sparsi lungo il percorso verso il nirvana, che non sono così facili da superare. Sono collegati all'essenza terrena e carnale di una persona e interferiscono con la sua emancipazione e liberazione spirituale. Possono essere brevemente formulati come:
Ci sono molti ostacoli sparsi lungo il percorso verso il nirvana, che non sono così facili da superare. Sono collegati all'essenza terrena e carnale di una persona e interferiscono con la sua emancipazione e liberazione spirituale. Possono essere brevemente formulati come:
- Personalità illusoria
- Dubbi
- Superstizioni
- Passioni carnali
- Odio
- Attaccamento all'esistenza terrena
- Sete di piacere
- Orgoglio
- Compiacimento
- Ignoranza
Solo superando questi ostacoli l’Ottuplice Sentiero potrà considerarsi completato. Tre aspetti del Buddismo ne sono indicatori:
Panya: saggezza
1. Visione corretta.
2. Pensiero corretto.
Sheela: moralità
3. Discorso corretto.
4. Comportamento corretto.
5. Stile di vita corretto.
Samadhi: disciplina
6. Giusta diligenza.
7. Adeguata autodisciplina.
8. Concentrazione corretta.
Passando attraverso tutte queste fasi, una persona ottiene benessere, felicità e risolve i suoi problemi di vita, per poi entrare nel nirvana, liberandosi di tutti i tipi di sofferenza.
Nonostante l’eterogeneità e la diversità delle correnti all’interno del Buddismo, che talvolta si contraddicono tra loro, esse si basano tutte su quattro nobili verità fondamentali. Si ritiene che questi principi siano stati compresi, definiti e formulati dal Buddha stesso. Ha associato le quattro verità al rapporto tra medico e paziente, in cui lui stesso ha agito come medico, e tutta l'umanità come malata di numerose malattie. La prima verità in questa luce appare come l'affermazione del fatto della malattia, la seconda è l'istituzione di una diagnosi, la terza è la comprensione della possibilità di cura, la quarta è la prescrizione di un ciclo di farmaci e terapie procedure. Continuando la catena di associazioni, possiamo dire che Buddha e il suo insegnamento sono un medico esperto, le quattro nobili verità sono un metodo e un metodo di guarigione e il nirvana è completa salute, fisica e psicologica.
Lo stesso Buddha insisteva sul fatto che il suo insegnamento non è un dogma che deve essere seguito incondizionatamente da studenti e seguaci. È giunto alle sue conclusioni da solo, analizzando se stesso e il suo percorso di vita e si è offerto di mettere in discussione e testare tutte le sue parole. Ciò è fondamentalmente contrario alle tradizioni di altre religioni e credenze, dove la parola di Dio è irremovibile e irremovibile e richiede un'accettazione incondizionata senza la minima esitazione. Altre opinioni personali e reinterpretazioni delle divine scritture sono classificate come eresie e devono essere radicalmente sradicate. Questo è ciò che rende gli insegnamenti buddisti così attraenti agli occhi dei suoi studenti e seguaci moderni: la libertà di scelta e di volontà.
L'obiettivo finale del Buddismo è la liberazione dalla sofferenza e la reincarnazione. Buddha disse: “Sia nel passato che nel presente, dico solo una cosa: la sofferenza e la distruzione della sofferenza”. Nonostante la posizione di partenza negativa di questa formula, l’obiettivo in essa fissato ha anche un aspetto positivo, perché puoi porre fine alla sofferenza solo realizzando il tuo potenziale umano di gentilezza e felicità. Si dice che chi raggiunge uno stato di completa autorealizzazione abbia raggiunto il nirvana. Il Nirvana è il bene più grande nel Buddismo, il bene supremo e supremo. È sia un concetto che uno stato. Come concetto, riflette una certa visione della realizzazione del potenziale umano, delinea i contorni e le forme di una vita ideale; come stato, si incarna nel tempo in una persona che lotta per ottenerlo.
Il desiderio del nirvana è comprensibile, ma come raggiungerlo? La risposta è in parte contenuta nei capitoli precedenti. Sappiamo che la vita retta è molto apprezzata nel Buddismo; vivere virtuosamente è una condizione necessaria. Tuttavia, alcuni scienziati rifiutano questa idea. Sostengono che accumulare meriti compiendo buone azioni interferisce effettivamente con il raggiungimento del nirvana. Le buone azioni, secondo loro, creano karma e il karma porta a una serie di rinascite. Quindi, ragionano, ne consegue che per raggiungere il nirvana è necessario trascendere il karma e tutte le altre considerazioni etiche. In relazione a questa comprensione della questione, sorgono due problemi. In primo luogo, perché, se l’azione virtuosa è un ostacolo al percorso verso il nirvana, i testi sacri incoraggiano costantemente il compimento di buone azioni? In secondo luogo, perché coloro che hanno raggiunto l’illuminazione, come il Buddha, continuano a vivere una vita altamente morale?
La soluzione a questi problemi è possibile se una vita altamente morale è solo una parte della perfezione raggiunta da una persona, necessaria per l'immersione nel nirvana. Quindi, se la virtù (forza, sanscrito - shila) è uno degli elementi principali di questo ideale, allora non può essere autosufficiente e necessita di qualche tipo di aggiunta. Quest'altro elemento necessario è la saggezza, la capacità di percepire (panya, sanscrito - prajya). “Saggezza” nel Buddismo significa una profonda comprensione filosofica della condizione umana. Richiede una visione della natura della realtà, ottenuta attraverso una riflessione lunga e profonda. Questo è un tipo di gnosi, o visione diretta della verità, che si approfondisce nel tempo e alla fine culmina nell'illuminazione sperimentata dal Buddha.
1. La verità della sofferenza (dukkha).
Ma, monaci, qual è la Nobile Verità della sofferenza? La nascita è sofferenza, l'invecchiamento è sofferenza, la malattia è sofferenza, la morte è sofferenza. Il dolore, l'afflizione, la tristezza, la disperazione sono sofferenza. L'unione con ciò che non è amabile è sofferenza, la separazione da ciò che è caro è sofferenza. L'irraggiungibilità di ciò che si desidera è sofferenza. Pertanto, i cinque stati (skandha) della personalità soffrono.
Quindi, il nirvana è l'unità di virtù e saggezza. La relazione tra loro nel linguaggio della filosofia può essere espressa come segue: sia la virtù che la saggezza sono condizioni “necessarie” per il nirvana, la presenza di una sola di esse “non è sufficiente”. Solo insieme rendono possibile raggiungere il nirvana. In uno dei testi più antichi vengono paragonate a due mani che si lavano e si puliscono a vicenda; chi ne manca una è imperfetto (D.i.124).
Se la saggezza è davvero un accompagnamento assolutamente necessario della virtù, cosa deve sapere una persona per raggiungere l’illuminazione? Conoscere la verità percepita dal Buddha nella notte dell'illuminazione e successivamente esposta nel primo sermone, che pronunciò nel parco dei cervi vicino a Benares. Questo sermone parla di quattro punti conosciuti come le Quattro Nobili Verità. Affermano che: 1) la vita è sofferenza, 2) la sofferenza è generata dal desiderio o dalla sete di piacere, 3) la sofferenza può essere fermata, 4) esiste un percorso che porta alla liberazione dalla sofferenza. A volte viene fatto un paragone con la medicina per illustrare la relazione tra i due, paragonando il Buddha a un guaritore che trovò una cura per la malattia della vita. In primo luogo, diagnostica la malattia, in secondo luogo, ne spiega la causa, in terzo luogo, determina i mezzi contro di essa e, in quarto luogo, inizia il trattamento.
Lo psichiatra americano M. Scott Peck inizia il suo libro più venduto The Road Not Taken con le parole: “La vita è dura”. Parlando della Prima Nobile Verità, aggiunge: “Questa è una grande verità, una delle più grandi verità”. Conosciuta nel Buddismo come la “Verità della Sofferenza”, divenne la pietra angolare degli insegnamenti del Buddha. Secondo questa verità, la sofferenza (dukkha, sanscrito - duhkha) è parte integrante della vita, e definisce la condizione umana come uno stato di “insoddisfazione”. Comprende molti tipi di sofferenza, che vanno da quelle fisiche come la nascita, l'invecchiamento, la malattia e la morte. Molto spesso sono associati al dolore fisico e c'è un problema molto più serio: l'inevitabilità di ripetere questo ciclo in ogni vita successiva, sia per la persona stessa che per i suoi cari. Le persone sono impotenti di fronte a queste realtà e, nonostante le ultime scoperte della medicina, sono ancora suscettibili a malattie e incidenti a causa della loro natura corporea. Oltre al dolore fisico, la Verità della sofferenza indica le sue forme emotive e psicologiche: “ dolore, dolore, tristezza e disperazione.” . A volte possono presentare problemi più dolorosi della sofferenza fisica: poche persone vivono senza dolore e tristezza, mentre ci sono molte condizioni psicologiche gravi, come la depressione cronica, dalle quali è impossibile liberarsi completamente.
Al di là di questi esempi ovvi, La verità della sofferenza menziona un tipo di sofferenza più sottile che può essere definita “esistenziale”. Ciò deriva dall'affermazione: "L'irraggiungibilità di ciò che vogliamo è sofferenza", cioè fallimento, delusione, crollo delle illusioni, sperimentato quando le speranze non si realizzano e la realtà non corrisponde ai nostri desideri. Il Buddha non era un pessimista e, naturalmente, sapeva per esperienza personale quando era un giovane principe che ci possono essere momenti piacevoli nella vita. Il problema, però, è che i bei momenti non durano per sempre, prima o poi se ne vanno o una persona si annoia di ciò che sembrava nuovo e promettente. In questo senso, la parola dukkha ha un significato più astratto e profondo: indica che anche una vita priva di difficoltà potrebbe non portare soddisfazione e autorealizzazione. In questo e in molti altri contesti, la parola "insoddisfazione" esprime più accuratamente il significato di "duhkha" che di "sofferenza".
La verità della sofferenza permette di identificare il motivo principale per cui la vita umana non porta completa soddisfazione. L'affermazione che "i cinque skandha della personalità soffrono" si riferisce all'insegnamento esposto dal Buddha nel secondo sermone (Vin.i.13). Li elenchiamo: corpo (rupa), sensazione (vedana), immagini della percezione (samjna), desideri e attrazioni (sanskara), coscienza (vijnana). Non è necessario considerarli ciascuno in dettaglio, poiché per noi è importante non tanto ciò che è incluso in questo elenco quanto ciò che non è incluso. In particolare, la dottrina non fa menzione dell'anima o “io”, intesa come entità spirituale eterna e immutabile. Questa posizione del Buddha si discosta dalla tradizione religiosa indiana ortodossa del Brahmanesimo, che sosteneva che ogni persona ha un'anima eterna (Atman), che è parte dell'assoluto metafisico - Brahman (divinità impersonale), o identica ad esso.
Il Buddha disse di non aver trovato alcuna prova dell'esistenza né dell'anima umana (Atman) né della sua controparte cosmica (Brahman). Al contrario, il suo approccio – pratico ed empirico – è più vicino alla psicologia che alla teologia. La sua spiegazione della natura umana, formata da cinque stati, è per molti versi simile alla spiegazione del design di un'auto, composta da ruote, cambio, motore, sterzo, carrozzeria. Naturalmente, a differenza degli scienziati, credeva che l'essenza morale di una persona (che può essere chiamata "DNA spirituale") sopravvive alla morte e si reincarna. Sostenendo che i cinque stati della personalità sono sofferenza, il Buddha fece notare che la natura umana non può diventare la base della felicità permanente. Poiché un essere umano è composto da cinque “attributi” in costante cambiamento, prima o poi inevitabilmente sorgerà la sofferenza, proprio come un’auto prima o poi si consumerà e si romperà. La sofferenza è quindi intessuta nel tessuto stesso del nostro essere.
Il contenuto della Verità della Sofferenza è in parte spiegato dal fatto che il Buddha vide i primi tre segni - il vecchio, il lebbroso e il morto - e si rese conto che la vita è piena di sofferenza e disgrazia. Molti, rivolgendosi al buddismo, trovano che la sua valutazione della condizione umana sia pessimistica, ma i buddisti credono che la loro religione non sia né pessimistica né ottimista, ma realistica, che la Verità della sofferenza affermi solo oggettivamente i fatti. Se sembra pessimista, è a causa della tendenza umana di lunga data a evitare le verità spiacevoli e a “cercare il lato positivo di ogni cosa”. Ecco perché il Buddha notò che la Verità della sofferenza è estremamente difficile da comprendere. Questo è simile alla consapevolezza di una persona di essere gravemente malata, cosa che nessuno vuole ammettere e che è impossibile riprendersi.
Se la vita è sofferenza, allora come nasce? La seconda nobile verità, la Verità dell'Origine (samudaya), spiega che la sofferenza nasce dal desiderio o dalla “sete di vita” (tanha). La passione accende la sofferenza come il fuoco accende la legna da ardere. Nel suo sermone (C.iv.19), il Buddha disse che tutta l'esperienza umana è “ardente” di desideri. Il fuoco è una metafora adatta del desiderio perché consuma ciò che lo nutre senza essere soddisfatto. Si diffonde rapidamente, si sposta verso nuovi oggetti e provoca dolore, come i desideri insoddisfatti.
2. La verità dell'emergenza (samudaya).
Questa, monaci, è la Verità dell'origine della sofferenza. È la sete di vita, l'attaccamento a illusori valori terreni (tanha), che porta alla rinascita, associato al frenetico piacere della forma. 1) piaceri sensuali, 2) sete di “prosperità”, esistenza, 3) sete di “distruzione”, non esistenza.
È il desiderio di vivere, di godersi la vita che provoca la rinascita. Se continuiamo a confrontare i cinque “attributi” di una persona con un'auto, allora il desiderio è il carburante che la mette in moto. Sebbene si creda generalmente che la rinascita avvenga di vita in vita, essa avviene anche di momento in momento: si dice che una persona rinasce in pochi secondi se questi cinque elementi cambiano e interagiscono, spinti dal desiderio di esperienze piacevoli. La continuità dell'esistenza umana da una vita all'altra è semplicemente il risultato del potere accumulato del desiderio.
La verità dell'emergenza afferma che il desiderio si manifesta in tre forme fondamentali, la prima delle quali è il desiderio di piaceri sensuali. Prende la forma di un desiderio di piacere attraverso oggetti di percezione, ad esempio gusti, sensazioni, odori, suoni piacevoli. La seconda è la sete di “prosperità”. Riguarda il profondo, istintivo desiderio di esistenza che ci spinge verso nuove vite e nuove esperienze. Il terzo tipo di manifestazione del desiderio appassionato è il desiderio non di possesso, ma di “distruzione”. Questa è l'altra faccia della sete di vita, incarnata nell'istinto di negazione, nel rifiuto di ciò che è spiacevole e indesiderabile. La sete di distruzione può anche portare al sacrificio e alla negazione di sé.
Una bassa autostima e pensieri come “Non posso fare nulla” o “Sono un fallimento” sono manifestazioni di tale atteggiamento autodiretto. In forme estreme, può portare all’autodistruzione fisica, come il suicidio. Anche l'autotortura fisica, che il Buddha alla fine abbandonò, può essere vista come una manifestazione di abnegazione.
Quindi questo significa che ogni desiderio è malvagio? Dobbiamo avvicinarci a tali conclusioni con molta attenzione. Sebbene la parola tanha sia spesso tradotta come "desiderio", ha un significato più ristretto: desideri, in un certo senso pervertiti da eccessi o scopi malvagi. Di solito è mirato alla stimolazione sensuale e al piacere. Tuttavia, non tutti i desideri sono così, e le fonti buddiste parlano spesso di desideri positivi (chanda). Cercare un obiettivo positivo per te stesso e per gli altri (ad esempio, raggiungere il nirvana), desiderare la felicità per gli altri, desiderare che il mondo che rimane dopo di te diventi migliore: questi sono esempi di desideri positivi e benefici che non sono definiti dal concetto di “tanha”.
Se i cattivi desideri trattengono e incatenano una persona, allora quelli buoni gli danno forza e libertà. Per vedere la differenza, prendiamo come esempio il fumo. Il desiderio di un accanito fumatore di accendersi un'altra sigaretta è tanha, poiché è finalizzato a nient'altro che un piacere momentaneo, ossessivo, limitato, ciclico, e non porterà a nient'altro che un'altra sigaretta (e come effetto collaterale - a cattiva salute ). D'altra parte, il desiderio di un forte fumatore di smettere di fumare sarà benefico, poiché spezzerà il circolo vizioso di una cattiva abitudine ossessiva e servirà a migliorare la salute e il benessere.
Nella Verità dell'Origine, tanha rappresenta le suddette "tre radici del male": passione, odio e illusione. Nell'arte buddista sono raffigurati come un gallo, un maiale e un serpente che corrono in cerchio al centro della “ruota della vita”, di cui abbiamo parlato nel terzo capitolo, mentre formano un cerchio - la coda di uno è tenuto in bocca all'altro. Poiché la sete di vita dà origine solo al desiderio successivo, le rinascite formano un ciclo chiuso, le persone nascono ancora e ancora. Il modo in cui ciò accade è spiegato in dettaglio dalla teoria della causalità, chiamata pathikka-samuppada (sanscrito - pratitya-samutpada - origine dipendente). Questa teoria spiega come il desiderio e l'ignoranza conducano a una catena di rinascite composta da 12 fasi. Ma per noi ora è più importante non considerare queste fasi in dettaglio, ma comprendere il principio fondamentale alla base di esse, che si applica non solo alla psicologia umana, ma anche alla realtà in generale.
3. La verità della cessazione (nirodha).
Questa, monaci, è la Verità della cessazione della sofferenza, la rinuncia alla sete di vita (tanha), il lasciarla, la rinuncia ad essa, la liberazione da essa, l'eliminazione dell'attaccamento ad essa.
In termini più generali, l'essenza di questa teoria è che ogni effetto ha una causa, in altre parole, tutto nasce in interdipendenza. Secondo questo, tutti i fenomeni fanno parte di una serie di causa-effetto, nulla esiste in modo indipendente, in sé e per sé. Pertanto, l’Universo non è un insieme di oggetti statici, ma una rete di cause ed effetti in costante movimento. Inoltre, proprio come la personalità di una persona può essere completamente scomposta in cinque “attributi”, tutti i fenomeni possono essere ridotti alle loro componenti costitutive senza trovare in essi alcuna “essenza”. Tutto ciò che sorge ha tre segni di esistenza, vale a dire: mancanza di comprensione della fragilità della vita terrena (dukkha), variabilità (anigga) e mancanza di autoesistenza (anatta). Le “azioni e cose” non danno soddisfazione perché sono impermanenti (e quindi instabili e inaffidabili), perché non hanno una natura propria, indipendente dai processi universali di causa-effetto.
È ovvio che l'Universo buddista è caratterizzato principalmente da cambiamenti ciclici: a livello psicologico - il processo infinito del desiderio e della sua soddisfazione; a livello personale - una catena di morti e rinascite; in termini cosmici: la creazione e la distruzione delle galassie. Tutto ciò si basa sui principi della teoria pathikka-samuppada, le cui disposizioni furono successivamente sviluppate in modo approfondito dal Buddismo.
La Terza Nobile Verità è la Verità della cessazione (nirodha). Dice che quando ci si libera dalla sete di vita, la sofferenza cessa e arriva il nirvana. Come sappiamo dalla storia della vita del Buddha, il nirvana ha due forme: la prima avviene durante la vita (“nirvana con resto”), e la seconda dopo la morte (“nirvana senza resto”). Buddha raggiunse il nirvana durante la sua vita all'età di 35 anni, seduto sotto un albero saporito. All'età di 80 anni si tuffò nel nirvana finale, dal quale non si può tornare indietro attraverso la rinascita.
"Nirvana" significa letteralmente "spegnere" o "spegnere", proprio come si spegne la fiamma di una candela. Ma cosa significa esattamente “svanire”? Forse questa è l'anima di una persona, il suo “io”, la sua individualità? Non può essere l'anima, poiché il Buddismo ne nega assolutamente l'esistenza. Non è “io” o autocoscienza, anche se il nirvana implica certamente un cambiamento radicale nello stato di coscienza, liberato dall'attaccamento all'“io” e al “mio”. In effetti, la fiamma della triade - passione, odio e illusione, che porta alla reincarnazione - si spegne. In effetti, la definizione più semplice di “nirvana con resto” è “la fine della passione, dell’odio e dell’illusione” (C.38.1). Questo è un fenomeno psicologico e morale, uno stato trasformato della personalità, caratterizzato da pace, profonda gioia spirituale, compassione, percezione raffinata e piena di sentimento. Gli stati mentali e le emozioni negativi, come il dubbio, l’ansia, la preoccupazione e la paura, sono assenti in una mente illuminata. Alcune o tutte queste qualità sono caratteristiche dei santi in molte religioni, e anche le persone comuni possono possederne alcune in una certa misura. Tuttavia, gli Illuminati, come un Buddha o un arhat, sono inerenti nella loro totalità.
Cosa succede a una persona quando muore? Non c'è una risposta chiara a questa domanda nelle prime fonti. Le difficoltà nel comprenderlo sorgono proprio in connessione con l'ultimo nirvana, quando la fiamma della sete di vita si spegne, le reincarnazioni cessano e una persona che ha raggiunto l'illuminazione non rinasce. Il Buddha disse che chiedere dove sia l’Illuminato dopo la morte è come chiedere dove va una fiamma quando viene spenta. La fiamma, ovviamente, non “va” da nessuna parte, il processo di combustione semplicemente si ferma. Liberarsi della sete di vita e dell'ignoranza equivale a tagliare l'ossigeno necessario alla combustione. Tuttavia, il paragone con la fiamma non dovrebbe essere interpretato nel senso che il “nirvana senza resto” sia annientamento. Le fonti indicano chiaramente che tale comprensione è errata, così come la conclusione che il nirvana è l'esistenza eterna dell'anima.
Il Buddha era contrario a varie interpretazioni del nirvana, attribuendo l'importanza principale al desiderio di raggiungerlo. Ha paragonato coloro che hanno chiesto informazioni sul Nirvana a un uomo ferito da una freccia avvelenata, che, invece di estrarre la freccia, pone con insistenza domande prive di significato nella situazione data su chi l'ha lanciata, come si chiama, che tipo di famiglia ha. da dove si trovava, quanto lontano si trovava ecc. (M.i.426). In pieno accordo con la riluttanza del Buddha a sviluppare questo argomento, le prime fonti definiscono il nirvana principalmente in termini di negazione, cioè come "mancanza di desiderio", "soppressione della sete", "estinzione", "estinzione". Si possono trovare meno definizioni positive, tra cui “buon auspicio”, “buono”, “purezza”, “pace”, “verità”, “sponda lontana”. Alcuni testi indicano che il nirvana è trascendentale, come «non nato, non sorto, non creato e non formato» (Udana, 80), ma non si sa come ciò debba essere interpretato. Di conseguenza, la natura del “nirvana senza residui” rimane un mistero per tutti coloro che non l’hanno sperimentato. Tuttavia, ciò di cui possiamo essere sicuri è che significa la fine della sofferenza e della rinascita.
4. Verità del sentiero (magga).
Questa, o monaci, è la Verità del sentiero (magga), che conduce alla cessazione della sofferenza. Questo è il nobile "ottuplice sentiero", che consiste in 1) giusta visione, 2) giusto pensiero, 3) giusta parola, 4) giusta condotta, 5) giusto sostentamento, 6) giusto sforzo, 7) giusta memoria, 8) corretto concentrazione.
La Quarta Nobile Verità - la Verità del sentiero (magga, sanscrito - marga) - spiega come dovrebbe avvenire la transizione dal samsara al nirvana. Nel trambusto della vita quotidiana, poche persone si fermano a pensare allo stile di vita più appagante. Queste domande preoccupavano i filosofi greci e anche il Buddha contribuì alla loro comprensione. Credeva che la forma di vita più alta fosse una vita che conduce alla perfezione della virtù e della conoscenza, e l '"ottuplice sentiero" definisce il modo di vivere attraverso il quale ciò può essere praticamente raggiunto. È chiamata anche la “via di mezzo” perché passa tra due estremi: una vita di eccessi e un’ascesi rigorosa. Comprende otto passaggi, divisi in tre categorie: moralità, concentrazione (meditazione) e saggezza. Definiscono i parametri del bene umano e indicano dove si trova la sfera della prosperità umana. Nella categoria della “moralità” (sila), le qualità morali vengono migliorate e nella categoria della “saggezza” (panya), vengono sviluppate le qualità intellettuali. Il ruolo della meditazione sarà discusso in dettaglio nel prossimo capitolo.
Sebbene il “percorso” sia composto da otto parti, queste non dovrebbero essere pensate come le fasi che una persona attraversa avvicinandosi al nirvana, lasciandosi alle spalle. Al contrario, gli otto passi rappresentano percorsi di miglioramento continuo nella “moralità”, nella “meditazione” e nella “saggezza”. "Retta Visione" significa prima accettare gli insegnamenti buddisti e poi confermarli empiricamente; “pensiero giusto” - impegno per la formazione dei giusti atteggiamenti; Il “giusto discorso” significa dire la verità, mostrare attenzione e interesse per la conversazione, e il “giusto comportamento” è astenersi da azioni malvagie come l’omicidio, il furto o il cattivo comportamento (piaceri sensuali). “Il modo giusto di vivere” implica evitare azioni che causano danni agli altri; “corretta applicazione delle forze”: acquisire il controllo sui propri pensieri e sviluppare atteggiamenti positivi; La “memoria corretta” è lo sviluppo di una comprensione costante, la “concentrazione corretta” è il raggiungimento di uno stato di profonda tranquillità, che è ciò a cui mirano varie tecniche di concentrazione della coscienza e integrazione della personalità.
1. Saggezza della Retta Visione
2. Giusto pensiero (panya)
3. Discorso corretto Moralità
4. Giusta condotta (Sheela)
5. Il modo giusto per preservare la vita
6. Corretta applicazione delle forze Meditazione
7. Correggere la memoria (samadhi)
8. Concentrazione corretta
L'Ottuplice Sentiero e le sue tre componenti
A questo proposito, la pratica dell’Ottuplice Sentiero è una sorta di processo di modellazione: questi otto principi mostrano come vivrà un Buddha e, vivendo come un Buddha, una persona può gradualmente diventarlo. L'Ottuplice Sentiero è quindi un percorso di auto-trasformazione, una ristrutturazione intellettuale, emotiva e morale, durante la quale una persona viene riorientata da obiettivi ristretti ed egoistici allo sviluppo di opportunità di autorealizzazione. Attraverso il desiderio di conoscenza (panya) e virtù morale (sila), l'ignoranza e i desideri egoistici vengono superati, le cause della sofferenza vengono eliminate e arriva il nirvana.
Quali nobili verità furono rivelate al Buddha?
1. La vita è sofferenza. La sofferenza è la nascita, la malattia, il contatto con lo spiacevole, la separazione da chi ami e la convivenza con persone a te estranee, costante delusione e insoddisfazione. La vita di qualsiasi persona (ricca o povera, fortunata o meno) si riduce alla sofferenza. Girando nella ruota della rinascita, una persona è condannata alla sofferenza eterna e riproduttiva. 2. Causa della sofferenza sono i desideri, la sete di vita, di potere e di piaceri, che portano alla continuazione della vita e a nuove sofferenze. I desideri e le azioni che provocano danno origine al karma (letteralmente "punizione") - una catena di causalità che determina la nascita e il destino successivi. Dalle buone azioni una persona rinasce nel regno degli dei, dei semidei o degli umani. Dai malvagi - nei mondi inferiori, tra gli animali e gli spiriti maligni. In ogni caso, una cosa è inevitabile: il coinvolgimento in un nuovo ciclo di nascite e morti, in nuove sofferenze. Questo ciclo è chiamato "samsara" - "ruota della vita". 3. La cessazione dei desideri porta alla cessazione della sofferenza. 4. Esiste un modo per sbarazzarsi dei desideri: l'ottuplice sentiero. Evita gli estremi dell'ascetismo, ma rifiuta anche l'edonismo, il desiderio del piacere. L'auto-miglioramento è richiesto da una persona.
L’idea che la vita sia piena di sofferenza non è nuova nella visione religiosa indiana del mondo. Ma Buddha lo portò all'estremo, quando nella vita non si riconosce altro che la sofferenza. Il Buddismo predica la rinuncia completa al mondo, a tutti i movimenti spirituali. “L’uomo saggio non piange nel suo cuore né i vivi né i morti”. Una persona che segue il Buddha è invitata: "Non lottare per le gioie, né terrene né celesti", sii equanime, non lasciarti sorprendere da nulla, non ammirare nulla, non lottare per nulla, non desiderare nulla. Il sentimento di amore per l'individuo non è compatibile con il Buddismo: bisogna strappare da sé “ogni attrazione per la forma e il nome”, cioè per l'individuo; un buddista dovrebbe diventare profondamente indifferente se accanto a lui c'è suo fratello o un completo estraneo che vede per la prima volta, perché ogni attaccamento è dolore, perché la personalità è un'illusione. 1
L’idea che la personalità, l’“io” e la fisicità essenzialmente non esistano è una delle più importanti nel Buddismo. Si ritiene che tutto nel mondo sia un flusso di minuscoli elementi-particelle in costante cambiamento: i dharma ("dharma" in sanscrito significa "detentore", "portatore"). Il mondo intero, ogni creatura vivente e ciò che chiamiamo uomo, la sua anima e la sua coscienza sono costituiti da essi. Infatti (questa è la conoscenza che manca alle persone comuni ignoranti) non c’è nulla di stabile e permanente in questo mondo. Non esiste la materia come sostanza permanente, non esiste ciò che una persona chiama “io”; Oggi hai gli stessi pensieri, sentimenti e stati d’animo, e domani – completamente diversi; una nuova combinazione di dharma cambia sia il corpo che la psiche. I dharma possono essere definiti portatori di uno stato psicofisico; la loro combinazione forma una data individualità. Pertanto, quando ci si reincarna in un altro corpo, non viene infusa la stessa anima immutabile, ma alcuni stati iniziali, così che come risultato si forma un nuovo complesso di dharma. Il famoso ricercatore buddista O. Rosenberg paragona questo a un nastro composto da fili diversi: puoi tessere un altro motivo dagli stessi fili e, sebbene la base sarà la stessa, il motivo (e quindi la cosa) sarà diverso 1 . La domanda è legittima: “Che cosa allora si reincarna se non esiste una personalità stabile? Dopotutto, non vengono preservati né i tratti caratteriali caratteristici di una determinata persona né la sua memoria, su cui si basa l’autoidentificazione, cioè l’autocoscienza di una persona?” Non esiste una risposta chiara a questo nel Buddismo.
Inizialmente, i dharma sono passivi, ma ricevono energia e vengono messi in moto dai pensieri, dalle parole e dalle azioni volitive di una persona. Il Buddha ha scoperto un metodo di “pacificazione dei dharma”, il cui risultato è la cessazione della catena delle rinascite. La cosa più importante è la cessazione dei desideri, l'assenza di aspirazioni nella vita. Naturalmente, raggiungere un tale stato non è facile, o meglio, impossibile, se si vive una vita mondana ordinaria.
Ottuplice Sentiero di Salvezza
L’Ottuplice Sentiero scoperto da Buddha comprende:
Opinioni corrette, cioè basate sulle “nobili verità”.
Giusta determinazione, cioè volontà di cambiare la propria vita in conformità con le verità buddiste, di intraprendere la strada che porta alla liberazione. La prima cosa necessaria per questo è il miglioramento morale. Include quanto segue:
Discorso corretto, ad es. amichevole, sincero, veritiero. Non puoi avere conversazioni oscene o usare parolacce.
Comportamento corretto, cioè adempimento dei cinque comandamenti: non danno agli esseri viventi (compresi gli animali), divieto di false testimonianze e di calunnie, divieto di furto, divieto di adulterio, divieto di uso di bevande inebrianti.
Lo stile di vita giusto, cioè pacifico, onesto, pulito. Astenersi da fonti di reddito “disoneste” (nel senso più ampio del termine), come il commercio di esseri viventi, bevande alcoliche, armi, droghe, ecc.
Sforzo corretto (zelo), cioè autoeducazione e autocontrollo, lotta contro le tentazioni e i cattivi pensieri.
Corretta attenzione o direzione del pensiero, cioè liberarsi delle passioni attraverso la consapevolezza della natura transitoria di tutto ciò che lega una persona alla vita. Idealmente, calma la mente e ferma i disturbi emotivi.
Giusta concentrazione, cioè giusti metodi di contemplazione e meditazione che portano al distacco dal mondo; il sentimento dell'inseparabilità del soggetto della contemplazione (la persona stessa), dell'oggetto della contemplazione (a cosa è diretta la sua coscienza) e del processo di contemplazione stesso. Di conseguenza, il mondo e l'uomo sono percepiti come un tutt'uno.
Avendo raggiunto la perfezione nell'ottuplice sentiero, una persona sarà in grado di liberarsi dalla sofferenza e dalla morte, non si incarnerà più. Questo stato è chiamato “nirvana” (in sanscrito significa “lenta estinzione del fuoco”, “estinzione”).
Nirvana
Cos'è esattamente il nirvana? Immortalità dell'anima (sebbene l'anima eterna non esista separatamente dal corpo, secondo la teoria del Buddismo) o cessazione di ogni esistenza, dispersione nell'Universo? Il Buddha stesso non ha mai risposto a questa domanda.
Sulla base dei pensieri di filosofi, scienziati culturali e studiosi religiosi sull'essenza del nirvana, penso che abbia senso considerare due forme di nirvana. Il primo è il nirvana, che una persona può raggiungere durante la sua vita. Allora possiamo dire con certezza che si tratta di un altro essere, come se esistesse in una dimensione speciale. Una persona è liberata dall'egoismo, l'orgoglio e l'orgoglio gli sono estranei, nulla può turbarlo, sente pace e amore per il mondo intero. Il Nirvana è la liberazione dal proprio “io”, superando ogni connessione mondana. Questo è uno stato di libertà mentale, gioia e armonia durature; le imperfezioni del mondo terreno cessano di influenzare l'uomo. Il Nirvana è uno stato di intensa attività spirituale, rinuncia all'azione e al desiderio, calma assoluta. “Il Nirvana è la distruzione delle fiamme della lussuria, dell’odio e dell’ignoranza” 1.
La seconda forma – il nirvana dopo la morte, l'uscita dalla catena delle reincarnazioni – resta inspiegabile. Gli stessi buddisti al Terzo Concilio (metà del III secolo a.C.) si espressero nel senso che il nirvana è incomprensibile per coloro che non l'hanno raggiunto. I nostri concetti terreni, le nostre parole non possono esprimere l'essenza di questo stato postumo. Tuttavia, S. Radhakrishnan scrive: “Il Nirvana o liberazione non è la dissoluzione dell'anima, ma il suo ingresso in uno stato di beatitudine che non ha fine. Questa è la liberazione dal corpo, ma non dall’esistenza”. Ma che tipo di esistenza può esserci se non c'è memoria, sentimenti, sé? Chi è beato e in cosa consiste tale beatitudine? Un'altra definizione, data da S. Radhakrishnan, parla piuttosto della trasformazione di una persona in nulla: “Questa è l'estinzione di una stella in un'alba brillante o lo scioglimento di una nuvola bianca nell'aria estiva...” 2.
Pratica religiosa del buddismo
Nell'insegnamento del Buddha originariamente non c'era posto per Dio. Dalle sue dichiarazioni possiamo concludere che non ha negato la presenza degli dei nel mondo, ma essi non hanno avuto alcun ruolo in materia di salvezza (liberazione dalla morte). Gli dei sono soggetti anche alla legge della reincarnazione e del karma, ad es. una persona che ha raggiunto il nirvana risulta essere superiore agli dei. È una conclusione legittima che un buddista non sia obbligato a ringraziare Dio, poiché non lo ha invocato durante la lotta. Gli dei si inchinano davanti a lui, non lui davanti agli dei.
Anche un'analisi superficiale dell'ottuplice cammino di salvezza proposto dal Buddha mostra che solo pochi possono seguirlo, poiché ad esso bisogna dedicare tutta la vita.
Infatti, già durante la vita del Buddha, dai suoi discepoli si formò la prima comunità monastica, il sangha (letteralmente “società”). I monaci erano chiamati bhikkhu (“mendicanti”) ed erano asceti. Rinunciarono alla proprietà, fecero voto di celibato, dedicarono tutto il loro tempo al lavoro spirituale e vivevano dell'elemosina dei laici. Fino a mezzogiorno potevano mangiare solo cibo vegetariano. Si rasavano la testa, indossavano una tonaca gialla e i loro effetti personali: un boccale per la raccolta dell'elemosina, una ciotola per l'acqua, un rasoio, un ago e un bastone. Non era consentito risparmiare cibo: doveva essere preso così tanto da essere sufficiente per un solo pasto. All'inizio, i bhikkhu vagavano per il paese, rifugiandosi nelle caverne durante la stagione delle piogge, dove dedicavano tempo alla riflessione e alla meditazione. Furono sepolti vicino ai loro habitat e furono erette cripte a cupola. A poco a poco, attorno a questi monumenti iniziarono a essere eretti edifici residenziali, che divennero monasteri. Nel Buddismo non esiste una casta sacerdotale, né un'organizzazione ecclesiastica. I monasteri divennero centri del buddismo, vi apparvero biblioteche e divennero università uniche.
L'etica dei monaci buddisti si basa sull'adempimento dei seguenti comandamenti: 1) non uccidere; 2) non rubare; 3) non commettere adulterio; 4) non mentire; 5) non bere bevande alcoliche; 6) non mangiare dopo mezzogiorno; 7) non ballare, non cantare, non assistere a spettacoli; 8) non indossare gioielli; 9) non utilizzare posti di lusso; 10) non prendere oro e argento.
Negando l'attaccamento a persone specifiche, il Buddismo richiede un amore onnicomprensivo per tutti gli esseri viventi, per l'umanità sofferente. Lo spirito benevolo di un buddista abbraccia tutti i mondi e incoraggia tutti a non danneggiare gli altri con bugie, rabbia o malizia. Il Buddismo predica la tolleranza e l’uguaglianza di tutte le persone.
Solo un monaco può raggiungere il nirvana e le persone comuni devono migliorare il proprio karma aiutando i bhikkhu asceti e sperare di diventare bhikkhu nelle incarnazioni successive.
Sviluppo e diffusione del Buddismo
Dopo la morte del Buddha, i suoi studenti formarono la scuola buddista più ortodossa: Theravada ("scuola dell'antica saggezza"). Il Buddismo cominciò a diffondersi con successo in India nel IV secolo. AVANTI CRISTO e. Era particolarmente popolare nel 3 ° secolo. AVANTI CRISTO e. sotto il re Ashoka, quando si trasformò in una sorta di religione nazionale. Dopo la morte del re Ashoka, regnò la dinastia Shunga, che patrocinò il Brahmanesimo. Quindi il centro del buddismo si trasferì nello Sri Lanka (Ceylon). Il secondo patrono del Buddismo in India dopo Ashoka fu il re Kanishka (I-II secolo); In questo momento, il buddismo inizia a diffondersi dai confini settentrionali dell'India all'Asia centrale, penetrando in Cina.
Nei primi secoli d.C. e. Una nuova direzione sta emergendo nel Buddismo, i cui sostenitori lo chiamano “Mahayana”, che significa “grande (o grande) veicolo”. Questo nome è associato all'universalità e all'accessibilità della salvezza, proclamata in questa versione del buddismo. Hanno soprannominato in senso peggiorativo il buddismo Theravada classico “Hinayana” (“piccolo, insignificante veicolo”).
La particolarità del Mahayana è che promette la salvezza non solo ai bhikkhu, ma anche ai laici comuni. In linea di principio, chiunque può raggiungere il nirvana: questo è ciò che afferma il buddismo Mahayana. Se nel buddismo classico la salvezza è il risultato degli sforzi di una persona, del suo instancabile lavoro su se stesso ("Non cercare protezione dagli altri, sii la tua protezione"), allora nel Mahayana una persona ha assistenti: bodhisattva. Un bodhisattva è una persona che ha raggiunto il nirvana ma ha rinunciato alla liberazione personale per salvare le persone. I bodhisattva hanno saggezza e compassione per gli altri. È così che appare l'altruismo nel buddismo, una persona riceve sostegno nel suo cammino verso la salvezza e la solitudine agghiacciante si allontana. Ma questo significa che una persona deve chiedere aiuto ai bodhisattva illuminati rivolgendosi a loro con preghiere. Sta emergendo un culto (preghiere e rituali), che non aveva posto nel buddismo originario, che non riconosceva Dio.
Anche l'immagine del Buddha diventa diversa. Da una persona che ha raggiunto l'illuminazione, si trasforma in un'eterna essenza divina. È stato sviluppato il concetto del "corpo cosmico del Buddha": una sostanza creativa che è in grado di assumere varie forme terrene per aiutare l'umanità a salvare l'umanità dalla sofferenza. Una di queste manifestazioni è l'incarnazione in una persona. Buddha apparve sulla Terra, assumendo forma umana, scegliendo il suo luogo di nascita e la famiglia reale degli Shakya. La sua nascita è miracolosa e ricorda la nascita verginale: sua madre sognava un elefante bianco (un'altra opzione è che l'elefante effettivamente discendesse da lei da una nuvola), che entrava nel suo lato destro, dopo di che la regina rimase incinta. Il Buddha nacque uscendo dal lato destro della regina, che era nel giardino, e immediatamente fece sette passi. Al posto delle sue impronte fiorirono fiori di loto bianchi.
Oltre al Buddha Shakyamuni, venivano adorati anche altri Buddha, il cui numero è molto elevato. Il secondo più importante tra quelli particolarmente venerati è il Buddha Amitabha, il creatore e sovrano del paradiso. C'è anche l'inferno come punizione per i peccati. L'immagine del paradiso - un luogo di beatitudine - è molto più comprensibile per i credenti comuni rispetto al concetto astratto e oscuro di nirvana. Ma questo non viene rifiutato, si sostiene che dal paradiso, questa terra magica, le persone passano al nirvana. Il terzo Buddha più importante è Maitreya (Amichevole). Verrà sulla terra per salvare il mondo intero, per salvare le persone dalla sofferenza. Questo è il Messia, il Salvatore (come I. Cristo nel cristianesimo).
Quindi, nel numeroso pantheon delle divinità del buddismo, il rango più alto sono i Buddha. Buddha è chiunque abbia raggiunto il nirvana. Proprietà di un Buddha: onnipotenza, capacità di compiere miracoli, influenzare gli eventi, apparire nel mondo in diverse forme.
Il secondo grado sono i bodhisattva, coloro che hanno rinunciato volontariamente al nirvana per aiutare le persone a raggiungere il nirvana qui sulla terra. Si distinguono per generosità, moralità, coraggio, pazienza, saggezza e capacità di contemplazione. I bodhisattva più venerati: Avalokiteshvara (personifica la compassione), Manjushri (portatore di saggezza), Vajrapani (combattente contro l'illusione e la stupidità).
Il terzo grado del pantheon sono gli arhat ("degni") - coloro che hanno raggiunto il livello più alto di perfezione spirituale (i discepoli e seguaci più vicini del Buddha Shakyamuni), così come i pratyeka buddha ("buddha per se stessi") - coloro che hanno raggiunto il nirvana, ma non salvano altre persone.
Nelle religioni indiane non esisteva un concetto sviluppato di paradiso e inferno (e nemmeno questi concetti stessi): questo è qualcosa di nuovo introdotto dal buddismo Mahayana. È interessante notare che la beatitudine celeste e il tormento infernale attendono ugualmente sia le persone che gli dei, soggetti alla legge del karma. La permanenza all'inferno è considerata temporanea, quindi le persone si incarnano nella vita terrena.
Diffusione del Buddismo
Il buddismo è stata la prima religione che ha attratto popoli di altre culture ed è riuscita a diffondersi in molti paesi adiacenti all'India. Allo stesso tempo, il Buddismo cambiò, si adattò alla mentalità di altri popoli e li arricchì con le sue idee e la sua pratica spirituale. Dal 3 ° secolo. AVANTI CRISTO e. Il buddismo è apparso in Asia centrale (gli attuali Tagikistan e Uzbekistan) a partire dal I secolo. - in Cina, dal II secolo. - nella penisola dell'Indocina, dal IV secolo. - in Corea, dal VI secolo. - in Giappone, dal VII secolo. - in Tibet, dal XII secolo. - in Mongolia.
È importante notare che il buddismo ortodosso classico (Theravada o Hinayana) si diffuse in Sri Lanka (Ceylon), Nyama (ex Birmania), Thailandia, Laos e Cambogia.
Il Buddismo Mahayana si affermò in Cina, da dove si diffuse in Giappone, Corea, Tibet, Mongolia e Russia.
I secoli II-VIII possono essere considerati il periodo di ascesa senza precedenti del buddismo. Apparvero molti monasteri buddisti: centri di educazione, apprendimento e arte. Alcuni monasteri divennero una sorta di università, dove venivano a studiare buddisti di diverse direzioni provenienti da tutta l'Asia. Nel V secolo Nel nord del Bihar (India) è stato aperto un famoso monastero: l'Università di Nalanda.
Tuttavia, in India dall'VIII secolo. Il buddismo cominciò a declinare, lasciando il posto all’induismo tradizionale. L'induismo è riuscito a includere nei suoi insegnamenti sia la pratica religiosa che molti elementi del buddismo. Buddha nell'Induismo divenne l'incarnazione del dio Brahma. Entro il 13 ° secolo. Il buddismo come religione indipendente in India è completamente scomparso.
In altri paesi si sono sviluppate forme nazionali di buddismo, le più famose sono il buddismo Chan in Cina (una combinazione di buddismo e taoismo) e il buddismo Zen in Giappone (una combinazione di buddismo e shintoismo) 1 .
Domande di autotest:
Quando appare il Buddismo, in cosa è diverso dal Brahmanesimo?
Chi è Budda?
L'esistenza di Dio(i) è accettata nel buddismo classico Theravada (Hinayana)?
Quali sono le quattro nobili verità del Buddismo?
Quali sono le caratteristiche più importanti degli insegnamenti buddisti sul mondo e sull'uomo?
Chi può raggiungere la salvezza (nirvana) secondo la teoria del buddismo classico (Hinayana)?
Cos'è il Sangha?
Quali sono le regole di condotta dei bhikkhu?
Dove si diffuse il Buddismo Hinayana classico?
Qual è la storia dello sviluppo e della diffusione del Buddismo?
Qual è la differenza tra il Buddismo Mahayana e quello originale (Hinayana)?
Interpretazione del Buddha nel Mahayana.
Chi sono i bodhisattva, gli arhat?
Cos'è il nirvana: durante la vita e dopo la morte?
Quali sono le ragioni del declino del Buddismo in India?
Letteratura:
Principale:
Zelenkov M. Yu. Religioni del mondo: storia e modernità: un libro di testo per studenti, dottorandi e docenti universitari - Rostov sul Don: Phoenix, 2008.
Ilyin V.V., Karmin A.S., Nosovich N.V. Studi religiosi - San Pietroburgo: Pietro, 2008.
Storia della religione. In 2 volumi: libro di testo per università/generale. ed. prof. I. N. Yablokova, volume 2. - M .: Scuola superiore, 2007.
Corano/trad. I. Yu Krachkovsky - Rostov n/D.: Phoenix, 2009.
Matetskaya A.V. Studi religiosi. Corso breve. – Rostov n/d.: Fenice, 2008.
Religioni del mondo: dizionario-riferimento/ed. A. Yu Grigorenko. – San Pietroburgo: Pietro, 2009.
Studi religiosi per studenti di università pedagogiche / ed. A. Yu Grigorenko. – San Pietroburgo: Pietro, 2008.
Ulteriori:
Alov A. A., Vladimirov N. G., Ovsienko F. G. Religioni del mondo. – M., 1998.
R. Uomini. Sermone di Gautama Buddha / Scienza e religione, 1991, n. 11; 1992, n. 1, 2.
Elchaninov A., Florensky P., Ern V. Storia della religione. – M.: modo russo; Parigi: YMCA-Press, 2005.
Ilyin V.V., Karmin A.S., Nosovich N.V. Studi religiosi. – San Pietroburgo: Pietro, 2008.
Oldenburg S. F. La vita di Buddha, il maestro indiano di vita. – Pag., 1919.
Radhakrishnan S. Filosofia indiana. M., 1956.
Studi religiosi: libro di testo e dizionario educativo minimo per gli studi religiosi. – M.: Gardariki, 2002.
Rosenberg O. Lavori sul buddismo. M.: Nauka, 1991
Enciclopedia per bambini. Vol. 6, parte 1. Religioni del mondo. - M., 1996.
Argomenti per saggi
Il ruolo della religione nella vita umana.
Differenza tra religioni teistiche e panteistiche.
Il nucleo della religione: fede o culto?
Il problema dell'attendibilità dell'esperienza spirituale.
Comprensione di Dio nelle religioni teistiche.
Caratteristiche della conoscenza mistica.
Motivazione del creazionismo.
Prove classiche dell'esistenza di Dio nella teologia e nella filosofia europea.
Prova moderna dell'esistenza di Dio.
I. Kant sul ruolo della religione.
Il marxismo sull'essenza della religione.
Le idee più importanti del libro di W. James “The Varieties of Religious Experience”.
La religione come giustificazione dei valori assoluti.
Cause e risultati della politica antireligiosa nello Stato sovietico.
Il significato del totemismo nella vita di un clan (tribù).
Manifestazione del feticismo ai nostri giorni.
D. Frazer sulla differenza tra magia e religione.
Religione degli antichi greci.
Religione degli antichi romani.
Religione degli antichi Celti.
Religione vudù.
Religione degli antichi slavi.
La teoria di S. Freud sull'origine della religione: pro e contro.
Settarismo moderno – essenza, varietà.
Antichi pensatori sull'origine della religione.
Tipi di pratica magica.
La magia attraverso gli occhi di scienziati e mistici.
Rituali e feste nell'ebraismo.
Misticismo nel giudaismo: chassidismo.
Interpretazione dei miti del libro “Genesi” (Bibbia, Antico Testamento).
TaNakh e la Bibbia: somiglianze e differenze.
La Kabbalah è l'insegnamento mistico del giudaismo.
Talmud - Tradizione nell'ebraismo. Struttura, contenuto.
Rituali e feste nell'Islam.
Il digiuno nel cristianesimo: la loro essenza e significato.
Rituali e feste nell'Ortodossia (cattolicesimo).
La differenza tra ortodossia e cattolicesimo.
Caratteristiche del protestantesimo, differenza dal cattolicesimo e dall'ortodossia.
L'essenza e il ruolo della Riforma nella cultura europea.
Il significato dell'idea di predestinazione nel protestantesimo.
Lutero e Calvino sono figure di spicco della Riforma.
Caratteristiche del misticismo nelle Chiese d'Oriente e d'Occidente.
Il ruolo della Sunnah nell'Islam.
Caratteristiche del misticismo nell'Islam (sufismo).
La Bibbia e il Corano: somiglianze e differenze.
Ebraismo, Cristianesimo, Islam: somiglianze e differenze.
Il ruolo dei profeti nelle religioni abramitiche.
Il futuro della religione
Cause dell'antisemitismo.
L'essenza e il significato dell'ascetismo.
Santi della Chiesa Ortodossa.
Santi della Chiesa occidentale (cattolica).
La verità (falsità) dello spiritismo.
Il Buddismo è una religione senza Dio.
Gli insegnamenti del Buddismo.
Il Nirvana è l'interpretazione della salvezza nel Buddismo.
Tripitaka - Il libro sacro del Buddismo.
Somiglianze tra cristianesimo e buddismo Mahayana.
La differenza tra il Buddismo Mahayana e il Theravada classico (Hinayana).
Il ruolo dei monasteri buddisti nella cultura indiana.
1Vedi: Breve dizionario filosofico. Ed. A. P. Alekseeva. 2a edizione, riveduta. e inoltre - PBOYUL M. A. Zakharov, 2001, p. 323.
1Vedi: Dizionario enciclopedico di studi culturali. – M., Casa editrice “Centro”, 1997, p.322.
1Vedi: Borodai Yu.M. Sulla questione degli aspetti socio-psicologici dell'origine della comunità tribale primitiva / Il principio dello storicismo nella conoscenza dei fenomeni sociali. – M.: Nauka, 1972, p. 189 – 190, 192.
2 Vedi: Borodai Yu.M., op. lavoratore, pag. 198.
1Vedi: Frazer J. Il ramo d'oro. – M., 1986.
1 La parola “sciamano” deriva dalla lingua degli Evenki (i popoli della Siberia); è ampiamente usata per riferirsi a persone di culture non occidentali, che in precedenza venivano chiamate “stregone”, “stregone”, “mago” , “strega”, “streghe”.
1 citazione di: Harner M. La Via dello Sciamano / Cristallo Magico: la magia attraverso gli occhi di scienziati e stregoni. – M.: Repubblica, 1992, p. 429.
2 Cfr.: Ibid., p. 413..
1Vedi: Enciclopedia per bambini. – M.: Casa editrice Avanta+, vol.6, parte 1, Religioni del mondo.p. 363.
1. Enciclopedia per bambini. T. 6. parte 1. Religioni del mondo - M.: Avanta+, 1996, p. 350.
1 “Promesso” significa “promesso”.
1 Vedi: Es.: 20, 2-17 - Bibbia. – Società Biblica Russa, M., 2004
1P. Florensky, A. Elchaninov, S. Ern. Storia della religione. Pag. 107.
1 Eccl 9; 7 - Bibbia. – M., 2004.
1 Alov A. A., Vladimirov N. G., Ovsienko F. G. Religioni del mondo. – M.: Casa editrice PRIOR, 1998. – p. 407.
1 Enciclopedia per bambini. Vol. 6, parte 1. Religioni del mondo. Con. 429.
1 Elchaninov A., Florensky P., Ern V. Storia della religione., p. 122.
2 Giobbe 14:10.
4 Eccl. 3:21
1 Sventsitskaya I. S. Cristianesimo primitivo: pagine di storia. – M.: Politizdat, 1989, p.73.
2mercoledì: Matt. 1,21: “E gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
2 Vedi: Cristianesimo. Dizionario Enciclopedico in 3 volumi: T. 3 – M.: Grande Enciclopedia Russa, 1995.p.395.
1 Si chiama così perché si celebra il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, che è una festa commovente.
1 Rashkova R. T. Cattolicesimo - San Pietroburgo: Pietro, 2007, p. 19.
1Vedi: Filocalia. In 5 voll. - Rappresentante. Pubblicato da Santissima Trinità Sergio Lavra, 1993.
1Vedi: Michel Malherbe. Religioni dell'umanità. M-Spb., 1997, pag. 306.
1Vedi: Cristianesimo. Dizionario Enciclopedico in 3 volumi – T 2, 1995, pp. 514 – 519.
1Rashkova R. T. Cattolicesimo, p. 203.
1Vedi: M. Lutero. 95 tesi - San Pietroburgo: Rosa del mondo, 2002.
1 Vedi: Elchaninov A., Florensky P., Ern V. Storia della religione – p. 92.
1Vedi: O. Rosenberg. Opere sul buddismo. - M.: Nauka, 1991, p. 24-25.
1Radhakrishnan S. Filosofia indiana. M., 1956. P. 381.
2Ibidem. P.383.
1Su questo vedi: N.V. Vetkasova. Un manuale di studi religiosi. Seconda parte. Storia delle religioni d'Oriente.
Gli insegnamenti del Buddha furono espressi sotto forma delle Quattro Nobili Verità.
"La prima nobile verità afferma che la caratteristica fondamentale dell'esistenza umana è duhkha, cioè la sofferenza e la delusione. La delusione è radicata nella nostra riluttanza a riconoscere il fatto ovvio che tutto intorno a noi non è eterno, tutto è transitorio. "Tutte le cose sorgono e muoiono", disse il Buddha, e l'idea che la fluidità e la mutevolezza siano le proprietà fondamentali della natura è il fondamento del suo insegnamento. Secondo i buddisti, la sofferenza nasce quando resistiamo al flusso della vita e cerchiamo di aggrapparci a certe forme stabili, che, siano esse cose, fenomeni, persone o pensieri, sono ancora maya. Il principio di impermanenza si incarna anche nell’idea che non esiste un ego speciale, un “io” speciale che sia il soggetto costante delle nostre mutevoli impressioni. I buddisti credono che la nostra fede nell'esistenza di un "io" individuale separato sia un'altra illusione, un'altra forma di maya, un concetto intellettuale privo di connessione con la realtà. Se aderiamo a tali punti di vista, come a qualsiasi altra categoria stabile di pensiero, sperimenteremo inevitabilmente delusione.
Seconda Nobile Verità spiega la causa della sofferenza, chiamandola trishna, cioè “attaccamento”, “attaccamento”. Questo è un attaccamento insignificante alla vita, derivante dall'ignoranza, che i buddisti chiamano avidya. A causa della nostra ignoranza, cerchiamo di dividere il mondo che percepiamo in parti separate e indipendenti e quindi di incarnare le forme fluide della realtà in categorie fisse di pensiero. Finché la pensiamo così, sperimenteremo una delusione dopo l’altra. Cercando di stabilire relazioni con cose che ci sembrano solide e permanenti, ma in realtà sono transitorie e mutevoli, ci ritroviamo in un circolo vizioso in cui ogni azione genera ulteriore azione, e la risposta a qualsiasi domanda solleva nuove domande. Nel Buddismo, questo circolo vizioso è noto come samsara, il ciclo di nascita e morte, la cui forza trainante è il karma, la catena infinita di causa ed effetto.
Secondo la Terza Nobile Verità, puoi smettere di soffrire e di delusione. Puoi lasciare il circolo vizioso del samsara, liberarti dai vincoli del karma e raggiungere uno stato di completa liberazione: il nirvana. In questo stato non ci sono più false idee sull'io separato e la sensazione costante e unica diventa l'esperienza dell'unità di tutte le cose. Il Nirvana corrisponde al moksha degli indù e non può essere descritto in modo più dettagliato, poiché questo stato di coscienza si trova al di fuori del regno dei concetti intellettuali. Raggiungere il nirvana significa risvegliarsi, cioè diventare un Buddha.
Quarta Nobile Verità indica un mezzo per liberarsi dalla sofferenza, invitando a seguire l'Ottuplice Sentiero di auto-miglioramento, che conduce alla Buddità. Come già accennato, i primi due passi su questo cammino hanno a che fare con la retta visione e la vera conoscenza, cioè la retta comprensione della vita umana. Altri quattro passi riguardano la giusta azione. Contengono una descrizione delle regole che un buddista deve seguire: le regole della Via di Mezzo, che si trova ad uguale distanza dagli estremi opposti. Gli ultimi due passi conducono alla corretta consapevolezza e alla corretta meditazione, alla percezione mistica diretta della realtà, che è la meta finale e più alta del Sentiero.
Il Buddha considerava il suo insegnamento non come un sistema filosofico coerente, ma come un mezzo per raggiungere l'illuminazione.
Le sue dichiarazioni su questo mondo hanno un obiettivo: enfatizzare l'impermanenza di tutte le cose. Ha messo in guardia i suoi seguaci dall'adorare ciecamente qualsiasi autorità, incluso se stesso, dicendo che poteva solo mostrare il percorso verso la Buddità e che tutti avrebbero dovuto seguire questo percorso da soli, facendo i propri sforzi.
Le ultime parole del Buddha sul letto di morte caratterizzano tutta la sua visione del mondo e il suo insegnamento. Prima di lasciare questo mondo, disse: “La decomposizione è il destino di tutte le cose composte. Sii persistente."
Per diversi secoli dopo la morte del Buddha, figure di spicco della chiesa buddista si riunirono più volte ai Grandi Consigli, dove le disposizioni degli insegnamenti del Buddha venivano lette ad alta voce e le discrepanze nella loro interpretazione venivano eliminate. Al quarto concilio, tenutosi nel I sec. N. e. sull'isola di Ceylon (Sri Lanka), gli insegnamenti, trasmessi oralmente per cinque secoli, furono scritti per la prima volta. Era chiamato canone pali, poiché i buddisti allora usavano la lingua pali, e divenne il pilastro del buddismo ortodosso Hinayana. D'altra parte, il Mahayana si basa su una serie di cosiddetti sutra - opere di notevole lunghezza scritte in sanscrito uno o due secoli dopo, che espongono gli insegnamenti del Buddha in modo più dettagliato e dettagliato rispetto al canone Pali.
La scuola Mahayana si definisce il Grande Veicolo del Buddismo, poiché offre ai suoi seguaci molti metodi diversi, mezzi perfetti, per raggiungere la Buddità - Buddità. Questi mezzi includono, da un lato, la fede religiosa negli insegnamenti del fondatore del Buddismo e, dall’altro, sistemi filosofici altamente sviluppati, le cui idee sono molto vicine alle categorie della moderna conoscenza scientifica”.
Fridtjof Capra, Il Tao della fisica: radici comuni della fisica moderna e del misticismo orientale, M., Sofia, 2008, p. 109-111.
1.
La nobile verità sulla sofferenza
2.
La nobile verità sull'origine delle cause della sofferenza
3.
La nobile verità sulla possibilità di porre fine alla sofferenza e alle sue cause
4.
La nobile verità del cammino verso la fine della sofferenza
Dalai Lama XIV (lezione) - Università di Washington
In effetti, tutte le religioni hanno le stesse motivazioni per l’amore e la compassione. Sebbene ci siano spesso grandi differenze nel campo della filosofia, l’obiettivo fondamentale del miglioramento è più o meno lo stesso. Ogni religione ha i suoi metodi speciali. Sebbene le nostre culture siano naturalmente diverse, i nostri sistemi si stanno avvicinando man mano che il mondo si avvicina grazie al miglioramento della comunicazione, offrendoci buone opportunità di imparare gli uni dagli altri. Penso che questo sia abbastanza utile.
Il cristianesimo, ad esempio, utilizza molti metodi pratici a beneficio dell’umanità, soprattutto nei settori dell’istruzione e della salute. I buddisti possono imparare molto qui. Allo stesso tempo, ci sono insegnamenti buddisti sulla meditazione profonda e modi di ragionamento filosofico da cui i cristiani potrebbero apprendere utili tecniche di coltivazione. Nell'antica India, buddisti e indù presero in prestito molti concetti gli uni dagli altri.
Poiché questi sistemi sono fondamentalmente gli stessi a beneficio dell’umanità, non c’è niente di sbagliato nell’imparare gli uni dagli altri. Al contrario, aiuterà a sviluppare il rispetto reciproco e aiuterà a promuovere l’armonia e l’unità. Quindi parlerò un po’ delle idee buddiste.
La radice della dottrina buddista sono le quattro nobili verità: la vera sofferenza, le sue cause, la soppressione di quest'ultima e il percorso verso questa. Le quattro verità consistono in due gruppi di effetto e di causa: la sofferenza e le sue cause, la cessazione della sofferenza e le modalità della sua attuazione. La sofferenza è come la malattia. Le condizioni esterne ed interne che portano dolore sono le cause della sofferenza. Lo stato di guarigione dalla malattia è la soppressione della sofferenza e delle sue cause. Le medicine che curano i disturbi sono la strada giusta.
Le ragioni per considerare gli effetti (la sofferenza e la sua soppressione) prima delle cause (fonti della sofferenza e percorsi) sono le seguenti: bisogna innanzitutto stabilire la malattia, il vero tormento, che è l'essenza della prima nobile verità . Allora non basterà più semplicemente ammettere la malattia. Perché per sapere quale medicina prendere, è necessario conoscere le malattie. Ciò significa che la seconda delle quattro verità sono le cause o fonti della sofferenza.
Anche stabilire le cause della malattia non sarà sufficiente; è necessario determinare se la malattia può essere curata. Questa conoscenza è proprio il terzo livello, cioè che esiste una corretta soppressione della sofferenza e delle sue cause.
Ora che la sofferenza indesiderata è stata identificata, le sue cause sono state stabilite e quindi è diventato chiaro che la malattia può essere curata, si assumono farmaci che sono il mezzo per eliminare la malattia. Bisogna avere fiducia nei percorsi che condurranno ad uno stato di liberazione dalla sofferenza.
La cosa più importante è stabilire immediatamente la sofferenza. In generale, ci sono tre tipi di sofferenza: sofferenza del dolore, sofferenza del cambiamento e sofferenza complessa e diffusa. Soffrire dolore è ciò che di solito confondiamo con un tormento fisico o mentale, come un mal di testa. Il desiderio di essere liberati da questo tipo di sofferenza è caratteristico non solo delle persone, ma anche degli animali. Esistono modi per evitare alcune forme di tale sofferenza, come assumere farmaci, indossare abiti caldi ed eliminare la fonte della malattia.
Il secondo livello - la sofferenza del cambiamento - è ciò che superficialmente percepiamo come piacere, ma vale la pena guardare più da vicino per comprendere la vera essenza della sofferenza. Prendi ad esempio qualcosa che di solito è considerato divertente: acquistare una nuova auto. Quando lo acquisti sei estremamente felice, felice e soddisfatto, ma mentre lo usi sorgono problemi. Se le cause del piacere fossero interne, allora più utilizzi la causa della soddisfazione, più il tuo piacere dovrebbe aumentare di conseguenza, ma ciò non accade. Man mano che ti abitui sempre di più, inizi a provare dispiacere. Pertanto, la sofferenza del cambiamento rivela anche l'essenza della sofferenza.
Il terzo livello di sofferenza serve come base per i primi due. Riflette i nostri complessi inquinati mentali e fisici. Si chiama sofferenza complessa e pervasiva perché pervade ed è collegata a tutti i tipi di rinascita degli esseri, è parte della base della sofferenza presente e causa anche sofferenza futura. Non c’è modo di uscire da questo tipo di sofferenza se non quello di fermare la serie di rinascite.
Questi tre tipi di sofferenza sono stabiliti fin dall’inizio. Pertanto, non solo non esistono sentimenti che possano essere identificati con la sofferenza, ma non esistono nemmeno fenomeni esterni o interni a seconda dei quali tali sentimenti sorgerebbero. La combinazione di menti e fattori mentali è chiamata sofferenza.
Quali sono le cause della sofferenza? A seconda di cosa si presenta? Tra questi, le fonti karmiche e le emozioni disturbanti sono la seconda delle quattro nobili verità sulla vera causa della sofferenza. Il karma o l'azione consiste in azioni corporee, verbali e mentali. Dal punto di vista della realtà presente o essenza, le azioni sono di tre tipi: virtuose, non virtuose e indifferenti. Le azioni virtuose sono quelle che producono conseguenze piacevoli o buone. Le azioni non virtuose sono quelle che causano conseguenze dolorose o negative.
Le tre principali passioni disturbanti sono l'illusione, il desiderio e l'odio. Emergono anche molti altri tipi di emozioni disturbanti, come l'invidia e l'ostilità. Per fermare le azioni karmiche, bisogna fermare queste passioni disturbanti che agiscono come causa. Se confrontiamo il karma e le emozioni violente, la causa principale della sofferenza è quest'ultima.
Quando ti chiedi se sia possibile eliminare le passioni inquiete, stai già toccando la terza nobile verità, la vera cessazione. Se le emozioni disturbanti fossero localizzate nella natura stessa della mente, non potrebbero essere rimosse. Ad esempio, se l'odio fosse nella natura della mente, allora ne sentiremmo il bisogno per molto tempo, ma questo chiaramente non accade. Lo stesso vale per l’attaccamento. Pertanto, la natura della mente o coscienza non è contaminata dalle contaminazioni. Le contaminazioni possono essere rimosse, adatte ad essere eliminate dalla base, la mente.
È chiaro che le buone relazioni sono l’opposto di quelle cattive. Ad esempio, l’amore e la rabbia non possono sorgere contemporaneamente nella stessa persona. Finché provi rabbia verso un determinato oggetto, non sarai in grado di provare amore nello stesso momento. Al contrario, mentre provi amore, non puoi provare rabbia. Ciò indica che questi tipi di coscienza si escludono a vicenda e sono opposti. Naturalmente, man mano che diventi più propenso a un tipo di relazione, l'altro si indebolirà sempre di più. Ecco perché, praticando e aumentando la compassione e l’amore – il lato buono della mente – sradicherai automaticamente l’altro lato.
Quindi è stato stabilito che le fonti della sofferenza possono essere gradualmente eliminate. La completa scomparsa della causa della sofferenza è la corretta cessazione. Questa è la liberazione finale, questa è la vera salvezza che calma la pace. Ecco la terza delle quattro nobili verità.
Quale percorso dovresti intraprendere per raggiungere questa cessazione? Poiché le carenze derivano principalmente dalle azioni della mente, l’antidoto deve essere mentale. In effetti, bisogna conoscere l'esistenza ultima di tutti i fenomeni, ma la cosa più importante è conoscere lo stato mentale ultimo.
Per prima cosa devi realizzare di nuovo, direttamente e perfettamente, la natura non duale e assoluta della mente, esattamente così com'è. Questo è il modo di vedere. Quindi, al livello successivo, questa percezione diventa normale. Questo è già il percorso della meditazione. Ma prima di questi due livelli è necessario raggiungere la duplice stabilità meditativa, che è l’unità di tranquillità e visione speciale. In generale, questo deve essere fatto per avere una coscienza potente e sofisticata, per la quale è necessario, prima di tutto, sviluppare la stabilità della coscienza, chiamata tranquillità.
Questi sono i livelli del sentiero, la quarta nobile verità, richiesta per la realizzazione della terza nobile verità, la verità della cessazione, che a sua volta elimina le prime due nobili verità, vale a dire la sofferenza e le sue cause.
Le Quattro Verità costituiscono la struttura centrale della dottrina e della pratica buddista.
Domanda: Almeno superficialmente, sembra esserci una differenza tra il principio buddista dell’eliminazione e l’importanza occidentale di avere uno scopo nella vita, il che implica che il desiderio è positivo.
Risposta: Esistono due tipi di desiderio: uno è privo di ragione e misto a passioni violente, il secondo è quando si guarda il bene in quanto buono e si cerca di realizzarlo. L'ultimo tipo di desiderio è corretto dato che tutti coloro che vivono sono coinvolti in attività. È vero, ad esempio, credere che il progresso materiale si basi sulla consapevolezza che questo progresso è utile all’umanità e quindi è positivo.