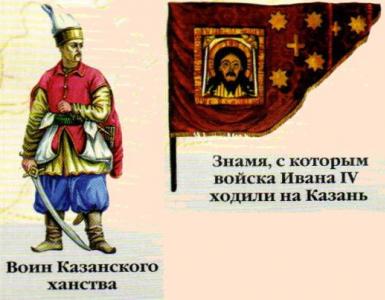Uno standard di moralità generalmente accettato. Norme e principi morali
 La moralità è un concetto condizionale di regole, principi, valutazioni, norme basato sul paradigma delle valutazioni del male e del bene, che si è formato in un certo periodo di tempo. Questo è un modello di coscienza sociale, un metodo per regolare il comportamento di un soggetto nella società. Si sviluppa sia in forme individuali che sociali di relazioni soggettive.
La moralità è un concetto condizionale di regole, principi, valutazioni, norme basato sul paradigma delle valutazioni del male e del bene, che si è formato in un certo periodo di tempo. Questo è un modello di coscienza sociale, un metodo per regolare il comportamento di un soggetto nella società. Si sviluppa sia in forme individuali che sociali di relazioni soggettive.
Il concetto di moralità dal punto di vista considerato dagli psicologi è un frammento della psiche umana, formato a livello profondo, responsabile della valutazione degli eventi che si verificano su vari piani con il significato di bene e male. La parola moralità è spesso usata come sinonimo della parola moralità.
Cos'è la moralità
La parola "moralità" deriva dal latino classico. Deriva da “mos”, parola latina che significa carattere, consuetudine. Riferendosi ad Aristotele, Cicerone, guidato da questo significato, formò le parole: “moralis” e “moralitas” - morale ed etica, che divennero equivalenti alle espressioni della lingua greca: etica ed etica.
Il termine “moralità” viene utilizzato principalmente per designare il tipo di comportamento della società nel suo insieme, ma ci sono delle eccezioni, ad esempio la moralità cristiana o borghese. Pertanto, il termine viene utilizzato solo in relazione a un gruppo limitato della popolazione. Analizzando l'atteggiamento della società nelle diverse epoche dell'esistenza nei confronti della stessa azione, va notato che la moralità è un valore condizionale, variabile in relazione alla struttura sociale accettata. Ogni nazione ha la propria moralità, basata sull'esperienza e sulle tradizioni.
Alcuni scienziati hanno anche notato che regole morali diverse si applicano non solo a soggetti di nazionalità diverse, ma anche a soggetti appartenenti a un gruppo “alieno”. La definizione di un gruppo di persone nel vettore “amico”, “estraneo” avviene a livello psicologico della relazione dell'individuo con questo gruppo in vari sensi: culturale, etnico e altri. Identificandosi con un gruppo specifico, il soggetto accetta quelle regole e norme (moralità) che sono accettate in esso; considera questo modo di vivere più giusto che seguire la moralità dell'intera società.
Una persona conosce un gran numero di significati di questo concetto, che viene interpretato da vari punti di vista in varie scienze, ma la sua base rimane costante: questa è la definizione di una persona delle sue azioni, le azioni della società nell'equivalente di "buono o Cattivo".
La moralità viene creata sulla base del paradigma adottato in una particolare società, poiché le designazioni di "buono o cattivo" sono relative, non assolute, e la spiegazione della moralità o dell'immoralità di vari tipi di atti è condizionale.
La moralità, come combinazione di regole e norme della società, si forma per un lungo periodo sulla base delle tradizioni e delle leggi adottate in una particolare società. Per fare un confronto, puoi usare l'esempio associato al rogo delle streghe, donne sospettate di usare la magia e la stregoneria. In un periodo come il Medioevo, sullo sfondo delle leggi adottate, un'azione del genere era considerata un atto altamente morale, cioè buono. Nel moderno paradigma delle leggi adottate, tale atrocità è considerata un crimine assolutamente inaccettabile e stupido contro il soggetto. Allo stesso tempo, puoi includere incidenti come guerre sante, genocidi o schiavitù. Nella loro epoca, in una società particolare con le proprie leggi, tali azioni erano accettate come la norma ed erano considerate assolutamente morali.
La formazione della moralità è direttamente correlata all'evoluzione dei vari gruppi etnici dell'umanità nella sua chiave sociale. Gli scienziati che studiano l'evoluzione sociale delle persone considerano la moralità il risultato dell'influenza delle forze dell'evoluzione sul gruppo nel suo insieme e sugli individui individualmente. In base alla loro comprensione, le norme comportamentali prescritte dalla moralità cambiano durante l'evoluzione dell'umanità, garantendo la sopravvivenza delle specie e la loro riproduzione e garantendo il successo dell'evoluzione. Insieme a ciò, il soggetto costituisce in sé una parte fondamentale “prosociale” della psiche. Di conseguenza, si forma un sentimento di responsabilità per ciò che è stato fatto, un senso di colpa.
Di conseguenza, la moralità è un certo insieme di norme comportamentali che si forma per un lungo periodo di tempo, sotto l'influenza delle condizioni ambientali in un certo momento forma un insieme di norme ideologiche stabilite che contribuiscono allo sviluppo della cooperazione umana. Si mira anche ad evitare l'individualismo del soggetto nella società; formazione di gruppi uniti da una visione del mondo comune. I sociobiologi considerano questo punto di vista in un certo numero di specie di animali sociali; c'è il desiderio di cambiare il comportamento finalizzato alla sopravvivenza e alla conservazione della propria specie durante il periodo dell'evoluzione. Ciò corrisponde alla formazione della moralità, anche negli animali. Negli esseri umani, le norme morali sono più sofisticate e diversificate, ma si concentrano anche sulla prevenzione dell'individualismo nel comportamento, che contribuisce alla formazione delle nazionalità e, di conseguenza, aumenta le possibilità di sopravvivenza. Si ritiene che anche norme di comportamento come l'amore dei genitori siano conseguenze dell'evoluzione della moralità umana: questo tipo di comportamento aumenta il livello di sopravvivenza della prole.
Gli studi sul cervello umano condotti da sociobiologi determinano che le parti della corteccia cerebrale del soggetto coinvolte quando una persona è preoccupata per questioni morali non formano un sottosistema cognitivo separato. Spesso, durante il periodo di risoluzione dei problemi morali, vengono attivate aree del cervello che localizzano la rete neurale responsabile delle idee del soggetto sulle intenzioni degli altri. Nella stessa misura è coinvolta la rete neurale responsabile della rappresentazione dell’esperienza emotiva di altri individui. Cioè, quando risolve problemi morali, una persona usa quelle parti del suo cervello che corrispondono all'empatia e alla compassione, questo indica che la moralità mira a sviluppare la comprensione reciproca tra i soggetti (la capacità di un individuo di vedere le cose attraverso gli occhi di un altro soggetto, di comprendere i suoi sentimenti e le sue esperienze). Secondo la teoria della psicologia morale, la moralità in quanto tale si sviluppa e cambia man mano che si sviluppa la personalità. Esistono diversi approcci per comprendere la formazione della moralità a livello personale:
– approccio cognitivo (Jean Piaget, Lorenz Kohlberg e Eliot Turiel) – la moralità nello sviluppo personale attraversa diverse fasi o aree costruttive;
– approccio biologico (Jonathan Haidt e Martin Hoffman) – la moralità è considerata nel contesto dello sviluppo della componente sociale o emotiva della psiche umana. Interessante per lo sviluppo della dottrina della moralità come componente psicologica della personalità è l'approccio dello psicoanalista Sigmund Freud, il quale ha suggerito che la moralità si forma come conseguenza del desiderio del “Super Io” di uscire dallo stato di colpa.
Cosa sono gli standard morali
L'adempimento delle norme morali è dovere morale del soggetto; la violazione di queste misure di comportamento rappresenta un sentimento di colpa morale.
Le norme morali nella società sono misure generalmente accettate del comportamento dei soggetti che derivano dalla moralità formata. L'insieme di queste norme forma un certo sistema di regole, che differisce sotto tutti gli aspetti dai sistemi normativi della società come costumi, diritti ed etica.
Nelle prime fasi della formazione, le norme morali erano direttamente correlate alla religione, che prescrive alle norme morali il significato della rivelazione divina. Ogni religione ha una serie di determinate norme morali (comandamenti) che sono obbligatorie per tutti i credenti. Il mancato rispetto degli standard morali prescritti nella religione è considerato un peccato. In varie religioni del mondo esiste un certo modello in conformità con gli standard morali: il furto, l'omicidio, l'adulterio e la menzogna sono regole di comportamento innegabili per i credenti.
I ricercatori che studiano la formazione delle norme morali propongono diverse direzioni per comprendere il significato di queste norme nella società. Alcuni credono che il rispetto delle regole prescritte dalla moralità sia una priorità sotto forma di altre norme. I seguaci di questa tendenza attribuiscono a queste norme morali determinate proprietà: universalità, categoricità, immutabilità, crudeltà. La seconda direzione, studiata dagli scienziati, suggerisce che l'attribuzione dell'assolutismo, delle norme morali generalmente accettate e obbligatorie agisce come qualcuno.
In termini di forma di manifestazione, alcune norme morali nella società sono simili alle norme legali. Quindi il principio “non rubare” è comune ad entrambi i sistemi, ma ponendo la domanda perché un soggetto segue questo principio, si può determinare la direzione del suo pensiero. Se un soggetto segue un principio perché teme la responsabilità legale, allora il suo atto è legale. Se il soggetto segue con sicurezza questo principio, poiché il furto è un atto cattivo (malvagio), il vettore di direzione del suo comportamento segue il sistema morale. Esistono precedenti in cui il rispetto degli standard morali è contrario alla legge. Un soggetto, considerando suo dovere, ad esempio, rubare la medicina per salvare dalla morte la persona amata, agisce moralmente correttamente, infrangendo assolutamente la legge.
Studiando la formazione delle norme morali, gli scienziati sono giunti a una certa classificazione:
– norme che riguardano questioni relative all'esistenza di un individuo come essere biologico (omicidio);
– norme sull'indipendenza del soggetto;
– norme di fiducia (lealtà, veridicità);
– norme relative alla dignità del soggetto (onestà, giustizia);
– norme su altre norme morali.
Funzioni della moralità
L'uomo è una creatura con libertà di scelta e ha tutto il diritto di scegliere la strada per seguire gli standard morali o viceversa. Questa scelta di una persona che mette sulla bilancia il bene o il male si chiama scelta morale. Avendo tale libertà di scelta nella vita reale, il soggetto si trova di fronte a un compito difficile: seguire ciò che è personale o seguire ciecamente ciò che dovrebbe essere. Avendo fatto una scelta per se stesso, il soggetto porta con sé alcune conseguenze morali, di cui il soggetto stesso è responsabile, sia verso la società che verso se stesso.
Analizzando le caratteristiche della moralità, possiamo estrarre molte delle sue funzioni:
– Funzione di regolazione. Seguire i principi morali lascia una certa impronta nella coscienza dell'individuo. La formazione di determinate visioni del comportamento (cosa è consentito fare e cosa non è consentito) avviene fin dalla tenera età. Questo tipo di azione aiuta il soggetto ad adeguare il proprio comportamento in linea con l'utilità non solo per se stesso, ma anche per la società. Le norme morali sono in grado di regolare le convinzioni individuali del soggetto nella stessa misura dell'interazione tra gruppi di persone, il che favorisce la conservazione della cultura e della stabilità.
– Funzione di valutazione. La moralità valuta le azioni e le situazioni che si verificano in una società sociale in termini di bene e male. Le azioni compiute vengono valutate in base alla loro utilità o negatività per un ulteriore sviluppo, dopodiché ad ogni azione viene data una valutazione dal punto di vista morale. Grazie a questa funzione il soggetto forma il concetto di appartenenza alla società e sviluppa la propria posizione in essa.
– Funzione educativa. Sotto l'influenza di questa funzione, una persona sviluppa la consapevolezza dell'importanza non solo dei propri bisogni, ma anche dei bisogni delle persone che lo circondano. Nasce un sentimento di empatia e rispetto, che contribuisce allo sviluppo armonioso delle relazioni nella società, alla comprensione degli ideali morali di un altro individuo e contribuisce a una migliore comprensione reciproca.
– Funzione di controllo. Determina il controllo sull'uso delle norme morali, nonché la condanna delle loro conseguenze a livello sociale e individuale.
– Funzione di integrazione. Il rispetto degli standard morali unisce l’umanità in un unico gruppo, che sostiene la sopravvivenza dell’uomo come specie. Aiuta anche a mantenere l'integrità del mondo spirituale dell'individuo. Le funzioni chiave della moralità sono: valutativa, educativa e normativa. Riflettono il significato sociale della moralità.
Morale ed etica
Il termine etica deriva dal greco "ethos". L'uso di questa parola denotava azioni o azioni di una persona che erano potenti per lui personalmente. Aristotele definì il significato della parola "ethos" come la virtù del carattere di un soggetto. Successivamente fu consuetudine che la parola “ethicos” fosse ethos, cioè qualcosa legato al temperamento o all’indole del soggetto. L'emergere di una tale definizione ha portato alla formazione della scienza dell'etica: lo studio delle virtù del carattere del soggetto. Nella cultura dell'antico impero romano esisteva la parola "moralis" che definiva una vasta gamma di fenomeni umani. Più tardi apparve un derivato di questo termine "moralitas", relativo ai costumi o al carattere. Analizzando il contenuto etimologico di questi due termini (“moralitas” ed “ethicos”), va notato che i loro significati coincidono.
Molte persone sanno che concetti come “moralità” ed “etica” hanno un significato vicino e sono spesso considerati intercambiabili. Molte persone usano questi concetti come estensioni reciproche. L'etica, prima di tutto, è una direzione filosofica che studia le questioni morali. Spesso l'espressione “etica” viene utilizzata per designare specifici principi morali, tradizioni e costumi che esistono tra i soggetti di un gruppo limitato della società. Il sistema kantiano vede la parola moralità usandola per denotare il concetto di dovere, principi di comportamento e obblighi. La parola "etica" utilizza il sistema di ragionamento di Aristotele per denotare la virtù, l'inseparabilità delle considerazioni morali e pratiche.
Il concetto di moralità, come sistema di principi, forma un insieme di regole basate su molti anni di pratica e consente a una persona di determinare lo stile di comportamento nella società. L'etica è una sezione della filosofia e della giustificazione teorica di questi principi. Nel mondo moderno, il concetto di etica ha mantenuto la sua designazione originale come scienza nei ranghi della filosofia che studia le proprietà umane, i fenomeni reali, le regole e le norme, che sono norme morali nella società.
Moralità (dal latino moralis - morale; mores - morale) è uno dei modi di regolazione normativa del comportamento umano, una forma speciale di coscienza sociale e un tipo di relazioni sociali. Esistono numerose definizioni di moralità che mettono in risalto alcune delle sue proprietà essenziali.
La moralità è uno dei modi per regolare il comportamento delle persone nella società. È un sistema di principi e norme che determinano la natura delle relazioni tra le persone in conformità con i concetti accettati in una data società di bene e male, giusto e ingiusto, degno e indegno. Il rispetto dei requisiti morali è assicurato dal potere dell'influenza spirituale, dell'opinione pubblica, della convinzione interiore e della coscienza di una persona.
La particolarità della moralità è che regola il comportamento e la coscienza delle persone in tutte le sfere della vita (attività produttive, vita quotidiana, famiglia, relazioni interpersonali e altre). La moralità si estende anche alle relazioni intergruppo e interstatali.
Principi morali hanno un significato universale, abbracciano tutte le persone, consolidano le basi della cultura delle loro relazioni, create nel lungo processo di sviluppo storico della società.
Ogni azione, il comportamento umano può avere una varietà di significati (giuridici, politici, estetici, ecc.), Ma il suo lato morale, il contenuto morale è valutato su un'unica scala. Le norme morali vengono riprodotte quotidianamente nella società attraverso il potere della tradizione, il potere di una disciplina generalmente riconosciuta e sostenuta e l'opinione pubblica. La loro attuazione è controllata da tutti.
La moralità è considerata sia come una forma speciale di coscienza sociale, sia come un tipo di relazioni sociali, sia come norme di comportamento operanti nella società che regolano l'attività umana - l'attività morale.
Attività morale rappresenta il lato oggettivo della moralità. Possiamo parlare di attività morale quando un atto, un comportamento e le relative motivazioni possono essere valutati dal punto di vista della distinzione tra bene e male, degno e indegno, ecc. L'elemento primario dell'attività morale è un atto (o un delitto), poiché esso incarna obiettivi, motivazioni o orientamenti morali. Un'azione include: motivo, intenzione, scopo, azione, conseguenze dell'azione. Le conseguenze morali di un’azione sono l’autostima di una persona e la valutazione da parte degli altri.
La totalità delle azioni di una persona che hanno un significato morale, eseguite da lui per un periodo relativamente lungo in condizioni costanti o mutevoli, è solitamente chiamata comportamento. Il comportamento di una persona è l'unico indicatore oggettivo delle sue qualità morali e del suo carattere morale.
L'attività morale caratterizza solo le azioni moralmente motivate e intenzionali. La cosa decisiva qui sono i motivi che guidano una persona, i suoi motivi specificamente morali: il desiderio di fare del bene, realizzare un senso del dovere, raggiungere un certo ideale, ecc.
Nella struttura della moralità è consuetudine distinguere tra i suoi elementi costitutivi. La moralità comprende norme morali, principi morali, ideali morali, criteri morali, ecc.
Standard morali- queste sono norme sociali che regolano il comportamento di una persona nella società, il suo atteggiamento verso le altre persone, verso la società e verso se stesso. La loro attuazione è assicurata dal potere dell'opinione pubblica, dalla convinzione interna basata sulle idee accettate in una data società sul bene e sul male, sulla giustizia e sull'ingiustizia, sulla virtù e sul vizio, sul dovuto e sul condannato.
Le norme morali determinano il contenuto del comportamento, il modo in cui è consuetudine agire in una determinata situazione, cioè la morale inerente a una determinata società o gruppo sociale. Differiscono dalle altre norme che operano nella società e che svolgono funzioni normative (economiche, politiche, legali, estetiche) nel modo in cui regolano le azioni delle persone. La morale viene riprodotta quotidianamente nella vita della società attraverso il potere della tradizione, l'autorità e il potere di una disciplina generalmente riconosciuta e sostenuta, l'opinione pubblica e la convinzione dei membri della società riguardo al comportamento corretto in determinate condizioni.
A differenza dei semplici usi e costumi, quando le persone agiscono allo stesso modo in situazioni simili (feste di compleanno, matrimoni, addii all'esercito, vari rituali, abitudine a determinate attività lavorative, ecc.), le norme morali non vengono semplicemente soddisfatte a causa dell'ordine generalmente accettato stabilito, ma trova giustificazione ideologica nelle idee di una persona sul comportamento corretto o inappropriato sia in generale che in una specifica situazione di vita.
La formulazione delle norme morali come regole di comportamento ragionevoli, appropriate e approvate si basa su principi reali, ideali, concetti di bene e male, ecc., Che operano nella società.
L'adempimento delle norme morali è assicurato dall'autorità e dalla forza dell'opinione pubblica, dalla coscienza del soggetto di ciò che è degno o indegno, morale o immorale, che determina la natura delle sanzioni morali.
Norma morale in linea di principio destinati all'esecuzione volontaria. Ma la sua violazione comporta sanzioni morali, consistenti in una valutazione negativa e nella condanna del comportamento di una persona e in un'influenza spirituale diretta. Significano un divieto morale di commettere atti simili in futuro, rivolto sia a una persona specifica che a tutti coloro che la circondano. La sanzione morale rafforza i requisiti morali contenuti nelle norme e nei principi morali.
La violazione degli standard morali può comportare oltre alla morale sanzioni- sanzioni di altro genere (disciplinari o previste da norme di organismi pubblici). Ad esempio, se un militare ha mentito al suo comandante, a questo atto disonesto seguirà una reazione adeguata in base al grado di gravità sulla base delle norme militari.
Le norme morali possono essere espresse sia in forma negativa, proibitiva (ad esempio, Legge mosaica- I Dieci Comandamenti formulati nella Bibbia) e in positivo (sii onesto, aiuta il prossimo, rispetta gli anziani, abbi cura del tuo onore fin dalla giovane età, ecc.).
Principi morali- una delle forme di espressione dei requisiti morali, nella forma più generale che rivela il contenuto della moralità esistente in una particolare società. Esprimono requisiti fondamentali riguardanti l'essenza morale di una persona, la natura delle relazioni tra le persone, determinano la direzione generale dell'attività umana e sono alla base di norme di comportamento private e specifiche. A questo proposito, servono come criteri di moralità.
Se la norma morale prescrive quali azioni specifiche una persona dovrebbe compiere e come comportarsi in situazioni tipiche, allora il principio morale dà a una persona una direzione generale di attività.
Tra i principi morali includere principi generali di moralità come umanesimo- riconoscimento di una persona come valore più alto; altruismo: servizio disinteressato al prossimo; misericordia: amore compassionevole e attivo, espresso nella disponibilità ad aiutare tutti i bisognosi; collettivismo: un desiderio consapevole di promuovere il bene comune; rifiuto dell'individualismo - opposizione dell'individuo alla società, a ogni socialità ed egoismo - preferenza dei propri interessi agli interessi di tutti gli altri.
Oltre ai principi che caratterizzano l'essenza di una particolare moralità, esistono i cosiddetti principi formali che riguardano i metodi per soddisfare i requisiti morali. Tali, ad esempio, sono la coscienza e il suo formalismo opposto, feticismo , fatalismo , fanatismo , dogmatismo. Principi di questo tipo non determinano il contenuto di specifiche norme di comportamento, ma caratterizzano anche una certa moralità, mostrando come vengono soddisfatti consapevolmente i requisiti morali.
Ideali morali- concetti di coscienza morale, in cui le esigenze morali poste alle persone sono espresse sotto forma di un'immagine di una personalità moralmente perfetta, un'idea di una persona che incarna le qualità morali più elevate.
L'ideale morale veniva inteso diversamente in tempi diversi, in società e insegnamenti diversi. Se Aristotele vedeva un ideale morale in una persona che considera la virtù più alta come autosufficiente, distaccata dalle preoccupazioni e dalle ansie dell'attività pratica, dalla contemplazione della verità, quindi Emmanuel Kant(1724-1804) caratterizzò l'ideale morale come guida delle nostre azioni, “l'uomo divino che è in noi” con il quale ci confrontiamo e miglioriamo, ma senza mai riuscire a metterci al suo stesso livello. L'ideale morale è definito a modo suo da vari insegnamenti religiosi, movimenti politici e filosofi.
L'ideale morale accettato da una persona indica l'obiettivo finale dell'autoeducazione. L'ideale morale accettato dalla coscienza morale pubblica determina lo scopo dell'educazione e influenza il contenuto dei principi e delle norme morali.
Possiamo parlarne. ideale morale pubblico come immagine di una società perfetta costruita sui requisiti della massima giustizia e umanesimo.
OBIETTIVI:
- dare un'idea del problema filosofico di determinare l'essenza della moralità;
- formare un'idea delle proprietà essenziali e specifiche della moralità come tipo di regolamentazione sociale;
- sviluppare capacità di analisi della struttura della moralità;
- dare un'idea e sviluppare capacità di analisi delle funzioni della moralità.
1. L'essenza della moralità.
2. Specificità soggettiva e oggettiva della moralità.
3. La struttura della moralità.
4. Funzioni della moralità.
5. Morale e moralità: il problema dell'unità e della differenza.
1. L'essenza della moralità
L'essenza è la cosa principale necessaria nell'oggetto studiato, è la sua “certezza qualitativa” (G.V.F. Hegel). L'essenza è le proprietà generiche degli oggetti studiati.
Qual è l'essenza della moralità? La moralità è una sorta di regolatore sociale.
Possiamo evidenziare cinque caratteristiche essenziali della moralità:
1. Normativa. Ordinare fenomeni e processi è sempre un movimento dal caos all'ordine.
2. Storicità. Tutti i tipi di regolamentazione sociale hanno il loro specifico momento storico di origine e caratteristiche di sviluppo e cambiamento storico.
3. Socialità. Tutti i tipi di regolamentazione, in particolare la moralità, sono generati da una certa necessità sociale.
4. Eterogeneità sociale o differenziazione sociale della moralità. Ogni classe e gruppo sociale forma la propria moralità, che garantisce il consolidamento interno e la conservazione di queste comunità.
5. Un certo posto della moralità nel sistema di regolamentazione sociale.
Che posto occupa la moralità nel sistema di regolamentazione sociale?
| Tipologie di regolamentazione/criteri di confronto | politica | Giusto | moralità |
| 1. Scopo della regolamentazione | R. L’obiettivo ovvio della politica è il potere e il dominio. L'essenza di ogni potere è il dominio sugli altri, il primato, la supremazia. | A. tutela della proprietà e del proprietario. Insieme allo Stato nasce il diritto; storicamente sono cambiati i tipi e le forme della proprietà, ma lo scopo del diritto è sempre rimasto lo stesso. | A. risoluzione delle contraddizioni universali della vita sociale e individuale: sociale e individuale (priorità del sociale), cosa dovrebbe essere e cosa è (orientamento a ciò che dovrebbe essere), bene e male (primato del bene). |
| B. soddisfare i bisogni e gli interessi di varie classi, gruppi, strati sociali. Il potere diventa spesso un mezzo per raggiungere questo obiettivo. | B. tutela dell'ordine pubblico. Tutela dell’individuo dall’arbitrarietà sociale e individuale. | B. Il secondo scopo della moralità è quello di essere custode della comunità. Questo è lo scopo principale della moralità. | |
| 2. Modalità di regolamentazione: A. modo di regolazione spirituale. B. materiale ed economico. B. fisicamente violento. |
La politica si basa su tutti i metodi possibili: A. Educazione politica, agitazione, lavoro diplomatico. B. Assistenza economica o blocchi economici B. Attacchi terroristici, eliminazione fisica dei leader politici, rivoluzioni, l'intero arsenale di guerre: civile, anticoloniale, mondiale. |
Il diritto si basa su tutti i metodi possibili: A. educazione giuridica, educazione giuridica, sanzioni spirituali della legge, ad esempio, sospensione della pena, esecuzione differita, processi con giuria. B. Multe, privazione della proprietà. B. Tuttavia, la legge si basa più attivamente sull'ultimo metodo: la reclusione, la pena di morte. |
La moralità si basa solo sul metodo di regolamentazione spirituale: su una buona mente, buoni sentimenti e buona volontà di una persona. Fa appello al sentimento sociale e alla coscienza sociale. È il tipo più perfetto di regolazione sociale, perché non utilizza metodi di regolazione né materiali né fisici. La moralità spesso si trasforma nel modo di regolamentazione più impotente, e quindi il più imperfetto. |
Pertanto, la moralità è, prima di tutto, un tipo di regolamentazione sociale. La tragica contraddizione della moralità è che essa è, in sostanza, il tipo di regolamentazione più perfetta, basata sull'umano nell'uomo. La moralità, infatti, risulta essere la tipologia di regolamentazione più violata, e quindi imperfetta. Charles Fourier chiamava la moralità “impotenza nell’azione”; Friedrich Nietzsche considerava la moralità la sorte dei deboli. La moderna teoria etica consente di dimostrare il contrario: la moralità è la sorte delle persone forti in mente, volontà e spirito.
2. Particolarità della moralità
La specificità è qualcosa di speciale, singolare, unico nell'oggetto studiato. Questo è ciò che distingue il fenomeno studiato dai fenomeni correlati. Consideriamo due livelli di specificità: la specificità dell'oggetto della moralità (la moralità è studiata come oggetto olistico, astratto, ideale). Il secondo livello è la specificità soggettiva della moralità (la moralità è studiata come le qualità speciali di un soggetto morale - portatore di moralità).
Specificità oggettuale della moralità comprende quattro segni:
1. Durabilità storica della moralità: la moralità sorge prima di altri tipi di regolamentazione sociale, dietro la regolamentazione morale è possibile il futuro.
2. Completezza: la sua inclusione universale in tutte le sfere della vita umana e della società. Questa qualità è spiegata dall'universalità delle contraddizioni, la cui risoluzione è finalizzata alla moralità: sociale - individuale, dovuto - esistente, bene - male.
3. Non isolamento della moralità basato sull'attività: la moralità è un aspetto di tutti gli altri tipi di attività: economica, politica, giuridica, religiosa, ecc., a causa della stessa universalità delle contraddizioni che risolve.
4. Natura non istituzionale e onnistituzionale della moralità: la moralità non ha istituzioni sociali specifiche che svolgano le sue funzioni. Tuttavia, possiamo riconoscere la non istituzionalità come pan-istituzionalizzazione, perché ci aspettiamo che ciascuna istituzione svolga funzioni morali.
Specificità soggettiva della moralità
Segni:
1. Coscienza morale: corretta consapevolezza e corretta attuazione dei requisiti morali. La consapevolezza è un’immagine speculare della realtà. La coscienza è un riflesso valutativo e basato sui valori della realtà; la coscienza è una qualità dell’azione.
2. Volontariato. In “Filosofia del diritto” G.V.F. Hegel scrive che “la volontà in sé non è né buona né cattiva”, “la volontà... è il desiderio della coscienza di comunicare a se stessa l'esistenza”.
In altre parole, la volontà è l'attività della coscienza finalizzata alla sua attuazione nell'attività. La volontà può essere forte e debole, calma e tesa, buona e cattiva, sana e malata. Una malattia mentale della volontà è "abulia" - mancanza patologica di volontà. Affinché la volontà diventi malvagia, è sufficiente una condizione: un obiettivo malvagio, un intento malvagio. Per realizzare un perfetto atto di buona volontà, è necessario che tre condizioni coincidano: un buon obiettivo, buoni mezzi, libero arbitrio, cioè l'assenza di qualsiasi coercizione, sia esterna che interna, autocoercizione.
Le qualità che ci permettono di esercitare il libero arbitrio sono:
1. L'abitudine morale è l'automaticità di seguire il dovere, che non richiede lunghi pensieri, lunghe decisioni o uno sforzo volontario per commettere un atto.
2. Bisogno morale, che governa le buone azioni compiute non per dovere, non per obbligo, ma per necessità naturale, poiché una persona non può agire altrimenti (non solo è abitualmente onesta, non può mentire).
3. L'altruismo è un motivo morale specifico (questo è un principio esplicativo dell'attività che risponde alla domanda "per cosa?" una persona agisce in questo modo e non altrimenti, questo è un obiettivo e valore implicito, distante nel tempo, ma vero atto).
Tre segni di altruismo:
1. Mancanza di scopo di lucro (disinteresse di una persona per i benefici). Il beneficio è solo un tipo di beneficio ottenuto da una persona a scapito del beneficio degli altri. Questo è un vantaggio basato sull'inganno e sulle bugie (guadagnare - imbrogliare, ingannare, ingannare, ingannare). Il desiderio di profitto può essere provocato dall'invidia. L'invidia è “la religione degli storpi mentali” (F. Iskander). L’invidia è “l’indignazione dell’insignificanza davanti alla dignità”. La cultura morale delle relazioni interpersonali e commerciali presuppone la loro attuazione su base reciprocamente vantaggiosa e reciprocamente vantaggiosa.
2. Mancanza di motivo di gratitudine, ricompensa per il bene fatto. “La ricompensa più alta per la virtù è la virtù stessa” (Seneca). Non bisogna contare o aspettarsi gratitudine per il bene, ma è necessario coltivare in sé e negli altri una cultura della gratitudine, perché una cultura della gratitudine è una cultura della “reciprocità nel bene”. L'attesa di gratitudine per il bene fatto rende questo bene altruistico.
3. Priorità del pubblico rispetto al personale. La moralità, come custode della comunità, come forza consolidatrice interna, adatta l'individuo alle varie società, “costruisce” una parte nel tutto, insegna alla parte a vivere secondo le leggi del tutto, assicura il normale funzionamento del tutto , e, quindi, le sue parti. Questa priorità è oggettiva, perché una parte non può essere più significativa del tutto. Ciò significa che è illegale negarlo: “Non devo niente a nessuno”.
3. La struttura della moralità
Caratterizzando la struttura della moralità, possiamo distinguere due blocchi di elementi: coscienza morale e pratica morale.
Nella struttura della pratica morale si distinguono i seguenti elementi:
1. Le relazioni morali sono un tipo specifico di connessione sociale in cui i soggetti entrano nel processo dell'attività morale.
2. L'attività morale è un tipo specifico di attività sociale, che rappresenta l'attuazione di requisiti e valori morali.
3. Comportamento morale. Ogni tipo di attività ha la sua forma comportamentale.
4. L'azione è un'unità dell'attività morale. Tutte le azioni sono divise in azioni - operazioni e azioni - azioni. Ogni azione è un'azione, ma non ogni azione è un'operazione. L'atto evidenzia il significato dell'azione: l'operazione per la persona stessa e per le altre persone. Anche il rifiuto di agire può essere un atto. Un'azione viene eseguita in una situazione di scelta morale.
La coscienza morale è un tipo specifico di coscienza, che è un riflesso di requisiti morali, valori e situazioni morali specifiche.
Criteri di strutturazione:
1. Soggetto (vettore). Struttura soggettiva: coscienza morale pubblica, coscienza morale di classe, coscienza morale etnica, coscienza morale nazionale, coscienza morale individuale.
2. Livello. Struttura dei livelli (livello di riflessione della realtà): livello ordinario di coscienza morale, livello teorico di coscienza morale. Specificità del livello ordinario di coscienza morale: la conoscenza è spontanea, accidentale. Conoscenza a livello di fenomeni che non fornisce una comprensione olistica della moralità. Specificità del livello teorico della coscienza morale: l'etica è un riflesso secondario della coscienza morale. Conoscenza di entità, leggi, che è sistematizzata. Il livello teorico della coscienza morale è importante perché elimina il nichilismo nella coscienza ordinaria, dal soggettivismo e dal pluralismo ordinari.
3. Elemento. Struttura elementare (funzioni costitutive della coscienza).
Riflessione. (La coscienza è conoscenza). Sfera intellettuale della coscienza morale. Conoscenza: ordinaria, teorica, astratta, concreta, contemplativa, praticamente - effettiva, distaccata (indifferente), sperimentata (avente un significato personale, ad esempio, virtù).
Atteggiamento. (Coscienza - atteggiamento). Sfera sensuale - emotiva. La gamma di sentimenti ed emozioni morali è ampia. Dal situazionale (insulto) al grande dolore e gioia civile. V. Solovyov ha riflettuto sui fondamenti della moralità nella sua opera "La giustificazione del bene". Ha identificato tre fonti o principi naturali della moralità: vergogna, pietà e riverenza.
Gestione delle attività. (La coscienza è controllo.). Sfera volitiva.
La gestione è composta da tre sottofunzioni:
Pianificazione. La pianificazione si manifesta nella definizione degli obiettivi, nella scelta dei mezzi, nella motivazione e nella previsione dei risultati. L'unicità della pianificazione nella coscienza morale sta nel fatto che un buon obiettivo richiede buoni mezzi. Il motivo è un principio giustificativo dell'attività, un obiettivo nascosto. Risponde alla domanda “per cosa?” Il motivo integrale è l’altruismo.
Prevedere il risultato è una responsabilità a lungo termine (chronos). La regolamentazione vera e propria della responsabilità.
Controllo: stabilire la conformità tra obiettivi e risultati, valutazione morale delle attività.
Valutazione morale- un tipo specifico di valutazione, che è un modo per identificare il significato morale dei fenomeni.
Oggetti di valutazione morale:
1. Una persona, le sue qualità, pensieri, azioni.
2. Realtà sociale (rapporti tra soggetti).
3. Fenomeni naturali attraverso il prisma dei benefici per l'uomo e la società.
4. Chronos: passato, presente e futuro.
Oggetto della valutazione morale:
Il soggetto della valutazione morale ne è portatore ed esponente. L'esponente della valutazione morale può essere sia un soggetto individuale che una comunità. Se il soggetto e l'oggetto coincidono in un mezzo, questa è autostima. La più alta manifestazione di autostima è la coscienza. In coscienza, una persona passa dalla moralità alla moralità.
Criteri di valutazione morale.
1. Nello specifico - criterio storico: idee accettate in una data società, in un dato periodo di tempo;
2. Il criterio universale è l'umanesimo.
Tipi di valutazione morale delle azioni.
L'oggetto principale della valutazione morale è un atto. Un atto è un'unità di attività morale. Un atto è un'azione legata al bene delle persone.
La struttura dell'azione
| Bersaglio | Strutture | Motivo | Risultato | Caratteristiche dell'azione |
| + | + | + | + | Moralmente: azioni ideali. Proprietà delle azioni moralmente ideali: coerenza, integrità, efficacia. |
| + | + | + | - | Azioni moralmente giustificate. |
| + | + | - | + | Azioni moralmente accettabili. |
| ? | ? | ? | + | Azioni legali e moralmente corrette. “Secondo il dovere”, ma non “per esso”. |
Sistema di requisiti morali
La regolamentazione (gestione) dell'attività morale si basa su un sistema di requisiti morali. Un requisito morale è uno standard che risolve le contraddizioni:
Ciò che dovrebbe essere è ciò che è
Sociale - individuale,
Bene male.
Segni di esigenze morali.
1. Unità di contenuto e imperatività.
2. Unità di ciò che dovrebbe essere e di ciò che è. Ogni esigenza è uno standard di ciò che è dovuto. Ogni dovere è radicato nell'esistenza, nella realtà. E se non esiste tale radicamento, allora non c'è costruttività di ciò che dovrebbe essere.
3. Unità del campione e divieto. Le richieste morali sono spesso formulate sotto forma di divieto. La natura della moralità preferisce esprimere le esigenze sotto forma di esemplari.
4. Soggettività delle esigenze morali. Il requisito è generale e universale.
Struttura di una esigenza morale:
Un'ipotesi è il destinatario previsto di un'esigenza morale.
La disposizione è una forma per esprimere un requisito.
Sanzione - un sistema di misure applicate in caso di mancato rispetto dei requisiti
Sistema di requisiti morali.
Un ideale morale, principi morali di vita: una strategia che determina il futuro, una verticale di sviluppo.
Standard morali di attività, regole elementari di comportamento: tattica, specificità, vita quotidiana, sviluppo orizzontale.
Regole fondamentali di condotta. Etichetta
Esistono due tipi di cultura comportamentale. Universale ed etichetta. La base della cultura comportamentale universale è il principio dell’equivalenza della dignità umana. Forme di manifestazione: cortesia (buona volontà), sincera simpatia, tatto. Il tatto è un accordo non scritto di non notare gli errori altrui. Il tatto è il senso delle proporzioni in ogni cosa. La base della cultura comportamentale dell'etichetta è il principio di disuguaglianza. La cultura dell'etichetta è gerarchica: "Proprio - Alieno". Nella corte dei re, l'etichetta ha anche lo scopo di enfatizzare la gerarchia.
Standard morali di attività.
Classificazione delle norme sociali:
Norme regolatrici.
Norme regolamentari (procedurali) che determinano l'ordine delle azioni, ad esempio regolamenti, carte.
Norme di subordinazione gerarchica. Norme nella sfera della politica, del diritto, della religione, della morale. Subordinazione: controllo dell'interazione.
Quali sono le specificità degli standard morali?
Standard morali:
Sono di natura più generale delle regole di comportamento (norme di etichetta). Maggiore è il grado di generalizzazione delle norme, minore è la loro imperatività.
Principi morali e beni morali:
- sono ancora più generalizzati delle norme. Hanno un’imperatività inferiore e un grado più elevato di libertà di scelta morale. Se le regole e le norme regolano, allora i principi e gli ideali guidano. I principi possono essere codificati. Da questi vengono elaborati i codici che diventano la base dell'ideologia. I principi morali cambiano nel tempo, ma sono necessari. Ad esempio, il “codice morale del costruttore del comunismo” o il “codice etico aziendale” in una determinata organizzazione.
Ideale morale
Un ideale morale è il livello più alto di ciò che è corretto.
Funzioni degli ideali.
1. Software: programma di sviluppo.
2. Educativo:
- personificato (la vera incarnazione di un ideale morale);
- ideali polipersonalizzati (immagine collettiva dell'ideale).
Nessuna funzione dovrebbe essere assolutizzata o ipertrofica.
L'attività morale e le relazioni morali sono le specificità che determinano lo status ontologico.
Ogni tipo di attività e relazione è multidimensionale. Gli aspetti dell’attività e delle relazioni sono:
1. Spazio.
3. Obiettivo specifico. (Criterio di statuto ontologico).
4. Mezzi specifici.
5. Motivazione specifica.
6. Risultato specifico.
L'attività morale è un tipo specifico di attività sociale volta a soddisfare i requisiti morali.
L'atteggiamento morale è un tipo di connessione sociale in cui i soggetti entrano nel processo dell'attività morale.
L'obiettivo morale è seguire i valori e i requisiti morali.
La motivazione morale è l’altruismo.
L'attività morale nella sua forma pura è moralizzazione, educazione morale, riflessione morale (lavoro su se stessi).
4. Funzioni della moralità
1. Normativa;
2. Cognitivo;
3. Educativo;
4. Valutazione;
5. Orientato ai valori (atteggiamento preferenziale nei confronti dei valori);
6. Visione del mondo e atteggiamento nei confronti del mondo (contesto dell'atteggiamento astratto e pratico nei confronti del mondo);
7. Comunicazione universale di una persona con il mondo;
8. Adattamento universale dell'uomo al mondo;
9. Umano-creativo;
10. Salvare l'uomo e il genere umano dall'autodistruzione e dalla reciproca distruzione.
Funzioni della moralità: normative, cognitive, educative, valutative, orientate ai valori. La transizione alla moralità viene effettuata attraverso le seguenti funzioni: ideologica e relazionale mondiale, comunicazione universale dell'uomo con il mondo, adattamento universale dell'uomo al mondo, uomo-creativo, salvataggio dell'uomo e della razza umana dall'autodistruzione e dalla reciproca distruzione . Pertanto, la moralità modella la visione del mondo e l’atteggiamento sociale; la moralità è la custode della comunità. La moralità costituisce un paradigma universale di visione del mondo e di atteggiamento.
5. Morale ed etica: il problema dell'unità e della differenza
Abbiamo già usato molte volte i concetti di “moralità” e “moralità”. Qual è il problema dell'unità e della differenza di questi fenomeni?
Moralità- una parola latina. Viene introdotto da Cicerone come l'equivalente latino della parola etica. Ci sono diversi significati di questa parola:
1. come un insieme di determinate norme e regole che regolano le attività congiunte delle persone. La moralità è un tipo di regolamentazione sociale.
2. come una sorta di istruzione, insegnamento.
3. come conclusione istruttiva (la morale è: ...)
Morale- Parola russa. Correlazione: disposizione - moralità (parole con la stessa radice: “norma”, “mi piace”). V. Dahl dà la seguente interpretazione della parola: “... metà o una delle due proprietà principali dello spirito umano: Mente e carattere insieme formano lo Spirito (anima, nel senso più alto); trattano il carattere come concetto di subordinazione: volontà, amore, misericordia, passioni, ecc., e la mente: ragione, ragione, memoria, ecc. L'unione consonante di carattere e mente... forma l'armonia, la perfezione dello spirito; la discordanza di questi principi porta al declino. Non può esserci una tale discordanza in un animale: lì carattere e mente, volontà e ragione sono inseparabilmente fusi in uno (istinto); e la stessa unità deve essere raggiunta dall’uomo, ma in un modo più elevato: attraverso la convinzione, il freno alle passioni e all’intelligenza, e il senso del dovere”.
Per la prima volta nella storia dell'etica, morale ed etica furono divise da G.V.F. Hegel. Ma questa divisione è già delineata nella filosofia di I. Kant, che distingueva due tipi di azioni: "secondo il dovere" e "per amore del dovere". Credeva che se una persona agisce secondo l'imperativo, allora è accettabile solo il "dovere per amore del dovere". In queste riflessioni di I. Kant si possono vedere le origini della giustificazione del fenomeno della “moralità”. L’azione “secondo il dovere” è moralità. G.V.F. Hegel nella "Filosofia del diritto" sosteneva che il primo stadio dello sviluppo della volontà corrisponde alla legge astratta, il secondo alla moralità, il terzo alla moralità (comprende: famiglia, società civile e stato). La moralità secondo G.V.F. Per Hegel questa è la “ragione della volontà”, “l’obbedienza nella libertà”.
Gli studiosi di moralità sono abbastanza unanimi nel ritenere che la sua specificità sia difficile da cogliere. O.G. Drobnitsky, dopo aver scritto la famosa monografia “Il concetto di moralità”, notò di non essere mai riuscito a comprenderne l'originalità, il suo status ontologico. Il livello attuale della ricerca morale. Gli studi morali sono presentati nelle opere di pensatori russi: S.F. Anisimova, O.G. Drobnitsky, A.A. Guseinova, A.I. Titarenko, Yu.M. Smolentseva. Si riducono a diverse disposizioni fondamentali: la moralità è considerata come un prodotto e il risultato dell'interazione interumana e intersoggettiva. La moralità è autonoma, immanente all'attività umana.
La moralità caratterizza il paradigma sociale della visione del mondo e dell'atteggiamento; la moralità è la giustificazione di ciò che è necessario.
La moralità è un paradigma universale di visione del mondo e di atteggiamento. N. Fedorov credeva: "La moralità non è signoria, non schiavitù, ma parentela". G. Heine sosteneva che “la moralità è la mente del cuore”.
La moralità è un tipo di regolamentazione sociale.
La moralità è un modo spirituale e pratico di esplorazione umana del mondo; un modo di autodeterminazione spirituale di una persona.
La moralità è custode della comunità e delle relazioni sociali; la moralità è custodita dall’individuo. Una persona può essere morale, ma immorale.
Quali sono i segni specifici della moralità?
1. La moralità contribuisce all'universalizzazione dell'esistenza umana, ricordando a una persona che non è solo parte della società, ma anche parte dell'universo, attraverso un sistema di valori eterni e più alti.
2. La moralità contribuisce all'armonizzazione dell'esistenza umana. L'armonia è integrità, completezza e autenticità dell'essere. La moralità è una forza anti-caos, la moralità è una forza armonizzante.
3. La moralità contribuisce all'umanizzazione dell'esistenza umana. L'uomo è inteso come il valore più alto.
4. La moralità contribuisce alla deontizzazione (dal greco “deon” - dovere) dell'esistenza umana. "Unicità adeguata nell'universo": così M. Bachtin parlava dell'uomo.
V. Solovyov ha riflettuto sui fondamenti della moralità nella sua opera "La giustificazione del bene". Il pensatore russo individuava tre fonti o “principi naturali” della moralità: vergogna, pietà e riverenza. Ciascuno dei principi morali stabiliti - vergogna, pietà e sentimento religioso - può essere considerato da tre lati: come virtù, come regola d'azione e come condizione del bene. I sentimenti fondamentali di vergogna, pietà e riverenza determinano l'atteggiamento morale di una persona verso ciò che è al di sotto di lui, ciò che è uguale a lui e ciò che è al di sopra di lui. Tutti gli altri fenomeni della vita morale, tutte le cosiddette virtù, possono essere rappresentate come modificazioni di questi tre principi o come risultato dell'interazione tra essi. Il coraggio, ad esempio, è una manifestazione del principio di elevazione e di padronanza sugli istinti. Pertanto, l '"elevazione", la capacità di una persona di superare l'esistenza esistente, si manifesta organicamente proprio attraverso la moralità. V.Sh. Sabirov ritiene che l’etica sia la “metafisica della moralità”. Questa è la dottrina della base sostanziale dell’umanità. Pertanto, la moralità è la comunione di una persona con la ragione più alta (umana) e l'eternità.
DIO
DNA teocentrico
- VERO
Umano
DNA antropocentrico
2. Cosa distingue la moralità da altri tipi di regolamentazione sociale?
3. Elenca i segni della specificità dell'oggetto della moralità.
4. Elencare i segni della specificità soggettiva della moralità.
5. Quale condizione è necessaria affinché la volontà di una persona diventi malvagia (secondo G.V.F. Hegel)? Quali condizioni sono necessarie per la buona volontà?
6. Perché l'altruismo è definito un motivo morale?
7. Cos’è la “valutazione morale”? Quali sono i suoi criteri?
8. Elencare i tipi di valutazioni morali delle azioni.
9. Quali sono la definizione e le caratteristiche delle esigenze morali?
10. Quali sono le funzioni della moralità e dell'etica? Spiegare la transizione (che caratterizza le funzioni) dalla regolamentazione morale a un modo morale di padroneggiare la realtà.
13. Quale pensatore fu il primo a separare “moralità” e “moralità”?
14. Quali sono i segni specifici della moralità?
15. Confrontare la cultura morale religiosa e quella morale universale. Qual è la differenza?
Letteratura
- Guseinov A.A. Moralità: tra individuo e società (sulla questione del posto della moralità nella società moderna) / - [Risorsa elettronica]. - Modalità di accesso: http://www.ethicscenter.ru/biblio/guseynov.html/ - Data di accesso: 06/06/2013
- Guseinov, A.A. Etica: libro di testo. per studenti universitari/A.A. Guseinov, R.G. Apresyan. - M.: Gardariki, 2002. - 472 p.
- Drobnitsky, O.G. Filosofia morale: Opere scelte / O.G. Drobnitsky; Comp. R.G. Apresyan. - M.: Gardariki, 2002. - 523 p.
- Durkheim, E. Sulla divisione del lavoro sociale / E. Durkheim; sentiero A.B. Hoffmann. - M.: Kanon, 1996. - 432 p.
- Zolotukhina-Abolina, E. V. Etica moderna: libro di testo. manuale per studenti universitari / E.V. Zolotukhina-Abolina. - M.; Rostov n/d: MarT, 2005. - 413 p.
- Sabirov, V.Sh. Etica e vita morale dell'uomo: monografia / V.Sh. Sabirov, O.S. Soina. - San Pietroburgo. : Dmitry Bulanin, 2010. - 486 p.
- Etica: libro di testo. per gli studenti di filosofia falso. università/A.A. Guseinov, E.L. Dubko, S.F. Anisimov e altri; Sotto generale ed. AA. Guseinova e E.L. Dubko. - M.: Gardariki, 2000. - 493 p.
- Etica: enciclica. parole / [S.S. Averintsev, I.Yu. Alekseeva, R.G. Apresyan et al.]; a cura di R.G. Apresyan e A.A. Guseinova; Istituto di Filosofia Ross. acad. Sci. - M.: Gardariki, 2001. - 669 p.
La struttura e le funzioni della moralità. 2.3. Morale e diritto.
Il concetto di moralità.
TEMA 2. CONCETTO ED ESSENZA DELLA MORALITÀ
La moralità (dal latino "moralis" - morale; "mores" - mores) è uno dei modi di regolazione normativa del comportamento umano, una forma speciale di coscienza sociale e un tipo di relazioni sociali. Esistono numerose definizioni di moralità che mettono in risalto alcune delle sue proprietà essenziali.
La moralità è uno dei modi per regolare il comportamento delle persone nella società. È un sistema di principi e norme che determinano la natura delle relazioni tra le persone in conformità con i concetti accettati in una data società di bene e male, giusto e ingiusto, degno e indegno. Conformità al
La base della moralità è assicurata dal potere dell'influenza spirituale, dell'opinione pubblica, della convinzione interiore e della coscienza di una persona.
La particolarità della moralità è che regola il comportamento e la coscienza delle persone in tutte le sfere della vita (attività produttive, vita quotidiana, famiglia, relazioni interpersonali e altre). La moralità si estende anche alle relazioni intergruppo e interstatali .
I principi morali hanno un significato universale, abbracciano tutte le persone e consolidano le basi della cultura delle loro relazioni, create nel lungo processo di sviluppo storico della società.
Ogni atto e comportamento di una persona può avere significati diversi (giuridici, politici, estetici, ecc.), Ma il suo lato morale, il contenuto morale, viene valutato su un'unica scala. Le norme morali vengono riprodotte quotidianamente nella società attraverso il potere della tradizione, il potere di una disciplina generalmente riconosciuta e sostenuta e l'opinione pubblica. La loro attuazione è controllata da tutti.
La responsabilità nella moralità ha un carattere spirituale, ideale (condanna o approvazione delle azioni), appare sotto forma di valutazioni morali che una persona deve realizzare, accettare internamente e, di conseguenza, dirigere e correggere le proprie azioni e comportamenti. Tale valutazione deve corrispondere ai principi e alle norme generali, accettati da tutti i concetti di ciò che è corretto e ciò che non è corretto, ciò che è degno e ciò che non è degno, ecc.
La moralità dipende dalle condizioni dell'esistenza umana, dai bisogni essenziali dell'uomo, ma è determinata dal livello di coscienza sociale e individuale. Insieme ad altre forme di regolazione del comportamento delle persone nella società, la moralità serve ad armonizzare le attività di molti individui, trasformandole in attività di massa aggregata, soggetta a determinate leggi sociali.
2.2. La struttura e le funzioni della moralità. Indagando sulla questione delle funzioni della moralità, distinguono
− normativo,
− educativo, − cognitivo,
− imperativo valutativo, − orientamento,
− motivazionale,
− comunicativo, − prognostico
e alcune delle sue altre funzioni4.
4Arkhangelsky L.M. Corso di conferenze sull'etica marxista-leninista. M., 1974. P.37-46.
Di primario interesse per gli avvocati sono le funzioni della moralità come quelle normative ed educative. La funzione normativa è considerata la funzione guida della moralità. La moralità guida e corregge le attività pratiche di una persona dal punto di vista della presa in considerazione degli interessi delle altre persone e della società. Allo stesso tempo, l'influenza attiva della moralità sulle relazioni sociali viene effettuata attraverso il comportamento individuale.
La funzione educativa della moralità è quella di partecipare alla formazione della personalità umana e alla sua autocoscienza. La moralità contribuisce alla formazione di opinioni sullo scopo e sul significato della vita, sulla consapevolezza di una persona della propria dignità, sul dovere verso le altre persone e sulla società, sulla necessità di rispettare i diritti, la personalità e la dignità degli altri. Questa funzione è solitamente caratterizzata come umanistica. Influenza le funzioni normative e altre funzioni della moralità.
Come accennato in precedenza, la moralità agisce come regolatore delle relazioni sociali, i cui soggetti sono sia i singoli individui che la società nel suo insieme. Nel processo di queste relazioni sociali si verifica l'autoregolamentazione del comportamento morale dell'individuo e l'autoregolamentazione morale dell'ambiente sociale nel suo insieme. La moralità regola quasi tutte le sfere della vita umana. Regolando il comportamento umano, la moralità gli pone le massime esigenze. Inoltre, la funzione normativa della moralità viene svolta sulla base dell'autorità dell'opinione pubblica e delle convinzioni morali di una persona (sebbene sia la società che l'individuo possano sbagliarsi).
La moralità è considerata sia come una forma speciale di coscienza sociale, sia come un tipo di relazioni sociali, sia come norme di comportamento operanti nella società che regolano l'attività umana - l'attività morale.
La coscienza morale è uno degli elementi della moralità, che rappresenta il suo lato ideale e soggettivo. La coscienza morale prescrive determinati comportamenti e azioni alle persone come loro dovere. La coscienza morale valuta vari fenomeni della realtà sociale (un'azione, le sue motivazioni, un comportamento, uno stile di vita, ecc.) dal punto di vista del rispetto dei requisiti morali. Questa valutazione si esprime in approvazione o condanna, lode o biasimo, simpatia e ostilità, amore e odio. La coscienza morale è una forma di coscienza sociale e allo stesso tempo l'area della coscienza individuale dell'individuo. In quest'ultimo, un posto importante è occupato dall'autostima di una persona, associata a sentimenti morali (coscienza, orgoglio, vergogna, pentimento, ecc.).
La moralità non può essere ridotta soltanto alla coscienza.
Parlare contro l'identificazione
morale (morale)
moralità ed etica
coscienza morale, M. S. Strogovich ha scritto: “La coscienza morale è
punti di vista, credenze, idee sul bene e sul male, sul comportamento degno e indegno e la moralità sono il sociale
tutte le norme che regolano le azioni, il comportamento delle persone, le loro relazioni”5
Le relazioni morali sorgono tra le persone nel processo delle loro attività che hanno un carattere morale. Differiscono nel contenuto, nella forma e nel metodo di comunicazione sociale tra i soggetti. Il loro contenuto è determinato da chi e quali responsabilità morali ha una persona (verso la società nel suo insieme; verso le persone unite da una professione; verso una squadra; verso i membri della famiglia, ecc.), Ma in tutti i casi una persona alla fine si ritrova in un sistema di relazioni morali sia con la società nel suo insieme che con se stessi come suo membro. Nelle relazioni morali, una persona agisce sia come soggetto che come oggetto dell'attività morale. Pertanto, poiché ha delle responsabilità verso gli altri, egli stesso è un soggetto nei confronti della società, di un gruppo sociale, ecc., ma allo stesso tempo è anche oggetto di doveri morali verso gli altri, poiché devono tutelare i suoi interessi, prendersi cura di lui, ecc.
L'attività morale rappresenta il lato oggettivo della moralità. Possiamo parlare di attività morale quando un atto, un comportamento e le relative motivazioni possono essere valutati dal punto di vista della distinzione tra bene e male, degno e indegno, ecc. L'elemento primario dell'attività morale è un atto (o un delitto), poiché esso incarna obiettivi morali, motivazioni o orientamento. Un'azione include: motivo, intenzione, scopo, azione, conseguenze dell'azione. Le conseguenze morali di un atto sono l’autovalutazione di una persona e la valutazione da parte degli altri.
La totalità delle azioni di una persona che hanno un significato morale, eseguite da lui per un periodo relativamente lungo in condizioni costanti o mutevoli, è solitamente chiamata comportamento. Il comportamento di una persona è l'unico indicatore oggettivo delle sue qualità morali e del suo carattere morale.
L'attività morale caratterizza solo le azioni moralmente motivate e intenzionali. La cosa decisiva qui sono i motivi che guidano una persona, i suoi motivi specificamente morali: il desiderio di fare del bene, realizzare un senso del dovere, raggiungere un certo ideale, ecc.
Nella struttura della moralità è consuetudine distinguere tra gli elementi che la compongono. La moralità comprende norme morali, principi morali, ideali morali, criteri morali, ecc.
Le norme morali sono norme sociali che regolano il comportamento di una persona nella società, il suo atteggiamento verso le altre persone, verso la società e verso se stesso. La loro attuazione è assicurata dal potere pubblico
5Problemi di etica giudiziaria/Ed. SM. Strogovich. M., 1974, pag. 7.
opinioni, convinzioni interne basate sulle idee accettate in una data società riguardo al bene e al male, alla giustizia e all'ingiustizia, alla virtù e al vizio, al dovuto e al condannato.
Le norme morali determinano il contenuto del comportamento, il modo in cui è consuetudine agire in una determinata situazione, cioè la morale inerente a una determinata società, gruppo sociale. Differiscono dalle altre norme che operano nella società e che svolgono funzioni normative (economiche, politiche, legali, estetiche) nel modo in cui regolano le azioni delle persone. La morale viene riprodotta quotidianamente nella vita della società attraverso il potere della tradizione, l'autorità e il potere di una disciplina generalmente riconosciuta e sostenuta, l'opinione pubblica e la convinzione dei membri della società riguardo al comportamento corretto in determinate condizioni.
A differenza dei semplici costumi e abitudini, quando le persone agiscono allo stesso modo in situazioni simili (feste di compleanno, matrimoni, saluti nell'esercito, vari rituali, abitudine a determinate azioni lavorative, ecc.), le norme morali non vengono semplicemente seguite a causa dell'ordine stabilito generalmente accettato, ma trova giustificazione ideologica nelle idee di una persona sul comportamento corretto o inappropriato, sia in generale che in una specifica situazione di vita.
Le basi per la formulazione delle norme morali come regole di comportamento ragionevoli, appropriate e approvate si basano su principi reali, ideali, concetti di bene e male, ecc., che operano nella società.
L'adempimento delle norme morali è assicurato dall'autorità e dalla forza dell'opinione pubblica, dalla coscienza del soggetto di ciò che è degno o indegno, morale o immorale, che determina la natura delle sanzioni morali.
Una norma morale è, in linea di principio, concepita per l’adempimento volontario. Ma la sua violazione comporta sanzioni morali, consistenti in una valutazione negativa e nella condanna del comportamento di una persona e in un'influenza spirituale diretta. Significano un divieto morale di commettere atti simili in futuro, rivolto sia a una persona specifica che a tutti coloro che la circondano. La sanzione morale rafforza i requisiti morali contenuti nelle norme e nei principi morali.
La violazione delle norme morali può comportare, oltre alle sanzioni morali, sanzioni di diverso tipo (disciplinari o previste dalle norme degli organismi pubblici). Ad esempio, se un militare ha mentito al suo comandante, a questo atto disonorevole seguirà una reazione adeguata in base al grado di gravità sulla base delle norme militari.
Le norme morali possono essere espresse sia in forma negativa, proibitiva (ad esempio, le leggi mosaiche - i Dieci Comandamenti,
formulato nella Bibbia) e in modo positivo (sii onesto, aiuta il tuo prossimo, rispetta i tuoi anziani, prenditi cura del tuo onore fin dalla giovane età, ecc.).
I principi morali sono una delle forme di espressione dei requisiti morali, nella forma più generale che rivela il contenuto della moralità esistente in una particolare società. Esprimono requisiti fondamentali riguardanti l'essenza morale di una persona, la natura delle relazioni tra le persone, determinano la direzione generale dell'attività umana e sono alla base di norme di comportamento private e specifiche. A questo proposito, servono come criteri di moralità.
Se la norma morale prescrive quali azioni specifiche una persona dovrebbe compiere e come comportarsi in situazioni tipiche, allora il principio morale dà a una persona una direzione generale di attività.
I principi morali includono principi generali di moralità come
− umanesimo – riconoscimento dell'uomo come valore supremo; − altruismo: servizio disinteressato al prossimo;
− misericordia: amore compassionevole e attivo, espresso nella disponibilità ad aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno;
− collettivismo: desiderio consapevole di promuovere il bene comune;
− rifiuto dell'individualismo - opposizione dell'individuo alla società, a qualsiasi socialità ed egoismo - preferenza per il proprio
interessi agli interessi di tutti gli altri.
Oltre ai principi che caratterizzano l'essenza di tale moralità, esistono i cosiddetti formali
o altri principi
già legati ai modi di soddisfare i requisiti morali. Tali sono, ad esempio, la coscienza e i suoi opposti, il formalismo, il feticismo, il fatalismo, il fanatismo, il dogmatismo. Principi di questo tipo non determinano il contenuto di specifiche norme di comportamento, ma caratterizzano anche una certa moralità, mostrando come vengono soddisfatti consapevolmente i requisiti morali.
Gli ideali morali sono concetti di coscienza morale, in cui le esigenze morali poste alle persone sono espresse sotto forma di un'immagine di una personalità moralmente perfetta, un'idea di una persona che incarna le qualità morali più elevate.
L'ideale morale veniva inteso diversamente in tempi diversi, in società e insegnamenti diversi. Se Aristotele vedeva l'ideale morale in una persona che considera la virtù più alta l'autosufficienza, il distacco dalle preoccupazioni e dalle ansie dell'attività pratica, la contemplazione della verità, allora Immanuel Kant (1724-1804) caratterizzò l'ideale morale come guida per le nostre azioni, "l'uomo divino dentro di noi" con cui ci confrontiamo e
miglioriamo, ma mai, però, riuscendo a diventare al suo livello. L'ideale morale è definito a modo suo da vari insegnamenti religiosi, movimenti politici e filosofi.
L'ideale morale accettato da una persona indica l'obiettivo finale dell'autoeducazione. L'ideale morale accettato dalla coscienza morale pubblica determina lo scopo dell'educazione e influenza il contenuto dei principi e delle norme morali.
Possiamo anche parlare di un ideale morale pubblico come immagine di una società perfetta, costruita sui requisiti della massima giustizia e umanesimo.
La moralità è un fenomeno sociale complesso e contraddittorio e una delle forme di coscienza sociale. La natura della moralità può essere rivelata sulla base di un'analisi storico-sociale dello sviluppo umano. Pertanto, l'ordine nella società primitiva veniva mantenuto con l'aiuto di un sistema di tabù: divieti, e nel corso dell'evoluzione storica, dai divieti emersero costumi e tradizioni. Nel processo di stratificazione sociale hanno preso forma nuove forme di regolamentazione morale del comportamento umano.
La specificità della moralità è che riflette le norme oggettivamente stabilite del comportamento umano nella società in concetti e categorie etiche di base. Le norme morali, insieme ai concetti, costituiscono la coscienza morale, che si trova nelle azioni e nel comportamento delle persone. In ogni fase dello sviluppo, l'umanità sviluppa principi e norme del suo comportamento. Queste norme e regole sono fissate nella coscienza individuale dei membri della collettività sociale, grazie alla quale si sviluppa gradualmente un'idea generale di morale e immorale.Kropotkin P.A. Etica. - M.: Yurait, 2016. - P.15.
Seguire i principi morali è il risultato di una scelta significativa e volontaria di una persona. L’adempimento degli standard morali si basa sul senso del dovere, sui requisiti della coscienza e sul desiderio di evitare la vergogna per le proprie azioni o inazioni.
I principi fondamentali della moralità rimangono invariati: questo è il desiderio di fare il bene e astenersi dal male, prendersi cura delle altre persone e del bene pubblico Skvortsov A.A.. Etica: libro di testo. per studenti universitari - M.: Yurait, 2015. - P. 140. Esistono principi morali universali, il cui significato è non causare danni ad altre persone, indipendentemente dal loro status sociale, appartenenza nazionale e religiosa. Tuttavia, nel corso della storia dell'umanità, si sono sviluppate forme specifiche di norme e requisiti morali. Etica e pari vita dell'uomo. - San Pietroburgo: Dmitry Bulanin, 2010. - P. 205.
Si distinguono i seguenti tipi di norme morali:
- 1. Taboo: un severo divieto di commettere qualsiasi azione, la cui violazione nella mente delle persone è associata a una minaccia per la società ed è punibile da forze soprannaturali; questo fenomeno era caratteristico delle prime fasi dello sviluppo della società umana ed è persistito fino ai nostri tempi nelle culture tradizionali;
- 2. Consuetudine: un modello di azione che si è sviluppato durante la pratica sociale, ripetuto in determinate circostanze e sostenuto dall'opinione pubblica;
- 3. La tradizione è una consuetudine stabile, una forma di comportamento che si tramanda di generazione in generazione e si riproduce per un lungo periodo di esistenza della società;
- 4. Regole morali: norme formulate consapevolmente che governano il comportamento umano; in contrasto con i divieti rituali, i costumi e le tradizioni, richiedono l'autodeterminazione morale e la scelta consapevole da parte di una persona.
La moralità come forma di coscienza sociale e modo di regolare la vita sociale è caratterizzata dalle seguenti caratteristiche principali Zolotukhin-Abolina, E. V. Etica moderna: libro di testo. manuale per studenti universitari - M.; Rostov n/d: Fenice, 2013. - P. 86:
- 1. Universalità delle norme morali: i requisiti morali sono gli stessi per tutti i membri della società e coprono tutte le persone, consolidano le basi della cultura e delle loro relazioni, create nel lungo processo di sviluppo storico della società
- 2. Volontà nel seguire i requisiti morali, in contrasto con le norme legali, la cui attuazione è obbligatoria e controllata dalle forze dell'ordine, le norme morali sono riprodotte nella società dal potere della tradizione e dell'opinione pubblica. La loro attuazione è controllata dalle persone stesse.
- 3. Globalità della moralità: le regole del comportamento morale regolano tutti i tipi di attività umana - nella comunicazione interpersonale e intergruppo, nelle attività produttive, nella politica, nella creatività.
- 4. La responsabilità nella moralità è spirituale, un carattere ideale appare sotto forma di valutazioni morali, che una persona deve realizzare, accettare internamente e, di conseguenza, dirigere e correggere le proprie azioni e comportamenti.
- 5. La moralità dipende dalle condizioni dell'esistenza umana, dai bisogni essenziali dell'uomo, ma è determinata dal livello di coscienza sociale e individuale.
L'essenza della moralità sono le proprietà generiche della moralità che la mettono in relazione con il regolatore sociale Sudokov A.K. Moralità assoluta: etica dell'autonomia e dell'incondizionatezza - M.: Editoriale URSS, 2012. - P.28.
Cinque segni essenziali della moralità:
- 1. Normativa. Ordinare fenomeni e processi è sempre un movimento dal caos all'ordine.
- 2. Storicità. Tutti i tipi di regolamentazione sociale hanno il loro specifico momento storico di origine e caratteristiche di sviluppo e cambiamento storico.
- 3. Socialità. Tutti i tipi di regolamentazione, in particolare la moralità, sono generati da una certa necessità sociale.
- 4. Eterogeneità sociale o differenziazione sociale della moralità. Ogni classe e gruppo sociale forma la propria moralità, che garantisce il consolidamento interno e la conservazione di queste comunità.
- 5. Un certo posto della moralità nel sistema di regolamentazione sociale.