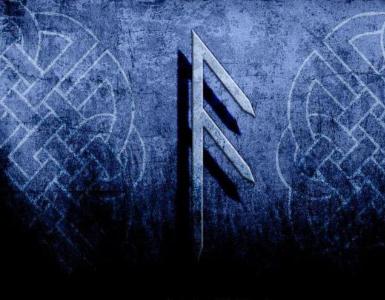L'acetone è tossico. Avvelenamento da vapori di acetone, che colpiscono il sistema nervoso. Impatto sugli esseri umani
ACETONE(dal latino aceto; dimetilchetone; CH 3 COCH 3) - materia organica; il rappresentante più semplice della classe chetonica. Nel corpo umano e animale, l'acetone è un prodotto metabolico intermedio: è determinato nella composizione dei corpi chetonici.
L'acetone è un liquido trasparente incolore con un odore caratteristico; È altamente volatile e miscibile con acqua, alcool, etere e la maggior parte dei solventi organici. L'acetone è altamente infiammabile; t° balla 56,24°, t° pl - 95,35°, d 4 20 - 0,7908, n D 20 - 1,3558. L'acetone si trova in piccole quantità in alcune piante e oli essenziali. Nell'industria, l'acetone viene prodotto principalmente mediante la deidrogenazione catalitica dell'alcol isopropilico ottenuto durante la raffinazione del petrolio. Quantità significative di acetone si formano durante la fermentazione degli zuccheri sotto la tua influenza. acetobutylicus o tu. macerani (fermentazione acetonica), nonché durante la distillazione a secco del legno. L'acetone è altamente reattivo. Con idrossilammina, idrazina e semicarbazide si ottengono ossime cristalline, idrazoni e semicarbazoni, che vengono utilizzati per l'identificazione A, l'acetone è il materiale di partenza per la sintesi di iodoformio, cloroformio e di molti altri composti organici, ad esempio chetone, isoprene , sostanze aromatiche artificiali (iononi) ecc. L'acetone è ampiamente usato come solvente per vernici, pellicole, acetato di nitro e cellulosa, acetilene, ecc.
L'effetto dell'acetone sul corpo
L'acetone ha un effetto stimolante e narcotico, che colpisce il sistema nervoso centrale; L'effetto tossico dovuto alla capacità dell'acetone di accumularsi nell'organismo dipende non solo dalla concentrazione, ma anche dal tempo di azione. L'avvelenamento da acetone è accompagnato da una sensazione di calore, vertigini e svenimento; compaiono congiuntivite, dermatite e catarro delle vie respiratorie superiori.
In condizioni industriali, quando si lavora a lungo con l'acetone, sono possibili casi di avvelenamento cronico.
Di norma, nel corpo umano si trovano solo tracce di acetone, ma in vari disturbi metabolici (ad esempio diabete mellito), l'acetone appare nel sangue e nelle urine dei pazienti (vedi Acetonemia, Acetonuria).
L'acetone nelle urine o in altri liquidi è determinato qualitativamente dalle reazioni con il nitroprussiato di sodio (colore rosso in un mezzo alcalino, che non scompare se acidificato con acido acetico - test di Legal) e dalla formazione di iodoformio con una soluzione di iodio in ioduro di potassio - Il test di Liben.
La concentrazione massima consentita nell'aria dei locali industriali è di 200 mg/m 3 .
Acetone in medicina legale
Nella medicina legale, l'acetone è importante nell'avvelenamento acuto, ad esempio, se usato come sostituto dell'alcol. All'autopsia: odore di acetone, segni di asfissia, gonfiore e congestione del cervello e delle sue membrane, gonfiore e congestione dei polmoni, emorragie nella mucosa del tratto gastrointestinale; microscopicamente - degenerazione granulare del miocardio, del fegato, dei reni.
La ricerca chimica forense è determinata nel cervello, nella milza, nel fegato, nei polmoni, nei reni.
Bibliografia: Weisberger A. et al., Solventi organici, trad. dall'inglese, pag. 128, M., 1958; Sostanze nocive nell'industria, ed. N.V. Lazareva, parte 1, p. 389, L., 1971; Fizer L. e Fizer M. Chimica organica, trad. dall'inglese, vol.1, M., 1969.
M. A. Cheltsova, Ya. S. Smusin (giudice medico).
Acetone, propanone(dal lat. Aceto- aceto) è il primo rappresentante della serie omologa dei chetoni alifatici. Formula (CH3)2CO.
caratteristiche generali
Liquido volatile incolore con odore caratteristico. È completamente miscibile con acqua e solventi organici polari, ed è anche miscibile in proporzioni limitate con solventi non polari.
L'acetone è un prezioso solvente industriale e, grazie alla sua bassa tossicità, è ampiamente utilizzato nella produzione di vernici, esplosivi e medicinali. È un materiale di partenza in numerose sintesi chimiche. Nella pratica di laboratorio viene utilizzato come solvente polare aprotico per la preparazione di miscele refrigeranti insieme a ghiaccio secco e ammoniaca; l'acetone è molto utile per il lavaggio della vetreria chimica.
L'acetone è uno dei prodotti del metabolismo negli organismi viventi, in particolare nell'uomo. È uno dei componenti dei cosiddetti corpi acetonici, che sono estremamente piccoli nel sangue di una persona sana, tuttavia, in condizioni patologiche (digiuno prolungato, attività fisica intensa, diabete grave), la loro concentrazione può aumentare significativamente e raggiungere 20 mmol/l (chetonemia).
In Ucraina, l’acetone, in conformità con la Risoluzione del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2012 N 1129 “Sull’approvazione dell’elenco degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e dei precursori”, è un precursore per il quale sono stabilite misure di controllo. Inoltre, le sostanze contenenti almeno il 50% di acetone sono soggette alle stesse misure di controllo.
Significato industriale
L'acetone, uno dei chetoni più semplici e importanti, fu scoperto per la prima volta nel 1595 dal chimico tedesco Andreas Libavius durante la distillazione a secco dell'acetato di piombo. Ma fu solo nel 1832 che Jean-Baptiste Dumas e Liebig ne determinarono con precisione la natura e la composizione. Nel 1914 l'acetone veniva prodotto quasi esclusivamente dalla coke del legno, ma l'aumento della domanda durante la prima guerra mondiale portò rapidamente allo sviluppo di nuovi metodi di produzione.
Ricevuta
Vecchi metodi
Il metodo più antico di produzione industriale dell'acetone era la distillazione a secco dell'acetato di calcio, che si forma quando l'aceto di legno, che si forma durante la cottura del legno, viene neutralizzato con la calce. Ora questo metodo non viene più utilizzato, poiché l'acetone in questo caso contiene troppe impurità e il materiale di partenza è scarso.
Sono noti anche metodi per produrre acetone mediante degradazione batterica dei carboidrati (amido, zuccheri, melassa) e come sottoprodotti si forma alcol butilico o etilico. Acetone e alcol butilico si ottengono in un rapporto molare da 2: 1 a 3: 1.
In Germania è stato sviluppato un processo tecnologico per la produzione di acetone a base di acido acetico. A 400 °C, l'acido acetico veniva fatto passare attraverso i contatti con il cerio:
Questo acetone è particolarmente puro.
L'acetone è anche prodotto dall'acetilene mediante sintesi diretta:
L'acetilene reagisce con il vapore acqueo a 450°C in presenza di catalizzatori (in particolare ossido di zinco o composito Fe 2 O 3 -ZnO).
Preparazione da alcol isopropilico
Uno dei metodi principali per produrre acetone è la deidrogenazione dell'alcol isopropilico:
La deidrogenazione avviene a 350-400°C in presenza di catalizzatori quali lega ferro-rame-zinco, ossido di zinco o ossido di zinco al 4,5% di carbonato di sodio, rame, piombo ed altri. A causa della natura endotermica della reazione, il processo viene effettuato in un reattore tubolare, i cui tubi lunghi e stretti vengono riscaldati dai gas di scarico. La produttività del processo aumenta all'aumentare della pressione (circa 2,7-3,4 atmosfere).
L'attività del catalizzatore diminuisce progressivamente a causa del deposito di fuliggine e sostanze resinose sulla sua superficie. La rigenerazione del catalizzatore prevede la combustione di depositi di carbonio con ossigeno diluito con gas inerti.
Recentemente, l'acetone è stato prodotto sempre più spesso ossidando l'alcol isopropilico con l'aria. Questo produce anche perossido di idrogeno:
Questo metodo gioca un ruolo nella produzione di glicerina in assenza di cloro. Argento, rame, nichel, platino e altri vengono utilizzati come catalizzatori durante il processo.
In questo processo, l'aria satura di vapori di alcol isopropilico viene fatta passare su un sottile strato di catalizzatore a una temperatura di 400-650 ° C. I prodotti della reazione vengono rapidamente raffreddati e la condensa dopo la neutralizzazione di piccole quantità di acido acetico distillato. L'acetone tecnico separato viene rettificato e l'alcool isopropilico non reagito viene restituito per l'ossidazione.
La reazione di ossidazione dell'alcol isopropilico è altamente esotermica e difficile da controllare. Pertanto, si consiglia di combinare sia l'ossidazione che la deidrogenazione in un'unica reazione in modo che l'effetto termico totale si avvicini allo zero.
Metodo di ossidazione diretta del propilene
Una tecnologia per la sintesi diretta dell'acetaldeide dall'etilene è stata sviluppata e introdotta nell'industria
può anche servire per ottenere direttamente l'acetone dal propilene. In questo caso, il propilene (o una miscela di gas ricchi di propilene) viene convertito in acetone sotto l'azione di una soluzione catalitica e in acido cloruro. Il catalizzatore ridotto viene nuovamente ossidato dall'aria. In questo caso si verificano le seguenti reazioni:
La resa è del 92-94% a 90-120°C e una pressione di 9-12 kgf/cm². Come sottoprodotti si formano lo 0,5-1,5% di propionaldeide (propanale) e circa il 2% di mono- e dicloroacetoni. Si presuppone che la reazione proceda attraverso il complesso -, che in presenza di acqua si decompone idroliticamente in acetone, palladio e acido perclorico. Gli agenti di riossidazione saranno CuCl 2 o FeCl 3, nonché miscele di entrambi i composti.
La reazione può essere effettuata a temperatura ambiente, ma temperature elevate accelerano il processo. Nella maggior parte dei casi il pH della soluzione è compreso tra 3 e 4. Anche la pressione ha un effetto benefico sul decorso della reazione. Di solito funzionano con una soluzione molto diluita di PdCl 2 (parzialmente insieme ad acetato di rame). L'uso di una soluzione concentrata accelera la reazione.
I catalizzatori di acroleina modificati vengono utilizzati anche nell'ossidazione diretta del propilene in acetone. Catalizzatori a base di MoO 3 o Bi 2 O 3 in presenza di H 3 PO 4 o H 3 BO 3 a 375 °C danno, insieme ad acetaldeide, acido acetico, formaldeide, acetato di etile e acroleina, nonché acetone, e il l'aggiunta di argento ha un effetto positivo. È possibile utilizzare il fosforomolibdato di bismuto su Al 2 O 3 e l'acido fosfomolibdico su SiO 2 (260 ° C, 1 s).
Metodo cumene-idroperossido
Questo metodo è anche uno dei principali metodi industriali per produrre acetone; è più economico del 40% rispetto al metodo per produrre acetone dall'alcol isopropilico. I prodotti di partenza sono benzene e propilene.
L'alchilazione del benzene con propilene viene effettuata in presenza di un catalizzatore di cloruro di alluminio ad una temperatura di 50 ° C. Come catalizzatori sono stati utilizzati anche acido solforico concentrato, acido fluoridrico, fluoruro di boro e altri.
L'ossidazione del cumene viene effettuata con ossigeno dell'aria a 4-5 atmosfere e 110-120 ° C, e si forma idroperossido di cumene.
L'idroperossido di cumene ad una temperatura di 30-60 ° C in presenza di circa lo 0,1% di acido solforico si decompone in fenolo e acetone:
Altri metodi
L'acetone può essere prodotto dalla reazione catalitica del vapore di acido acetico a temperature elevate (400-450 °C). Catalizzatori: carbonato di calcio o bario, ossidi di calcio, alluminio, torio, uranio, zinco, sali di manganese e altri.
Un altro metodo ben noto è la deidrogenazione catalitica del vapore di etanolo ad una temperatura di 450-500 ° C. I catalizzatori del processo sono ossido di ferro, calce attivata e altri.
La formazione di acetone è possibile durante l'ossidazione catalitica del propano con ossigeno atmosferico ad una temperatura di 400 ° C:
Proprietà chimiche
L'acetone ha le proprietà chimiche tipiche dei chetoni. È difficile da ossidare e viene ridotto cataliticamente ad alcol isopropilico. Quando si riduce l'acetone con reagenti alcalini e soprattutto con amalgama di magnesio o zinco, si verificano condensazione e riduzione, culminanti nella formazione del pinacone:
L'acetone ossida gli alcoli secondari in chetoni in presenza strofina-butossido di alluminio (reazione di Openauer)
Quando si utilizza un grande eccesso di acetone, la reazione si sposta a destra.
L'azione del perossido di idrogeno sull'acetone in un ambiente acido produce perossido di acetone. L'anidride cromica ossida l'acetone in anidride carbonica e acqua.
L'acetone subisce varie reazioni di condensazione. Durante la condensazione aldolica si forma l'alcool diacetonico che viene utilizzato come solvente:
Durante la condensazione del crotone si formano in sequenza l'ossido di mesitile e poi il forone. L'ossido di mesitile viene utilizzato per ridurre la volatilità dei solventi per rivestimenti di pitture e vernici.
Quando tre molecole di acetone vengono condensate sotto l'azione di acido solforico o cloridrico concentrato, si forma il trimetilbenzene simmetrico (mesitilene):

Quando condensato con acetilene, l'acetone forma dimetilcarbinolo, che viene facilmente convertito in isoprene:
Quando l'acetone si condensa con formaldeide in presenza di piccole quantità di alcali, si forma acetoalcol che, sotto l'azione di iodio o acidi quando riscaldato, separa facilmente l'acqua, trasformandosi in metilvinilchetone:
Condensando l'acetato di etile con acetone si ottiene l'acetilacetone:
Una delle reazioni più importanti dell'acetone è l'aggiunta di acido cianidrico, con conseguente formazione di acetone cianoidrina:

L'acetone reagisce con ammoniaca e idrogeno in presenza di nichel o rame per formare ammine:
Solitamente la reazione avviene ad una temperatura di 125-175°C e ad una pressione di 5-10 atmosfere.
Quando l'acetone viene esposto al sodio metallico o all'ammide di sodio, si forma acetone di sodio - alcossido di sodio dell'alcol isopropenilico:
Quando l'acetone viene pirolizzato (500-700 ° C) su allumina o su un filo di platino riscaldato dalla corrente elettrica in un dispositivo speciale - una lampada a chetene, si forma il chetene stesso:
In presenza di alcali, l'acetone reagisce facilmente con l'alogeno per formare cloroformio, iodoformio e bromoformio:
L'acetone si combina anche con il cloroformio per formare cloroetone, che viene utilizzato come antisettico:

L'acetone reagisce anche con l'ammoniaca in una reazione di Mannich per formare 2,2', 6,6'-tetrametilpiperidone-4 con rese accettabili.
Applicazione
L'acetone è un ottimo solvente per grassi, oli, molte resine, vernici nitro, ceralacca e colofonia. L'acetone dissolve anche la celluloide, la nitro e l'acetato di cellulosa. Le resine di gomma, pece e mastice non si sciolgono in acetone.
A causa della sua bassa tossicità e della buona solubilità, l'acetone è ampiamente utilizzato nelle imprese di lavaggio a secco.
Condensando l'acetone in un mezzo alcalino si possono ottenere vari prodotti. Ad una temperatura di 10-20 ° C in una soluzione di metanolo, l'acetone dimerizza in presenza di piccole quantità di alcali in alcool diacetonico, da cui si ottengono glicole esilene, ossido mesitilico, metil isobutil carbinolo, metil isobutil chetone ed esilene glicole metil etere. ottenuto.
Il glicole esilene viene aggiunto principalmente al carburante. L'ossido di mesitile è in grado di subire varie reazioni di addizione, ad esempio con metanolo in presenza di piccole quantità di alcali. Il metilisobutilchetone è un solvente molto importante. Il metilisobutilchetone e il metilisobutilcarbinolo sono ottimi solventi per cloruro di polivinile, copolimeri di cloruro di vinile, derivati della cellulosa, gomma clorurata e altre sostanze. Nella maggior parte dei casi, sono superiori agli esteri nelle loro proprietà solubili.
Durante la condensazione catalitica dell'acetone in presenza di basi a 200°C, insieme ai cosiddetti isociclitoni, si forma l'isoforone, che è anche la base per varie sintesi. Lo stesso isoforone occupa una posizione eccezionale come solvente per vernici viniliche. Conferisce brillantezza e resistenza alle vernici termoessiccanti. Un'attenta idrogenazione con isoforone produce 3,3,5-trimetilcicloesanone, che viene utilizzato per produrre perossidi e funge da solvente. Il 3,3,5-trimetilcicloesanolo, che si forma a seguito della completa idrogenazione dell'isoforone, è un componente importante di plastificanti speciali, soprattutto in interazione con acidi mono- e dicarbossilici alifatici a catena lunga. Ma un'importanza ancora maggiore è attribuita al prodotto della sua ossidazione con acido nitrico: acido α, α, γ-trimetiladipico. Questo acido viene eterificato in speciali plastificanti e convertito tramite dimetil etere in 2,2,4-trimetilesandiolo-1,6 mediante vigorosa idrogenazione. In alternativa, l'acido può essere convertito mediante idrogenazione del dinitrile in 2,2,4-trimetilesametilendiammina.
Un altro modo per ottenere una diammina con isoforone è trattarla con acido cianidrico e formare il nitrile isoforone - 3,3,5-trimetil-5-cianocicloesanone, che in condizioni speciali può essere ridotto a 1-amminometil-1,3,3 -trimetil-5-amminocicloesano (isoforonediammina).
Le diammine possono essere facilmente convertite in diisocianato e ulteriormente utilizzate come indurenti per resine epossidiche. Il loro ruolo è particolarmente importante per la produzione di poliammidi trasparenti. Le poliammidi vengono utilizzate per la produzione di resine, componenti coesivi di vernici, adesivi e materie plastiche di alta qualità.
Influenza fisiopatologica
Carattere generale dell'azione
Il farmaco colpisce costantemente tutte le parti del sistema nervoso centrale. Quando inalato, si accumula nel corpo per un lungo periodo di tempo. L'effetto tossico dipende non solo dalla concentrazione, ma anche dal tempo di azione. La lenta escrezione dal corpo aumenta la possibilità di avvelenamento cronico. Sopprime alcuni enzimi mitocondriali (ossidativi).
Effetto sugli animali
Nell'avvelenamento acuto nei topi bianchi, si verifica una posizione laterale dopo un'esposizione di 2 ore a 30-40 mg/l; morte - a 150 mg/l. Nei ratti albini, la posizione laterale è stata esposta a 30 mg/L per 2 ore. Concentrazioni fino a 10 mg/l non hanno alcun effetto anche dopo le 8:00. I primi segni di avvelenamento sono stati rilevati a 25 mg/l dopo 1,5-3 ore. A 50 mg/l i riflessi scompaiono dopo 2-2,5 ore. Nelle cavie e nei conigli, il posizionamento laterale si è verificato con un'esposizione di 2 ore a 72 mg/L. Le concentrazioni minime che modificano l'attività riflessa folle dei conigli sono 1,25-2,5 mg/l. Nei topi, ratti, porcellini d’India e conigli, le concentrazioni di acetone che inducevano il posizionamento laterale hanno comportato aumenti di acetone, acido acetoacetico e soprattutto acido β-idrossibutirrico nel sangue e nelle urine. Nei gatti l'inalazione di 8-10 mg/l per 5:00 provoca solo irritazione delle mucose del naso e degli occhi e sonnolenza. Nei cani, a 5-6 mg/le un'esposizione di 7:00, i riflessi condizionati non cambiano.
Negli studi sull'avvelenamento cronico, ai ratti bianchi sono stati somministrati 0,00053 mg/L di acetone da inalare continuamente per 45 giorni o 0,2 mg/L al giorno per 8:00 ore. Di conseguenza, non sono stati trovati segni significativi di avvelenamento. L'effetto di 0,019 mg/l 4:00 al giorno per 3 settimane non ha modificato l'attività riflessa condizionata. Gli animali sono stati esposti all'acetone per 9 giorni ad una concentrazione ematica del 100 mg% e non hanno mostrato alcun segno di avvelenamento, a parte un po' di sonnolenza. A 250 mg% di acetone nel sangue - debolezza e perdita di coordinazione dei movimenti. Topi e conigli esposti quotidianamente ad avvelenamento per 4 ore con una concentrazione di 8 mg/l per più di 3 mesi hanno sviluppato una maggiore sensibilità all'acetone con un peggioramento delle loro condizioni generali. Secondo altri dati, invece, inalando concentrazioni crescenti da 1 a 4 mg/l per 40 minuti 1-2 volte a settimana si osservava “dipendenza”. Il contenuto di acetone nel sangue degli animali “abituati” alla stessa concentrazione nell'aria era inferiore a quello di chi lo inalava per la prima volta. Nei gatti, avvelenamenti ripetuti di 3-5 mg/l hanno causato solo irritazione delle mucose.
Impatto sugli esseri umani
La soglia di percezione dell'odore è 0,0011 mg/l, la soglia di azione, che comporta la comparsa di un riflesso condizionato elettrocorticale, è 0,44 mg/l. L'inalazione di 1,2 mg/l per 3-5 minuti ha irritato le mucose degli occhi, del naso e della gola, mentre l'inalazione di 0,01 mg/l per 6:00 ha aumentato l'attività della colinesterasi nel sangue e il tasso di utilizzo dell'ossigeno. Un aumento del contenuto di corpi chetonici nel sangue si è verificato anche con esposizione a 0,001 mg/l; il contenuto di corpi chetonici nelle urine non è cambiato.
In caso di avvelenamento acuto, il contenuto di acetone nel sangue della vittima il secondo giorno ha raggiunto il 18 mg% (la norma è 1-2 mg%). L'acetone è stato trovato anche nelle urine; Dopo qualche tempo, nelle urine sono state trovate una piccola quantità di proteine, leucociti e globuli rossi. Il livello di zucchero nel sangue il giorno dell'avvelenamento ha raggiunto il 142 mg%.
Con concentrazioni simultanee di 2,3-3 mg/l di acetone e butanone nell'aria sono stati segnalati casi di svenimento tra le lavoratrici. Quando l'acetone fu usato come solvente insieme al butanone, fu descritto l'avvelenamento di diversi lavoratori (malessere, lacrimazione, breve perdita di coscienza accompagnata da convulsioni, mal di testa). Gravi malattie acute degli occhi tra gli operai dei calzaturifici (fotofobia, lacrimazione, congiuntivite e perfino disturbi della vista) erano causate dall'alcol acetonico e ovviamente dipendevano non tanto dall'acetone quanto dagli alcoli metilico e allilico. Malattie simili sono state attribuite alla contaminazione dell'acetone con acetaldeide.
Secondo le osservazioni effettuate durante gli studi sull'avvelenamento cronico ad una concentrazione di 0,1-0,12 mg/l di acetone, non sono stati osservati segni di avvelenamento nei lavoratori, sebbene sia stato costantemente rilevato nelle urine; a 0,5-1 mg/l l'acetone nel sangue non è stato rilevato entro una settimana. Una concentrazione di 5 mg/l nell'aria con l'esposizione giornaliera ha causato la comparsa di fino al 40 mg% di acetone nel sangue. In presenza di ~0,6 mg/l di acetone nell'aria (in presenza di acetato di butile e alcol etilico) sono stati osservati segni di avvelenamento. Sono stati osservati cambiamenti nel tratto respiratorio superiore, spesso sotto forma di catarro atrofico, anemia, spostamento a sinistra della formula dei leucociti e diminuzione dell'appetito. In alcuni lavoratori nel siero del sangue è stata rilevata una diminuzione del livello di albumina e un aumento del livello delle globuline α, β e γ, nonché dei lipidi totali, senza altri sintomi di intossicazione.
Effetto sulla pelle
Quando si immergono le orecchie di un coniglio nell'acetone per 3:00 o si applica acetone puro sulla pelle della pancia tagliata per 6:00, l'effetto locale è quasi impercettibile. Durante l'applicazione di compresse di acetone, sono stati riscontrati cambiamenti nel sistema nervoso periferico, con le fibre nervose cerebrali che sono le più sensibili.
Gli impacchi di acetone applicati quotidianamente sulla spalla di una persona provocavano un leggero rossore, che presto scompariva. Nei lavoratori, nelle zone della pelle esposte all'acetone durante la giornata lavorativa, il pH e la quantità di colesterolo sono diminuiti e la funzione delle ghiandole sebacee è stata soppressa.
Ingresso nel corpo e comportamento in esso
L'acetone liquido può essere assorbito attraverso la pelle. L'acetone appare nel sangue subito dopo l'inizio dell'inalazione; la sua concentrazione aumenta gradualmente fino a stabilire l'equilibrio dinamico. Il contenuto nei tessuti è il seguente: cervello → milza → fegato → pancreas → reni → polmoni → muscoli → cuore. Carbonio marcato, parte della molecola dell'acetone, presente nel glicogeno, nelle urine, nel colesterolo, negli acidi grassi e negli amminoacidi. L'acetone viene metabolizzato in modo più completo quando vengono inalate basse concentrazioni. Con l'aria espirata viene rilasciato acetone invariato e durante la sua ossidazione si forma. L'acetone viene escreto anche attraverso i reni e la pelle.
"Test dell'acetone"
Acetone, acido acetoacetico e acido betaidrossibutirrico sono collettivamente chiamati corpi chetonici. Questi sono prodotti dell'ossidazione incompleta dei grassi e parzialmente delle proteine e sono strettamente correlati tra loro.
In uno stato normale del corpo, i corpi chetonici sono assenti nell'analisi generale delle urine. Va notato che una piccola quantità di questi composti viene escreta quotidianamente nelle urine, ma tali concentrazioni non possono essere determinate con i metodi convenzionali utilizzati nei laboratori. Pertanto, è generalmente accettato che normalmente non ci siano corpi di acetone nelle urine.
I corpi chetonici compaiono in un test generale delle urine quando si verifica una violazione del metabolismo dei carboidrati e dei grassi. Questo disturbo è accompagnato da un aumento del numero di corpi acetonici nei tessuti del sangue (chetonemia). Il contenuto di corpi di acetone nelle urine è chiamato chetonuria.
In condizioni normali, il corpo trae energia principalmente dal glucosio. Il glucosio si accumula nel corpo, principalmente nel fegato sotto forma di glicogeno. Il glicogeno costituisce una riserva energetica che può essere rapidamente mobilitata quando necessario per compensare un'improvvisa mancanza di glucosio.
Durante lo stress fisico ed emotivo, durante malattie con temperatura elevata e altri maggiori costi energetici, le riserve di glicogeno si esauriscono e il corpo inizia a ricevere energia dalle riserve di grasso. Quando il grasso si decompone, si formano corpi chetonici, che vengono escreti nelle urine. Se il glucosio viene rilevato con corpi di acetone in un test generale delle urine, questo è un segno di diabete mellito. Inoltre, i corpi chetonici in un esame generale delle urine compaiono a causa di disidratazione, perdita di peso improvvisa, febbre, digiuno, avvelenamento grave con vomito grave e diarrea.
Video sull'argomento
L'avvelenamento da acetone è comune nella vita di tutti i giorni. L'avvelenamento è particolarmente pericoloso se ingerito in grandi dosi, così come per inalazione, soprattutto quando avviene in ambienti chiusi. Il primo soccorso tempestivo può salvare la vita di una persona.
Applicazione
L'acetone è un liquido volatile, incolore, infiammabile con un odore particolare. La sua formula chimica è CH3–CO–CH3.
L'acetone è un componente di vernici e svernicianti, solventi per grassi, resine, vernici, alcuni adesivi, detergenti e molte altre sostanze.
CH3–CO–CH3 ha un effetto tossico associato ad un effetto narcotico sul sistema nervoso centrale. La sua dose letale è superiore a 100 ml.
Causa di avvelenamento
L'avvelenamento da acetone avviene per ingestione, inalazione dei suoi vapori in grandi quantità o, cosa molto rara, per contatto con la pelle. Una volta nel corpo umano, viene rapidamente assorbito nel sangue. L'acetone ha un effetto irritante e narcotico; influisce negativamente sull'intero sistema nervoso centrale, sul tratto gastrointestinale, sul fegato, sui reni e su altri organi interni. La vittima manifesta sintomi di sensazione di bruciore, prima nella bocca, poi penetrante nella faringe e nell'esofago.
Se il primo soccorso non viene fornito tempestivamente e correttamente, la condizione peggiorerà rapidamente:
- il viso impallidirà;
- le membra diventeranno fredde e blu;
- la respirazione diventerà pesante e rumorosa;
- appariranno le convulsioni.
Anche dopo aver ingerito poco più di 50 ml di acetone si può verificare la morte.
Viene escreto attraverso i polmoni e i reni, ma ciò avviene molto lentamente.
L'acetone può entrare nel corpo nei seguenti modi:
- in caso di ingestione accidentale o intenzionale di acetone;
- attraverso il sistema delle vie respiratorie;
- attraverso gli occhi quando gli schizzi colpiscono il viso;
- a contatto con la pelle a causa di fuoriuscita accidentale.
Accade spesso che il primo soccorso fornito in caso di avvelenamento aiuti a salvare la vita di una persona.
Sintomi di avvelenamento
L'avvelenamento da acetone è simile all'intossicazione da alcol. I principali sintomi di avvelenamento sono i seguenti:
- un forte calo della pressione sanguigna;
- andatura instabile;
- gonfiore e infiammazione della mucosa faringea
- dalla bocca esce un odore fruttato o pungente di acetone;
- vomito,
- nausea persistente;
- forte dolore addominale;
- brevi periodi di svenimento;
- sonnolenza;
- mal di testa;
- arrossamento degli occhi;
- irritazione delle vie respiratorie;
- allucinazioni.
Se non viene fornito aiuto per questi sintomi, l'avvelenamento è esteso e dura a lungo, compaiono ulteriori sintomi, come:
- giallo della sclera;
- ingrossamento del fegato;
- insufficienza renale,
- difficoltà a urinare.
Pronto soccorso e trattamento
Il trattamento dipende da come è entrato il veleno.
Se noti sintomi di avvelenamento da acetone, dovresti chiamare immediatamente un'ambulanza. Prima del suo arrivo è opportuno fornire i primi soccorsi per ridurre rapidamente l'assorbimento della sostanza tossica. Per fare questo è necessario:
- sciacquare accuratamente lo stomaco; se la vittima ha assunto acetone per via orale, è possibile costringerla a bere carbone attivo o un lassativo salino. Se una persona ha perso conoscenza, prima di lavarsi lo stomaco è necessario riportarla alla coscienza. Per fare questo, è necessario dargli un batuffolo di cotone imbevuto di ammoniaca per annusare.
- Ventilare la stanza, ma è meglio portare la vittima all'esterno se è stata avvelenata dai vapori di acetone per fornire una grande quantità di aria fresca.
- Dopo tutte le misure adottate, il paziente deve essere messo a letto. Anche in questo caso il tè caldo o il caffè aiuteranno.
L'avvelenamento dai vapori di questa potente sostanza è particolarmente pericoloso per i bambini.
La persona avvelenata deve essere ricoverata in ospedale nel reparto terapeutico.
Quando si esegue il test per l'avvelenamento con questa sostanza,
- esami delle urine e del sangue per i chetoni;
- screening tossicologico, per determinare le sostanze chimiche tossiche presenti nel corpo.
Dopo la conferma dell'avvelenamento da acetone, viene eseguita la lavanda gastrica utilizzando un tubo che viene inserito attraverso la gola nello stomaco.
La terapia infusionale con soluzioni isotoniche e cristalloidi è molto comune. Al paziente vengono somministrate anche soluzioni alcalinizzanti e viene effettuata la terapia antibiotica.
L'inalazione di ossigeno aiuta bene con l'avvelenamento da acetone. L'ossigeno lo rimuove efficacemente dal sangue, ma il sollievo con questo metodo di trattamento non arriva rapidamente; passano diverse settimane prima che il paziente si senta meglio.
Se il primo soccorso viene fornito in modo tempestivo e entro 48 ore i sintomi di avvelenamento iniziano a diminuire e compaiono segni di miglioramento della salute, le possibilità di recupero saranno piuttosto elevate. Ma è necessaria l'osservazione da parte di un tossicologo, poiché spesso si verificano complicazioni.
Prevenzione dell'avvelenamento
Quando si lavora con sostanze ad alto contenuto di acetone, è necessario osservare la sicurezza:
- utilizzare un respiratore e guanti di gomma;
- Ventilare costantemente la stanza; i vapori di acetone tendono ad accumularsi gradualmente nel corpo umano.
Se in casa ci sono bambini piccoli, assicurarsi di rimuovere tutte le sostanze contenenti acetone fuori dalla loro portata. Ricorda, il solvente per unghie non dovrebbe finire nelle loro mani!
Se noti i sintomi dell'avvelenamento da acetone, non dovresti sperare nell'auto-cura, ma chiama un'équipe medica il prima possibile.
L'acetone impiega molto tempo per essere eliminato dal corpo e le conseguenze dell'avvelenamento possono essere molto terribili. Pertanto sono necessari il pronto soccorso immediato e l'intervento medico qualificato obbligatorio.
Quando si lavora con l'acetone, è molto importante prendersi cura della sicurezza antincendio. Il problema è che l'acetone è infiammabile. Inoltre, le miscele d'aria contenenti dal 2,5% al 12,8% di vapore di acetone possono essere esplosive. In questo caso, l'acetone stesso evapora abbastanza rapidamente. Se una nuvola di vapore di acetone si diffonde in grandi quantità, anche una piccola scintilla o un forte calore possono provocare un'accensione. Per questo motivo il lavoro con l'acetone viene effettuato a notevole distanza dai luoghi di accensione.
Tossicità dell'acetone e precauzioni di sicurezza
È generalmente accettato che l'acetone non sia altamente tossico. Inoltre, questa sostanza non è in grado di causare malattie croniche se si seguono attentamente le precauzioni di sicurezza quando si lavora con essa. Allo stesso tempo, i vapori di acetone con esposizione cronica possono causare eccitazione e persino avere effetti narcotici, possono irritare il sistema nervoso centrale e accumularsi nel corpo umano. Di conseguenza, l'effetto tossico dipende non tanto dalla concentrazione di acetone, ma dalla quantità di esposizione al corpo.
Con un'esposizione prolungata, il vapore di acetone ad alta concentrazione può irritare i bronchi, i polmoni, il rinofaringe, causare spiacevoli dolori agli occhi e persino portare a gonfiore oculare. Anche se avverti una leggera sensazione di disorientamento, vertigini o nausea, devi immediatamente smettere di lavorare con l'acetone ed uscire all'aria aperta. Non dovresti entrare nella stanza in cui lavori con l'acetone senza una maschera speciale.
L'acetone si diffonde nell'atmosfera a una velocità incredibile. L'emivita di questa sostanza se esposta alla luce solare è di 22 giorni. In piccole concentrazioni, l'acetone viene rapidamente assorbito da alcuni batteri e non ha un impatto negativo sull'ambiente.
Condizioni di conservazione dell'acetone
L'acetone può essere conservato a lungo in un contenitore chiuso (completamente sigillato) all'interno in un luogo lontano da impianti di riscaldamento e dispositivi di riscaldamento. In nessun caso la sostanza deve essere esposta ai raggi ultravioletti diretti. Puoi lavorare con l'acetone solo in stanze dotate di un potente sistema di ventilazione. Se la sostanza si accende può essere estinta solo con estintori a polvere.
L'acetone tecnico allo stato liquido viene versato in botti di alluminio, contenitori zincati o in acciaio e bottiglie di vetro. Può essere trasportato tramite autocisterne o apposite cisterne ferroviarie rispettando tutte le norme per il trasporto di merci pericolose. L'acetone può essere conservato in vetro per un anno, in altri tipi di contenitori - non più di tre mesi.
Ancora qualche parola sulle precauzioni
Quando si lavora con l'acetone, è molto importante assicurarsi che non entri negli occhi. È inoltre necessario avere guanti di gomma spessi sulle mani. Se l'acetone viene a contatto con la pelle esposta, assicurati di lavarlo via immediatamente con acqua tiepida e sapone.
Tossicità dell'acetone
1.5.1 Pericolo di incendio, esplosione
L'acetone che ha perso le sue proprietà di consumo appartiene alla classe di pericolo III.
Uno dei pericoli principali quando si lavora con l'acetone è che è altamente infiammabile. Temperatura di accensione +465 °C.
Le miscele d'aria contenenti dal 2,5% al 12,8% (in volume) sono esplosive. Questo deve essere preso in considerazione, poiché l'acetone evapora rapidamente e la nuvola risultante può diffondersi fino al punto di accensione (riscaldamento o scintilla) lontano dal luogo di lavoro.
1.5.2 Tossicità
Si ritiene che l'acetone abbia una tossicità relativamente ridotta. Attualmente, la concentrazione massima consentita è considerata pari allo 0,1%. La permanenza per un breve periodo in un'atmosfera in cui la concentrazione di acetone è molto superiore a quella specificata non provoca danni.
Di particolare pericolo è l'avvelenamento orale con grandi dosi di acetone, nonché l'avvelenamento da inalazione (soprattutto in spazi chiusi). L'avvelenamento cutaneo grave praticamente non si verifica ed è classificato come casistico.
Tuttavia, gli effetti dell'acetone si manifestano in modo diverso nei diversi esseri viventi e in condizioni diverse.
Norme igieniche
MPCr.z. = 200 mg/m3 di vapore, classe di pericolosità 4. MPCm.r. e MPC.s. = 0,35 mg/m3, classe di pericolo 4. MAC = 2,2 mg/l, indicatore sanitario generale, classe di pericolo 3.
MAC nei bacini di pesca = 0,05 mg/l; segno tossicologico.
La sua concentrazione massima consentita (MPC) nell'acqua pubblica è di 2,2 mg/l.
Il livello consentito di acetone rilasciato nell'aria dai materiali da costruzione polimerici è 0,35 mg/m3, nei prodotti alimentari - 60 mg/kg.
Natura generale dell'effetto sugli animali a sangue caldo
Un farmaco che colpisce tutte le parti del sistema nervoso centrale; inibisce la funzione gonadotropica della ghiandola pituitaria e di alcuni enzimi mitocondriali e ha un effetto embriotossico. I vapori penetrano nella pelle.
La tossicità dell'acetone che entra nel corpo dall'esterno è stata ben studiata. La tossicità acuta dell'acetone (LD50) che entra attraverso lo stomaco è, secondo vari autori, per i ratti - 5,8-9,8 g/kg, per i topi - 3,0-5,25 g/kg, per conigli e cani - 3,8-8,0 g/ kg. In questo indicatore, l'acetone differisce poco dall'etanolo.
L'LD50 per i topi se inalato per 4 ore è 44 g/m3. Per l'uomo la DL50 è stimata in 1.159 g/kg. LD50 per pesce 8,3 g/l per 96 ore.
Una concentrazione di acetone di circa 750-790 mg/l inibisce il processo di trattamento delle acque reflue e ritarda la digestione dei fanghi e la formazione di metano negli impianti di trattamento delle acque reflue. Ad una concentrazione di 40-70 mg/l conferisce odore all'acqua e 80 mg/l gusto (gusto PC 12 mg/l). L'acetone non è molto stabile in acqua: alla concentrazione di 20 mg/l scompare il 7° giorno.
Idrobionti
L'acetone ha una tossicità relativamente bassa per gli organismi acquatici.
Le concentrazioni tossiche per le dafnie giovani sono 8.300, per gli adulti 12.900 mg/l; con 9300 mg/l le dafnie muoiono dopo 16 ore, mentre concentrazioni di A. a partire da 20 mg/l stimolano la riproduzione delle dafnie.
Per la trota e la gambusia, le concentrazioni tossiche sono 14,2-15,5 g/l dopo 24 ore di esposizione. Altri organismi acquatici possono sopportare senza danni una concentrazione dello 0,2%.
Azione combinata
L'acetone dà l'effetto della somma degli effetti tossici con aldeide acrilica, anidride ftalica, acetofenone, furfurale, formaldeide e fenolo.
Quando esposti a una miscela di vapori di acetone e benzene, si verificano reazioni del corpo che differiscono da quelle osservate quando queste sostanze agiscono separatamente. L'acetone da solo a concentrazioni di 2000 e 200 mg/m3 non influenza l'attività fagocitaria dei leucociti, ma in combinazione con il benzene rallenta il declino dell'attività fagocitaria caratteristico dell'azione del solo benzene. Una miscela di acetone e benzene in varie combinazioni durante un'esposizione di 3 mesi ha causato un'irritazione degli organi ematopoietici, più pronunciata rispetto all'esposizione separata a ciascuna di queste sostanze nelle stesse concentrazioni.
Conseguenze dell'esposizione al corpo umano
L'effetto tossico dell'acetone è associato ad un effetto narcotico sul sistema nervoso centrale, un effetto cauterizzante sulla mucosa delle vie respiratorie e sugli organi digestivi, acidosi metabolica e un effetto negativo sullo sviluppo fetale.
Incluso nell'elenco IV (precursori) delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
La dose singola efficace (EDmin) di acetone per l'uomo, determinata dal suo effetto sul sistema nervoso, sui reni e sul sangue quando somministrato attraverso lo stomaco, è di 2,9 g/kg.
La dose letale per l'uomo è superiore a 100 ml.
La concentrazione tossica nel sangue è 200 - 300 mg/l, letale - 550 mg/l.
Le principali conseguenze dell'esposizione all'acetone: mal di testa, vertigini, andatura instabile, debolezza generale, lieve intossicazione, tosse, lacrimazione, gonfiore della mucosa orale, faringe, laringospasmo, bruciore in bocca, lungo l'esofago, nausea, vomito.
Colpisce il sistema nervoso centrale, il fegato, i reni, emolizza i globuli rossi. Irrita e cauterizza localmente le mucose.
L'acetone ha un effetto stimolante e narcotico (che è particolarmente evidente durante l'esposizione cronica a persone che spesso lavorano con l'acetone come solvente), colpisce il sistema nervoso centrale e può accumularsi nel corpo, e quindi l'effetto tossico dipende non solo dalla sua concentrazione, ma e dal tempo di esposizione al corpo.
L'acetone ad alte concentrazioni (con un'esposizione più che a breve termine) irrita il sistema respiratorio e provoca una sensazione di bruciore agli occhi; con un'esposizione più lunga si verifica un gonfiore oculare a breve termine. Possibilmente in grado di provocare vertigini, nausea e disorientamento se esposto ad elevate concentrazioni di vapore.
In caso di avvelenamento massiccio, si osserva una diminuzione della pressione sanguigna, depressione respiratoria, polso rapido e debole e cianosi. Successivamente si sviluppano coma e asfissia. La morte avviene per arresto respiratorio.
In caso di avvelenamento grave, la vittima perde conoscenza entro pochi minuti e la morte avviene entro 4-12 ore a causa di insufficienza cardiovascolare acuta. Secondo alcuni dati, una persona può assumere 25 g di acetone senza danni. Secondo altri dati, la dose letale se assunta per via orale è di 50 g o addirittura 1,5 g/kg. Particolarmente pericolosa è l'aspirazione di acetone liquido nelle vie respiratorie, che può portare ad asfissia, arresto cardiaco e respiratorio e morte istantanea.
Ecologia
A causa della sua elevata volatilità, una parte significativa dell'acetone evapora nell'atmosfera, dove la sua emivita sotto l'influenza dei raggi ultravioletti è di 22 giorni.
L'emivita nell'ambiente acquatico va da 1 a 10 giorni. L'acetone può causare una significativa diminuzione dei livelli di ossigeno nell'acqua a causa del suo consumo da parte dei microrganismi.
Tuttavia, l'acetone in piccole concentrazioni viene rapidamente assorbito da un numero di batteri che lo utilizzano come mezzo nutritivo.
Precauzioni di sicurezza quando si lavora con l'acetone
L'acetone è un liquido infiammabile che si accende in modo esplosivo a contatto con perossido di sodio o anidride cromica.
Quando si lavora con l'acetone, è necessario osservare le seguenti regole:
Tutti i lavori con acetone devono essere eseguiti all'interno utilizzando la ventilazione di alimentazione e di scarico.
Tutte le apparecchiature coinvolte nei processi tecnologici (scarico, riempimento, stoccaggio) devono essere sigillate.
Nei locali di produzione e nelle aree di stoccaggio è necessario rispettare le norme di protezione contro l'elettricità statica.
Dispositivi di protezione respiratoria in situazioni di emergenza che coinvolgono acetone tecnico: una maschera antigas di grado "A" o "BKF".
Per estinguere l'acetone in fiamme vengono utilizzati estintori a polvere, sabbia, una coperta di amianto, acqua e schiuma.
1.6.1 Imballaggio
L'acetone tecnico viene versato in cisterne ferroviarie appositamente progettate per l'acetone con scarico dall'alto o dispositivo di scarico universale, autocisterne, in fusti di alluminio, acciaio o zincati con una capacità da 100 a 275 dm3, in bottiglie di vetro secondo OST 6-09 -185, con capacità di 10 e 20 dm3. L'acetone destinato al commercio al dettaglio è confezionato in bottiglie di vetro e bottiglie con una capacità di 30, 50, 100, 500 e 1000 cm3.
1.6.2 Trasporti
L'acetone viene trasportato con tutti i tipi di trasporto in conformità con le norme di trasporto merci in vigore per questo tipo di trasporto.
Il trasporto aereo viene effettuato esclusivamente su navi mercantili con un volume netto massimo per collo di 60 dm3. Vengono trasportati su rotaia in barili su vagoni coperti. Quando si trasporta acetone in barili con una capacità di 100 dm3 in vagoni ferroviari coperti, trasporti fluviali e marittimi, il trasporto viene effettuato in pacchi in conformità con le regole per il trasporto di merci.
1.6.3 Conservazione
L'acetone tecnico viene conservato in contenitori o botti di acciaio, alluminio, zincati e bottiglie di vetro secondo le norme per lo stoccaggio di sostanze infiammabili. La durata di conservazione è illimitata.