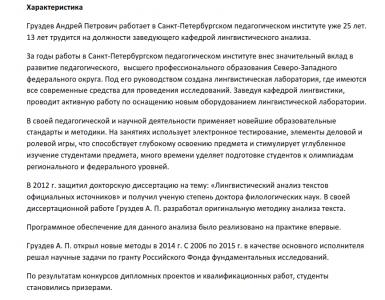La gamma di frequenze che una persona sente. Quanti decibel può sopportare l'orecchio umano? Suddivisione della gamma udibile in sottogruppi più piccoli
È noto che una persona riceve il 90% delle informazioni sul mondo che lo circonda attraverso la visione. Sembrerebbe che non sia rimasto molto per l'udito, ma in realtà l'organo uditivo umano non è solo un analizzatore altamente specializzato delle vibrazioni sonore, ma anche un mezzo di comunicazione molto potente. Medici e fisici si preoccupano da tempo della questione: è possibile determinare con precisione la portata dell'udito umano in diverse condizioni, se l'udito differisce tra uomini e donne, ci sono detentori di record "particolarmente eccezionali" che sentono suoni inaccessibili o possono produrre loro? Proviamo a rispondere a queste e ad altre domande correlate in modo più dettagliato.
Ma prima di capire quanti hertz sente l'orecchio umano, devi comprendere un concetto così fondamentale come il suono e, in generale, capire cosa si misura esattamente in hertz.
Le vibrazioni sonore sono un modo unico di trasmettere energia senza trasferire materia; sono vibrazioni elastiche in qualsiasi mezzo. Quando si tratta della vita umana ordinaria, un tale mezzo è l’aria. Contengono molecole di gas in grado di trasmettere energia acustica. Questa energia rappresenta l'alternanza di fasce di compressione e di tensione della densità del mezzo acustico. Nel vuoto assoluto le vibrazioni sonore non possono essere trasmesse.
Qualsiasi suono è un'onda fisica e contiene tutte le caratteristiche d'onda necessarie. Questa è frequenza, ampiezza, tempo di decadimento, se parliamo di un'oscillazione libera smorzata. Diamo un'occhiata a questo utilizzando semplici esempi. Immaginiamo, ad esempio, il suono della corda Sol aperta di un violino quando viene suonata con un archetto. Possiamo definire le seguenti caratteristiche:
- suono debole o forte. Non è altro che l'ampiezza, o la forza, del suono. Un suono più forte corrisponde ad un'ampiezza di vibrazione maggiore, mentre un suono debole corrisponde a un'ampiezza di vibrazione più piccola. Un suono con maggiore forza può essere udito a maggiore distanza dal punto di origine;
- durata del suono. Questo è chiaro a tutti, e tutti sanno distinguere il suono di un rullo di tamburi dal suono prolungato di una melodia di organo corale;
- altezza o frequenza della vibrazione del suono. È questa caratteristica fondamentale che ci aiuta a distinguere i suoni “cigolanti” dal registro dei bassi. Se non esistesse la frequenza del suono, la musica sarebbe possibile solo sotto forma di ritmo. La frequenza si misura in hertz e 1 hertz equivale a una vibrazione al secondo;
- timbro del suono. Dipende dalla mescolanza di ulteriori vibrazioni acustiche - formanti, ma è molto facile spiegarlo in parole semplici: anche con gli occhi chiusi, capiamo che è il violino che suona, e non il trombone, anche se hanno esattamente le stesse caratteristiche sopra elencate.
Il timbro del suono può essere paragonato a numerose sfumature di sapore. In totale abbiamo gusti amaro, dolce, acido e salato, ma queste quattro caratteristiche non esauriscono tutte le possibili sensazioni gustative. La stessa cosa accade con il timbro.
Soffermiamoci più in dettaglio sull'altezza del suono, poiché è da questa caratteristica che dipende in massima misura l'acuità dell'udito e la gamma delle vibrazioni acustiche percepite. Qual è la gamma di frequenze audio?
Campo uditivo in condizioni ideali

Le frequenze percepite dall'orecchio umano in condizioni di laboratorio o ideali rientrano in una banda relativamente ampia da 16 Hertz a 20.000 Hertz (20 kHz). Tutto ciò che è inferiore e superiore non può essere udito dall'orecchio umano. Stiamo parlando di infrasuoni e ultrasuoni. Cos'è?
Infrasuoni
Non può essere ascoltato, ma il corpo può sentirlo, come il lavoro di un grande altoparlante per bassi: un subwoofer. Queste sono vibrazioni infrasoniche. Tutti sanno perfettamente che se allenti costantemente la corda del basso di una chitarra, nonostante le continue vibrazioni, il suono scompare. Ma queste vibrazioni possono ancora essere percepite con la punta delle dita quando tocchi la corda.
Molti organi umani interni operano nella gamma degli infrasuoni: si verificano contrazione dell'intestino, dilatazione e costrizione dei vasi sanguigni e molte reazioni biochimiche. Gli infrasuoni molto forti possono causare gravi condizioni dolorose, persino ondate di panico, questa è la base dell'azione delle armi infrasoniche.
Ultrasuoni

Sul lato opposto dello spettro ci sono suoni molto acuti. Se il suono ha una frequenza superiore a 20 kilohertz, smette di "cigolare" e in linea di principio diventa impercettibile all'orecchio umano. Diventa ultrasuoni. Gli ultrasuoni sono ampiamente utilizzati nell'economia nazionale, la diagnostica ecografica si basa su di essi. Con l'aiuto degli ultrasuoni, le navi navigano nel mare, evitando gli iceberg e le acque poco profonde. Utilizzando gli ultrasuoni, gli specialisti trovano vuoti nelle strutture metalliche solide, come le rotaie. Tutti hanno visto come i lavoratori facevano rotolare uno speciale carrello per il rilevamento dei difetti lungo i binari, generando e ricevendo vibrazioni acustiche ad alta frequenza. Gli ultrasuoni vengono utilizzati dai pipistrelli per orientarsi con precisione nell'oscurità senza sbattere contro le pareti di caverne, balene e delfini.
È noto che la capacità di distinguere i suoni acuti diminuisce con l'età e i bambini li sentono meglio. La ricerca moderna mostra che già all’età di 9-10 anni, la portata uditiva dei bambini inizia a diminuire gradualmente e negli anziani l’udibilità delle alte frequenze è molto peggiore.
Per sentire come percepiscono la musica gli anziani, è sufficiente abbassare una o due file di alte frequenze sull'equalizzatore multibanda del lettore del cellulare. Il conseguente fastidioso "mormorio, come da un barile" sarà un eccellente esempio di come sentirai tu stesso dopo i 70 anni.
Una dieta scorretta, il consumo di alcol, il fumo e la deposizione di placche di colesterolo sulle pareti dei vasi sanguigni svolgono un ruolo importante nella perdita dell'udito. Le statistiche dei medici otorinolaringoiatri affermano che le persone con il primo gruppo sanguigno sviluppano la perdita dell'udito più spesso e più velocemente di altre. La perdita dell'udito è causata dall'eccesso di peso e da patologie endocrine.
Campo uditivo in condizioni normali

Se eliminiamo le "aree marginali" dello spettro sonoro, allora non c'è molto a disposizione per una vita umana confortevole: questa è la gamma da 200 Hz a 4000 Hz, che corrisponde quasi completamente alla gamma della voce umana, dal profondo dal basso profondo al soprano con alta coloratura. Tuttavia, anche in condizioni confortevoli, l’udito di una persona si deteriora costantemente. Di solito, la massima sensibilità e suscettibilità negli adulti di età inferiore ai 40 anni è al livello di 3 kilohertz e all'età di 60 anni o più diminuisce a 1 kilohertz.
Gamma uditiva negli uomini e nelle donne
Attualmente, la segregazione di genere non è incoraggiata, ma uomini e donne percepiscono il suono in modo diverso: le donne sono in grado di sentire meglio nella gamma alta, e l’involuzione del suono nella regione delle alte frequenze, legata all’età, è più lenta per loro, mentre gli uomini percepiscono le alte frequenze. suona un po' peggio. Sembrerebbe logico supporre che gli uomini sentano meglio nel registro basso, ma non è così. La percezione dei suoni bassi è quasi la stessa sia negli uomini che nelle donne.
Ma ci sono donne uniche nel “generare” suoni. Pertanto, l'estensione vocale della cantante peruviana Ima Sumac (quasi cinque ottave) si estendeva dal suono “B” dell'ottava grande (123,5 Hz) a “A” della quarta ottava (3520 Hz). Di seguito è riportato un esempio della sua voce unica.
Allo stesso tempo, c'è una differenza piuttosto ampia nel funzionamento dell'apparato vocale tra uomini e donne. Secondo i dati medi, le donne producono suoni da 120 a 400 Hz e gli uomini da 80 a 150 Hz.
Varie scale per indicare la portata dell'udito
All'inizio abbiamo parlato di come l'altezza non sia l'unica caratteristica del suono. Pertanto, esistono scale diverse a seconda degli intervalli. Il suono udito dall'orecchio umano può essere, ad esempio, debole e forte. La scala di intensità sonora più semplice e clinicamente accettabile è quella che misura la pressione sonora percepita dal timpano.
Questa scala si basa sulla vibrazione energetica più bassa del suono, che può essere trasformata in un impulso nervoso e provocare una sensazione sonora. Questa è la soglia della percezione uditiva. Più bassa è la soglia di percezione, maggiore è la sensibilità e viceversa. Gli esperti distinguono tra l’intensità del suono, che è un parametro fisico, e il volume, che è un valore soggettivo. È noto che un suono della stessa intensità verrà percepito da una persona sana e da una persona con perdita dell'udito come due suoni diversi, più forte e più basso.
Tutti sanno come nello studio otorinolaringoiatrico il paziente sta in un angolo, si volta e il medico dall'angolo successivo controlla la percezione del paziente del discorso sussurrato, pronunciando i singoli numeri. Questo è l'esempio più semplice di diagnosi primaria di perdita dell'udito.
È noto che il respiro appena percettibile di un'altra persona corrisponde a 10 decibel (dB) di intensità di pressione sonora, una normale conversazione in ambiente domestico corrisponde a 50 dB, il lamento di una sirena antincendio corrisponde a 100 dB e un aereo a reazione il decollo vicino alla soglia del dolore corrisponde a 120 decibel.
Può sorprendere che tutta l'enorme intensità delle vibrazioni sonore rientri in una scala così piccola, ma questa impressione è ingannevole. Questa è una scala logaritmica e ogni passaggio successivo è 10 volte più intenso del precedente. Utilizzando lo stesso principio è stata costruita una scala per valutare l’intensità dei terremoti, con soli 12 punti.
L’uomo è davvero il più intelligente tra gli animali che abitano il pianeta. Tuttavia, la nostra mente spesso ci priva di capacità superiori come la percezione dell'ambiente circostante attraverso l'olfatto, l'udito e altre sensazioni sensoriali.
Pertanto, la maggior parte degli animali è molto più avanti di noi per quanto riguarda la gamma uditiva. La gamma dell'udito umano è la gamma di frequenze che l'orecchio umano può percepire. Proviamo a capire come funziona l'orecchio umano in relazione alla percezione del suono.

Gamma dell'udito umano in condizioni normali
In media, l’orecchio umano è in grado di rilevare e distinguere le onde sonore nell’intervallo compreso tra 20 Hz e 20 kHz (20.000 Hz). Tuttavia, con l'invecchiamento, la gamma uditiva di una persona diminuisce, in particolare diminuisce il suo limite superiore. Nelle persone anziane è solitamente molto più basso che nei giovani, con neonati e bambini che hanno le capacità uditive più elevate. La percezione uditiva delle alte frequenze inizia a deteriorarsi dall'età di otto anni.
Udito umano in condizioni ideali
In laboratorio, il campo uditivo di una persona viene determinato utilizzando un audiometro, che emette onde sonore di frequenze diverse, e cuffie sintonizzate di conseguenza. In tali condizioni ideali, l'orecchio umano può rilevare frequenze che vanno da 12 Hz a 20 kHz.
Gamma uditiva negli uomini e nelle donne
Esiste una differenza significativa tra la gamma uditiva di uomini e donne. È stato riscontrato che le donne sono più sensibili alle alte frequenze rispetto agli uomini. La percezione delle basse frequenze è più o meno allo stesso livello negli uomini e nelle donne.
Varie scale per indicare la portata dell'udito
Sebbene la scala di frequenza sia la scala più comune per misurare la portata dell'udito umano, viene spesso misurata anche in pascal (Pa) e decibel (dB). Tuttavia, la misurazione in pascal è considerata scomoda, poiché questa unità implica lavorare con numeri molto grandi. Un microPascal è la distanza percorsa da un'onda sonora durante la vibrazione, che equivale a un decimo del diametro di un atomo di idrogeno. Le onde sonore percorrono una distanza molto maggiore nell'orecchio umano, rendendo difficile indicare la gamma dell'udito umano in pascal.
Il suono più debole che può essere rilevato dall'orecchio umano è di circa 20 µPa. La scala decibel è più facile da usare perché è una scala logaritmica che fa direttamente riferimento alla scala Pa. Prende 0 dB (20 µPa) come punto di riferimento e poi continua a comprimere questa scala di pressione. Pertanto, 20 milioni di μPa equivalgono a soli 120 dB. Risulta che la gamma dell'orecchio umano è 0-120 dB.
La gamma uditiva varia in modo significativo da persona a persona. Pertanto, per rilevare la perdita dell’udito, è meglio misurare la gamma dei suoni udibili rispetto ad una scala di riferimento, piuttosto che rispetto ad una scala standardizzata convenzionale. Gli esami possono essere eseguiti utilizzando sofisticati strumenti diagnostici dell'udito in grado di determinare con precisione l'entità e diagnosticare le cause della perdita dell'udito.
Dopo aver considerato la teoria della propagazione e i meccanismi attraverso i quali si originano le onde sonore, è utile comprendere come il suono viene “interpretato” o percepito dall’uomo. Un organo accoppiato, l'orecchio, è responsabile della percezione delle onde sonore nel corpo umano. Orecchio umano- un organo molto complesso che è responsabile di due funzioni: 1) percepisce gli impulsi sonori 2) funge da apparato vestibolare dell'intero corpo umano, determina la posizione del corpo nello spazio e fornisce la capacità vitale di mantenere l'equilibrio. L'orecchio umano medio è in grado di rilevare vibrazioni di 20 - 20.000 Hz, ma ci sono deviazioni verso l'alto o verso il basso. Idealmente, la gamma di frequenza udibile è compresa tra 16 e 20.000 Hz, che corrisponde anche a una lunghezza d'onda di 16 m - 20 cm. L'orecchio è diviso in tre componenti: orecchio esterno, medio e interno. Ognuna di queste "divisioni" svolge la propria funzione, ma tutte e tre le divisioni sono strettamente collegate tra loro e in realtà si trasmettono le onde sonore. 
Orecchio esterno (esterno).
L'orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare e dal canale uditivo esterno. Il padiglione auricolare è una cartilagine elastica di forma complessa, ricoperta di pelle. Nella parte inferiore del padiglione auricolare c'è un lobo costituito da tessuto adiposo ed è anch'esso ricoperto di pelle. Il padiglione auricolare funge da ricevitore delle onde sonore provenienti dallo spazio circostante. La speciale forma della struttura del padiglione auricolare consente di catturare meglio i suoni, in particolare i suoni della gamma delle frequenze medie, responsabile della trasmissione delle informazioni vocali. Questo fatto è in gran parte dovuto alla necessità evolutiva, poiché una persona trascorre gran parte della sua vita in comunicazione orale con rappresentanti della sua specie. Il padiglione auricolare umano è praticamente immobile, a differenza di un gran numero di rappresentanti delle specie animali, che utilizzano i movimenti dell'orecchio per sintonizzarsi con maggiore precisione sulla sorgente sonora.
Le pieghe del padiglione auricolare umano sono progettate in modo tale da introdurre correzioni (piccole distorsioni) relative alla posizione verticale e orizzontale della sorgente sonora nello spazio. È grazie a questa caratteristica unica che una persona è in grado di determinare abbastanza chiaramente la posizione di un oggetto nello spazio rispetto a se stessa, guidata solo dal suono. Questa caratteristica è nota anche con il termine "localizzazione del suono". La funzione principale del padiglione auricolare è quella di catturare quanti più suoni possibile nella gamma di frequenze udibili. L'ulteriore destino delle onde sonore "catturate" viene deciso nel condotto uditivo, la cui lunghezza è di 25-30 mm. In esso, la parte cartilaginea del padiglione auricolare esterno passa nell'osso e la superficie cutanea del condotto uditivo è dotata di ghiandole sebacee e solforose. Alla fine del condotto uditivo si trova un timpano elastico, al quale arrivano le vibrazioni delle onde sonore, provocando così le sue vibrazioni di risposta. Il timpano, a sua volta, trasmette le vibrazioni risultanti all'orecchio medio.
Orecchio medio
Le vibrazioni trasmesse dal timpano entrano in un’area dell’orecchio medio chiamata “regione timpanica”. Si tratta di un'area del volume di circa un centimetro cubo in cui si trovano tre ossicini uditivi: martello, incudine e staffa. Sono questi elementi “intermedi” che svolgono la funzione più importante: trasmettere le onde sonore all’orecchio interno e contemporaneamente amplificarle. Gli ossicini uditivi rappresentano una catena estremamente complessa di trasmissione del suono. Tutte e tre le ossa sono strettamente collegate tra loro, così come al timpano, grazie al quale le vibrazioni vengono trasmesse “lungo la catena”. Avvicinandosi all'orecchio interno si trova una finestra del vestibolo, che è bloccata dalla base della staffa. Per equalizzare la pressione su entrambi i lati del timpano (ad esempio, in caso di variazioni della pressione esterna), la zona dell'orecchio medio è collegata al rinofaringe tramite la tromba di Eustachio. Conosciamo tutti l'effetto delle orecchie chiuse, che si verifica proprio a causa di una regolazione così precisa. Dall'orecchio medio le vibrazioni sonore, già amplificate, entrano nella zona dell'orecchio interno, la più complessa e sensibile.

Orecchio interno
La forma più complessa è l'orecchio interno, chiamato per questo motivo labirinto. Il labirinto osseo comprende: vestibolo, coclea e canali semicircolari, nonché l'apparato vestibolare, responsabile dell'equilibrio. La coclea è direttamente correlata all'udito in questo contesto. La coclea è un canale membranoso a forma di spirale riempito di liquido linfatico. All'interno, il canale è diviso in due parti da un'altra partizione membranosa chiamata "membrana principale". Questa membrana è costituita da fibre di varia lunghezza (più di 24.000 in totale), tese come corde, ciascuna corda risuona con il proprio suono specifico. Il canale è diviso da una membrana in scala superiore e inferiore, comunicanti all'apice della coclea. All'estremità opposta, il canale si collega all'apparato recettore dell'analizzatore uditivo, che è ricoperto da minuscole cellule ciliate. Questo apparecchio per l'analisi dell'udito è anche chiamato “Organo di Corti”. Quando le vibrazioni provenienti dall'orecchio medio entrano nella coclea, anche il fluido linfatico che riempie il canale inizia a vibrare, trasmettendo le vibrazioni alla membrana principale. In questo momento entra in azione l'apparato analizzatore uditivo, le cui cellule ciliate, disposte su più file, trasformano le vibrazioni sonore in impulsi elettrici “nervosi”, che vengono trasmessi lungo il nervo uditivo alla zona temporale della corteccia cerebrale. In un modo così complesso e elaborato, una persona alla fine sentirà il suono desiderato.
Caratteristiche della percezione e della formazione del linguaggio
Il meccanismo di formazione del linguaggio si è formato negli esseri umani durante l'intero stadio evolutivo. Il significato di questa capacità è trasmettere informazioni verbali e non verbali. Il primo porta con sé un carico verbale e semantico, il secondo è responsabile della trasmissione della componente emotiva. Il processo di creazione e percezione del discorso comprende: formulazione del messaggio; codifica in elementi secondo le regole della lingua esistente; azioni neuromuscolari transitorie; movimenti delle corde vocali; emissione di un segnale acustico; Successivamente entra in azione l'ascoltatore che effettua: analisi spettrale del segnale acustico ricevuto e selezione delle caratteristiche acustiche nel sistema uditivo periferico, trasmissione delle caratteristiche selezionate tramite reti neurali, riconoscimento del codice della lingua (analisi linguistica), comprensione del significato del messaggio.  L'apparato per la generazione di segnali vocali può essere paragonato a un complesso strumento a fiato, ma la versatilità e flessibilità di configurazione e la capacità di riprodurre le più piccole sottigliezze e dettagli non hanno analoghi in natura. Il meccanismo di formazione della voce è costituito da tre componenti inestricabili:
L'apparato per la generazione di segnali vocali può essere paragonato a un complesso strumento a fiato, ma la versatilità e flessibilità di configurazione e la capacità di riprodurre le più piccole sottigliezze e dettagli non hanno analoghi in natura. Il meccanismo di formazione della voce è costituito da tre componenti inestricabili:
- Generatore- polmoni come serbatoio di volume d'aria. L'energia dell'eccesso di pressione viene immagazzinata nei polmoni, poi attraverso il canale escretore, con l'aiuto del sistema muscolare, questa energia viene eliminata attraverso la trachea collegata alla laringe. In questa fase il flusso d'aria viene interrotto e modificato;
- vibratore- è costituito da corde vocali. Il flusso è influenzato anche da getti d'aria turbolenti (creando toni di bordo) e da sorgenti pulsate (esplosioni);
- Risonatore- comprende cavità risonanti di forma geometrica complessa (faringe, cavità orali e nasali).
La totalità della disposizione individuale di questi elementi forma il timbro unico e individuale della voce di ogni persona individualmente.
L'energia della colonna d'aria viene generata nei polmoni, che creano un certo flusso d'aria durante l'inspirazione e l'espirazione a causa della differenza di pressione atmosferica e intrapolmonare. Il processo di accumulo energetico avviene attraverso l'inspirazione, il processo di rilascio è caratterizzato dall'espirazione. Ciò avviene grazie alla compressione ed espansione del torace, che viene effettuata con l'aiuto di due gruppi muscolari: intercostale e diaframma; con la respirazione profonda e il canto si contraggono anche i muscoli della stampa addominale, del torace e del collo. Quando inspiri, il diaframma si contrae e si abbassa, la contrazione dei muscoli intercostali esterni solleva le costole e le sposta lateralmente e lo sterno in avanti. Un aumento del torace porta ad un calo della pressione all'interno dei polmoni (rispetto alla pressione atmosferica) e questo spazio viene rapidamente riempito d'aria. Quando espiri, i muscoli si rilassano di conseguenza e tutto ritorna al suo stato precedente (il torace ritorna al suo stato originale a causa della sua stessa gravità, il diaframma si alza, il volume dei polmoni precedentemente espansi diminuisce, la pressione intrapolmonare aumenta). L'inalazione può essere descritta come un processo che richiede dispendio energetico (attivo); l'espirazione è un processo di accumulo di energia (passivo). Il controllo del processo di respirazione e formazione del linguaggio avviene inconsciamente, ma quando si canta, il controllo della respirazione richiede un approccio consapevole e un allenamento aggiuntivo a lungo termine.
La quantità di energia che viene successivamente spesa per la formazione della parola e della voce dipende dal volume dell'aria immagazzinata e dalla quantità di pressione aggiuntiva nei polmoni. La pressione massima sviluppata da un cantante d'opera addestrato può raggiungere 100-112 dB. Modulazione del flusso d'aria mediante vibrazione delle corde vocali e creazione di una sovrappressione subfaringea, questi processi avvengono nella laringe, che è una sorta di valvola situata all'estremità della trachea. La valvola svolge una duplice funzione: protegge i polmoni da corpi estranei e mantiene alta la pressione. È la laringe che funge da fonte della parola e del canto. La laringe è un insieme di cartilagini collegate da muscoli. La laringe ha una struttura piuttosto complessa, il cui elemento principale è una coppia di corde vocali. Sono le corde vocali la principale (ma non l'unica) fonte di produzione della voce o "vibratore". Durante questo processo, le corde vocali iniziano a muoversi, accompagnate da attrito. Per proteggersi da ciò, viene secreta una speciale secrezione mucosa che agisce come un lubrificante. La formazione dei suoni del parlato è determinata dalle vibrazioni dei legamenti, che portano alla formazione di un flusso d'aria espirata dai polmoni ad un certo tipo di ampiezza caratteristica. Tra le corde vocali ci sono piccole cavità che fungono da filtri acustici e risonatori quando richiesto.
Caratteristiche della percezione uditiva, sicurezza dell'ascolto, soglie uditive, adattamento, corretto livello del volume
Come si può vedere dalla descrizione della struttura dell'orecchio umano, questo organo è molto delicato e di struttura piuttosto complessa. Tenendo conto di questo fatto, non è difficile determinare che questo dispositivo estremamente delicato e sensibile presenta una serie di limitazioni, soglie, ecc. Il sistema uditivo umano è adattato per percepire suoni silenziosi, nonché suoni di media intensità. L'esposizione prolungata a suoni forti comporta cambiamenti irreversibili delle soglie uditive, così come altri problemi uditivi, inclusa la completa sordità. L'entità del danno è direttamente proporzionale al tempo di esposizione in un ambiente rumoroso. In questo momento entra in vigore anche il meccanismo di adattamento, vale a dire Sotto l'influenza di suoni forti e prolungati, la sensibilità diminuisce gradualmente, il volume percepito diminuisce e l'udito si adatta.
L'adattamento inizialmente cerca di proteggere gli organi uditivi da suoni troppo forti, tuttavia, è l'influenza di questo processo che molto spesso costringe una persona ad aumentare in modo incontrollabile il livello del volume del sistema audio. La protezione è realizzata grazie al lavoro del meccanismo dell'orecchio medio e interno: la staffa viene retratta dalla finestra ovale, proteggendo così dai suoni eccessivamente forti. Ma il meccanismo di protezione non è ideale e ha un ritardo temporale, che si attiva solo 30-40 ms dopo l'inizio dell'arrivo del suono, e la protezione completa non viene raggiunta nemmeno dopo una durata di 150 ms. Il meccanismo di protezione si attiva quando il livello del volume supera gli 85 dB, mentre la protezione stessa arriva fino a 20 dB.  Il più pericoloso, in questo caso, può essere considerato il fenomeno dello “spostamento della soglia uditiva”, che di solito si verifica nella pratica a seguito di un'esposizione prolungata a suoni forti superiori a 90 dB. Il processo di ripristino del sistema uditivo dopo tali effetti dannosi può durare fino a 16 ore. Lo spostamento della soglia inizia già a un livello di intensità di 75 dB e aumenta proporzionalmente all'aumentare del livello del segnale.
Il più pericoloso, in questo caso, può essere considerato il fenomeno dello “spostamento della soglia uditiva”, che di solito si verifica nella pratica a seguito di un'esposizione prolungata a suoni forti superiori a 90 dB. Il processo di ripristino del sistema uditivo dopo tali effetti dannosi può durare fino a 16 ore. Lo spostamento della soglia inizia già a un livello di intensità di 75 dB e aumenta proporzionalmente all'aumentare del livello del segnale.
Quando si considera il problema del corretto livello di intensità del suono, la cosa peggiore da considerare è il fatto che i problemi (acquisiti o congeniti) associati all'udito sono praticamente incurabili nella nostra epoca di medicina abbastanza avanzata. Tutto ciò dovrebbe indurre qualsiasi persona sana di mente a pensare a prendersi cura del proprio udito, a patto, ovviamente, di preservarne l'integrità originaria e la capacità di ascoltare l'intera gamma di frequenze il più a lungo possibile. Fortunatamente, tutto non è così spaventoso come potrebbe sembrare a prima vista e, seguendo una serie di precauzioni, puoi facilmente preservare l'udito anche in età avanzata. Prima di considerare queste misure, è necessario ricordare una caratteristica importante della percezione uditiva umana. L'apparecchio acustico percepisce i suoni in modo non lineare. Questo fenomeno è il seguente: se immaginiamo una frequenza di un tono puro, ad esempio 300 Hz, allora la non linearità appare quando i sovratoni di questa frequenza fondamentale appaiono nel padiglione auricolare secondo il principio logaritmico (se la frequenza fondamentale è considerata f, quindi gli armonici della frequenza saranno 2f, 3f ecc. in ordine crescente). Questa non linearità è anche più facile da comprendere ed è familiare a molti sotto questo nome "distorsioni non lineari". Poiché tali armoniche (sovratoni) non compaiono nel tono puro originale, risulta che l'orecchio stesso apporta le proprie correzioni e sovratoni al suono originale, ma possono essere determinati solo come distorsioni soggettive. A livelli di intensità inferiori a 40 dB non si verifica alcuna distorsione soggettiva. All'aumentare dell'intensità da 40 dB, il livello delle armoniche soggettive inizia ad aumentare, ma anche a livello di 80-90 dB il loro contributo negativo al suono è relativamente piccolo (pertanto, questo livello di intensità può essere considerato condizionatamente una sorta di “ sezione aurea” in campo musicale).
Sulla base di queste informazioni, puoi facilmente determinare un livello di volume sicuro e accettabile che non danneggerà gli organi uditivi e allo stesso tempo consentirà di ascoltare assolutamente tutte le caratteristiche e i dettagli del suono, ad esempio, nel caso di lavorare con un sistema “hi-fi”. Questo livello di "media aurea" è di circa 85-90 dB. È a questa intensità sonora che è possibile sentire tutto ciò che è contenuto nel percorso audio, riducendo al minimo il rischio di danni prematuri e di perdita dell'udito. Un livello di volume di 85 dB può essere considerato quasi completamente sicuro. Per capire quali sono i pericoli dell'ascolto ad alto volume e perché un livello di volume troppo basso non consente di sentire tutte le sfumature del suono, esaminiamo questo problema in modo più dettagliato. Per quanto riguarda i bassi livelli di volume, la mancanza di opportunità (ma più spesso desiderio soggettivo) di ascoltare musica a bassi livelli è dovuta ai seguenti motivi:
- Nonlinearità della percezione uditiva umana;
- Caratteristiche della percezione psicoacustica, che saranno discusse separatamente.
La non linearità della percezione uditiva discussa sopra ha un effetto significativo a qualsiasi volume inferiore a 80 dB. In pratica, assomiglia a questo: se accendi la musica a un livello basso, ad esempio 40 dB, allora si sentirà più chiaramente la gamma delle frequenze medie della composizione musicale, che si tratti della voce dell'esecutore o degli strumenti che suonano in questa gamma. Allo stesso tempo, ci sarà una chiara mancanza di frequenze basse e alte, dovuta proprio alla non linearità della percezione e anche al fatto che frequenze diverse suonano a volumi diversi. È quindi ovvio che per poter percepire pienamente l'insieme dell'immagine, il livello di intensità della frequenza deve essere allineato il più possibile ad un unico valore. Nonostante il fatto che anche a un livello di volume di 85-90 dB non vi sia un'equalizzazione ideale del volume delle diverse frequenze, il livello diventa accettabile per il normale ascolto quotidiano. Più basso è il volume, più chiaramente sarà percepita dall'orecchio la caratteristica non linearità, ovvero la sensazione di assenza della giusta quantità di frequenze alte e basse. Allo stesso tempo, si scopre che con tale non linearità è impossibile parlare seriamente della riproduzione del suono "hi-fi" ad alta fedeltà, perché in questa particolare situazione la precisione dell'immagine sonora originale sarà estremamente bassa.
Se si approfondiscono questi risultati, diventa chiaro perché l'ascolto della musica a un volume basso, sebbene il più sicuro dal punto di vista della salute, è estremamente negativo per l'orecchio a causa della creazione di immagini chiaramente non plausibili di strumenti musicali e voci e la mancanza di scala del palcoscenico. In generale, la riproduzione di musica tranquilla può essere utilizzata come accompagnamento di sottofondo, ma è del tutto controindicato l'ascolto di alta qualità "hi-fi" a basso volume, per i motivi sopra menzionati dell'impossibilità di creare immagini naturalistiche della scena sonora, che è stata formato dal tecnico del suono in studio, in fase di registrazione del suono. Ma non solo il volume basso introduce alcune restrizioni sulla percezione del suono finale; la situazione è molto peggiore con l'aumento del volume. È possibile e abbastanza semplice danneggiare l'udito e ridurre significativamente la sensibilità se si ascolta musica a livelli superiori a 90 dB per lungo tempo. Questi dati si basano su un gran numero di studi medici, che concludono che il suono superiore a 90 dB causa danni reali e quasi irreparabili alla salute. Il meccanismo di questo fenomeno risiede nella percezione uditiva e nelle caratteristiche strutturali dell'orecchio. Quando un'onda sonora con un'intensità superiore a 90 dB entra nel condotto uditivo, entrano in gioco gli organi dell'orecchio medio, provocando un fenomeno chiamato adattamento uditivo.
Il principio di ciò che accade in questo caso è questo: la staffa viene allontanata dalla finestra ovale e protegge l'orecchio interno dai suoni troppo forti. Questo processo si chiama riflesso acustico. All'orecchio questo viene percepito come una diminuzione della sensibilità a breve termine, che può essere familiare a chiunque abbia assistito, ad esempio, a concerti rock nei club. Dopo un tale concerto, si verifica una diminuzione a breve termine della sensibilità, che dopo un certo periodo di tempo viene ripristinata al livello precedente. Tuttavia, il ripristino della sensibilità non avviene sempre e dipende direttamente dall’età. Dietro tutto ciò si nasconde il grande pericolo di ascoltare musica ad alto volume e altri suoni la cui intensità supera i 90 dB. L'insorgenza di un riflesso acustico non è l'unico pericolo “visibile” di perdita della sensibilità uditiva. In caso di esposizione prolungata a suoni troppo forti, i peli situati nella zona dell'orecchio interno (che rispondono alle vibrazioni) diventano molto deviati. In questo caso, si verifica l'effetto che i capelli responsabili della percezione di una certa frequenza vengono deviati sotto l'influenza di vibrazioni sonore di elevata ampiezza. Ad un certo punto, tali capelli potrebbero deviare troppo e non poter tornare indietro. Ciò causerà una corrispondente perdita di sensibilità ad una frequenza specifica!
La cosa peggiore di tutta questa situazione è che le malattie dell'orecchio sono praticamente incurabili, anche con i metodi più moderni conosciuti dalla medicina. Tutto ciò porta ad alcune conclusioni serie: il suono superiore a 90 dB è pericoloso per la salute ed è quasi garantito che causi una perdita prematura dell'udito o una significativa diminuzione della sensibilità. Ciò che è ancora più spiacevole è che la proprietà di adattamento, menzionata in precedenza, entra in gioco nel tempo. Questo processo negli organi uditivi umani avviene in modo quasi impercettibile, ad es. una persona che sta lentamente perdendo sensibilità ha una probabilità prossima al 100% di non accorgersene finché le persone che la circondano non prestano attenzione alle continue domande ripetute, come: "Cosa hai appena detto?" La conclusione alla fine è estremamente semplice: quando si ascolta la musica è di vitale importanza non consentire livelli di intensità sonora superiori a 80-85 dB! C'è anche un lato positivo in questo: il livello del volume di 80-85 dB corrisponde approssimativamente al livello della registrazione musicale in uno studio. È qui che nasce il concetto di “Golden Mean”, al di sopra del quale è meglio non salire se i problemi di salute sono di qualche importanza.
 Anche ascoltare musica per un breve periodo ad un livello di 110-120 dB può causare problemi all'udito, ad esempio durante un concerto dal vivo. Ovviamente a volte è impossibile o molto difficile evitarlo, ma è estremamente importante provare a farlo per mantenere l'integrità della percezione uditiva. Teoricamente, l'esposizione a breve termine a suoni forti (non superiori a 120 dB), anche prima della comparsa dell'“affaticamento uditivo”, non porta a gravi conseguenze negative. Ma in pratica, di solito si verificano casi di esposizione prolungata a suoni di tale intensità. Le persone diventano assordate senza rendersi conto della portata del pericolo in macchina mentre ascoltano un sistema audio, a casa in condizioni simili o nelle cuffie di un lettore portatile. Perché succede questo e cosa costringe il suono a diventare sempre più forte? Ci sono due risposte a questa domanda: 1) L'influenza della psicoacustica, di cui parleremo separatamente; 2) Il bisogno costante di “urlare” alcuni suoni esterni con il volume della musica. Il primo aspetto del problema è piuttosto interessante e verrà discusso in dettaglio più avanti, ma il secondo lato del problema porta più a pensieri e conclusioni negativi su un'errata comprensione dei veri fondamenti del corretto ascolto del suono della classe hi-fi.
Anche ascoltare musica per un breve periodo ad un livello di 110-120 dB può causare problemi all'udito, ad esempio durante un concerto dal vivo. Ovviamente a volte è impossibile o molto difficile evitarlo, ma è estremamente importante provare a farlo per mantenere l'integrità della percezione uditiva. Teoricamente, l'esposizione a breve termine a suoni forti (non superiori a 120 dB), anche prima della comparsa dell'“affaticamento uditivo”, non porta a gravi conseguenze negative. Ma in pratica, di solito si verificano casi di esposizione prolungata a suoni di tale intensità. Le persone diventano assordate senza rendersi conto della portata del pericolo in macchina mentre ascoltano un sistema audio, a casa in condizioni simili o nelle cuffie di un lettore portatile. Perché succede questo e cosa costringe il suono a diventare sempre più forte? Ci sono due risposte a questa domanda: 1) L'influenza della psicoacustica, di cui parleremo separatamente; 2) Il bisogno costante di “urlare” alcuni suoni esterni con il volume della musica. Il primo aspetto del problema è piuttosto interessante e verrà discusso in dettaglio più avanti, ma il secondo lato del problema porta più a pensieri e conclusioni negativi su un'errata comprensione dei veri fondamenti del corretto ascolto del suono della classe hi-fi.
Senza entrare nello specifico, la conclusione generale sull'ascolto della musica e sul volume corretto è la seguente: l'ascolto della musica dovrebbe avvenire a livelli di intensità sonora non superiori a 90 dB, non inferiori a 80 dB in una stanza in cui suoni estranei provenienti dall'esterno fonti (come ad esempio: conversazioni dei vicini e altri rumori dietro il muro dell'appartamento; rumori della strada e rumori tecnici se si è in macchina, ecc.). Vorrei sottolineare una volta per tutte che proprio rispettando requisiti probabilmente così rigorosi è possibile raggiungere il tanto atteso equilibrio di volume, che non causerà danni prematuri e indesiderati agli organi uditivi e porterà anche vero piacere. dall'ascolto delle tue opere musicali preferite con i più piccoli dettagli sonori alle alte e basse frequenze e alla precisione, che è perseguita dal concetto stesso di suono “hi-fi”.
Psicoacustica e caratteristiche della percezione
Per rispondere in modo più completo ad alcune importanti domande riguardanti la percezione umana finale delle informazioni sonore, esiste un intero ramo della scienza che studia un'enorme varietà di tali aspetti. Questa sezione si chiama "psicoacustica". Il fatto è che la percezione uditiva non termina solo con il funzionamento degli organi uditivi. Dopo la percezione diretta del suono da parte dell'organo dell'udito (orecchio), entra in gioco il meccanismo più complesso e poco studiato per analizzare le informazioni ricevute; questo è interamente responsabilità del cervello umano, che è progettato in modo tale che durante il funzionamento genera onde di una certa frequenza, anch'esse indicate in Hertz (Hz). Diverse frequenze delle onde cerebrali corrispondono a determinati stati umani. Pertanto, si scopre che l'ascolto della musica aiuta a cambiare la sintonizzazione della frequenza del cervello, e questo è importante da considerare quando si ascoltano composizioni musicali. Sulla base di questa teoria esiste anche un metodo di terapia del suono che influenza direttamente lo stato mentale di una persona. Esistono cinque tipi di onde cerebrali:
- Onde Delta (onde inferiori a 4 Hz). Corrisponde ad uno stato di sonno profondo senza sogni, mentre vi è completa assenza di sensazioni corporee.
- Onde Theta (onde 4-7 Hz). Stato di sonno o meditazione profonda.
- Onde alfa (onde 7-13 Hz). Stato di rilassamento e rilassamento durante la veglia, sonnolenza.
- Onde beta (onde 13-40 Hz). Stato di attività, pensiero quotidiano e attività mentale, eccitazione e cognizione.
- Onde gamma (onde superiori a 40 Hz). Uno stato di intensa attività mentale, paura, eccitazione e consapevolezza.
La psicoacustica, come branca della scienza, cerca risposte alle domande più interessanti riguardanti la percezione umana finale delle informazioni sonore. Durante lo studio di questo processo, viene rivelato un numero enorme di fattori, la cui influenza si verifica invariabilmente sia nel processo di ascolto della musica, sia in qualsiasi altro caso di elaborazione e analisi di qualsiasi informazione sonora. Uno psicoacustico studia quasi l'intera varietà di possibili influenze, a partire dallo stato emotivo e mentale di una persona al momento dell'ascolto, per finire con le caratteristiche strutturali delle corde vocali (se parliamo delle peculiarità di percepire tutte le sottigliezze di performance vocale) e il meccanismo di conversione del suono in impulsi elettrici del cervello. I fattori più interessanti e soprattutto importanti (che è di vitale importanza tenere in considerazione ogni volta che ascolti le tue composizioni musicali preferite, così come quando costruisci un sistema audio professionale) verranno discussi ulteriormente.
Il concetto di consonanza, consonanza musicale
La struttura del sistema uditivo umano è unica principalmente nel meccanismo di percezione del suono, nella non linearità del sistema uditivo e nella capacità di raggruppare i suoni in base all'altezza con un grado di precisione abbastanza elevato. La caratteristica più interessante della percezione è la non linearità del sistema uditivo, che si manifesta sotto forma di comparsa di armoniche aggiuntive inesistenti (nel tono fondamentale), particolarmente spesso manifestate in persone con tono musicale o assoluto. Se ci fermiamo più in dettaglio e analizziamo tutte le sottigliezze della percezione del suono musicale, allora è possibile distinguere facilmente i concetti di "consonanza" e "dissonanza" di vari accordi e intervalli sonori. Concetto "consonanza"è definito come un suono consonante (dal francese “accordo”), e di conseguenza viceversa, "dissonanza"- suono discordante, discordante. Nonostante la varietà di diverse interpretazioni di questi concetti, le caratteristiche degli intervalli musicali, è più conveniente utilizzare la decodificazione “musicale-psicologica” dei termini: consonanzaè definito e sentito da una persona come un suono piacevole, confortevole, morbido; dissonanza d'altro canto, può essere caratterizzato come un suono che provoca irritazione, ansia e tensione. Tale terminologia è di natura leggermente soggettiva e inoltre, nel corso della storia dello sviluppo della musica, intervalli completamente diversi sono stati presi come “consonanti” e viceversa.
Al giorno d'oggi, questi concetti sono anche difficili da percepire in modo inequivocabile, poiché esistono differenze tra persone con preferenze e gusti musicali diversi e non esiste un concetto di armonia generalmente accettato e concordato. La base psicoacustica per la percezione dei vari intervalli musicali come consonanti o dissonanti dipende direttamente dal concetto di “banda critica”. Banda critica- questa è una certa larghezza di banda all'interno della quale le sensazioni uditive cambiano radicalmente. La larghezza delle bande critiche aumenta proporzionalmente all'aumentare della frequenza. Pertanto la sensazione di consonanze e dissonanze è direttamente correlata alla presenza di bande critiche. L'organo uditivo umano (orecchio), come accennato in precedenza, svolge il ruolo di filtro passa-banda in una certa fase dell'analisi delle onde sonore. Questo ruolo è assegnato alla membrana basilare, sulla quale si trovano 24 bande critiche con ampiezze dipendenti dalla frequenza.
Pertanto, la consonanza e l'incoerenza (consonanza e dissonanza) dipendono direttamente dalla risoluzione del sistema uditivo. Si scopre che se due toni diversi suonano all'unisono o la differenza di frequenza è zero, allora questa è una consonanza perfetta. La stessa consonanza si verifica se la differenza di frequenza è maggiore della banda critica. La dissonanza si verifica solo quando la differenza di frequenza è compresa tra il 5% e il 50% della banda critica. Il massimo grado di dissonanza in un dato segmento è udibile se la differenza è pari a un quarto della larghezza della banda critica. Sulla base di ciò, è facile analizzare qualsiasi registrazione musicale mista e combinazione di strumenti per consonanza o dissonanza del suono. Non è difficile indovinare quale ruolo importante giochino in questo caso l'ingegnere del suono, lo studio di registrazione e gli altri componenti della traccia audio digitale o analogica finale, e tutto questo anche prima di tentare di riprodurla su un apparecchio di riproduzione del suono.
Localizzazione del suono
Il sistema di udito binaurale e localizzazione spaziale aiuta una persona a percepire la pienezza dell'immagine sonora spaziale. Questo meccanismo di percezione è realizzato attraverso due ricevitori uditivi e due canali uditivi. L'informazione sonora che arriva attraverso questi canali viene successivamente elaborata nella parte periferica del sistema uditivo e sottoposta ad analisi spettrotemporale. Inoltre, queste informazioni vengono trasmesse alle parti superiori del cervello, dove viene confrontata la differenza tra i segnali sonori sinistro e destro e si forma un'unica immagine sonora. Questo meccanismo descritto si chiama udito binaurale. Grazie a ciò, una persona ha le seguenti capacità uniche:
 1) localizzazione dei segnali sonori provenienti da una o più fonti, formando così un'immagine spaziale della percezione del campo sonoro
1) localizzazione dei segnali sonori provenienti da una o più fonti, formando così un'immagine spaziale della percezione del campo sonoro
2) separazione dei segnali provenienti da sorgenti diverse
3) evidenziare alcuni segnali sullo sfondo di altri (ad esempio, isolare il parlato e la voce dal rumore o dal suono degli strumenti)
La localizzazione spaziale è facile da osservare con un semplice esempio. In un concerto, con un palco e un certo numero di musicisti su di esso ad una certa distanza l'uno dall'altro, puoi facilmente (se lo desideri, anche chiudendo gli occhi) determinare la direzione di arrivo del segnale sonoro di ciascuno strumento, valutare la profondità e la spazialità del campo sonoro. Allo stesso modo, viene apprezzato un buon sistema hi-fi, capace di “riprodurre” in modo affidabile tali effetti di spazialità e localizzazione, così di fatto “ingannando” il cervello facendogli sentire una piena presenza durante l'esibizione dal vivo del proprio artista preferito. La localizzazione di una sorgente sonora è solitamente determinata da tre fattori principali: tempo, intensità e spettrale. Indipendentemente da questi fattori, esistono numerosi modelli che possono essere utilizzati per comprendere le nozioni di base relative alla localizzazione del suono.
Il maggiore effetto di localizzazione percepito dall'udito umano è nella regione delle frequenze medie. Allo stesso tempo, è quasi impossibile determinare la direzione dei suoni con frequenze superiori a 8000 Hz e inferiori a 150 Hz. Quest'ultimo fatto è particolarmente utilizzato nei sistemi hi-fi e home theater quando si sceglie la posizione del subwoofer (sezione delle basse frequenze), la cui posizione nella stanza, a causa della mancanza di localizzazione delle frequenze inferiori a 150 Hz, è praticamente irrilevante, e l'ascoltatore ha comunque un'immagine olistica della scena sonora. La precisione della localizzazione dipende dalla posizione della sorgente della radiazione delle onde sonore nello spazio. Pertanto, la massima precisione di localizzazione del suono si osserva sul piano orizzontale, raggiungendo un valore di 3°. Sul piano verticale, il sistema uditivo umano è molto peggiore nel determinare la direzione della sorgente; la precisione in questo caso è di 10-15° (a causa della struttura specifica delle orecchie e della geometria complessa). La precisione della localizzazione varia leggermente a seconda dell'angolo degli oggetti che emettono il suono nello spazio rispetto all'ascoltatore e l'effetto finale è influenzato anche dal grado di diffrazione delle onde sonore dalla testa dell'ascoltatore. Va inoltre notato che i segnali a banda larga sono localizzati meglio del rumore a banda stretta.
Molto più interessante è la situazione con la determinazione della profondità del suono direzionale. Ad esempio, una persona può determinare la distanza da un oggetto tramite il suono, tuttavia ciò accade in misura maggiore a causa dei cambiamenti nella pressione sonora nello spazio. Tipicamente, quanto più l'oggetto è lontano dall'ascoltatore, tanto più le onde sonore nello spazio libero vengono attenuate (nella stanza si aggiunge l'influenza delle onde sonore riflesse). Possiamo quindi concludere che la precisione della localizzazione è maggiore in un ambiente chiuso proprio a causa della presenza di riverbero. Le onde riflesse che si verificano in spazi chiusi consentono di creare effetti interessanti come l'espansione del palcoscenico sonoro, l'avvolgimento, ecc. Questi fenomeni sono possibili proprio grazie alla sensibilità della localizzazione tridimensionale del suono. Le principali dipendenze che determinano la localizzazione orizzontale del suono: 1) la differenza nel tempo di arrivo dell'onda sonora nell'orecchio sinistro e destro; 2) differenze di intensità dovute alla diffrazione sulla testa dell'ascoltatore. Per determinare la profondità del suono, sono importanti la differenza nel livello di pressione sonora e la differenza nella composizione spettrale. Anche la localizzazione sul piano verticale dipende fortemente dalla diffrazione nel padiglione auricolare.
La situazione è più complicata con i moderni sistemi audio surround basati sulla tecnologia dolby surround e analoghi. Sembrerebbe che i principi della costruzione dei sistemi home theater regolino chiaramente il metodo per ricreare un'immagine spaziale abbastanza naturalistica del suono 3D con il volume intrinseco e la localizzazione delle fonti virtuali nello spazio. Tuttavia, non tutto è così banale, poiché i meccanismi stessi di percezione e localizzazione di un gran numero di sorgenti sonore di solito non vengono presi in considerazione. La trasformazione del suono da parte degli organi dell'udito comporta il processo di aggiunta di segnali provenienti da fonti diverse che arrivano a orecchie diverse. Inoltre, se la struttura di fase di suoni diversi è più o meno sincrona, tale processo viene percepito dall'orecchio come un suono proveniente da un'unica fonte. Ci sono anche una serie di difficoltà, tra cui le peculiarità del meccanismo di localizzazione, che rende difficile determinare con precisione la direzione della sorgente nello spazio.
Alla luce di quanto sopra, il compito più difficile diventa la separazione dei suoni provenienti da fonti diverse, soprattutto se queste diverse fonti riproducono un segnale di ampiezza e frequenza simile. E questo è esattamente ciò che accade in pratica in qualsiasi moderno sistema audio surround, e anche in un sistema stereo convenzionale. Quando una persona ascolta un gran numero di suoni provenienti da fonti diverse, il primo passo è determinare se ciascun suono specifico appartiene alla fonte che lo crea (raggruppamento per frequenza, altezza, timbro). E solo nella seconda fase l'udito cerca di localizzare la fonte. Successivamente, i suoni in arrivo vengono suddivisi in flussi in base alle caratteristiche spaziali (differenza nel tempo di arrivo dei segnali, differenza nell'ampiezza). In base alle informazioni ricevute si forma un'immagine uditiva più o meno statica e fissa, dalla quale è possibile determinare da dove proviene ogni specifico suono.
È molto conveniente seguire questi processi usando l'esempio di un normale palco, su cui sono fissati i musicisti. Allo stesso tempo, è molto interessante che se il cantante/interprete, occupando inizialmente una certa posizione sul palco, inizia a muoversi dolcemente sul palco in qualsiasi direzione, l'immagine uditiva precedentemente formata non cambierà! La determinazione della direzione del suono emanato dal cantante rimarrà soggettivamente la stessa, come se si trovasse nello stesso punto in cui si trovava prima di muoversi. Solo in caso di un improvviso cambiamento nella posizione dell’esecutore sul palco, l’immagine sonora formata verrà divisa. Oltre ai problemi discussi e alla complessità dei processi di localizzazione dei suoni nello spazio, nel caso dei sistemi audio surround multicanale, il processo di riverbero nell'ambiente di ascolto finale gioca un ruolo piuttosto importante. Questa dipendenza si osserva più chiaramente quando un gran numero di suoni riflessi provengono da tutte le direzioni: la precisione della localizzazione si deteriora in modo significativo. Se la saturazione energetica delle onde riflesse è maggiore (predominante) rispetto ai suoni diretti, il criterio di localizzazione in una stanza del genere diventa estremamente confuso ed è estremamente difficile (se non impossibile) parlare dell'accuratezza della determinazione di tali fonti.
Tuttavia in un ambiente fortemente riverberante avviene teoricamente la localizzazione; nel caso di segnali a banda larga l'udito è guidato dal parametro della differenza di intensità. In questo caso, la direzione viene determinata utilizzando la componente ad alta frequenza dello spettro. In qualsiasi stanza, la precisione della localizzazione dipenderà dal tempo di arrivo dei suoni riflessi dopo i suoni diretti. Se lo spazio tra questi segnali sonori è troppo piccolo, la “legge dell’onda diretta” inizia a lavorare per aiutare il sistema uditivo. L'essenza di questo fenomeno: se i suoni con un breve intervallo di ritardo provengono da direzioni diverse, la localizzazione dell'intero suono avviene in base al primo suono che arriva, ad es. l'orecchio ignora, in una certa misura, il suono riflesso se arriva troppo presto dopo il suono diretto. Un effetto simile si verifica anche quando viene determinata la direzione di arrivo del suono sul piano verticale, ma in questo caso è molto più debole (a causa del fatto che la sensibilità del sistema uditivo alla localizzazione sul piano verticale è notevolmente peggiore).
L'essenza dell'effetto precedenza è molto più profonda ed è di natura psicologica piuttosto che fisiologica. Sono stati condotti numerosi esperimenti, sulla base dei quali è stata stabilita la dipendenza. Questo effetto si verifica principalmente quando il momento in cui si verifica l’eco, la sua ampiezza e direzione coincidono con alcune delle “aspettative” dell’ascoltatore su come l’acustica di una particolare stanza forma l’immagine sonora. Forse la persona ha già avuto esperienze di ascolto in questa stanza o in stanze simili, che predispongono il sistema uditivo al verificarsi dell'effetto di precedenza “atteso”. Per aggirare queste limitazioni inerenti all'udito umano, nel caso di più sorgenti sonore, vengono utilizzati vari trucchi e trucchi, con l'aiuto dei quali alla fine si forma una localizzazione più o meno plausibile di strumenti musicali/altre sorgenti sonore nello spazio. In generale, la riproduzione di immagini sonore stereo e multicanale si basa su un grande inganno e sulla creazione di un'illusione uditiva.
Quando due o più sistemi di altoparlanti (ad esempio 5.1 o 7.1, o anche 9.1) riproducono il suono da punti diversi della stanza, l'ascoltatore sente suoni provenienti da fonti inesistenti o immaginarie, percependo un certo panorama sonoro. La possibilità di questo inganno risiede nelle caratteristiche biologiche del corpo umano. Molto probabilmente, una persona non ha avuto il tempo di adattarsi al riconoscimento di tale inganno a causa del fatto che i principi della riproduzione del suono "artificiale" sono apparsi relativamente di recente.  Ma, sebbene il processo di creazione di una localizzazione immaginaria si sia rivelato possibile, l'implementazione è ancora lungi dall'essere perfetta. Il fatto è che l'orecchio percepisce davvero una sorgente sonora dove in realtà non esiste, ma la correttezza e l'accuratezza della trasmissione delle informazioni sonore (in particolare il timbro) è una grande domanda. Attraverso numerosi esperimenti in camere riverberanti reali e in camere anecoiche, si è stabilito che il timbro delle onde sonore provenienti da sorgenti reali e immaginarie è diverso. Ciò influisce principalmente sulla percezione soggettiva dell'intensità spettrale; il timbro in questo caso cambia in modo significativo ed evidente (se confrontato con un suono simile riprodotto da una sorgente reale).
Ma, sebbene il processo di creazione di una localizzazione immaginaria si sia rivelato possibile, l'implementazione è ancora lungi dall'essere perfetta. Il fatto è che l'orecchio percepisce davvero una sorgente sonora dove in realtà non esiste, ma la correttezza e l'accuratezza della trasmissione delle informazioni sonore (in particolare il timbro) è una grande domanda. Attraverso numerosi esperimenti in camere riverberanti reali e in camere anecoiche, si è stabilito che il timbro delle onde sonore provenienti da sorgenti reali e immaginarie è diverso. Ciò influisce principalmente sulla percezione soggettiva dell'intensità spettrale; il timbro in questo caso cambia in modo significativo ed evidente (se confrontato con un suono simile riprodotto da una sorgente reale).
Nel caso dei sistemi home theater multicanale, il livello di distorsione è notevolmente più elevato per diversi motivi: 1) Molti segnali sonori simili in ampiezza, frequenza e caratteristiche di fase arrivano simultaneamente da diverse sorgenti e direzioni (comprese le onde riflesse) a ciascun orecchio canale. Ciò porta ad una maggiore distorsione e alla comparsa del filtraggio a pettine. 2) Una forte separazione degli altoparlanti nello spazio (relativi tra loro; nei sistemi multicanale questa distanza può essere di diversi metri o più) contribuisce alla crescita delle distorsioni timbriche e della colorazione del suono nell'area della sorgente immaginaria. Di conseguenza, possiamo dire che la colorazione timbrica nei sistemi audio multicanale e surround in pratica si verifica per due ragioni: il fenomeno del filtraggio a pettine e l'influenza dei processi di riverbero in una particolare stanza. Se più sorgenti sono responsabili della riproduzione delle informazioni sonore (questo vale anche per un impianto stereo con due sorgenti), è inevitabile la comparsa di un effetto di “filtro a pettine”, causato dai diversi tempi di arrivo delle onde sonore su ciascun canale uditivo . Particolari irregolarità si osservano nella gamma medio-alta di 1-4 kHz.
Il nostro organo uditivo è molto sensibile. Con un udito normale siamo in grado di distinguere i suoni che causano vibrazioni trascurabili (calcolate in frazioni di micron) del timpano.
La sensibilità dell'analizzatore uditivo ai suoni di diverse altezze non è la stessa. L'orecchio umano è più sensibile ai suoni con frequenze di vibrazione comprese tra 1000 e 3000. Quando la frequenza di vibrazione diminuisce o aumenta, la sensibilità diminuisce. Un calo di sensibilità particolarmente netto si osserva nella regione dei suoni più bassi e più alti.
Con l’età, la sensibilità uditiva cambia. La massima acuità uditiva si osserva tra i 15 ei 20 anni, per poi diminuire gradualmente. La zona di massima sensibilità fino a 40 anni è nella regione dei 3000 Hz, dai 40 ai 60 anni nella regione dei 2000 Hz e oltre i 60 anni nella regione dei 1000 Hz.
Si chiama intensità sonora minima capace di provocare la sensazione di un suono appena udibile soglia dell'udito, O soglia uditiva. Quanto minore è la quantità di energia sonora necessaria per ottenere la sensazione di un suono appena udibile, cioè quanto più bassa è la soglia della sensazione uditiva, tanto maggiore è la sensibilità dell'orecchio a un dato suono. Da quanto sopra ne consegue che nella regione delle frequenze medie (da 1000 a 3000 Hz) le soglie della percezione uditiva sono le più basse, e nella regione delle frequenze basse e alte le soglie aumentano.
Con l'udito normale, la soglia della sensazione uditiva è 0 dB. Va ricordato che zero decibel non significa assenza di suono (non “suono zero”), ma livello zero, cioè livello di riferimento quando si misura l'intensità dei suoni percepiti, e corrisponde alla soglia di intensità per l'udito normale.
All'aumentare dell'intensità del suono, aumenta la sensazione del volume del suono, ma quando l'intensità del suono raggiunge un certo valore, l'aumento del volume si ferma e nell'orecchio appare una sensazione di pressione o addirittura di dolore. L'intensità del suono alla quale si verifica una sensazione di pressione o dolore è chiamata soglia sensazione spiacevole (soglia del dolore), soglia del disagio.
La distanza tra la soglia della sensazione uditiva e la soglia del disagio è massima nella regione delle medie frequenze (1000-3000 Hz) e qui raggiunge i 130 dB, cioè il rapporto tra la massima forza sonora sopportabile dall'orecchio e la la forza minima percepita è 10 13, o 10.000.000.000 000 (dieci trilioni).
Questa capacità dell'analizzatore uditivo è davvero sorprendente. È impossibile trovare un esempio nella tecnologia in cui lo stesso dispositivo possa registrare impatti, la cui entità differirebbe di tali cifre astronomiche. Se fosse possibile costruire una bilancia con lo stesso range di sensibilità dell’orecchio umano, questa bilancia potrebbe pesare pesi da 1 milligrammo a 10.000 tonnellate.
La sensibilità dell'analizzatore uditivo è caratterizzata non solo dall'entità della soglia di percezione, ma anche dall'entità differenza, O soglia differenziale. La soglia della differenza di frequenza è l'aumento minimo, appena percettibile all'orecchio, della frequenza del suono rispetto alla frequenza originale.
Le soglie di differenza sono le più piccole nell'intervallo da 500 a 5000 Hz e qui sono espresse come 0,003. Ciò significa che un cambiamento, ad esempio, nella frequenza di 1000 Hz di 3 Hz viene già percepito dall'orecchio umano come un suono diverso.
La soglia differenziale dell'intensità del suono è l'aumento minimo dell'intensità del suono, che dà un aumento appena percettibile del volume del suono originale. Le soglie di differenza dell'intensità del suono sono in media 0,1-0,12, cioè, affinché il suono venga percepito più forte, deve essere amplificato di 0,1 del valore originale, ovvero di 1 dB.
Così, area della percezione uditiva in una persona con udito normale è limitato in frequenza e intensità del suono. In termini di frequenza, questa regione copre l'intervallo da 16 a 25.000 Hz (gamma di frequenza dell'udito) e in intensità - fino a 130 dB (gamma dinamica dell'udito).
È generalmente accettato che la regione del parlato, cioè la frequenza e la gamma dinamica necessarie per la percezione dei suoni del parlato, occupi solo una piccola parte dell'intera regione della percezione uditiva, vale a dire in frequenza da 500 a 600 Hz e in intensità da 50 a 90 dB sopra la soglia udibile. Una tale limitazione dell'area del parlato in termini di frequenza e intensità può, tuttavia, essere accettata solo in modo molto condizionato, poiché risulta valida solo in relazione all'area dei suoni percepiti che è più importante per la comprensione del parlato, ma non copre tutti i suoni che compongono il discorso.
In effetti, un certo numero di suoni del parlato, come le consonanti Con, H, sì, contiene formanti che si trovano significativamente al di sopra di 3000 Hz, vale a dire fino a 8600 Hz. Per quanto riguarda la gamma dinamica, bisogna tenere presente che il livello di intensità di un sussurro silenzioso corrisponde a 10-15 dB, e nel parlato ad alta voce ci sono componenti la cui intensità non supera il livello del normale parlato sussurrato, cioè 25 dB. Questi includono, ad esempio, alcune consonanti sorde. Di conseguenza, per la piena discriminazione uditiva di tutti i suoni del parlato, è necessaria la conservazione dell'intera o quasi tutta l'area della percezione uditiva, sia in termini di frequenza che di intensità del suono.
La Figura 17 mostra la gamma di suoni percepiti dall'orecchio umano normale. La curva superiore rappresenta la soglia dei suoni uditivi di varie frequenze, la curva inferiore - la soglia delle sensazioni spiacevoli. Tra queste curve si trova l'area della percezione uditiva, cioè l'intera gamma di suoni udibili dall'uomo. Le parti ombreggiate del diagramma coprono l'area dei suoni più frequenti nella musica e nel parlato.
Adattamento uditivo e affaticamento uditivo. Trauma sonoro. Quando esposto a stimoli sonori, si verifica una temporanea diminuzione della sensibilità dell'organo uditivo. Quindi, ad esempio, uscendo in una strada rumorosa, una persona con un udito normale percepisce il rumore della strada come molto forte, corrispondente alla sua intensità effettiva. Tuttavia, dopo un po' di tempo, il rumore della strada viene percepito come meno forte, anche se in realtà l'intensità del rumore non cambia. Questa diminuzione della sensazione di volume è una conseguenza di una diminuzione della sensibilità dell'analizzatore uditivo a seguito dell'esposizione a un forte stimolo sonoro. Dopo la cessazione dell'esposizione al rumore, quando, ad esempio, una persona entra in una stanza tranquilla da una strada rumorosa, la sensibilità dell'organo uditivo viene rapidamente ripristinata e quando esce di nuovo la persona percepirà nuovamente il rumore della strada come molto forte. Questa diminuzione temporanea della sensibilità viene chiamata adattamento(dal latino adattare - adattare). L'adattamento è una reazione protettiva-adattativa del corpo che protegge gli elementi nervosi dell'analizzatore uditivo dall'esaurimento sotto l'influenza di un forte stimolo. La diminuzione della sensibilità uditiva durante l'adattamento è di brevissima durata. Dopo la cessazione della stimolazione sonora, la sensibilità dell'organo uditivo viene ripristinata entro pochi secondi.
Un cambiamento nella sensibilità durante il processo di adattamento avviene sia nell'estremità periferica che in quella centrale dell'analizzatore uditivo. Ciò è evidenziato dal fatto che quando il suono viene applicato a un orecchio, la sensibilità cambia in entrambe le orecchie.
Con un'irritazione intensa e prolungata (ad esempio diverse ore) dell'analizzatore uditivo, si verifica un affaticamento uditivo. È caratterizzato da una significativa diminuzione della sensibilità uditiva, che viene ripristinata solo dopo un riposo più o meno lungo. Se durante l'adattamento la sensibilità viene ripristinata entro pochi secondi, per ripristinare la sensibilità quando l'analizzatore uditivo si stanca è necessario un tempo misurato in ore e talvolta in giorni. Con una sovrastimolazione frequente e prolungata (per diversi mesi o anni) dell'analizzatore uditivo, possono verificarsi cambiamenti patologici irreversibili che portano a danni permanenti all'udito (danni da rumore all'organo uditivo).
Con una potenza sonora molto elevata, può verificarsi anche con un'esposizione a breve termine trauma sonoro, a volte accompagnato da una violazione della struttura anatomica dell'orecchio medio e interno.
Mascheramento del suono. Se un suono viene percepito sullo sfondo di un altro suono, il primo suono viene sentito meno forte che nel silenzio: è, per così dire, soffocato dall'altro suono.
Ad esempio, in un'officina rumorosa o su un treno della metropolitana, si osserva un significativo deterioramento della percezione del parlato e alcuni suoni deboli in un ambiente con rumore di fondo non vengono affatto percepiti.
Questo fenomeno si chiama mascherando il suono. Per suoni di altezze diverse, il mascheramento viene espresso in modo diverso. I suoni alti sono fortemente mascherati dai suoni bassi e, al contrario, hanno un effetto di mascheramento molto piccolo sui suoni bassi. L'effetto di mascheramento dei suoni vicini nell'altezza al suono mascherato è più pronunciato. In pratica, spesso si ha a che fare con l'effetto di mascheramento di vari rumori. Ad esempio, il rumore di una strada cittadina ha un effetto smorzante (mascherante), raggiungendo i 50-60 dB durante il giorno.
Binaurale udito. La presenza di due orecchie determina la capacità di determinare la direzione della sorgente sonora. Questa capacità si chiama binaurale(a due orecchie) udito, O ototopici(dal greco otos - orecchio e topos - luogo).
Per spiegare questa proprietà dell'analizzatore uditivo sono state fatte tre proposizioni: 1) l'orecchio situato più vicino alla sorgente sonora percepisce il suono con maggiore forza rispetto a quello opposto; 2) l'orecchio situato più vicino alla sorgente sonora lo percepisce un po' prima; 3) le vibrazioni sonore raggiungono entrambe le orecchie in fasi diverse. Apparentemente la capacità di distinguere la direzione del suono è dovuta all'azione combinata di tutti e tre i fattori.
Per determinare con precisione la direzione di una sorgente sonora, è necessario che l'udito in entrambe le orecchie sia lo stesso. L'udito può essere ridotto, ma con una diminuzione uguale in entrambe le orecchie. Se si sente il suono, la sua direzione verrà determinata correttamente. Va notato che anche con l'udito asimmetrico in entrambe le orecchie e anche con la sordità completa in un orecchio, una certa capacità di determinare la direzione di una sorgente sonora può essere sviluppata attraverso un addestramento speciale.
L'analizzatore uditivo ha la capacità non solo di distinguere la direzione del suono, ma anche di determinare la posizione della sua sorgente, cioè di stimare la distanza alla quale si trova la sorgente sonora. L'udito binaurale consente anche di percepire complessi sonori complessi, quando il suono proviene simultaneamente da direzioni diverse, e allo stesso tempo di determinare la posizione delle sorgenti sonore nello spazio (stereofonia).
Le fasi principali dello sviluppo della funzione uditiva in un bambino
L'analizzatore uditivo umano inizia a funzionare dal momento della sua nascita. Quando esposti a suoni di volume sufficiente nei neonati, si possono osservare risposte che si verificano in base al tipo di riflessi incondizionati e si manifestano sotto forma di cambiamenti nella respirazione e nel polso, movimenti di suzione ritardati, ecc. Alla fine del primo e all'inizio dei secondi mesi di vita, il bambino forma già riflessi condizionati agli stimoli sonori. Rafforzando ripetutamente un segnale sonoro (ad esempio il suono di una campana) con l'alimentazione, è possibile sviluppare in un bambino del genere una reazione condizionata sotto forma di movimenti di suzione in risposta alla stimolazione sonora. Molto presto (nel terzo mese) il bambino inizia a distinguere i suoni in base alla loro qualità (timbro, altezza). Secondo gli ultimi studi, la discriminazione primaria dei suoni che differiscono nettamente l'uno dall'altro nel carattere (ad esempio, rumori e colpi da toni musicali, nonché la discriminazione dei toni all'interno di ottave adiacenti) può essere osservata anche nei neonati. Secondo gli stessi dati, i neonati hanno anche la capacità di determinare la direzione del suono.
Nel periodo successivo, la capacità di differenziare i suoni si sviluppa ulteriormente e si estende alla voce e agli elementi del discorso. Il bambino inizia a reagire in modo diverso alle diverse intonazioni e alle diverse parole, ma all'inizio queste ultime non vengono percepite da lui in modo sufficientemente dettagliato. Durante il secondo e il terzo anno di vita, in connessione con la formazione della parola nel bambino, si verifica un ulteriore sviluppo della sua funzione uditiva, caratterizzato da un graduale affinamento della percezione della composizione sonora della parola. Alla fine del primo anno, il bambino di solito distingue parole e frasi principalmente in base al contorno ritmico e al colore dell'intonazione, e entro la fine del secondo e l'inizio del terzo anno ha già la capacità di distinguere a orecchio tutti i suoni del parlato . Allo stesso tempo, lo sviluppo della percezione uditiva differenziata dei suoni del parlato avviene in stretta interazione con lo sviluppo del lato pronuncia del discorso. Questa interazione è bidirezionale. Da un lato, la differenziazione della pronuncia dipende dallo stato della funzione uditiva e, dall'altro, la capacità di pronunciare l'uno o l'altro suono del parlato rende più facile per il bambino distinguerlo a orecchio. Va notato, tuttavia, che normalmente lo sviluppo della differenziazione uditiva precede l'affinamento delle capacità di pronuncia. Questa circostanza si riflette nel fatto che i bambini di 2-3 anni, pur distinguendo completamente a orecchio la struttura sonora delle parole, non riescono nemmeno a riprodurla in modo riflesso. Se inviti un bambino del genere a ripetere, ad esempio, la parola matita, lo riprodurrà come “kalandas”, ma non appena un adulto dirà “kalandas” al posto della matita, il bambino riconoscerà immediatamente la falsità nella pronuncia dell’adulto.
Una persona percepisce il suono attraverso l'orecchio (Fig.).
C'è un lavandino situato all'esterno orecchio esterno , passando nel canale uditivo con un diametro D 1 = 5 mm e lunghezza 3 cm.
Poi c'è il timpano, che vibra sotto l'influenza di un'onda sonora (risuona). La membrana è attaccata alle ossa orecchio medio , trasmettendo la vibrazione ad un'altra membrana e successivamente all'orecchio interno.
Orecchio interno sembra un tubo attorcigliato ("lumaca") con liquido. Il diametro di questo tubo D 2 = 0,2 mm lunghezza 3 – 4 cm lungo.
Poiché le vibrazioni dell'aria in un'onda sonora sono deboli per eccitare direttamente il fluido nella coclea, il sistema dell'orecchio medio e interno, insieme alle loro membrane, svolge il ruolo di un amplificatore idraulico. L'area del timpano dell'orecchio interno è più piccola dell'area della membrana dell'orecchio medio. La pressione esercitata dal suono sui timpani è inversamente proporzionale alla superficie:
 .
.
Pertanto, la pressione sull'orecchio interno aumenta in modo significativo:
 .
.
Nell'orecchio interno, un'altra membrana (longitudinale) è tesa per tutta la sua lunghezza, dura all'inizio dell'orecchio e morbida alla fine. Ciascuna sezione di questa membrana longitudinale può vibrare alla propria frequenza. Nella sezione dura vengono eccitate le oscillazioni ad alta frequenza e nella sezione morbida vengono eccitate le oscillazioni a bassa frequenza. Lungo questa membrana si trova il nervo vestibolococleare, che rileva le vibrazioni e le trasmette al cervello.
Frequenza di vibrazione più bassa di una sorgente sonora 16-20 Hz viene percepito dall'orecchio come un suono basso e basso. Regione massima sensibilità uditiva cattura parte delle frequenze medie e parte delle sottogamme delle frequenze alte e corrisponde alla gamma di frequenze da 500 Hz Prima 4-5 chilocicli . La voce umana e i suoni prodotti dalla maggior parte dei processi naturali per noi importanti hanno una frequenza nello stesso intervallo. In questo caso, suoni con frequenze che vanno da 2kHz Prima 5kHz sentito dall'orecchio come un suono squillante o sibilante. In altre parole, le informazioni più importanti vengono trasmesse a frequenze audio fino a circa 4-5 chilocicli.
Inconsciamente, una persona divide i suoni in "positivo", "negativo" e "neutro".
I suoni negativi includono suoni che prima erano sconosciuti, strani e inspiegabili. Causano paura e ansia. Questi includono anche suoni a bassa frequenza, ad esempio il suono basso di un tamburo o l'ululato di un lupo, poiché suscitano paura. Inoltre, la paura e l'orrore vengono suscitati da suoni a bassa frequenza non udibili (infrasuoni). Esempi:
Negli anni '30 del XX secolo, un'enorme canna d'organo veniva utilizzata come effetto scenico in uno dei teatri di Londra. Gli infrasuoni di questo tubo fecero tremare l'intero edificio e il terrore si insinuò nella gente.
I dipendenti del Laboratorio Nazionale di Fisica in Inghilterra hanno condotto un esperimento aggiungendo frequenze ultrabasse (infrasuoni) al suono degli strumenti acustici convenzionali della musica classica. Gli ascoltatori hanno avvertito un calo dell'umore e hanno provato un sentimento di paura.
Presso il Dipartimento di Acustica dell'Università Statale di Mosca sono stati condotti studi sull'influenza della musica rock e pop sul corpo umano. Si è scoperto che la frequenza del ritmo principale della composizione "Deep People" provoca eccitazione incontrollabile, perdita di controllo su se stessi, aggressività verso gli altri o emozioni negative verso se stessi. La canzone "The Beatles", a prima vista euforica, si è rivelata dannosa e persino pericolosa, perché ha un ritmo di base di circa 6,4 Hz. Questa frequenza risuona con le frequenze del torace, della cavità addominale ed è vicina alla frequenza naturale del cervello (7 Hz.). Pertanto, ascoltando questa composizione, i tessuti dell'addome e del torace iniziano a far male e gradualmente crollano.
Gli infrasuoni provocano vibrazioni in vari sistemi del corpo umano, in particolare nel sistema cardiovascolare. Ciò ha effetti negativi e può portare, ad esempio, all’ipertensione. Le oscillazioni alla frequenza di 12 Hz possono, se la loro intensità supera una soglia critica, causare la morte di organismi superiori, compreso l'uomo. Questa e altre frequenze infrasuoni sono presenti nel rumore industriale, nel rumore autostradale e in altre fonti.
Commento: Negli animali, la risonanza delle frequenze musicali e delle frequenze naturali può portare alla rottura delle funzioni cerebrali. Quando suona "metal rock", le mucche smettono di dare il latte, ma i maiali, al contrario, adorano il metal rock.
I suoni di un ruscello, la marea o il canto degli uccelli sono positivi; inducono la calma.
Inoltre, il rock non è sempre cattivo. Ad esempio, la musica country suonata con il banjo aiuta a riprendersi, sebbene abbia un effetto negativo sulla salute proprio all'inizio della malattia.
I suoni positivi includono melodie classiche. Ad esempio, gli scienziati americani hanno messo i neonati prematuri in scatole per ascoltare la musica di Bach e Mozart, e i bambini si sono ripresi rapidamente e hanno guadagnato peso.
Il suono delle campane ha un effetto benefico sulla salute umana.
Qualsiasi effetto sonoro viene potenziato al crepuscolo e nell'oscurità, poiché la percentuale di informazioni ricevute attraverso la vista diminuisce
Assorbimento acustico nell'aria e nelle superfici circostanti
Assorbimento del suono nell'aria
In ogni momento e in qualsiasi punto della stanza, l'intensità del suono è uguale alla somma dell'intensità del suono diretto proveniente direttamente dalla sorgente e dell'intensità del suono riflesso dalle superfici circostanti della stanza:

Quando il suono si propaga nell'aria atmosferica e in qualsiasi altro mezzo, si verificano perdite di intensità. Queste perdite sono dovute all'assorbimento dell'energia sonora nell'aria e nelle superfici circostanti. Consideriamo l'assorbimento acustico utilizzando teoria delle onde .
Assorbimento il suono è il fenomeno della trasformazione irreversibile dell'energia di un'onda sonora in un altro tipo di energia, principalmente nell'energia del movimento termico delle particelle del mezzo. L'assorbimento acustico avviene sia nell'aria che quando il suono viene riflesso dalle superfici circostanti.
Assorbimento del suono nell'aria accompagnato da una diminuzione della pressione sonora. Lascia che il suono viaggi lungo la direzione R dalla fonte. Poi a seconda della distanza R rispetto alla sorgente sonora, l'ampiezza della pressione sonora diminuisce secondo legge esponenziale :
 ,
(63)
,
(63)
Dove P 0 – pressione sonora iniziale a R = 0
 ,
,
– coefficiente di assorbimento suono. La formula (63) esprime legge dell'assorbimento acustico .
Significato fisico coefficiente è che il coefficiente di assorbimento è numericamente uguale al reciproco della distanza alla quale diminuisce la pressione sonora e = 2,71 una volta:
Unità SI:
 .
.
Poiché la forza del suono (intensità) è proporzionale al quadrato della pressione sonora, allora è la stessa cosa legge dell'assorbimento acustico può essere scritto come:
 ,
(63*)
,
(63*)
Dove IO 0 – potenza del suono (intensità) vicino alla sorgente sonora, cioè a R = 0 :
 .
.
Grafici delle dipendenze P suono (R) E IO(R) sono presentati in Fig. 16.

Dalla formula (63*) segue che per il livello di intensità sonora vale l'equazione:
 .
.
 .
(64)
.
(64)
Pertanto, l’unità SI del coefficiente di assorbimento è: neper al metro
 ,
,
Inoltre, può essere calcolato in belah al metro (b/m) O decibel al metro (dB/m).
Commento: L'assorbimento acustico può essere caratterizzato fattore di perdita , che è uguale
 ,
(65)
,
(65)
Dove – lunghezza d'onda del suono, prodotto – l coefficiente di attenuazione ogaritmica suono. Un valore pari al reciproco del coefficiente di perdita
 ,
,
chiamato fattore di qualità .
Non esiste ancora una teoria completa sull’assorbimento acustico nell’aria (atmosfera). Numerose stime empiriche danno valori diversi per il coefficiente di assorbimento.
La prima teoria (classica) dell'assorbimento acustico è stata creata da Stokes e si basa sulla presa in considerazione dell'influenza della viscosità (attrito interno tra gli strati di un mezzo) e della conduttività termica (equalizzazione della temperatura tra gli strati di un mezzo). Semplificato Formula di Stokes ha la forma:
 ,
(66)
,
(66)
Dove – viscosità dell'aria, – Rapporto di Poisson, 0 – densità dell'aria a 0 0 C, – velocità del suono nell'aria. Per condizioni normali, questa formula assumerà la forma:
 .
(66*)
.
(66*)
Tuttavia, la formula di Stokes (63) o (63*) è valida solo per monoatomico gas i cui atomi hanno tre gradi di libertà traslazionali, cioè quando =1,67 .
Per gas di 2, 3 o molecole poliatomiche Senso significativamente di più, poiché il suono eccita i gradi di libertà rotazionali e vibrazionali delle molecole. Per tali gas (compresa l'aria), la formula è più accurata
 ,
(67)
,
(67)
Dove T N = 273,15 mila – temperatura assoluta di scioglimento del ghiaccio (punto triplo), P N = 1,013 . 10 5 Papà - pressione atmosferica normale, T E P– temperatura reale (misurata) e pressione atmosferica, =1,33 per i gas biatomici, =1,33 per gas tri- e poliatomici.
Assorbimento acustico racchiudendo le superfici
Assorbimento acustico racchiudendo le superfici si verifica quando il suono viene riflesso da essi. In questo caso, una parte dell'energia dell'onda sonora viene riflessa e provoca la comparsa di onde sonore stazionarie, mentre l'altra energia viene convertita nell'energia del movimento termico delle particelle dell'ostacolo. Questi processi sono caratterizzati dal coefficiente di riflessione e dal coefficiente di assorbimento della struttura che li racchiude.
Coefficiente di riflessione il suono proveniente da un ostacolo è quantità adimensionale pari al rapporto tra la parte dell'energia delle ondeW negativo , riflessa dall'ostacolo, all'intera energia dell'ondaW tampone cadere su un ostacolo
 .
.
L'assorbimento acustico da parte di un ostacolo è caratterizzato da coefficiente di assorbimento – quantità adimensionale pari al rapporto tra la parte dell'energia delle ondeW assorbente inghiottito da un ostacolo(e trasformata nell’energia interna della sostanza barriera), a tutta l'energia delle ondeW tampone cadere su un ostacolo
 .
.
Coefficiente di assorbimento medio il suono di tutte le superfici circostanti è uguale
 ,
,
 ,
(68*)
,
(68*)
Dove io – coefficiente di assorbimento acustico del materiale io l'ostacolo, S i – area io gli ostacoli, S– area totale degli ostacoli, N- numero di ostacoli diversi.
Da questa espressione possiamo concludere che il coefficiente di assorbimento medio corrisponde ad un unico materiale che potrebbe rivestire tutte le superfici delle barriere della stanza mantenendo assorbimento acustico totale (UN ), pari
 .
(69)
.
(69)
Significato fisico dell'assorbimento acustico totale (A): è numericamente pari al coefficiente di assorbimento acustico di un'apertura aperta con superficie di 1 m2.
 .
.
Si chiama l'unità di assorbimento acustico sabino:
 .
.