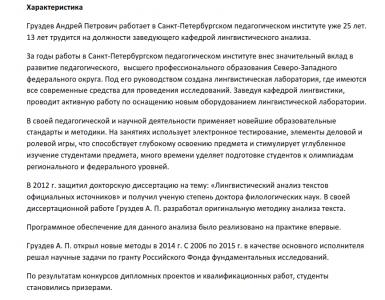Termini di guarigione delle ferite per seconda intenzione. Ferite nello studio dentistico. Tipi classici di guarigione delle ferite. Cause di compromissione della guarigione delle ferite
La guarigione secondaria della ferita è un processo anatomico complesso che comporta la formazione di nuovo tessuto connettivo attraverso la suppurazione preliminare. Il risultato della guarigione di una tale ferita sarà una cicatrice sgradevole di colore contrastante. Ma poco dipende dai medici: se una persona viene ferita in un certo modo, la seconda intenzione non può essere evitata.
Perché la ferita impiega così tanto tempo a guarire?
Le stesse ferite possono guarire in modo diverso in tutte le persone: variano sia la durata della guarigione che il processo stesso. E se una persona ha problemi con questo (la ferita peggiora, sanguina, prude), si possono trovare diverse spiegazioni per questo.
Infezione
I problemi con la guarigione delle superfici della ferita possono essere spiegati dalla loro infezione, che si verifica immediatamente dopo l'infortunio o dopo qualche tempo. Ad esempio, se non si seguono le norme igieniche nella fase di medicazione o pulizia di una ferita, possono penetrarvi microrganismi dannosi.
Se una ferita è infetta o meno può essere determinata dalla temperatura corporea elevata, dal rossore della pelle e dal gonfiore intorno all'area danneggiata. Quando si preme sul tumore, si verifica un forte dolore. Ciò indica la presenza di pus, che provoca intossicazione del corpo, causando sintomi generali.
Diabete
 I diabetici hanno difficoltà a guarire anche i graffi leggeri e qualsiasi danno porta facilmente allo sviluppo di un'infezione purulenta. Ciò si spiega con il fatto che nel diabete mellito la coagulazione del sangue è solitamente aumentata, cioè è troppo spesso.
I diabetici hanno difficoltà a guarire anche i graffi leggeri e qualsiasi danno porta facilmente allo sviluppo di un'infezione purulenta. Ciò si spiega con il fatto che nel diabete mellito la coagulazione del sangue è solitamente aumentata, cioè è troppo spesso.
Per questo motivo, la circolazione sanguigna viene interrotta e alcune cellule del sangue ed elementi che potrebbero contribuire alla guarigione della ferita semplicemente non raggiungono la ferita.
I danni alle gambe guariscono particolarmente male nei diabetici. Un piccolo graffio si trasforma spesso in ulcera trofica e cancrena. Ciò si spiega con il gonfiore delle gambe, perché a causa della grande quantità di acqua nel sangue è ancora più difficile “arrivare” nelle zone danneggiate.
Età anziana
Si osserva una guarigione problematica delle ferite anche nelle persone anziane. Spesso soffrono di malattie del cuore e dei vasi sanguigni, che provocano anche disfunzioni del sangue. Ma anche se una persona anziana è relativamente sana, tutti gli organi sono ancora usurati, quindi il processo di circolazione sanguigna rallenta e le ferite impiegano molto tempo per guarire.
Immunità debole
Anche le ferite guariscono male nei pazienti indeboliti. L'immunità indebolita può essere causata da una mancanza di vitamine o da malattie concomitanti. Spesso questi due fattori vengono combinati. Le malattie che influenzano il deterioramento della guarigione delle ferite includono l'HIV, l'oncologia, l'obesità, l'anoressia e varie malattie del sangue.
Meccanismo di guarigione delle ferite secondarie
La guarigione primaria, in termini semplici, è l'unione delle estremità della ferita e la loro fusione. Ciò è possibile con tagli o semplici penetrazioni chirurgiche, quando non c'è spazio libero all'interno della ferita. La guarigione primaria procede più velocemente e non lascia tracce. Questo è un processo anatomico naturale associato al riassorbimento delle cellule morte e alla formazione di nuove.
 Se il danno è più grave (un pezzo di carne viene strappato), i bordi della ferita non possono essere semplicemente cuciti insieme. È più semplice spiegarlo usando i vestiti come esempio: se ritagli una sezione di tessuto sulla manica di una camicia, poi unisci i bordi e li cuci, la manica diventerà più corta. E indossare una maglietta del genere sarà scomodo, perché il tessuto si allungherà costantemente e tenderà a strapparsi di nuovo.
Se il danno è più grave (un pezzo di carne viene strappato), i bordi della ferita non possono essere semplicemente cuciti insieme. È più semplice spiegarlo usando i vestiti come esempio: se ritagli una sezione di tessuto sulla manica di una camicia, poi unisci i bordi e li cuci, la manica diventerà più corta. E indossare una maglietta del genere sarà scomodo, perché il tessuto si allungherà costantemente e tenderà a strapparsi di nuovo.
Con la carne è lo stesso: se le estremità della ferita sono distanti, non possono essere suturate. Pertanto, la guarigione sarà secondaria: dapprima inizierà a formarsi tessuto di granulazione nella cavità, che riempirà tutto lo spazio libero.
Protegge temporaneamente la mucosa, quindi non può essere rimosso durante le medicazioni. Mentre il tessuto di granulazione ricopre la ferita, al di sotto di essa si forma gradualmente il tessuto connettivo: avviene il processo di epitelizzazione.
Se la ferita è estesa e l'immunità del paziente è indebolita, la formazione dell'epitelio avverrà lentamente. In questo caso il tessuto di granulazione non si dissolverà completamente, ma riempirà parzialmente la cavità, formando una cicatrice. All'inizio è rosa, ma col tempo i vasi si svuotano e la cicatrice diventa biancastra o beige.
A proposito! L'aspetto del tessuto di granulazione dipende dalla natura e dalla profondità della ferita. Ma più spesso è piuttosto sottile, ha colore rosso-rosa e superficie granulare (dal lat. granum– grano). A causa del gran numero di vasi sanguina facilmente.
Farmaci per accelerare la guarigione delle ferite
Gli agenti esterni per la guarigione delle ferite per intenzione secondaria devono avere diverse proprietà:
- antinfiammatorio (previene lo sviluppo di infiammazioni);
- disinfettante (distrugge i microbi);
- analgesico (per alleviare le condizioni del paziente);
- rigenerante (favorire la rapida formazione di nuove cellule).
Oggi nelle farmacie puoi trovare molti unguenti e gel diversi che hanno le proprietà di cui sopra. Prima di acquistare un prodotto specifico, dovresti consultare il tuo medico, perché ogni farmaco ha le sue caratteristiche.
Levomekol
 Un unguento universale necessario nei camerini degli ospedali. In sostanza, è un antibiotico che impedisce lo sviluppo di un'infezione purulenta. Viene utilizzato anche per congelamenti e ustioni, ma solo all'inizio. Quando la ferita si ricopre di una crosta o inizia a guarire, la somministrazione di Levomekol deve essere interrotta e si deve usare qualcos'altro.
Un unguento universale necessario nei camerini degli ospedali. In sostanza, è un antibiotico che impedisce lo sviluppo di un'infezione purulenta. Viene utilizzato anche per congelamenti e ustioni, ma solo all'inizio. Quando la ferita si ricopre di una crosta o inizia a guarire, la somministrazione di Levomekol deve essere interrotta e si deve usare qualcos'altro.
Il sovradosaggio (uso a lungo termine o uso frequente) può portare all'accumulo dell'antibiotico nel corpo e provocare cambiamenti nella struttura delle proteine. Gli effetti collaterali includono lieve arrossamento, gonfiore della pelle e prurito. Levomekol è economico: circa 120 rubli per 40 g.
Argosulfan
Questo farmaco per la guarigione delle ferite secondarie si basa sull'argento colloidale. Disinfetta perfettamente e l'unguento può essere utilizzato per 1,5 mesi. Le proprietà rigenerative sono leggermente inferiori a quelle di altri farmaci, quindi l'Argosulfan viene solitamente prescritto all'inizio o a metà del trattamento di ferite complesse per garantire che tutti i microbi vengano distrutti.
Il farmaco è piuttosto costoso: 400-420 rubli per confezione da 40 g.
Solcoseryl
Un farmaco unico contenente componenti del sangue di giovani vitelli. Hanno un effetto benefico sulla guarigione delle ferite secondarie, favorendo la saturazione delle cellule con ossigeno, accelerando la sintesi del tessuto di granulazione e una rapida cicatrizzazione.
Un'altra caratteristica distintiva di Solcoseryl: viene prodotto anche sotto forma di gel, adatto per l'uso su ferite essudanti, come le ulcere trofiche. È adatto anche per ustioni e ferite già in via di guarigione. Prezzo medio: 320 rubli per 20 g.
 Un rimedio popolare tra le donne incinte e le giovani madri, perché non contiene nulla che possa danneggiare il feto o il bambino. Il principio attivo del farmaco - dexpantenolo - quando entra in contatto con la superficie della ferita, si trasforma in acido pantotenico. È un catalizzatore dei processi di rigenerazione.
Un rimedio popolare tra le donne incinte e le giovani madri, perché non contiene nulla che possa danneggiare il feto o il bambino. Il principio attivo del farmaco - dexpantenolo - quando entra in contatto con la superficie della ferita, si trasforma in acido pantotenico. È un catalizzatore dei processi di rigenerazione.
Principalmente, il pantenolo viene utilizzato per le ustioni. Ma è adatto anche per ferite estese e profonde di diversa natura. Anche la guarigione secondaria della sutura dopo l'intervento chirurgico può essere accelerata con l'aiuto di questo farmaco. Si applica facilmente ed in modo uniforme, senza richiedere risciacquo prima del successivo utilizzo. Costo: 250-270 rubli per 130 g.
Baneocina
Agente antibatterico sotto forma di unguento (per ferite secche) e polvere (per ferite essudanti). Ha un ottimo effetto penetrante favorendo quindi una rapida guarigione. Ma non può essere usato spesso e per molto tempo, perché l'antibiotico si accumula nel corpo. Gli effetti collaterali possono includere perdita parziale dell'udito o problemi renali.
L'unguento alla baneocina può essere acquistato per 340 rubli (20 g). La polvere costerà un po' di più: 380 rubli per 10 g.
Ambulanza
Questa è una polvere a base di piante medicinali e acido salicilico. Può essere utilizzato dopo un ciclo di Baneocin come adiuvante. Ha proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antisettiche. Asciuga la ferita, prevenendo così la suppurazione. Ambulanza - polvere economica: solo 120 rubli per 10 g.
La guarigione per prima intenzione è possibile con un bendaggio protettivo in 6-8 giorni, “da sola”. I prerequisiti sono una piccola area di danno, uno stretto contatto dei bordi della ferita, l'assenza di focolai di necrosi ed ematoma e una relativa asepsi della ferita (contaminazione microbica inferiore a 10,5 per 1 g di tessuto). La superficie della ferita è ricoperta da una sottile crosta; dopo che quest'ultima è stata respinta, si apre una nuova cicatrice ricoperta di epitelio. Ogni ferita chirurgica applicata asetticamente guarisce in questo modo. I segni di infiammazione con questo tipo di guarigione sono minimi e possono essere determinati solo al microscopio.
Nelle ferite molto superficiali che non penetrano tutti gli strati della pelle (abrasioni), la guarigione avviene sotto una crosta costituita da fibrina, leucociti e globuli rossi. In assenza di infezione, questa guarigione avviene entro pochi giorni. In questo caso, l'epitelio si diffonde su tutta la superficie della ferita. La formazione di una crosta durante l'escoriazione è altamente auspicabile.
Guarigione per seconda intenzione. Tessuto di granulazione e suo significato biologico.
Il motivo della guarigione della ferita per intenzione secondaria è un'ampia area di danno tissutale e bordi della ferita aperti, la presenza di tessuto non vitale, ematomi e lo sviluppo di infezione della ferita. Innanzitutto, la superficie della ferita è ricoperta da uno strato di cellule del sangue mescolate con fibrina, che protegge la ferita in modo puramente meccanico. Dopo 3-6 giorni, la formazione di fibroblasti e capillari diventa così pronunciata che questi ultimi rappresentano un albero vascolare che penetra nello strato di fibrina. Di conseguenza, si forma un tessuto di granulazione che crea una difesa biologica per la ferita contro infezioni e tossine. L'epitelizzazione inizia solo dopo che la ferita è stata completamente ripulita dalle masse necrotiche e l'intero difetto della ferita è stato riempito con granulazioni. Per abbreviare i tempi di guarigione della ferita per seconda intenzione, su una ferita granulante o su un innesto cutaneo libero viene utilizzata una sutura. Le granulazioni agiscono come un muro protettivo e formano una linea di demarcazione al confine con i tessuti sani. Allo stesso tempo, il tessuto di granulazione secerne un secreto della ferita che ha un effetto battericida (necrolisi enzimatica) e pulisce meccanicamente la superficie della ferita. I corpi estranei (metallo, seta, ossa eterogenee) vengono incapsulati dal tessuto di granulazione e l'infiammazione avviata dai corpi estranei si arresta. I corpi estranei come il catgut e la spugna emostatica vengono riassorbiti. I corpi estranei infettati da microrganismi virulenti vengono prima circondati da tessuto di granulazione, ma poi attorno al corpo estraneo avviene la suppurazione con la formazione di una fistola o di un ascesso.
Reazioni generali del corpo.
Fattori che influenzano la guarigione delle ferite.
La reazione generale più nota del corpo a un infortunio è un aumento della temperatura corporea dovuto all'irritazione dei centri di termoregolazione durante il riassorbimento dei prodotti di degradazione delle proteine piogeniche. Questo aumento di temperatura da riassorbimento asettico non è accompagnato da brividi e non supera i 38,5 0 C. La frequenza del polso quasi non aumenta. In risposta alla lesione, la leucocitosi si sviluppa solitamente con uno spostamento a sinistra; il rapporto albumina/globulina nel plasma sanguigno cambia, la quantità di proteine totali diminuisce. Traumi gravi provocano disturbi del metabolismo basale e dei carboidrati (iperglicemia traumatica).
Fase catabolica dura solitamente 2-4 giorni e si manifesta con necrosi tissutale, proteolisi ed essudazione. La degradazione delle proteine del corpo è facilmente rilevabile dalla crescente escrezione di azoto nelle urine. In caso di lesioni gravi e infezioni, l'escrezione di azoto raggiunge i 15-20 g al giorno, che corrisponde alla degradazione e alla perdita di 70 g di proteine o 350 g di tessuto muscolare. Va notato che i livelli di proteine plasmatiche non riflettono questi cambiamenti. La disgregazione proteica può essere ridotta mediante la somministrazione di farmaci ad alto contenuto calorico per la nutrizione parenterale ed enterale.
Intermedio, fase di transizione richiede 1 – 2 giorni, non è clinicamente espresso. Fase anabolica caratterizzato da un aumento della sintesi proteica e dura da 2 a 5 settimane. Clinicamente manifestato dalla pulizia della ferita dal tessuto necrotico, dallo sviluppo del tessuto di granulazione e dall'epitelizzazione.
Tra i fattori che influenzano la guarigione delle ferite, vanno evidenziati i seguenti:
Età. I pazienti più giovani guariscono più velocemente dei pazienti più anziani.
Massa corporea. Nei pazienti obesi, la sutura della ferita è significativamente più difficile; il tessuto adiposo è più suscettibile a lesioni traumatiche e infezioni a causa di un apporto sanguigno relativamente debole.
Stato nutrizionale. Nei pazienti con scarsa nutrizione si verifica una carenza di energia e di materiale plastico, che inibisce i processi riparativi della ferita.
Disidratazione. Una grave intossicazione porta a carenza di liquidi, squilibrio elettrolitico, che influisce negativamente sulle funzioni del cuore e dei reni e sul metabolismo intracellulare.
Stato dell'afflusso di sangue. Le ferite nelle aree con un buon apporto di sangue (viso) guariscono più velocemente.
Stato immunitario. L'immunodeficienza di qualsiasi tipo peggiora la prognosi del trattamento chirurgico (cicli di chemioterapia, glucocorticosteroidi, radioterapia, ecc.).
Malattie croniche. I disturbi endocrini e il diabete mellito portano sempre ad un rallentamento dei processi di riparazione e allo sviluppo di complicanze postoperatorie.
Ossigenazione dei tessuti. Qualsiasi processo che impedisca l'accesso dell'ossigeno o di altri nutrienti compromette la guarigione (ipossiemia, ipotensione, insufficienza vascolare, ischemia tissutale, ecc.).
Farmaci antinfiammatori. L'uso di steroidi e farmaci antinfiammatori non specifici rallenta il processo di guarigione.
Infezione secondaria e suppurazione -è una delle cause più comuni di deterioramento della ferita. Da tenere presente che nel 95% dei casi la fonte della contaminazione batterica è la flora batterica endogena.
Si verifica attraverso lo sviluppo del tessuto di granulazione, che riempie gradualmente la cavità della ferita e si trasforma poi in tessuto connettivo cicatriziale. Si verifica nei casi:
Quando la ferita è infetta;
Quando la ferita contiene coaguli di sangue, corpi estranei, c'è una divergenza dei suoi bordi;
Se c'è un difetto tissutale che non può essere chiuso con suture;
Quando i tessuti del corpo perdono la capacità di guarire, quando il corpo è esausto, si verifica un completo disordine metabolico.
Nei primi minuti dopo l'infortunio, nella ferita si trovano coaguli di sangue sciolti e una grande quantità di plasma sanguigno. Entro la fine della prima ora appare la secrezione della ferita: un fluido sieroso e sanguinante. Si sviluppa una grave infiammazione infettiva. Già il secondo giorno, i bordi della ferita si gonfiano, il dolore si intensifica, la temperatura locale aumenta, la superficie della ferita è ricoperta da un rivestimento giallastro e una piccola quantità di essudato purulento inizia a fuoriuscire. Dopo due giorni, sui bordi della ferita si possono trovare noduli rosa-rossi delle dimensioni di un chicco di miglio. Il terzo giorno, il numero dei granuli raddoppia, il quinto l'intera superficie della ferita è ricoperta di granulazione: tessuto connettivo giovane. Le granulazioni sane non sanguinano, hanno un delicato colore rosa-rosso, una consistenza abbastanza densa. Il tessuto di granulazione si verifica sempre all'interfaccia tra il tessuto morto e quello vivo. Normalmente, il tessuto di granulazione non si estende mai al tessuto sano. Dopo aver raggiunto il livello della pelle, le granulazioni diminuiscono di volume, diventano pallide, si ricoprono di epitelio cutaneo e sporgono leggermente sopra la superficie della pelle. Man mano che i vasi delle granulazioni si svuotano, la cicatrice diventa ancora più chiara e più stretta.
27. Guarigione delle ferite per intenzione primaria
Fusione dei bordi della ferita senza formazione di tessuto intermedio e sintomi clinici di infiammazione. La guarigione per intenzione primaria è possibile:
Se non c'è infezione;
Quando i bordi della ferita sono in completo contatto;
Se la vitalità dei tessuti è preservata;
Quando non ci sono oggetti estranei nella ferita.
Per intenzione primaria, sia le ferite chirurgiche che le ferite contaminate soggette a trattamento chirurgico possono guarire. Una ferita che guarisce per intenzione primaria è una cavità simile a una fessura piena di linfa, fibrina e detriti tissutali. La guarigione inizia entro le prime ore dopo l'infortunio. Si sviluppa l'iperemia, il pH si sposta verso il lato acido, la fibrina caduta sulle pareti della ferita inizia a incollarla e si sviluppa un'adesione primaria. Durante il primo giorno, la ferita si riempie di linfociti, macrofagi e fibroblasti. Le cellule endoteliali vascolari si gonfiano e formano angioblasti (processi), quindi si muovono l'una verso l'altra dai bordi opposti e si anastomizzano tra loro. Pertanto, il flusso sanguigno viene ripristinato tra le pareti della ferita. Il quarto giorno, la ferita ha già una propria rete di capillari formata. Il sesto giorno, attorno ai vasi si forma un tessuto connettivo che fissa saldamente i bordi della ferita.
28. Corpi estranei nel corpo
I corpi estranei sono oggetti di origine organica e inorganica entrati nel corpo dell'animale in seguito a lesioni, con il cibo o introdotti nello stesso a scopo terapeutico.
Patogenesi
Piccoli frammenti, aghi, proiettili, se sono asettici, possono essere incapsulati. Attorno al corpo estraneo si forma prima una rete di fibrina, un infiltrato di leucociti e quindi il tessuto connettivo cicatrizzato. Molto spesso, i corpi estranei non vengono incapsulati, il che porta a un'infezione dormiente, a una guarigione lenta delle ferite e alla mancata guarigione a lungo termine delle fistole. Gli oggetti contundenti e rotondi ingeriti non causano patologie negli animali (grandi).
Se i corpi estranei mettono a rischio la vita, vengono rimossi immediatamente. Se il corpo estraneo si trova molto in profondità e non provoca dolore, suppurazione o reazioni infiammatorie, è meglio non toccarlo.
29. Carbonchio
Infiammazione acuta purulenta del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea con predominanza di necrosi cutanea.
Eziologia
Scarsa cura della pelle, ipovitaminosi A, B, C, intossicazione intestinale, disturbi metabolici.
Segni clinici
Un carbonchio è caratterizzato dalla formazione di un gran numero di nicchie e tasche.
Aperto con un'incisione a forma di croce, vengono applicate soluzioni antibiotiche intramuscolari, endovenose, lavate localmente con una soluzione di permanganato di potassio, perossido e unguento Vishnevskij.
30. Classificazione e caratteristiche cliniche e morfologiche delle ferite
Ferita – vulnus – danno meccanico aperto a tessuti e organi. Danni minori alla pelle (solo l'epidermide è danneggiata) - abrasioni.
In una ferita sono presenti bordi, pareti, cavità e fondo della ferita.
Penetrante ferite - quando vengono perforate da un oggetto lesivo prima di entrare in qualsiasi cavità.
Spiffero- se la ferita ha un'apertura di entrata e di uscita.
Cieco– se c'è solo un'entrata e nessuna uscita.
Accoltellato– canale della ferita stretto e profondo. Forcone, punteruolo, trequarti.
Taglio ferita: bordi lisci, apertura significativa, forte sanguinamento.
Tritato ferita: viene inflitta con oggetti taglienti contundenti. Ascia. Tali ferite presentano segni di livido e commozione cerebrale. Sanguinano meno. Molto spesso le ossa e il periostio sono danneggiati.
Ferito ferita. Livido – contusione. Danni ai tessuti con un oggetto contundente (bastone, verga, zoccoli; quando gli animali cadono da grandi altezze). I bordi della ferita sono irregolari, gonfi, schiacciati. Una ferita del genere è sempre contaminata (sporco, polvere, macchie di pelle).
Strappato– artigli di animali, corna, rami di alberi.
Schiacciato la ferita è la più grave. Si verifica sotto l'influenza della forza massima e dell'enorme pressione. Ruote di trasporti ferroviari, automobili, cadute da altezze superiori al quinto piano.
Morso ferita: livido, schiacciamento, rottura dei tessuti. Quando un cavallo morde, si formano profonde impronte bluastre degli incisivi.
Armi da fuoco ferita: 3 zone:
Area del canale della ferita – coaguli di sangue con tessuto schiacciato;
Necrosi traumatica – direttamente adiacente al canale della ferita;
Shock molecolare.
Il foro di ingresso di una ferita da arma da fuoco è concavo verso l'interno, i bordi sono bruciati, il foro di uscita è più grande e rivolto verso l'esterno.
Avvelenato ferita - mista Quando viene morso da un serpente – ferita avvelenata + morsicata.
Combinato ferite (pugnalate, lacerate, contuse).
La guarigione per intenzione primaria (guarigione primaria) si osserva quando i bordi e le pareti della ferita sono vicini, si toccano. I processi di guarigione procedono rapidamente, senza sviluppo di complicazioni, con la formazione di una sottile cicatrice lineare e l'epitelizzazione lungo la linea di connessione dei bordi della ferita.
La guarigione per intenzione secondaria (guarigione secondaria) si osserva quando è presente una grande cavità della ferita, i suoi bordi non si toccano o si è sviluppata un'infezione purulenta nella ferita. I processi di rigenerazione procedono lentamente, con pronunciata infiammazione purulenta, e dopo che la ferita viene pulita e si sviluppa la granulazione, guarisce con la formazione di una cicatrice.
La guarigione sotto una crosta avviene con ferite superficiali della pelle (abrasioni, graffi, ustioni, abrasioni), quando la ferita è ricoperta da una crosta (crosta) di sangue essiccato, linfa, liquido interstiziale e tessuto morto. Sotto la crosta avviene il processo di riempimento del difetto con granulazioni e l'epidermide rigenerante si insinua dai bordi della ferita, la crosta cade e la ferita viene epitelizzata.
32. Principi generali di trattamento delle ferite fresche. Trattamento chirurgico primario, secondario e ripetuto delle ferite, razionale, tecnica. Suture (primarie, primarie ritardate, secondarie). Principi di trattamento delle ferite infette. Metodi di trattamento generali e locali: fisici, chimici, biologici.
Il primo soccorso nella fase preospedaliera comprende l'arresto del sanguinamento, l'applicazione di una medicazione asettica e, se necessario, l'immobilizzazione del trasporto.
La pelle attorno alla ferita viene pulita dalla contaminazione, lubrificata con tintura di iodio al 5%, vengono rimossi grandi corpi estranei sciolti e viene applicata una benda asettica.
Trattamento chirurgico primario (PST) delle ferite- la componente principale del trattamento chirurgico per loro. Il suo obiettivo è creare le condizioni per una rapida guarigione delle ferite e prevenire lo sviluppo di infezioni della ferita.
Esistono PST precoci, effettuati nelle prime 24 ore dopo l'infortunio, ritardati - durante il secondo giorno e tardivi - dopo 48 ore.
Il compito quando si esegue la PCS di una ferita è rimuovere dalla ferita i tessuti non vitali e la microflora in essi contenuta. La PSO, a seconda del tipo e della natura della ferita, consiste nell'escissione completa della ferita o nella sua dissezione con escissione.
L'escissione completa è possibile a condizione che non siano trascorse più di 24 ore dalla lesione e se la ferita ha una configurazione semplice con una piccola area danneggiata. In questo caso il PST della ferita consiste nell'escissione dei bordi, delle pareti e del fondo della ferita all'interno dei tessuti sani, con ripristino dei rapporti anatomici.
La dissezione con escissione viene eseguita per ferite di configurazione complessa con un'ampia area di danno. In questi casi, il trattamento primario della ferita consiste nei seguenti punti;
1) ampia dissezione della ferita;
2) asportazione dei tessuti molli deprivati e contaminati nella ferita;
4) rimozione di corpi estranei sciolti e frammenti ossei privi di periostio;
5) drenaggio della ferita;
6) immobilizzazione dell'arto lesionato.
La PSO delle ferite inizia con il trattamento del campo chirurgico e la sua delimitazione con lino sterile. Se la ferita è sul cuoio capelluto del corpo, radere prima i capelli di 4-5 cm di circonferenza, cercando di radersi dalla ferita * periferia. Per le ferite di piccole dimensioni viene solitamente utilizzata l'anestesia locale.
Il trattamento inizia afferrando la pelle in un angolo della ferita con una pinzetta o pinze Kocher, sollevandola leggermente e da lì asportando gradualmente la pelle lungo tutta la circonferenza della ferita. Dopo l'escissione dei bordi schiacciati della pelle e del tessuto sottocutaneo, la ferita viene allargata con uncini, la sua cavità viene esaminata, le aree non vitali dell'aponeurosi e dei muscoli vengono rimosse e le tasche esistenti nei tessuti molli vengono aperte con ulteriori incisioni. Durante il trattamento chirurgico primario di una ferita, è necessario cambiare periodicamente bisturi, pinzette e forbici durante l'operazione. La PSO viene eseguita nel seguente ordine: prima vengono asportati i bordi danneggiati della ferita, poi le sue pareti e, infine, il fondo della ferita. Se nella ferita sono presenti piccoli frammenti ossei, è necessario rimuovere quelli che hanno perso il contatto con il periostio. Durante la PST delle fratture ossee esposte, le estremità affilate dei frammenti che sporgono nella ferita, che possono causare lesioni secondarie ai tessuti molli, ai vasi sanguigni e ai nervi, devono essere rimosse con una pinza ossea.
La fase finale del PST delle ferite, a seconda del tempo trascorso dal momento della lesione e della natura della ferita, può essere la sutura dei bordi o il drenaggio. Le suture ripristinano la continuità anatomica del tessuto, prevengono l'infezione secondaria e creano le condizioni per la guarigione per intenzione primaria.
Insieme alle primarie, ci sono chirurgico secondario trattamento della ferita, intrapreso per indicazioni secondarie a causa di complicazioni e insufficiente radicalità del trattamento primario allo scopo di trattare l'infezione della ferita.
Si distinguono i seguenti tipi di cuciture.
Sutura primaria: applicata alla ferita entro 24 ore dall'infortunio. La sutura primaria viene utilizzata per completare gli interventi chirurgici durante operazioni asettiche, in alcuni casi anche dopo l'apertura di ascessi, flemmoni (ferite purulente), se nel periodo postoperatorio sono previste buone condizioni per il drenaggio della ferita (utilizzo di drenaggi tubolari). Se sono trascorse più di 24 ore dall'infortunio, dopo la PSO della ferita non vengono applicati punti di sutura, la ferita viene drenata (con tamponi con una soluzione di cloruro di sodio al 10%, unguento Levomi-kol, ecc., E dopo 4- 7 giorni fino alla comparsa della granulazione, a condizione che la ferita non sia suppurata, vengono applicate suture primarie ritardate. Le suture ritardate possono essere applicate come suture provvisorie - immediatamente dopo la PSO - e legate dopo 3-5 giorni, se non ci sono segni di infezione della ferita .
Una sutura secondaria viene applicata alla ferita granulante, a condizione che sia passato il pericolo di suppurazione della ferita. È presente una sutura secondaria precoce, che viene applicata alla granulazione del PCS.
Una sutura secondaria tardiva viene applicata più di 15 giorni dalla data dell'intervento. In questi casi non è sempre possibile avvicinare i bordi, le pareti e il fondo della ferita; inoltre, la crescita del tessuto cicatriziale lungo i bordi della ferita impedisce la guarigione dopo il loro confronto. Pertanto, prima di applicare le suture secondarie tardive, i bordi della ferita vengono asportati e mobilizzati e le ipergranulazioni vengono rimosse.
Il trattamento chirurgico primario non deve essere eseguito se:
1) ferite ed abrasioni superficiali minori;
2) piccole ferite da puntura, comprese quelle cieche, senza danni ai nervi;
3) con ferite multiple cieche, quando i tessuti contengono un gran numero di piccoli frammenti metallici (frammenti di proiettili, granate);
4) attraverso ferite da proiettile con fori di entrata e uscita lisci in assenza di danni significativi a tessuti, vasi sanguigni e nervi.
La tensione della ferita secondaria è un tipo di guarigione dei tessuti molli danneggiati. Il processo di rigenerazione dipende dalla natura e dalla gravità della lesione e dalla salute generale. In chirurgia il metodo prevede il confronto dei bordi di una cavità patologica; il ripristino è possibile solo attraverso la crescita delle granulazioni.
Danni estesi alla pelle dovuti a ustioni e condizioni infiammatorie purulente sono caratterizzati da una marcata apertura della superficie. La guarigione avviene grazie alla lenta sostituzione delle aree colpite con cellule di granulazione.
L'aspetto del tessuto connettivo giovane è una reazione adattativa del corpo causata da una violazione dell'integrità dell'epidermide. Grazie al meccanismo è possibile il ripristino della ferita, la rimozione di corpi estranei e l'autopulizia.
L'area patologica viene tesa dal centro verso i bordi e al suo posto si forma una grande cicatrice. Il processo è inevitabile ed è una fase normale della formazione di granulazioni durante la seconda intenzione. Quando si utilizza il metodo vengono trattate ferite croniche, difetti nei seni pilonidali e ascessi. È necessario distinguere il tipo di terapia dalla guarigione della superficie danneggiata sotto la crosta: piccole abrasioni ricoperte da una crosta secca di linfa, fibrina, sangue. La formazione di uno strato protettivo costituisce una barriera contro l'infezione secondaria.

La differenza tra intenzione secondaria e intenzione primaria
La guarigione delle ferite per seconda intenzione è uno dei metodi classici utilizzati nella chirurgia moderna. La condizione principale per l'attuazione di questo tipo di trattamento è la presenza di tessuto non vitale o di una lesione infettiva nella cavità lesionata. La condizione si osserva quando viene rimosso un dente e l'alveolo viene rigenerato senza suture per seconda intenzione. L'uso di bagni con soluzioni asettiche accelererà il processo di recupero. Con intenzione primaria, i bordi della ferita vengono uniti, viene formato un tessuto di granulazione per incollare insieme le pareti.
Dopo la guarigione, si forma una piccola cicatrice lineare nel sito della lesione.
Condizioni necessarie per attuare la modalità di trattamento:
- i bordi della ferita si sono discostati di non più di 10 mm;
- lesione asettica;
- vitalità dei tessuti.
La guarigione della sutura per seconda intenzione è sempre accompagnata dalla formazione di una ruvida cicatrice. Se l’area della cavità infetta era ampia, il difetto risulterà molto pronunciato. La notevole distanza tra i bordi della ferita impedisce l'adesione primaria; la placca fibrinosa risultante fornisce scarsa protezione dagli effetti dell'ambiente esterno. L'aria secca i tessuti giovani, rendendo impossibile il processo di recupero.
Indicazioni per la seconda intenzione
Quando esiste un alto rischio di infezione, i chirurghi scelgono la seconda intenzione dei tessuti molli danneggiati. Condizioni necessarie per il trattamento:
- Abbondante inseminazione microbica della superficie lesa.
- Grande dimensione della ferita.
- La presenza di corpi estranei, sporco, tessuto necrotico e coaguli di sangue nella cavità patologica.
- Malattie per le quali il paziente non è indicato per interventi chirurgici gravi seguiti dall'escissione di una grande quantità di tessuto. L’intenzione secondaria è un metodo più sicuro.
Fattori importanti per determinare la tattica del trattamento chirurgico sono la contaminazione della lesione con microrganismi patogeni e la distanza tra i bordi della ferita. Il processo di guarigione può essere accelerato mediante l'escissione dei lembi interessati. Per migliorare l'effetto dell'operazione, viene prescritta la terapia farmacologica.

Come viene eseguita la procedura?
Il processo di recupero si divide in tre fasi:
- Lo stadio dell'infiammazione acuta è molto più pronunciato durante l'infezione. Prima dell’intenzione secondaria, è necessario eliminare la fonte della proliferazione microbica e prevenire l’invasione dei tessuti circostanti. Al confine del focolaio patologico, si forma un fusto leucocitario come barriera protettiva, che contribuisce alla graduale pulizia della ferita. Il processo dura da 3 giorni a 2 mesi. La gravità e la durata della fase dipendono dall’entità del danno, dalla composizione della microflora patogena, dalla resistenza dell’organismo e dalle condizioni generali del paziente. Dopo la completa fusione delle masse necrotiche e fibrinose seguita da rigetto, la ferita è caratterizzata dall'assenza di muco. Si forma una cavità ferita. La zona è delimitata da una chiara linea di demarcazione, accompagnata dal rilascio di essudato sieroso-purulento o di pus puro.
- Durante la fase di rigenerazione della ferita, si sviluppa attivamente la granulazione. Esternamente assomiglia a piccoli noduli rosa pallido, delle dimensioni di un grano. È riccamente vascolarizzato, contiene un gran numero di vasi e sanguina pesantemente quando viene danneggiato. Se il processo di rigenerazione non avviene correttamente, inizia la formazione di ipergranulazione, fenomeno popolarmente chiamato “carne selvatica”. Nell'intenzione secondaria, i chirurghi cauterizzano o asportano il tessuto in eccesso. Se si esamina un campione biologico al microscopio, si possono vedere cellule di granulazione ipertrofiche con abbondanza di piccoli vasi.
- La fase di formazione della cicatrice è la fase finale della guarigione della ferita per seconda intenzione. L'epitelio cresce a velocità diverse dal bordo della pelle intatta al centro sotto forma di un bordo grigio chiaro. Una caratteristica speciale del metodo di trattamento è una cicatrice ruvida, multiraggiata con una forma irregolare.
La durata del processo di recupero dopo seconda intenzione dipende da molti fattori.
È necessario studiare l'aggressività e la resistenza della microflora alla terapia antibatterica. Il medico deve tenere conto delle condizioni del paziente - mancanza di nutrienti, cachessia, stato di immunodeficienza, patologia somatica concomitante, grande perdita di sangue, fattori ambientali - esposizione alle radiazioni, agenti patogeni chimici. Se gli antibiotici sono inefficaci e la microflora patogena penetra in profondità, viene eseguita un'operazione per asportare la pelle, il tessuto sottocutaneo e i muscoli interessati. In alcuni casi può essere necessaria l’amputazione degli arti. Viene utilizzata l'artroscopia.
Nella fase di infiammazione acuta, è consigliabile pulire la ferita con acqua ossigenata e trattare il focolaio patologico con unguenti antibatterici. In caso di condizioni gravi del paziente con intenzione secondaria, deve essere utilizzata la terapia antibiotica.
Recupero dopo la guarigione
Il processo di trattamento delle ferite con il metodo dell'intenzione secondaria è caratterizzato dalla durata dell'epitelizzazione, dovuta al verificarsi di difficoltà. La cicatrice impiega molto tempo a formarsi, di conseguenza ha una forma irregolare, non si allunga bene e può impedire la libertà di movimento.
La riabilitazione completa dipende da fattori:
- emostasi di alta qualità;
- prevenzione dell'infiammazione, infezione secondaria;
- corretta ristrutturazione cellulare.
Una cura adeguata e tempestiva del tessuto cicatriziale contribuirà ad accelerare la riabilitazione dopo la guarigione della ferita secondaria.
Per ammorbidire, utilizzare unguenti speciali a base di collagene, elastina, impacchi idratanti e metodi di medicina tradizionale. Nel periodo postoperatorio, i medici prescrivono la terapia ad ultrasuoni per accelerare il processo di guarigione e mantenere l'immunità locale.
L'elettroterapia di una ferita sotto tensione comprende elettroforesi e fonoforesi, terapia diadinamica. I metodi di trattamento mirano a rafforzare le condizioni generali, a migliorare la circolazione sanguigna locale e generale e il funzionamento del sistema nervoso. L'irradiazione ultravioletta locale favorisce una rapida guarigione, la formazione di una cicatrice più liscia ed è un'eccellente prevenzione dell'infezione secondaria della ferita.
Quanto velocemente scompare una cicatrice?
La fine del processo di ripristino della ferita durante l'intenzione secondaria è la formazione di una cicatrice costituita da tessuto cheloide. È fibroso-grossolano, ha una superficie ruvida ed è caratterizzato da una forma irregolare. Un difetto estetico pronunciato provoca disagio. Se lo si desidera, il problema può essere eliminato utilizzando uno dei metodi di rimozione chirurgica. L'intervento viene effettuato esclusivamente in ambito ospedaliero da uno specialista esperto in completa sterilità.
Dopo che la ferita guarisce per seconda intenzione, il segno rimane così grande che non può essere rimosso mediante escissione. Dopo che il paziente si è completamente ripreso, i medici ricorrono all’innesto cutaneo o ad altri metodi della moderna chirurgia plastica.