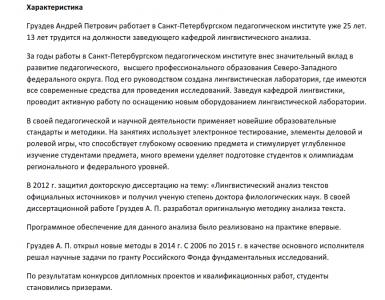Una malattia dei talentuosi e famosi. Malattia di Meniere: cause, sintomi, diagnosi, trattamento Casi noti di trattamento efficace della malattia di Meniere

La malattia di Meniere è una malattia non infiammatoria localizzata nell'orecchio medio, caratterizzata da acufeni, vertigini, perdita di equilibrio e rapido deterioramento delle capacità uditive. La malattia è abbastanza comune e spesso si manifesta anche tra personaggi famosi, ma nonostante ciò, le ragioni esatte del suo sviluppo rimangono poco chiare. Oggi i metodi di trattamento a disposizione della medicina non sono in grado di eliminare completamente la malattia, ma solo di alleviare temporaneamente le condizioni del paziente. Puoi scoprire più in dettaglio cos'è la malattia di Meniere se acquisisci informazioni generali sulla malattia, sui suoi tipi e sui possibili sintomi.
Varietà di forme della malattia di Meniere
La malattia di Meniere non deve essere confusa con la sindrome di Meniere, che hanno molto in comune, ma rimangono condizioni diverse. La malattia di Meniere è una malattia indipendente, la cui classificazione dipende dai sintomi nelle fasi iniziali dello sviluppo. Esistono tre forme principali di questa malattia:
- forma cocleare: si verifica in circa il 50% dei casi ed è caratterizzata da una grave compromissione delle capacità uditive;
- vestibolare: si verifica nel 20% dei pazienti e si manifesta con disturbi vestibolari;
- classico - diagnosticato nel 30% dei casi, mentre i pazienti presentano disturbi vestibolari e uditivi.

Con il progredire della malattia, il paziente sperimenta una remissione (temporanea assenza di manifestazioni dolorose) e una fase di esacerbazione, quando si verificano attacchi pronunciati. In base alla durata degli attacchi e agli intervalli tra i loro episodi, la malattia può essere di tre gradi:
- Il primo (lieve) è caratterizzato da attacchi minori, le cui pause possono durare mesi o addirittura anni.
- Secondo (medio): gli attacchi possono durare fino a 5 ore, mentre i pazienti non sono in grado di lavorare per diversi giorni.
- Terzo (grave): la durata degli attacchi supera le cinque ore e la frequenza può variare da una volta al giorno a una volta alla settimana. Tali pazienti sono completamente disabili.
Importante! Quando la durata degli attacchi e la frequenza del loro verificarsi aumentano in modo significativo, si verificano gravi disturbi vestibolari e un rapido deterioramento dell'udito causato da danni all'apparato di conduzione e ricezione del suono, ciò indica l'irreversibilità del decorso della malattia di Meniere.
Come si manifesta la malattia di Meniere?
Il segno principale della malattia sono le vertigini ripetute, che si manifestano insieme a una sensazione di nausea e vomito. I pazienti lamentano la sensazione che tutto giri, cade e muove il proprio corpo nello spazio. Le vertigini possono raggiungere un’intensità tale che le persone non sono in grado di stare in piedi o sedersi e, quando la loro posizione cambia, la gravità delle manifestazioni aumenta.
Inoltre, durante gli attacchi della malattia di Meniere, si verificano le seguenti condizioni:

- rumore nell'orecchio interessato;
- mancanza di coordinamento;
- perdita di equilibrio;
- disturbi dell'udito;
- tachicardia;
- aumento della sudorazione;
- dispnea;
- pelle pallida.
La durata degli attacchi e gli intervalli tra il loro verificarsi dipendono dallo stadio di progressione della malattia. I seguenti fattori possono causare un nuovo attacco:
- fumare;
- fatica;
- abuso di alcool;
- aumento della temperatura generale;
- azioni mediche.
I pazienti spesso prevedono in anticipo un attacco da una condizione precedente, espressa da un aumento dell'acufene, perdita di equilibrio e deterioramento delle capacità uditive.
Diagnostica della malattia di Meniere

Vertigini con presenza di acufeni e deterioramento delle capacità uditive consentono all'otorinolaringoiatra di identificare la malattia durante il primo esame, ma una diagnosi accurata della malattia di Meniere richiede ulteriori misure diagnostiche. Per determinare il grado di deficit uditivo, è necessario condurre studi speciali:
- audiometria;
- esame del diapason;
- misurazione dell'impedenza acustica;
- emissioni otoacustiche;
- elettrococleografia.
L'audiometria consente di diagnosticare la natura mista del danno uditivo. Nelle fasi iniziali della malattia, lo studio rivela una diminuzione dell'udito nelle frequenze da 125 a 1000 Hz.
Il test di impedenza acustica consente di valutare quanto sono mobili gli ossicini uditivi e quanto è funzionale il tessuto muscolare. Lo scopo di questo studio è rilevare patologie nel nervo uditivo. Inoltre, per escludere il rischio di neuroma, i pazienti dovrebbero sottoporsi a una risonanza magnetica del cervello.
L'otoscopia e la microotoscopia sono necessarie per rilevare cambiamenti nel timpano e nel canale uditivo esterno. Pertanto, si può escludere la possibilità di un processo infiammatorio.
Per determinare i disturbi vestibolari nella malattia di Meniere, vengono prescritti i seguenti studi:
- vestibolometria;
- otolitometria indiretta;
- stabilografia.
Quando un paziente sperimenta vertigini sistemiche, ma il suo udito non si deteriora, gli viene diagnosticata la sindrome di Meniere. Quindi, la diagnosi della malattia che ha causato la sindrome richiede il coinvolgimento di un neurologo e la nomina di altre misure diagnostiche:
- elettroencefalogramma;
- ECO-EG;
- scansione fronte-retro;
- REG ed ecografia.
Quando si diagnostica la malattia di Meniere, è importante differenziarla da altre malattie che presentano manifestazioni simili, come la labirintite, l'otosclerosi o l'otite media.
Opzioni terapeutiche per la malattia di Meniere
In medicina, la malattia di Meniere è considerata una malattia incurabile, ma è ancora possibile arrestarne l'ulteriore progressione e ridurre al minimo i sintomi. In genere, ai pazienti viene prescritto un trattamento complesso, che prevede l'uso di una serie di metodi diversi progettati per alleviare le condizioni del paziente. Anche durante la terapia è importante eliminare le cattive abitudini e aderire a una dieta sana. Puoi migliorare la funzionalità dell'apparato vestibolare con ginnastica speciale.
Terapia farmacologica

Quando si effettua il trattamento farmacologico per la malattia di Meniere, vengono prescritti vari farmaci che devono essere assunti sia durante gli attacchi che durante gli intervalli tra i loro episodi. Per fermare gli attacchi:
- antichilinergici;
- bloccanti adrenergici;
- antistaminici;
- farmaci antinfiammatori;
- farmaci vasodilatatori;
- farmaci del gruppo della betaistina.
Durante gli intervalli tra gli attacchi, il trattamento viene effettuato con agenti profilattici che riducono le manifestazioni della malattia. Durante questo periodo, ai pazienti viene prescritto:
- preparati a base di betagestina;
- diuretici;
- venotonici;
- farmaci che normalizzano la microcircolazione.
Il trattamento è prescritto dal medico in base ai risultati delle procedure diagnostiche, allo stadio di sviluppo della malattia e alla salute generale del paziente.
Il trattamento della malattia di Meniere mediante la terapia fisica è prescritto durante gli intervalli tra gli attacchi per migliorare il flusso sanguigno nell'area interessata, nonché per migliorare la microcircolazione nel cervello. Ai pazienti vengono prescritte le seguenti procedure fisioterapiche:

- irradiazione ultravioletta della zona del colletto;
- darsonvalutazione della zona del colletto;
- elettroforesi;
- bagni medicinali a base di sale marino o aghi di pino.
Se la terapia farmacologica e i metodi di terapia fisica non sono efficaci, ai pazienti viene prescritto il trattamento attraverso procedure chirurgiche.
Terapia operativa

L'obiettivo della terapia chirurgica è preservare e migliorare il deflusso dell'endolinfa e ridurre l'eccitabilità dei recettori vestibolari. A seconda del meccanismo dell'operazione, il trattamento chirurgico è suddiviso in diversi tipi:
- Distruttivo: per interrompere la trasmissione degli impulsi, le cellule del labirinto vengono distrutte o rimosse mediante ultrasuoni.
- Intervento chirurgico nel sistema nervoso autonomo: i nodi simpatici cervicali vengono rimossi e la corda del timpano viene resecata.
- Drenaggio: il labirinto viene drenato attraverso la zona dell'orecchio medio. È anche possibile la fenestrazione del canale semicircolare.
Sfortunatamente, quando si eseguono operazioni all'orecchio interno, il rischio di perdita dell'udito sul lato interessato è elevato. Esistono altri modi per trattare la malattia di Meniere, ad esempio la labirintectomia chimica, ovvero l'iniezione dell'antibiotico gentamicina nell'orecchio medio. In questo modo gli impulsi del lato interessato vengono interrotti e la coordinazione dipende completamente dall'orecchio sano.
Metodi tradizionali di trattamento

I metodi della medicina tradizionale non possono essere utilizzati come terapia primaria, ma vengono utilizzati in aggiunta al trattamento medico per alleviare le manifestazioni cliniche della malattia. La medicina tradizionale per il trattamento della malattia di Meniere comprende quanto segue:
- infusi diuretici, ad esempio, di poligono, timo o bardana;
- tè ai fiori di zenzero, limone, arancio o camomilla;
- tamponi con succo di cipolla, che devono essere inseriti nell'orecchio;
- respirare vapori di acqua e aceto d'uva.
Importante! Il trattamento con rimedi popolari deve essere effettuato solo dopo l'approvazione del medico curante. Tentativi indipendenti di trattamento domiciliare potrebbero non solo essere inefficaci, ma anche aggravare la situazione.
Come si può prevenire un attacco della malattia di Meniere?
Sia con la malattia che con la sindrome di Meniere, le misure preventive svolgono un ruolo speciale nel trattamento. Dopo i primi attacchi, i pazienti iniziano a osservare una serie di fattori che provocano un attacco. Se si evitano tali fattori, è possibile prolungare il periodo di remissione per diversi anni. Più spesso, gli attacchi possono verificarsi per i seguenti motivi:
- stress costante;
- dipendenza da alcol e fumo;
- suoni acuti;
- vibrazioni potenti;
- frequenti cambiamenti di pressione;
- infezioni dell'orecchio, del naso o della gola.
È anche importante monitorare la dieta seguendo una dieta speciale che il medico può prescrivere durante il trattamento.
Ginnastica speciale per la malattia di Meniere
Il trattamento della malattia di Meniere mediante particolari esercizi fisici è anche chiamato riabilitazione vestibolare, mirata ad aumentare la resistenza ai fattori esterni e allo stress al fine di ridurre la frequenza degli attacchi della malattia. L'uso di tale ginnastica viene discusso in anticipo con il medico, poiché per alcuni pazienti potrebbe essere controindicato.
Importante! Gli esercizi terapeutici non dovrebbero essere eseguiti durante un'esacerbazione della malattia, poiché ciò potrebbe influire negativamente sulla salute del paziente e aggravare la situazione.
Prognosi per i pazienti con malattia di Meniere
La malattia di Meniere non minaccia la vita di una persona, ma il costante deterioramento dell'udito e il funzionamento compromesso dell'apparato vestibolare peggiorano significativamente la vita del paziente e portano gradualmente alla disabilità. Il trattamento chirurgico nelle fasi iniziali della malattia può migliorare la prognosi, ma è impossibile preservare l’intero udito.
È possibile curare la malattia di Meniere?
La malattia non può essere completamente curata, poiché il meccanismo di insorgenza della malattia di Meniere non è completamente compreso. Tutti i metodi di terapia mirano principalmente ad alleviare le condizioni del paziente. Talvolta la terapia chirurgica comporta la distruzione dell'apparato vestibolare stesso. Se a un paziente viene diagnosticata la sindrome di Meniere, tutto dipende dal fatto che la causa della malattia sia nota. Se la malattia viene trattata con successo senza complicazioni, la sindrome di Meniere può essere eliminata in modo permanente.
Viene assegnato un gruppo di disabilità ai pazienti affetti dalla malattia di Meniere?
Di solito, quando viene diagnosticata la malattia di Meniere, ai pazienti non viene assegnato un gruppo di disabilità. Con una terapia efficace i pazienti si rimettono presto in piedi e, grazie alla prevenzione, sono pienamente in grado di lavorare. Un gruppo di disabilità può essere assegnato solo ai pazienti che rientrano nelle seguenti categorie:
- pazienti con sindrome di Meniere derivante da una malattia incurabile;
- pazienti con grave compromissione uditiva irreversibile;
- pazienti per i quali non è possibile selezionare una terapia efficace, ma gli attacchi si verificano frequentemente;
- pazienti con diagnosi di malattie gravi concomitanti.
Più spesso, il gruppo con disabilità viene assegnato a pazienti la cui malattia ha iniziato a manifestarsi durante l'infanzia, poiché la malattia di Meniere progredisce man mano che progredisce. Allo stesso tempo, l'udito si deteriora gradualmente e gli attacchi diventano più frequenti, il che porta il paziente alla disabilità e causa molti disagi nella vita di tutti i giorni.
Aggiornamento: ottobre 2018
La malattia o sindrome di Meniere è una malattia caratterizzata da danni alle strutture dell'orecchio interno, manifestati con ronzii nelle orecchie, vertigini e perdita transitoria dell'udito.
Gli studi hanno dimostrato che questa malattia si manifesta in 1 persona su 1000 (0,1%). Questo indicatore coincide approssimativamente con l'incidenza della sclerosi multipla.
La maggior parte dei pazienti sono persone di età superiore ai 40 anni. L’incidenza dello sviluppo tra uomini e donne è la stessa. La malattia (sindrome) di Meniere colpisce circa lo 0,2% dell'intera popolazione mondiale. La maggior parte dei pazienti sono anziani di età superiore ai 50-60 anni. Le donne si ammalano 1,5 volte più spesso degli uomini.
La malattia inizia come un processo unilaterale, diffondendosi successivamente ad entrambe le orecchie. Secondo vari studi, la malattia diventa bilaterale nel 17-75% dei casi entro 5-30 anni.
Ogni anno negli Stati Uniti vengono diagnosticati 46.000 nuovi casi. Sebbene non sia stata identificata alcuna associazione con un gene specifico, esiste una predisposizione familiare allo sviluppo della malattia. Nel 55% dei casi, la sindrome di Meniere è stata diagnosticata in parenti di pazienti o la malattia era presente nei loro antenati.
La malattia di Meniere nei personaggi famosi
- Alan Shepard, il primo astronauta americano e il quinto uomo a sbarcare sulla Luna. La malattia che lo bloccò dopo il suo unico volo spaziale fu diagnosticata nel 1964. Alcuni anni dopo, un intervento chirurgico sperimentale di shunt endolinfatico permise ad Alan di volare sulla luna come parte dell'equipaggio dell'Apollo 14;
- Jonathan Swift, scrittore satirico, poeta e sacerdote anglo-irlandese, soffriva di questa malattia;
- Varlam Shalamov, scrittore russo;
- Su Yu, un generale dell'Esercito popolare di liberazione che ottenne numerose vittorie significative durante la guerra civile cinese, fu ricoverato in ospedale nel 1949 con una diagnosi di malattia di Meniere. La malattia causò la sua rimozione dall'incarico di comandante per ordine di Mao Zedong durante la guerra di Corea;
- Ryan Adams, musicista americano, è stato costretto a interrompere la sua attività creativa per due anni a causa della rapida progressione della malattia. Dopo essersi sottoposto alle cure, è tornato sul palco senza permettere alla malattia di prendere il sopravvento.
Cause della sindrome di Meniere
La teoria più comune sull'insorgenza della malattia è un cambiamento nella pressione del fluido nell'orecchio interno. Le membrane situate nel labirinto si allungano gradualmente all'aumentare della pressione, il che porta a disturbi della coordinazione, dell'udito e altri disturbi.
La causa dell'aumento della pressione può essere:
- Blocco del sistema di drenaggio dei dotti linfatici (a causa di cicatrici dopo un intervento chirurgico o come malformazione congenita);
- Produzione eccessiva di liquidi;
- Aumento patologico del volume delle vie che conducono il fluido nelle strutture dell'orecchio interno.
L'allargamento delle formazioni anatomiche dell'orecchio interno è la condizione più comune diagnosticata nei bambini di origine sconosciuta. Inoltre, alcuni pazienti presentano un disturbo della coordinazione, che può causare lo sviluppo della malattia di Meniere.
Poiché la ricerca ha rivelato che non tutti i pazienti con sindrome di Meniere presentano un'aumentata produzione di liquidi nel labirinto e nella coclea, lo stato immunitario del paziente è diventato un ulteriore fattore che causa l'insorgenza della malattia.
L'aumento dell'attività degli anticorpi specifici nei pazienti esaminati viene rilevato in circa il 25% dei casi. La stessa quantità viene rilevata come malattia concomitante, il che conferma il ruolo dello stato immunitario nello sviluppo della malattia.
Secondo gli ultimi dati, le cause della malattia di Meniere nei pazienti esaminati nel 2014 rimangono poco chiare. I fattori di rischio includono:
- Malattie virali dell'orecchio interno;
- Lesioni alla testa;
- Anomalie congenite della struttura degli organi uditivi;
- Allergie e altri disturbi del sistema immunitario.
Sintomi della sindrome di Meniere
I sintomi caratteristici di questa malattia includono:
- ), spesso accompagnato da nausea e vomito. Un attacco di vertigini può essere così grave che il paziente ha l'impressione che l'intera stanza o gli oggetti circostanti ruotino attorno a lui. La durata dell'attacco dura da 10 minuti a diverse ore. Quando si gira la testa, la gravità dei sintomi aumenta e le condizioni del paziente peggiorano;
- Compromissione o perdita dell'udito. Il paziente potrebbe non percepire i suoni a bassa frequenza. Questo è un sintomo caratteristico che consente di distinguere la malattia di Meniere dalla perdita dell'udito, in cui si perde la capacità di percepire i suoni ad alta frequenza. Potrebbe verificarsi una maggiore sensibilità ai rumori forti, nonché dolore nelle stanze rumorose. In alcuni casi i pazienti lamentano toni “ovattati”;
- Fischi nelle orecchie non correlati alla sorgente sonora. Questo sintomo è un segno di danno agli organi uditivi. Nella malattia di Meniere, l'acufene è percepito come un "suono ovattato, un sibilo", un "cinguettio di cicale", un "suono di campanello" o una combinazione di questi suoni. Il ronzio nelle orecchie si intensifica prima di un attacco. Durante un attacco, la natura dello squillo può cambiare in modo significativo;
- Una sensazione di pressione o fastidio nell'orecchio dovuta all'accumulo di liquidi nella cavità dell'orecchio interno. Prima di un attacco, aumenta la sensazione di pienezza.
Durante un attacco, alcuni pazienti lamentano mal di testa, diarrea e dolore addominale. Immediatamente prima di un attacco, possono verificarsi sensazioni dolorose nell'orecchio.
I segnali di attacco includono una scarsa coordinazione quando si eseguono movimenti improvvisi e un aumento del ronzio nelle orecchie. Di solito l'inizio di un attacco è preceduto da una sensazione di “pienezza” o “pressione” nell'orecchio. Durante un attacco, il paziente avverte vertigini, perdita di coordinazione, nausea e vomito. In media, un attacco dura 2-3 ore. Alla fine dell'attacco, il paziente avverte una forte perdita di forza, affaticamento e sonnolenza. Esistono vari dati relativi alla durata dei sintomi (da “dossi” a breve termine a disturbi permanenti del benessere).
Una manifestazione relativamente grave della malattia, che può peggiorare la qualità della vita del paziente e determinarne il potenziale rischio, è una caduta improvvisa. La perdita di coordinazione si verifica a causa dell'improvvisa deformazione delle strutture dell'orecchio interno, che porta all'attivazione dei riflessi vestibolari.
Il paziente ha la sensazione di oscillare da un lato all'altro o di cadere (sebbene in questo momento possa rimanere in una posizione uniforme verticale) e cambia involontariamente la sua posizione per mantenere l'equilibrio. Questo sintomo è pericoloso perché si manifesta senza preavviso e può causare lesioni gravi. Spesso l'unico modo per sbarazzarsi di questo problema è il cosiddetto "trattamento distruttivo": labirintectomia o escissione del nervo vestibolare.
Le riacutizzazioni possono verificarsi a brevi intervalli sotto forma di "cluster" - una serie sequenziale di attacchi che si susseguono. In altri casi, l'intervallo tra gli attacchi può durare diversi anni. Al di fuori di una riacutizzazione, il paziente non nota alcun sintomo, oppure lamenta una lieve mancanza di coordinazione e un leggero ronzio nelle orecchie.
Trattamento
Esiste una cura?
Attualmente, la malattia di Meniere rimane una malattia incurabile, ma la terapia sintomatica è stata utilizzata con successo per controllare i sintomi e arrestare l’ulteriore progressione. Alcuni nuovi principi terapeutici si avvicinano molto alla guarigione completa (ad esempio, gentamicina a basso dosaggio).
La frequenza e l'intensità degli attacchi possono essere significativamente ridotte utilizzando metodi semplici, anche senza l'uso di farmaci. Si consiglia ai pazienti di seguire una dieta e uno stile di vita sano. È necessario rinunciare all'alcol, al fumo, al caffè e ad altri prodotti che possono peggiorare i sintomi della malattia.
Per controllare le manifestazioni della malattia nei pazienti con diagnosi di sindrome di Meniere, il trattamento prevede l'uso di farmaci antinausea, inclusi antistaminici (meclozina, trimetobenzamide) e altri gruppi (betaistina, diazepam). Particolare attenzione è rivolta alla betaistina, poiché è l'unico farmaco che ha un effetto vasodilatatore sui vasi dell'orecchio interno.
Preparati per uso a lungo termine
I diuretici possono essere utilizzati per ridurre la quantità di liquidi trattenuti. Una combinazione comune è triamterene e idroclorotiazide (Diazide). L'assunzione di diuretici riduce la quantità di liquidi nel corpo e normalizza la pressione nella cavità dell'orecchio interno.
L'assunzione di diuretici favorisce anche l'escrezione di grandi quantità di minerali (in particolare potassio), quindi è necessario adattare la dieta in modo che il potassio in essa contenuto superi la dose giornaliera minima richiesta (aggiungere banane, arance, spinaci, patate dolci).
Chirurgia
Se i sintomi continuano ad aumentare durante il trattamento, viene utilizzato un trattamento chirurgico più radicale. Sfortunatamente, la chirurgia non fornisce una garanzia al 100% di conservazione dell’udito.
Gli interventi di conservazione degli organi vengono utilizzati per normalizzare il funzionamento dell'apparato vestibolare senza rimuovere alcuna struttura anatomica. Di solito, tali operazioni sono accompagnate dall'introduzione di farmaci ormonali (desametasone, ecc.) Nell'orecchio medio.
Per migliorare temporaneamente le condizioni del paziente, viene utilizzata la decompressione chirurgica del sacco endolinfatico. La maggior parte dei pazienti sottoposti a questa operazione notano una diminuzione della frequenza e della gravità delle vertigini senza deterioramento o perdita dell'udito. Tuttavia, questo metodo non fornisce miglioramenti a lungo termine o la completa cessazione degli attacchi.
Gli interventi radicali sono irreversibili e comportano la rimozione completa o parziale di parti funzionali del sistema uditivo all'interno dell'area interessata. Tutte le strutture dell'orecchio interno vengono rimosse mediante labirintectomia. Dopo il trattamento, i sintomi associati alla malattia di Meniere regrediscono significativamente. Sfortunatamente, i pazienti perdono completamente la capacità di percepire i suoni durante l'operazione.
Un'alternativa è la labirintectomia chimica, che viene eseguita iniettando un farmaco (gentamicina) che provoca la morte delle cellule dell'apparato vestibolare. Questo metodo ha lo stesso effetto terapeutico della chirurgia, ma consente al paziente di preservare l'udito.
Iniezioni di farmaci nell'orecchio medio
Sono stati sviluppati numerosi metodi innovativi per combattere le vertigini e altri sintomi. La sindrome di Meniere viene trattata iniettando vari farmaci nell'orecchio medio. Successivamente penetrano nella cavità dell'orecchio interno e hanno un effetto simile all'intervento chirurgico.
- La gentamicina (un antibiotico con effetto ototossico) riduce la capacità di coordinare i movimenti delle strutture sul lato interessato. Di conseguenza, la funzione vestibolare viene assunta dall'orecchio sano. Il farmaco viene somministrato in anestesia locale. Dopo il trattamento, la frequenza e la gravità degli attacchi diminuiscono in modo significativo, sebbene vi sia un'alta probabilità di perdita dell'udito;
- Anche i farmaci ormonali (desametasone, prednisolone) aiutano a controllare i sintomi della malattia. I vantaggi dell’uso degli steroidi includono una bassa incidenza di perdita dell’udito. Lo svantaggio è che è meno efficace rispetto alla gentamicina.
Fisioterapia
Per la riabilitazione vestibolare vengono utilizzati metodi per migliorare la fissazione dello sguardo, ridurre le vertigini e migliorare la coordinazione attraverso esercizi speciali e uno stile di vita specifico.
Questo complesso di tecniche di trattamento è chiamato “riabilitazione vestibolare”. Con il suo aiuto è garantita una riduzione stabile della gravità dei sintomi della malattia e un miglioramento della qualità della vita dei pazienti.
Previsione
La malattia di Meniere è incurabile, ma non fatale. La perdita progressiva dell'udito può essere prevenuta con farmaci tra un attacco e l'altro o con un intervento chirurgico. I pazienti con sintomi moderati possono controllare con successo la malattia semplicemente seguendo una dieta.
Le conseguenze a lungo termine della malattia di Meniere comprendono la perdita dell'udito, l'aumento delle vertigini o le vertigini persistenti.
Sebbene la malattia in sé non sia mortale, può causare lesioni dovute a cadute o incidenti. Si raccomanda ai pazienti di esercitarsi con carichi moderati, mentre gli sport che richiedono un sistema vestibolare sano (ciclismo, motociclismo, alpinismo, alcuni tipi di yoga) dovrebbero essere evitati. Ai pazienti è inoltre vietato svolgere attività legate alla salita delle scale (costruzione, riparazione e tinteggiatura dei locali, ecc.).
La maggior parte dei pazienti (60-80%) riacquista le funzioni perdute, talvolta anche senza assistenza medica. I pazienti con forme gravi e complicate diventano disabili e successivamente necessitano di cure speciali.
La perdita dell'udito nel periodo iniziale è transitoria, diventando permanente nel tempo. Gli apparecchi acustici e gli impianti vengono utilizzati con successo per migliorare la condizione e ripristinare la funzione uditiva. L'acufene peggiora leggermente la qualità della vita, ma il paziente si abitua rapidamente.
La malattia di Meniere è una malattia con una prognosi imprevedibile. La frequenza e l'intensità degli attacchi possono aumentare o diminuire e quando il paziente perde le funzioni vestibolari, gli attacchi cessano.
La maggior parte dei ricercatori è attualmente di questa opinione la malattia di Meniereè una malattia indipendente. Tuttavia, se il quadro clinico della malattia è stato studiato in modo abbastanza completo, non esiste una chiara comprensione e unità di opinioni sull'eziologia e sulla patogenesi di questa malattia. Il substrato patomorfologico della malattia di Meniere è l'idrope labirintica, che si sviluppa con sovrapproduzione di endolinfa, ridotto riassorbimento e ridotta permeabilità delle biomembrane dell'orecchio interno.
Sono stati segnalati l'assenza di segni morfologici dell'idrope endolinfatica in persone che hanno sofferto di questa malattia durante la loro vita e la presenza di idrope endolinfatica in assenza di manifestazioni cliniche della malattia di Meniere. Questi fatti non si contraddicono a vicenda; dovrebbero essere considerati come collegamenti in un processo che si è sviluppato come risultato di una disfunzione vasomotoria, vale a dire spasmo o dilatazione dei vasi sanguigni e aumento della permeabilità delle loro pareti. L'eccessivo accumulo di endolinfa e la dilatazione del dotto endolinfatico sono un processo dinamico nello sviluppo continuo della malattia di Meniere.
La rilevanza dello studio della malattia di Meniere non diminuisce nel tempo. La mancanza di consenso su questioni di eziologia e patogenesi determina la varietà dei metodi di trattamento, compresi quelli conservativi e chirurgici.
La grande varietà di metodi conservativi per il trattamento della malattia di Meniere indica che nessuno di essi ha un'efficacia pronunciata e stabile. Attualmente non esiste un metodo di trattamento conservativo in grado di preservare o migliorare l’udito rallentando il decorso naturale della malattia e prevenendo la progressiva perdita dell’udito.
Il trattamento farmacologico della malattia di Meniere durante il periodo interictale è fondamentalmente poco diverso dal trattamento farmacologico nella fase acuta, solo la gamma dei farmaci si sta espandendo. Secondo G. Portmann, J. Ballantyne, J. Martin, la terapia conservativa è efficace solo durante una riacutizzazione, ad es. crisi; in tutti gli altri casi è indicato il trattamento chirurgico. K.Tokymasu et al. ritengono che il trattamento conservativo sia efficace solo nelle fasi iniziali della malattia. In effetti, i metodi conservativi forniscono solo un sollievo temporaneo, riducendo le vertigini e mitigando i disturbi autonomici. Anche i metodi chirurgici di trattamento si sono diffusi perché le visioni moderne sull'eziologia e sulla patogenesi della malattia di Meniere suggeriscono l'elevata efficacia degli interventi chirurgici. Una diagnosi topica accurata nella malattia di Meniere è la chiave per il successo del trattamento, in particolare il trattamento chirurgico, che consente non solo di eliminare gli attacchi di vertigini, ma in alcuni casi di stabilizzare l'udito. In questo caso, quanto più dettagliata è la diagnosi e l'analisi dei sintomi patologici, tanto più efficaci sono le tattiche terapeutiche.
Negli ultimi decenni, la Russia ha accumulato una vasta esperienza nel trattamento chirurgico della malattia di Meniere. Riteniamo che il criterio per l'efficacia del trattamento chirurgico e la conferma della correttezza delle indicazioni sviluppate per esso sia l'analisi dei risultati a lungo termine. Più lungo è il periodo di osservazione, più oggettivi e affidabili saranno i risultati. Un lungo periodo di osservazione permette di osservare il decorso della malattia di Meniere nel tempo. Nella letteratura a nostra disposizione il periodo di osservazione dei risultati del trattamento chirurgico della malattia di Meniere è prevalentemente limitato ad un periodo compreso tra 6 mesi e 5-7 anni, il che è insufficiente. Alcuni autori considerano i risultati del trattamento chirurgico dopo 14-17 anni, tuttavia analizzano lo stato solo dell'analizzatore uditivo o solo vestibolare, più spesso senza tener conto delle indicazioni per il trattamento chirurgico e senza confronto con lo stato della funzione dell’orecchio interno in pazienti trattati in modo conservativo. In alcuni casi, i risultati vengono valutati solo sulla base dei cambiamenti nelle condizioni del paziente dopo l’intervento chirurgico o vengono fornite singole osservazioni. Pertanto, la domanda rimane poco chiara: quali operazioni per la malattia di Meniere sono le operazioni di scelta, quali sono le indicazioni e le controindicazioni per ciascuna di esse.
Da un punto di vista moderno, il trattamento chirurgico della malattia di Meniere dovrebbe basarsi su tre principi: 1) miglioramento del drenaggio dell'endolinfa; 2) aumentare le soglie di eccitabilità dei recettori vestibolari; 3) il desiderio di preservare e migliorare l'udito.
Un esempio di intervento chirurgico per la malattia di Meniere è l'intersezione del nervo vestibolare.
Tutti gli interventi chirurgici possono essere divisi in tre gruppi. 1° gruppo: operazioni distruttive in cui sezione intracranica della porzione vestibolare dell'VIII paio di nervi cranici, o le sue terminazioni recettoriali nel labirinto vengono distrutte: a) rimozione del labirinto membranoso; b) elettrocoagulazione del labirinto dopo fenestrazione del canale semicircolare orizzontale; c) introduzione di alcol assoluto nel labirinto o somministrazione intratimpanica mediante drenaggio continuo di streptomicina, gentamicina o somministrazione transmiringea di una soluzione di pantocianina al 2%; d) distruzione dell'apparato vestibolare mediante esposizione ad ultrasuoni o laser dopo apertura del canale semicircolare orizzontale con approccio transmastoideo; D) resezione della porzione vestibolare dell'VIII nervo intracranico.
Gruppo 2 - interventi chirurgici sul labirinto, volti a normalizzare la pressione del fluido e la circolazione sanguigna nell'orecchio interno: a) drenaggio dello spazio perilinfatico mediante fenestrazione del canale semicircolare orizzontale, perforazione della base della staffa, platinectomia o stapedectomia; b) drenaggio endo- o perilinfatico del canale semicircolare orizzontale e del vestibolo mediante sacculotomia, criochirurgia e osmoinduzione, cocleostomia; c) interventi sul sacco endolinfatico finalizzati alla sua decompressione (esposizione, drenaggio, shunt).
Gruppo 3 - interventi chirurgici sul sistema nervoso autonomo: a) simpaticectomia dorsale cervicale; b) taglio o resezione della corda del timpano; c) intersezione o resezione del plesso timpanico.
Quasi tutti i tipi di operazioni distruttive mirano a disattivare la funzione degli analizzatori cocleari e vestibolari e pertanto possono essere utilizzati solo in presenza di sordità. Solo l'elettrocoagulazione del labirinto e l'esposizione agli ultrasuoni o al laser mirano selettivamente a sopprimere la funzione vestibolare e a preservare la funzione cocleare. Ma durante l'esposizione agli ultrasuoni, non solo le formazioni recettoriali del canale semicircolare, ma anche la coclea sono sottoposte a sondaggio, e quindi si verifica un progressivo deterioramento dell'udito fino alla sordità.
Nelle prime fasi dopo la distruzione laser selettiva dei canali semicircolari (2-5 anni), è stata osservata la scomparsa delle vertigini nel 91,7% dei casi. Gli autori spiegano la diminuzione dell'efficacia complessiva dell'intervento nel 57,9% nell'arco di 5-10 anni e la ripresa di rari e lievi capogiri nel 10,5% a causa del coinvolgimento del labirinto dell'altro orecchio nel processo. L'eliminazione delle vertigini dopo neurectomia vestibolare retrolabirintica è stata osservata nel 90-96,7% (periodo di osservazione 6 anni).
La labirintectomia eseguita con attenzione porta al sollievo di gravi disturbi vestibolari e può essere considerata il metodo di scelta per le lesioni periferiche unilaterali dell'apparato vestibolare in combinazione con una perdita dell'udito di alto grado. In presenza di sordità e manifestazioni vestibolari pronunciate, la cessazione degli attacchi di vertigini può essere ottenuta mediante resezione della porzione vestibolare dell'VIII nervo e somministrazione intratimpanica di gentamicina o streptomicina.
L'effetto delle operazioni distruttive può essere spiegato dall'ipofunzione e, in alcuni casi, disattivando la funzione dell'analizzatore vestibolare. In generale, le operazioni distruttive sono interventi complessi e non sicuri. Insieme alla perdita dell'udito, a volte sono complicati da paralisi facciale e meningite. Considerando la complessità e l'alto grado di rischio insieme ai risultati positivi a lungo termine, le operazioni distruttive non si sono diffuse nel trattamento della malattia di Meniere.
Gli interventi chirurgici sul sistema nervoso autonomo non si basano su modelli convincenti di patogenesi e si basano su osservazioni sperimentali e cliniche che confermano la connessione dei vasi dell'orecchio medio e interno con lo stato del sistema nervoso autonomo. Queste operazioni hanno lo scopo di fermare gli impulsi afferenti e migliorare il trofismo dell'organo. Tuttavia, la simpaticectomia dorsale, essendo un intervento tecnicamente complesso, non può sempre essere eseguita in un ospedale otorinolaringoiatrico. Gli interventi sui nervi della cavità timpanica sono tecnicamente gli interventi più semplici tra tutti quelli utilizzati per curare la malattia di Meniere. Sono più facili da tollerare da parte dei pazienti e non richiedono lunghi periodi di degenza ospedaliera.
Gli interventi chirurgici sui nervi della cavità timpanica nella malattia di Meniere furono utilizzati per la prima volta da Rosen nel 1955. L'autore, argomentando a favore dell'intervento proposto, ha scritto che il plesso timpanico e la corda del timpano trasmettono impulsi afferenti al nucleo sensoriale, che è funzionalmente connesso con i nuclei vestibolari.
Risultati a lungo termine in tempi diversi dopo interventi sui nervi della cavità timpanica (periodo massimo di osservazione 17 anni) confermano che la cordoplexustomia è indicata negli stadi I-II della malattia di Meniere, quando è presente idrope di primo grado, con moderata o ridotta capacità secretoria dell'orecchio interno, con aumento della soglia di percezione non superiore a 35 dB.
I migliori risultati sono stati ottenuti quando questo metodo è combinato con bicarbonato di sodio o trisamina per via endovenosa. Nella malattia di Meniere allo stadio III, questa operazione si è rivelata inefficace. Tuttavia, la cordoplexustomia ha un effetto positivo sulle vertigini solo durante i primi due anni dopo l'intervento. L’udito nella maggior parte dei pazienti non è cambiato, ma è progressivamente diminuito nel tempo. Nella moderna letteratura straniera non ci sono dati sugli interventi sui nervi della cavità timpanica, e ciò indica che questi interventi vengono attualmente eseguiti solo in Russia e sono stati abbandonati all'estero.
La fine degli anni '70 - l'inizio degli anni '80 furono caratterizzati da una tendenza verso il trattamento chirurgico precoce dei pazienti con malattia di Meniere, con una preferenza per metodi di decompressione volti ad eliminare l'idrope dell'orecchio interno e preservarne la funzione attraverso l'intervento diretto sul sistema endolinfatico - drenaggio o esposizione della sacca dell'area endolinfatica Gli interventi chirurgici sul sacco endolinfatico sono sembrati più delicati e fisiologici, poiché vengono eseguiti a distanza dai recettori cocleari, che hanno aumentato la vulnerabilità a qualsiasi impatto nella malattia di Meniere. Queste operazioni consentono di ottenere lo scarico del sacco endolinfatico, il che è giustificato dal punto di vista del riconoscimento dell'idrope labirintica come anello centrale nella patogenesi della malattia di Meniere.
Il primo intervento sul sacco endolinfatico fu eseguito da G. Portmann nel 1926. L'intervento consisteva nell'esporre la parete esterna del sacco endolinfatico e nel sezionarlo. Successivamente, per creare un drenaggio a lungo termine, sono stati utilizzati la resezione della parete del sacco e l'introduzione di polietilene, pellicole di teflon, tubi di nylon nell'incisione della sua parete, nonché drenaggio con valvola dosata e drenaggio laser. Gli interventi sul sacco endolinfatico comportano il drenaggio dell'endolinfa nella cavità mastoidea. Esiste un metodo per decomprimere lo spazio endolinfatico creando una connessione con lo spazio subaracnoideo: lo shunt subaracnoideo secondo W. House. È difficile giudicare i vantaggi dell'uno o dell'altro metodo di drenaggio del sacco endolinfatico. Secondo M. Glasslock et al. , lo shunt mastoideo presenta vantaggi rispetto allo shunt subaracnoideo a causa della possibilità di gravi complicazioni durante lo shunt dello spazio subaracnoideo con un alto rischio di danni all'udito.
Inizialmente, le indicazioni per il drenaggio del sistema endolinfatico, secondo la letteratura straniera, erano: malattia grave, manifestata da attacchi frequenti o gravi di vertigini con gravi disturbi statici e violenti sintomi vegetativi; mancanza di effetto da cicli ripetuti di terapia conservativa durante tutto l'anno; presenza di un udito socialmente inadatto.
Per la prima volta in Russia, gli interventi sul sacco endolinfatico furono eseguiti nella clinica ORL del 2° Istituto medico statale regionale di Mosca nel 1976 dal prof. VT Dito. Successivamente, dopo aver analizzato i risultati degli interventi chirurgici sul sacco endolinfatico nelle prime fasi di osservazione (fino a 4 anni), sono state sviluppate indicazioni cliniche e audiologiche per la decompressione del sacco endolinfatico.
Nel 1982 V.T. Palchun, V.I. Aslamazova, M.I. Kadymova e T.S. Polyakova ha sviluppato criteri diagnostici clinici differenziali per l'idrope perilinfatica, indicazioni per il drenaggio e l'esposizione del sacco endolinfatico, nonché per la cordoplexustomia sulla base dei risultati degli interventi chirurgici per un periodo di follow-up fino a 4 anni. Si è scoperto che i risultati positivi del drenaggio del sacco endolinfatico sono possibili solo se, nel decidere sulla necessità dell'intervento chirurgico, si tiene conto dello stato funzionale della coclea e della sua risposta alla disidratazione diagnostica; quest'ultimo può essere visto come un prototipo di drenaggio.
La gravità del decorso clinico della malattia e la mancanza di effetto della terapia conservativa non possono costituire il criterio principale per l'indicazione al drenaggio o alla decompressione del sistema endolinfatico, poiché ciò non sempre porta ad un miglioramento dell'udito. Il drenaggio del sacco endolinfatico è consigliabile nello stadio II della malattia, quando si riscontra idrope persistente e viene diagnosticata una reidratazione accelerata o moderata. L'esposizione del sacco endolinfatico è indicata anche nello stadio II della malattia, ma con un tasso di reidratazione moderato o lento. Allo stesso tempo, è stato notato un miglioramento dell'udito nell'85% dei casi, un miglioramento e stabilizzazione del livello iniziale dell'udito - nel 95%, la completa cessazione e una riduzione della frequenza e dell'intensità delle vertigini - nel 97% dei casi (periodo di osservazione 4 anni).
Se l'idrope è assente o la velocità di reidratazione è rallentata, quando il sacco endolinfatico viene drenato, il sistema endolinfatico risulta sovraccaricato, con conseguente aumento significativo delle soglie uditive, spesso a un livello socialmente inadeguato. Pertanto, nello stadio I della malattia, quando l'idrope è ancora instabile e si risolve rapidamente, il drenaggio del sacco endolinfatico è controindicato. Il drenaggio del sacco endolinfatico durante l'idrope perilinfatica influisce negativamente anche sulla funzione dell'orecchio interno, poiché una violazione della tenuta dello spazio endolinfatico crea le condizioni per la deformazione del labirinto membranoso. Nello stadio III della malattia, quando l'idrope non viene rilevata a causa dell'irreversibilità dei cambiamenti nella coclea, il drenaggio del sacco endolinfatico diventa inefficace.
Analizzando i risultati a lungo termine degli interventi sul sacco endolinfatico in vari periodi di follow-up (da 5 a 17 anni), si è riscontrato che gli attacchi di vertigini cessano nel 71-96% dei casi, ma in un certo numero di pazienti l'instabilità rimane quando si cammina, si avverte una sensazione di “oscillazione”, in 21. Nel 5% non si notano cambiamenti significativi, nel 6,6% si osserva un peggioramento della condizione. Per quanto riguarda l'udito, i risultati presentati sono stati peggiori: se subito dopo l'intervento sul sacco endolinfatico l'udito è migliorato nel 30% dei pazienti, successivamente è progressivamente diminuito, anche se la maggior parte dei pazienti non ha manifestato attacchi di vertigini. Gli autori hanno registrato un miglioramento dell'udito rispetto all'udito preoperatorio solo nel 10-30% dei pazienti. Nel 36%, l'udito non è cambiato durante l'intero periodo di tempo, nel 52% si è verificata una diminuzione dell'udito e nel 6% dei pazienti è stata osservata una perdita uditiva completa. Il rumore è scomparso o diminuito nel 40-60% dei pazienti.
L’intervento di decompressione del sacco endolinfatico è sicuro ed efficace. Drenaggio ed esposizione del sacco endolinfatico, secondo V.T. Palchuna, M.I. Kadymova, sono efficaci a vari livelli; Secondo altri autori il trattamento più efficace per la malattia di Meniere è il drenaggio del sacco endolinfatico. Secondo D. Welling et al. , il drenaggio del sacco endolinfatico è un intervento più distruttivo dell'esposizione, poiché comporta la rimozione del sacco endolinfatico periostale con taglio della parte intraossea. Infatti, qualsiasi intervento che preservi l'integrità delle strutture dell'orecchio interno è più fisiologico. Gli autori stranieri sottolineano la maggiore efficacia degli interventi sul sacco endolinfatico rispetto all'effetto degli interventi distruttivi e del trattamento conservativo.
Le complicanze osservate sono dello 0-6% e sono rappresentate principalmente da ematomi (fino al 5%), liquorrea o otite idrocefala, sordità (fino al 3%), soprattutto all'apertura della parete del canale semicircolare posteriore, aracnoidite. Le recidive si osservano nel 10-16% dei casi e si spiegano o con l'ostruzione del tubo di drenaggio da parte di granulazione o tessuto connettivo, oppure con la presenza di lesioni bilaterali. Una fistola liquorale che si aprì in una cicatrice postoperatoria 8 mesi dopo il drenaggio del sacco endolinfatico fu descritta da V.T. Palchun, M.I. Kadymova in una paziente con idrope bilaterale. Si ritiene che sia correlato all'aumento della pressione intracranica nella fossa posteriore. Dopo la terapia di disidratazione, la fistola si è chiusa.
Confrontando i risultati del trattamento della malattia di Meniere con vari tipi di interventi chirurgici secondo la letteratura, possiamo concludere che l'efficacia delle singole operazioni in relazione ai disturbi vestibolari è approssimativamente la stessa e ammonta al 71-96%. Per quanto riguarda la funzione uditiva, gli interventi distruttivi spesso portano alla sua perdita; gli interventi sui nervi della cavità timpanica nel primo periodo postoperatorio non provocano cambiamenti nell'udito, ma a lungo termine portano ad una progressiva diminuzione dell'udito. La stabilizzazione e il miglioramento dell'udito sono possibili solo a seguito di operazioni di decompressione sul sacco endolinfatico: il miglioramento dell'udito è stato ottenuto in media nel 10-30% dei casi, la stabilizzazione nel 36% dei casi, ma nel 52% dei casi l'udito è peggiorato. I dati presentati indicano l’efficacia relativamente bassa della decompressione del sacco endolinfatico in relazione all’udito. Ciò può essere spiegato dal fatto che le operazioni di decompressione sono state eseguite sul paziente prima che fossero sviluppate indicazioni chiare al riguardo. Inoltre, non sempre veniva presa in considerazione la bilateralità della lesione e l'intervento veniva solitamente eseguito sul lato dell'orecchio meno uditivo.
Tutti i metodi di trattamento chirurgico della malattia di Meniere sono prevalentemente di natura palliativa e sebbene interrompano parzialmente la catena del processo patologico (ad esempio il drenaggio del sacco endolinfatico), non influenzano la patogenesi dell'idrope. Tuttavia, dato che la gravità della malattia di Meniere è determinata in misura maggiore dalla frequenza e dalla durata delle crisi vestibolari e dalla gravità dei disturbi autonomici, solo l'attenuazione della loro natura a seguito dell'intervento chirurgico porta sollievo al paziente. Ad oggi il trattamento più efficace e sicuro per la malattia di Meniere è l'intervento di decompressione del sacco endolinfatico, che consente non solo di preservare, ma anche di migliorare l'udito. Pertanto, le questioni relative all'eziologia, alla patogenesi, nonché ai problemi del trattamento conservativo e chirurgico della malattia di Meniere rimangono rilevanti.
N.A. Papina. Bollettino di Otorinolaringoiatria N. 4, 2000, pp. 67-70.
Letteratura:
1. Belyakova L.V. Vestn Otorinolar 1972; 1:31-35.
2. Vishnyakov V.V. Atti del II MOLGMI intitolato. N.I. Pirogov. Serie ORL 1978; 3: 74-81.
3. Volkov Yu.N. Atti del II MOLGMI intitolato. N.I. Pirogov. Serie ORL 1975; 2: 67-70.
4. Makhmudov U.V., Blagoveshchenskaya N.S. Giornale di Neurochirurgia dal nome. N.N. Burdenko 1993; 4: 8-10.
5. Nikolaev M.P. Possibilità e prospettive per l'uso della radiazione laser nella malattia di Meniere. Abstract dell'autore. dis... Dott. med. Sci. M1985.
6. Palchun V.T., Aslamazova V.I., Polyakova T.S. Atti del II MOLGMI intitolato. N.I. Pirogov. Serie ORL. M1978; 3: 14-18.
7. Palchun V.T., Gorgiladze G.I., Kadymova M.I., Bulaev Yu.O. Vestn Otorinolar 1981; 5: 7-12.
8. Palchun V.T. Astratto. rapporto VIII Congresso di Otorinolaringoiatria. L'URSS. Suzdal 1982; 207-208.
9. Palchun V.T., Aslamazova V.I., Polyakova T.S., Kadymova M.I. e altri Clinica e diagnosi della malattia di Meniere: Metodo. raccomandazioni. M1984; 4-18.
10. Palchun V.T., Kadymova M.I. Vestn Otorinolar 1994; 2:5-9.
11. Patyakina O.K., Nikolaev M.P. Estratti delle relazioni della 4a rep. scientifico conf. otorinolo. Lettone. RSS. Riga 1978; 66-68.
12. Patyakina O.K., Sheremet A.S., Tverskoy Yu.L. Metodi fisici di diagnosi e trattamento in otorinolaringoiatria. Rappresentante. Sab. scientifico lavori M1992; 37: 88-96.
13. Patyakina O.K., Sheremet A.S., Tverskoy Yu.L. Patologia dell'orecchio interno. Sab. scientifico lavori M1993; 157-160.
14. Patyakina O.K., Sheremet A.S. Congresso degli otorinolaringoiatri della Russia: 15. Estratti delle relazioni. San Pietroburgo 1995; 143-146.
15. Patyakina O.K., Sheremet A.S. Vestn Otorinolar 1998; 1: 18-21.
16. Petrova L.N., Makarevich I.G. Problemi di diagnosi della patologia dell'orecchio interno. Sab. scientifico lavori San Pietroburgo 1993; 96-100.
17. Polyakova T.S. Diagnosi clinica e audiologica e indicazioni al trattamento chirurgico della malattia di Meniere. Dis....cand. Miele. Sci. 1982; 198.
18. Pomukhina A.N. Novità otorinolaringoiatriche e logopatiche 1995; 3:4:73-74.
19. Sagalovich B.M., Palchun V.T. La malattia di Meniere. M1999; 524.
20. Soldatov I.B. Novità nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Meniere: discorso reale al Samara Medical Center. in quelle Samara 1991.
21. Malattia di Meniere (Manuale di otorinolaringoiatria). Ed. I.B. Soldatova. 2a ed., riveduta. e aggiuntivi M: Medicina 1997; 185-200.
Una delle malattie misteriose fino ad oggi rimane la malattia di Meniere. È conosciuta e identificata come una malattia separata da molto tempo, più di un secolo e mezzo fa, ma la scienza medica non conosce ancora la ragione esatta del suo sviluppo. Questa malattia non è molto comune; le statistiche approssimative parlano di circa 10 persone affette da questa malattia ogni 10.000 abitanti. Tuttavia, la tragedia di ogni singolo paziente costringe la scienza e la pratica medica a lavorare per combattere e proteggere efficacemente questa patologia.
La malattia di Meniere è una malattia dell'orecchio interno. La malattia si sviluppa più spesso da un lato, sebbene in 1 paziente su 10 la lesione sia bilaterale. L'età delle persone affette da questa malattia è nella media (20-50 anni), la patologia non viene praticamente diagnosticata nei bambini e negli adolescenti. 
Alcuni autori distinguono separatamente la sindrome di Meniere, che descrive un complesso di sintomi clinici simili alle manifestazioni della malattia con lo stesso nome. Ma la differenza è che non è indipendente e si manifesta in altre patologie esistenti (alterazione del flusso sanguigno e del deflusso dovuto a distonia vegetativa-vascolare, aterosclerosi, anomalie congenite delle arterie e delle vene del cervello) insieme ad altri segni caratteristici di esse.
Cause della malattia
Medici e scienziati sono riusciti a stabilire i meccanismi patologici a seguito dei quali una persona sviluppa sintomi caratteristici, ma nessuno è ancora riuscito a identificare le vere ragioni sotto l'influenza delle quali vengono attivati.
L'orecchio interno umano è costituito da due sezioni: uditiva e vestibolare. Il primo contiene recettori che percepiscono i suoni e un complesso apparato osseo-legamentoso ausiliario, una sorta di amplificatore del suono. Il dipartimento vestibolare è responsabile della valutazione della posizione del corpo e delle sue parti nello spazio e della loro reciproca coordinazione. È necessario affinché una persona possa stare in piedi, camminare, correre ed eseguire altri movimenti, spesso molto complessi, in modo coordinato.

Nei pazienti con diagnosi di malattia di Meniere, nei tre canali semicircolari dell'apparato vestibolare e nella coclea uditiva aumenta la produzione di liquido, che normalmente dovrebbe esserci, ma in quantità adeguate. E con un aumento di quest'ultimo, si verifica una pressione costante su cellule recettoriali complesse, sensibili e altamente organizzate. Sotto questo influsso, che dura molti mesi e anni, si atrofizzano. Di conseguenza, l'udito di una persona è indebolito, fino alla sua completa perdita, e la coordinazione dei movimenti è compromessa. 
Sono stati identificati fattori predisponenti che aumentano la probabilità di sviluppare questa malattia:
- Lesioni traumatiche dell'orecchio interno;
- Processi infiammatori in esso;
- Patologie vascolari (generali e locali);
- Infezione virale;
- Grave stress;
- Tendenza ereditaria.
Viene considerata la teoria dell'infiammazione autoimmune, in cui il sistema immunitario attacca i tessuti del corpo. Si attiva quando esposto a qualsiasi fattore esterno e aiuta ad aumentare la produzione di liquido nelle cavità degli analizzatori sensibili. Esiste anche una versione della patologia dell'innervazione vascolare, cioè un danno primario al sistema nervoso e, di conseguenza, una maggiore permeabilità dei capillari con un aumento del rilascio di plasma da essi.
Segni clinici della malattia
La patologia si manifesta con periodi di esacerbazione e remissione (attenuazione del processo acuto). Il sintomo principale nella prima fase sono gli attacchi caratteristici.
Sintomi specifici della malattia di Meniere:
- Vertigini improvvise e gravi con perdita di equilibrio, il paziente cade, a volte non riesce nemmeno a sedersi;
- Violazione della determinazione da parte di una persona della posizione del suo corpo e delle sue parti nello spazio.

Ulteriori segni del sistema nervoso autonomo:
- Nausea;
- Aumento o calo della pressione sanguigna;
- Sudorazione;
- Pallore della pelle.
Sentimenti umani soggettivi:
- Girare gli oggetti intorno;
- Rotazione del proprio corpo o di sue parti.
Gli attacchi patologici si fermano dopo la morte della stragrande maggioranza delle cellule recettrici dell'analizzatore vestibolare e uditivo. Clinicamente, questo è caratterizzato da completa sordità nell'orecchio interessato.
Diagnostica aggiuntiva
Per valutare il grado di disfunzione degli analizzatori uditivi e di equilibrio, vengono utilizzati vari metodi: otoscopia, audiometria, vestibolometria e altri.
È inoltre necessaria la diagnosi differenziale per escludere malattie accompagnate da sintomi simili. A questo scopo vengono utilizzati vari metodi:
- Esame del cervello e del midollo spinale: radiografia del cranio, TC, risonanza magnetica nucleare, mielografia.
- Esame vascolare: ecografia (Doppler), radiografia con contrasto.
- Diagnosi di malattie del sistema endocrino e disturbi metabolici: esame del sangue biochimico, testandolo per il contenuto di principi attivi ormonali.
- A volte è necessaria una consultazione con un neurologo o uno psichiatra.
Con gravi sintomi del sistema nervoso autonomo e lievi vertigini primarie, il medico spesso diagnostica inizialmente altri disturbi: ipertensione arteriosa, malattie del tratto gastrointestinale e altri. Dopo un esame clinico completo e la determinazione del primato degli attacchi caratteristici, viene fatta la diagnosi della malattia di Meniere.
Terapia
Sostegno conservatore
Il trattamento della malattia di Meniere ha lo scopo di eliminare i sintomi della malattia e migliorare la qualità della vita del paziente. Nelle fasi iniziale e intermedia della malattia viene utilizzata la terapia farmacologica, il cui scopo è riducendo la produzione di liquidi nell'orecchio interno, migliorando la microcircolazione, proteggendo i vasi sanguigni e  cellule simili ai neuroni analizzatori sensibili: uditivi e vestibolari. Medicinali utilizzati:
cellule simili ai neuroni analizzatori sensibili: uditivi e vestibolari. Medicinali utilizzati:
- Diuretici;
- Sedativi (calmanti);
- Venotonico;
- Antistaminici.
Terapia acuta conservativa
Per fermare gli attacchi vengono utilizzati:
- Neurolettici;
- Anticolinergici (atropina, scopolamina);
- Antispastici;
- Antistaminici;
- Farmaci diuretici;
- Antiemetici.
Trattare una malattia senza conoscerne la causa è difficile e soprattutto inutile. Seguendo il piano terapeutico, un'assistenza tempestiva e completa durante gli attacchi riduce la frequenza degli attacchi, la loro durata e gravità, ma progrediscono costantemente. Ciò porta i pazienti a diventare gradualmente incapaci di lavorare. Le persone affette da malattia di Meniere da moderata a grave diventano disabili.
Chirurgico
Se il trattamento conservativo è inefficace, vengono eseguiti interventi chirurgici. A seconda dell’effetto prodotto si dividono in:
- Drenante. Aumentare il deflusso del fluido dall'orecchio interno.
- Distruttivo. Viene eseguita la distruzione delle sezioni riceventi e trasmittenti degli analizzatori sensibili.
- Sul sistema nervoso autonomo. I nervi simpatici e/o parasimpatici vengono incrociati, il che interrompe la trasmissione degli impulsi patologici dalla parte ricevente dell'analizzatore al sistema nervoso centrale.

L'operazione di distruzione chimica delle strutture dell'orecchio interno si chiama “ablazione” e diventa un'alternativa all'intervento chirurgico, ad esempio, quando è controindicato per il paziente. In questo caso vengono introdotte sostanze chimicamente attive che provocano una violenta infiammazione e successivo riempimento dell'orecchio interno con tessuto connettivo (sclerosazione).
Ulteriori
A volte i pazienti necessitano di una psicoterapia seria.
Stile di vita
Questa è una parte importante del regime di trattamento per questa malattia; si consiglia ai pazienti di:
- Seguire una dieta povera di sale, prestare attenzione alla qualità del cibo;
- Eseguire esercizi per allenare l'apparato vestibolare;
- Condurre uno stile di vita attivo e abbandonare le cattive abitudini;
- Presta attenzione al regime di veglia e sonno, lavoro e riposo. Il superlavoro e la mancanza di sonno impoveriscono il sistema nervoso e contribuiscono alla frequenza degli attacchi.
I rimedi popolari non sono praticamente utilizzati nel trattamento di questa malattia, poiché la loro efficacia è bassa.  Le erbe medicinali vengono utilizzate in via ausiliaria per ridurre la pressione del fluido nell'orecchio interno. Questi includono preparati a base di erbe con effetto diuretico (infuso di aneto), sedativi (decotto di erba madre), antiemetici (preparati di menta, cumino, centaurea). Vengono utilizzate anche le seguenti piante medicinali: epilobio, trifoglio, rosa canina, biancospino; da esse si preparano decotti e infusi, che vengono assunti per via orale in lunghe portate.
Le erbe medicinali vengono utilizzate in via ausiliaria per ridurre la pressione del fluido nell'orecchio interno. Questi includono preparati a base di erbe con effetto diuretico (infuso di aneto), sedativi (decotto di erba madre), antiemetici (preparati di menta, cumino, centaurea). Vengono utilizzate anche le seguenti piante medicinali: epilobio, trifoglio, rosa canina, biancospino; da esse si preparano decotti e infusi, che vengono assunti per via orale in lunghe portate.
Prevenzione
Le questioni relative alla prevenzione della patologia, la cui causa rimane ancora un mistero, sono irrilevanti. Per ridurre il rischio di sviluppare la malattia sono possibili solo misure generali per prevenire lesioni, infezioni generalizzate e infiammazioni locali dell’orecchio medio e interno.
Video: Malattia di Meniere, “Vivere sano”
La malattia di Meniere è una malattia dell'orecchio interno che provoca una caratteristica triade di sintomi nel paziente (vertigini, perdita dell'udito e rumore), associata a una violazione dell'idrodinamica del labirinto uditivo e che porta a una perdita dell'udito irreversibile. La malattia prende il nome dallo scienziato che per primo ne descrisse i sintomi.
Questa patologia si verifica in rappresentanti di entrambi i sessi, di solito debuttando all'età di 30-60 anni. Sono note varie varianti del decorso della malattia di Meniere: da lieve con attacchi rari a grave debilitante. Tuttavia, in entrambi i casi, “perseguita” una persona per tutta la vita. Questa malattia peggiora significativamente la qualità della vita dei pazienti e, nonostante non rappresenti una minaccia immediata per loro, è una malattia grave. Le crisi vestibolari ripetute sono dolorose per una persona, riducono la sua capacità lavorativa, portano e alla fine possono causare disabilità.
Cause e meccanismi di sviluppo della malattia
Cosa succede nell'orecchio con la malattia di MeniereLa malattia di Meniere è una di quelle condizioni patologiche le cui cause esatte rimangono poco chiare e non completamente comprese. Si ritiene che si basi sull'aumento della formazione del fluido intralabirintico, dell'idrope del labirinto e del suo allungamento. Questa condizione si sviluppa spesso in individui con imperfezioni congenite del sistema vascolare e della sua regolazione autonomica, ma può verificarsi anche in individui assolutamente sani. Inoltre, tali cambiamenti sono causati dall'influenza di fattori dannosi sul lavoro (rumore, vibrazioni) e stress frequenti, malattie del sistema cardiovascolare ed endocrino. Sotto l'influenza di questi fattori, la permeabilità della barriera sangue-labirintica può cambiare, mentre nell'endolinfa (fluido intra-labirintico) si accumulano vari metaboliti che hanno un effetto tossico sulle strutture dell'orecchio interno. In realtà, l'idropisia degli spazi endolinfatici porta al loro allungamento eccessivo, alla deformazione e al danno meccanico con la formazione di cicatrici. Un aumento della pressione nel labirinto favorisce la protrusione della base della staffa nella cavità timpanica. Tutto ciò complica la circolazione dell'endolinfa e la conduzione dell'onda sonora, interrompe la nutrizione dell'apparato recettore della coclea, porta alla sua degenerazione e interrompe il normale funzionamento dell'intero sistema nel suo insieme.
Si presume che gli attacchi tipici avvengano a causa del deterioramento del funzionamento dei recettori vestibolari da un lato e della loro sovrastimolazione dall'altro.
Va notato che in alcuni pazienti i sintomi caratteristici della malattia di Meniere hanno cause specifiche, come ischemia o emorragia nel labirinto, trauma o processo infiammatorio, ecc. In tali casi, il complesso di sintomi che si presenta dovrebbe essere definito come sindrome di Meniere.
Manifestazioni cliniche
Tutte le persone affette dalla malattia di Meniere presentano i seguenti sintomi patologici:
- attacchi di vertigini sistemiche con nausea, vomito, perdita di coordinazione e disturbi autonomici;
- perdita dell'udito in questo orecchio.
Nella maggior parte dei casi, la malattia inizia con una lesione unilaterale del labirinto, dopo qualche tempo anche il secondo orecchio è coinvolto nel processo patologico. In alcuni pazienti, i sintomi principali sono attacchi di vertigini, in altri - perdita dell'udito. Spesso l'esordio dei disturbi uditivi e vestibolari varia nel tempo, anche se possono manifestarsi contemporaneamente. La perdita dell’udito progredisce gradualmente e porta alla sordità.
Una caratteristica di questa patologia è una certa variabilità dell'udito. Durante un attacco, l'udito si deteriora bruscamente e, dopo il miglioramento, viene parzialmente ripristinato. Ciò si verifica in una fase reversibile della malattia, che dura diversi anni.
Gli attacchi di vertigini in ogni persona hanno le proprie caratteristiche di insorgenza, frequenza e durata. Possono disturbare il paziente ogni giorno, più volte alla settimana o al mese, oppure possono comparire una volta all'anno. Anche la loro durata varia da pochi minuti a un giorno, in media è di 2-6 ore. L'inizio tipico di un attacco è al mattino o alla sera, ma può verificarsi in qualsiasi altro momento della giornata.
Alcuni pazienti anticipano un deterioramento delle loro condizioni molto prima dell'attacco (sviluppano rumore nell'orecchio o perdono la coordinazione dei movimenti), ma spesso le vertigini compaiono improvvisamente sullo sfondo di completa salute. Lo stress mentale o fisico provoca un'esacerbazione della malattia.
Le vertigini in questi pazienti vengono avvertite come rotazione o spostamento degli oggetti circostanti. La gravità della loro condizione è determinata dalla gravità dei sintomi vegetativi (nausea, vomito, aumento della pressione sanguigna). Inoltre, in questo momento si osserva un aumento del rumore nell'orecchio, assordante e compromissione della coordinazione dei movimenti.
Al momento di un attacco, i pazienti non possono reggersi in piedi, assumono una posizione forzata a letto con gli occhi chiusi, poiché qualsiasi movimento, tentativo di cambiare posizione o luce intensa porta ad un netto peggioramento della condizione. Dopo l'attacco, le condizioni del paziente migliorano gradualmente, ma per diversi giorni presenta debolezza generale, ridotta capacità lavorativa e nistagmo (movimenti involontari dei bulbi oculari).
Durante il periodo di remissione, la persona si sente normale, ma persistono disturbi di acufene e perdita dell'udito. La guida e i movimenti improvvisi possono causare lievi vertigini in assenza di altri sintomi.
Va notato che nei casi gravi della malattia gli attacchi si ripetono frequentemente, gli intervalli “leggeri” tra loro diventano invisibili e la malattia diventa continua.
Diagnostica
Sulla base dei disturbi tipici del paziente, dell’anamnesi e dei risultati di un esame obiettivo, il medico formula una diagnosi preliminare e prescrive l’esame aggiuntivo necessario. Ciò consente di escludere possibili cause di tali sintomi e la presenza della sindrome di Meniere nel paziente. Pertanto, la malattia di Meniere deve essere differenziata dall'aracnoidite, dall'osteocondrosi del rachide cervicale, dai tumori dell'angolo cerebellopontino e del nervo prevestococleare.
Per identificare l'idrocele labirintico vengono eseguiti speciali test di disidratazione. Dopo la somministrazione di farmaci disidratanti (diuretici), la pressione nel labirinto diminuisce e le condizioni dei pazienti con malattia di Meniere migliorano temporaneamente.
Con l'aiuto di tali pazienti, viene identificata e determinata la percezione inadeguata dei suoni forti.
Tattiche di trattamento
 Il trattamento di questa patologia è sintomatico.
Il trattamento di questa patologia è sintomatico. Il trattamento per la malattia di Meniere è sintomatico. A questo scopo vengono utilizzati metodi conservativi e chirurgici.
La terapia conservativa dovrebbe avere un approccio globale:
- Durante un attacco, ha lo scopo di alleviare le condizioni del paziente, vale a dire bloccare gli impulsi patologici dal labirinto interessato dell'orecchio interno e ridurre la sensibilità del corpo nei loro confronti. A questo scopo vengono utilizzati agenti di disidratazione (diuretici - diacarb, veroshpiron, furosemide), antiemetici (metoclopramide, tietilperazina), tranquillanti e antidepressivi.
- Durante il periodo acuto, il consumo di alcol è limitato e viene prescritta una dieta priva di sale.
- Per fermare un attacco, gli alfa-bloccanti (pirroxano) possono essere somministrati in combinazione con anticolinergici (platiflina) e antistaminici (suprastina, tavegil). Il blocco della novocaina nell'area della parete posteriore del condotto uditivo ha un buon effetto.
- Per il vomito frequente, tutti i farmaci vengono somministrati per via parenterale.
- A volte per il trattamento possono essere utilizzati metodi proprietari.
Durante il periodo interictale, si raccomanda al paziente di condurre uno stile di vita sano, seguire una dieta priva di sale e possono essere prescritti farmaci che migliorano la circolazione sanguigna (trental) e vitamine. I preparati di betaistina vengono utilizzati anche per migliorare la microcircolazione e normalizzare la pressione nel labirinto e nella coclea.
I metodi di trattamento chirurgico sono utilizzati nelle forme gravi della malattia per eliminare dolorosi attacchi di vertigini. In questo caso, la funzione uditiva spesso viene persa. Il trattamento chirurgico può essere mirato a:
- eliminazione dell'idrocele del labirinto (drenaggio del sacco endolinfatico, shunt della coclea, resezione del plesso timpanico);
- normalizzazione dell'emodinamica nell'orecchio interno e blocco degli impulsi dal focus patologico (intervento chirurgico sul plesso timpanico).
Se questi interventi sono inefficaci e vi è una grave perdita dell'udito, possono essere utilizzati metodi distruttivi (labirintectomia con rimozione del ganglio vestibolare o resezione della radice del nervo vestibolococleare).
Conclusione
La malattia di Meniere ha un decorso costantemente progressivo. Nel tempo, la frequenza e l'intensità degli attacchi possono cambiare e persino indebolirsi. In questo caso, la compromissione della funzione uditiva aumenta e l'udito non viene più ripristinato. Solo una diagnosi precoce e un trattamento adeguato migliorano la prognosi dei disturbi dell’udito, aiutano a ridurre il numero degli attacchi e ad alleviare le condizioni di chi soffre di questa malattia.
Uno specialista parla della malattia di Meniere:
Canale Uno, programma “Vivi sano!” con Elena Malysheva, nella sezione “Sulla medicina”, una conversazione sulla malattia di Meniere:
Uno specialista della clinica Mosca Doctor parla della malattia di Meniere: