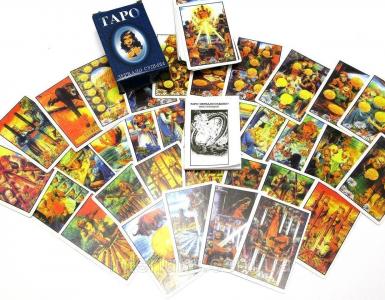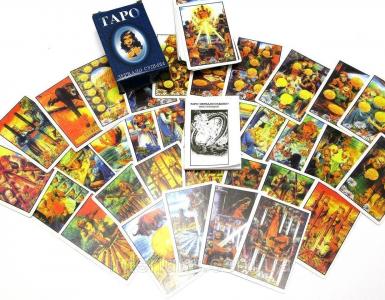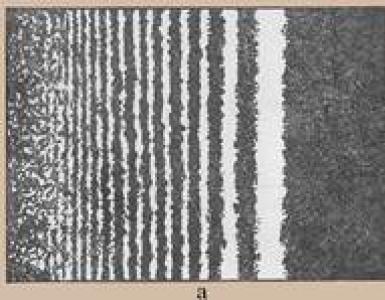Cause del disturbo di conversione. Disturbo di conversione: cause, sintomi, diagnosi, trattamento. Disturbi di conversione isterica
DISTURBO DI CONVERSIONE, precedentemente chiamata isteria, è un cambiamento o perdita della funzione sensoriale o motoria che indica un disturbo fisico (organico), che, tuttavia, non viene rilevato. Tali sintomi sono espressione di un conflitto psicologico o di un bisogno psicologico (p. es., “scappare” dallo stress psicosociale). Il termine "conversione" (lett. "trasformazione", "trasformazione") si riferisce alla causa del disturbo, che, essendo puramente psicologico, si esprime non a livello psicologico (ad esempio, ansia), ma attraverso sintomi somatici (corporei). .
I sintomi di conversione spesso imitano una condizione neurologica come la perdita sensoriale, che può includere grave perdita del campo visivo, cecità, sordità, perdita dell'olfatto o perdita di sensibilità in varie parti del corpo. Tipici sono la paralisi o la perdita della funzione motoria, che si manifesta con l'incapacità di muovere gli arti, la perdita della voce e l'incapacità di camminare o stare in piedi. Paralisi e compromissione sensoriale di solito coesistono; ad esempio, è molto tipica la perdita simultanea della capacità di muovere le braccia o le gambe e della sensibilità in esse. Sono possibili anche forme più complesse di manifestazioni comportamentali del disturbo, come perdita di coordinazione, crisi molto simili alle crisi epilettiche ed episodi di perdita di coscienza come svenimenti. Lamentele di dolore in assenza di una causa organica erano precedentemente considerate un sintomo di disturbo di conversione, ma nella pratica psichiatrica moderna la diagnosi di conversione non viene fatta per questo sintomo.
La ricerca sul disturbo di conversione iniziò nella seconda metà del XIX secolo, quando il neurologo francese J.-M. Charcot studiò pazienti con paralisi, convulsioni e altri sintomi di conversione, considerati manifestazioni di isteria. Il nome "isteria" ci riporta all'antica teoria che spiegava questi sintomi come un utero "errante" ( Guarda anche ISTERIA). Charcot studiò l'isteria usando l'ipnosi; grazie al suo lavoro, lo studio di questo problema divenne un'attività di tutto rispetto. Prima dell’era di Charcot, l’isteria era vista come una finzione o, nella migliore delle ipotesi, un frutto dell’immaginazione. L'interesse di Charcot per lo studio dell'isteria stimolò S. Freud, che venne da lui per uno stage, a intraprendere lo studio di questo disturbo ( Guarda anche FREUD, SIGMONDO).
I sintomi di conversione si riscontrano spesso in altre condizioni psicologiche, come la sindrome di Briquet (un disturbo di somatizzazione, caratterizzato dalla presenza di disturbi somatici persistenti e ad ampio raggio e un pronunciato bisogno di aiuto e supporto psicologico) e i disturbi antisociali di personalità. Il disturbo di conversione isolato è raro. Di solito si sviluppa improvvisamente in una situazione di estremo stress psicologico, come un trauma, la morte di una persona cara o una situazione terribile. I sintomi di conversione possono persistere per anni e trasformarsi in veri e propri disturbi organici. Ad esempio, una persona con paralisi "isterica" di un braccio o di una gamba può eventualmente sviluppare una grave atrofia dei muscoli non utilizzati o una contrattura dei muscoli che mantengono l'arto nella stessa posizione. Tuttavia, la maggior parte dei sintomi di conversione scompare molto più rapidamente.
Clinicamente, quando si verificano sintomi di conversione, è necessario escludere disturbi neurologici o altri disturbi organici che essi mimano. Ad esempio, se non vengono rilevati segni di danno al sistema nervoso quando un'area della pelle è insensibile, l'intorpidimento può essere considerato un sintomo di conversione. L'ipnosi viene spesso utilizzata come metodo per modificare un sintomo e persino come trattamento per eliminarlo. Va notato che i sintomi del disturbo di conversione non sono una frode o una finzione consapevole, ma sono assolutamente reali per il paziente.
Gli psicoterapeuti spesso sottolineano due ragioni inconsce che spingono un paziente a “aggrapparsi” a un sintomo nei disturbi di conversione. Uno di questi, il cosiddetto. il vantaggio principale è la protezione dalla consapevolezza del conflitto interno. Un altro beneficio – secondario – è la capacità di evitare situazioni pericolose grazie alla malattia o diventare oggetto di attenzione e cura. Il trattamento del disturbo di conversione può comportare l’eliminazione del guadagno secondario o, come avviene nella terapia psicoanalitica, la scoperta del conflitto inconscio. Guarda anche
L'uomo è una creatura molto perspicace. Ognuno “vive” qualsiasi conflitto sociale o interno, stress o trauma psicologico a modo suo. E non si tratta sempre di semplici lamentele, lacrime, isolamento, ansia... A volte la reazione della psiche e del corpo umano può essere del tutto inaspettata e assumere forme che dovrebbero essere attribuite alla malattia. Il disturbo di conversione è una di queste malattie.
Cos’è il disturbo di conversione?
Il disturbo di conversione è una malattia psicologica in cui una persona ha perso o parzialmente compromesso le funzioni sensoriali o motorie, a seguito delle quali inizia a manifestare disturbi fisiologici. Allo stesso tempo, questa è solo un'imitazione di una malattia, poiché non esistono veri e propri disturbi (malattie). In altre parole, una persona è in uno stato in cui si sente male, sebbene non lo sia, nonostante la presenza dei sintomi di una particolare malattia.
La scienza si avvicinò allo studio del disturbo di conversione, precedentemente chiamato isteria, nella seconda metà del XIX secolo. Prima di questo, la malattia era vista come una semplice finzione o ciarlataneria.
Tutto cambiò quando il neurologo francese J.-M. Charcot, basandosi sulle sue osservazioni su persone che soffrono di isteria, è giunto a una conclusione sensazionale: i pazienti non fingono, ma in realtà sperimentano i sintomi di una particolare malattia. Successivamente Z. Freud, che a quel tempo era un giovane specialista e si era formato con J.-M., iniziò a studiare questa malattia. Charcot.
Cause del disturbo di conversione
Si ritiene che il disturbo di conversione sia una malattia dei giovani e degli anziani, poiché è a questa età che lo stato emotivo di una persona è più instabile. Secondo le statistiche le donne ne sono più predisposte rispetto agli uomini.
La causa principale di questa malattia è un conflitto psicologico, a seguito del quale una persona pone maggiori richieste agli altri e smette di valutare criticamente la situazione attuale. Sottovalutare la propria personalità e il proprio comportamento porta al fatto che una persona inconsciamente ha il desiderio di essere significativa ad ogni costo, di essere al centro dell'attenzione, anche attraverso la malattia.
La causa del disturbo di conversione può essere il bisogno psicologico di una persona di “scappare” da qualche tipo di conflitto psicologico o stress sociale, ad es. “nascondersi dietro la malattia”.
Entrambe le ragioni sono inconsce e una persona non può controllarle, per cui ha piena fiducia di essere veramente malato, poiché sperimenta tutti i sintomi inerenti a una particolare malattia.
Sintomi del disturbo
In precedenza, si credeva erroneamente che tutti i sintomi del disturbo di conversione fossero limitati a svenimenti, vari gradi di paralisi, convulsioni o disturbi mentali. Ma la ricerca condotta da specialisti in questo campo ha dimostrato che questo disturbo non ha confini, per cui le sue manifestazioni possono essere varie e estendersi a qualsiasi organo o sistema umano.
Di conseguenza, tutti i sintomi sono stati divisi in quattro gruppi.
- Il primo gruppo sono i sintomi motori, che si manifestano nella compromissione o nell’assenza della funzione motoria di una persona. Le manifestazioni possono essere molto diverse, dai disturbi dell'andatura alla pseudoparalisi. Una manifestazione molto comune della malattia sono le convulsioni che si sviluppano in presenza di altre persone. Sorgono all'improvviso, durano da alcuni minuti a diverse ore e scompaiono improvvisamente con la comparsa di qualche stimolo esterno (suono forte, nuova persona, ecc.). In questo caso, il paziente può cadere, urlare, “rotolarsi sul pavimento”, piegarsi in modo innaturale, ecc.
- Il secondo gruppo è rappresentato dai sintomi sensibili (sensoriali), che si manifestano con una sensibilità ridotta o assente al dolore o alla temperatura. Una manifestazione sorprendente è l'insorgenza di sordità, cecità, alterazioni del gusto e dell'olfatto. Queste manifestazioni, come nel primo caso, variano nella durata e nella gamma delle sensazioni.
- Il terzo gruppo sono i sintomi vegetativi, quando una persona avverte spasmi della muscolatura liscia degli organi interni o spasmi dei vasi sanguigni. Questi sintomi possono imitare quasi tutte le malattie.
- Il quarto gruppo è quello dei sintomi mentali, che variano anche nella loro manifestazione. Queste possono essere fantasie innocue, deliri, allucinazioni o amnesie immaginarie (vuoti di memoria).
Diagnosi della malattia
Quando diagnosticano il disturbo di conversione, gli specialisti devono affrontare una serie di problemi.
- Poiché il paziente manifesta effettivamente i sintomi di una particolare malattia, nella fase iniziale di sviluppo del disturbo può essere molto difficile fare una diagnosi corretta. Uno specialista semplicemente non può escludere completamente la presenza di una vera malattia. In questo caso ricorrono all'osservazione a lungo termine del paziente, conducendo vari tipi di test e conducendo vari tipi di studi clinici.
- Poiché tutti i sintomi che un paziente sperimenta con disturbo di conversione sono inconsci, sorge il problema di differenziarli da quelli intenzionali, cioè quelli in cui una persona impersona deliberatamente un paziente. Ciò è possibile nei casi in cui una persona, ad esempio, è sotto inchiesta o sta cercando di sottrarsi al servizio militare. Ma il fatto è che una persona che soffre di un disturbo spesso esagera consapevolmente i suoi sintomi inconsci.
- La diagnosi può anche essere complicata dallo stereotipo secondo cui i sintomi motori evidenti, come le convulsioni, sono un anacronismo e non sono caratteristici di una persona nella società moderna. In ogni caso, qualunque sia il problema riscontrato dagli specialisti, il paziente richiede un attento esame e osservazione.
Trattamento del disturbo di conversione
Il disturbo di conversione, come qualsiasi altra malattia psicologica, richiede un trattamento attento e selezionato con molta attenzione. Non è sufficiente che il paziente dica semplicemente che tutti i sintomi che sperimenta sono solo frutto della sua immaginazione e che tutti i suoi problemi sono in lui stesso. Al contrario, con questo approccio la situazione potrebbe peggiorare ancora di più e il paziente peggiorerà ancora.
Nella medicina moderna sono state sviluppate diverse direzioni di trattamento, a seguito delle quali è possibile ottenere un risultato favorevole. E prima di tutto questa è la psicoterapia, il cui compito principale è valutare correttamente la situazione in cui si trova il paziente. Ciò è necessario per eliminare, nel modo più delicato possibile, il fattore che ha portato alla malattia o determinare il motivo (beneficio) della malattia. Quando si conduce un corso di psicoterapia, l'ipnosi dà buoni risultati.
Per quanto riguarda il trattamento farmacologico, il suo ruolo è minimo e si ricorre solo quando si osservano ricadute del disturbo di conversione o quando il paziente cade in una grave forma di depressione.
È importante ricordare che il trattamento deve iniziare il più presto possibile, perché più a lungo una persona rimane in uno stato di disturbo, meno è probabile che si riprenda completamente.
Tali sintomi sono espressione di un conflitto psicologico o di un bisogno psicologico (p. es., “scappare” dallo stress psicosociale). Il termine "conversione" (lett. "trasformazione", "trasformazione") si riferisce alla causa del disturbo, che, essendo puramente psicologico, si esprime non a livello psicologico (ad esempio, ansia), ma attraverso sintomi somatici (corporei). .
I sintomi di conversione spesso imitano una condizione neurologica come la perdita sensoriale, che può includere grave perdita del campo visivo, cecità, sordità, perdita dell'olfatto o perdita di sensibilità in varie parti del corpo. Tipici sono la paralisi o la perdita della funzione motoria, che si manifesta con l'incapacità di muovere gli arti, la perdita della voce e l'incapacità di camminare o stare in piedi. Paralisi e compromissione sensoriale di solito coesistono; ad esempio, è molto tipica la perdita simultanea della capacità di muovere le braccia o le gambe e della sensibilità in esse. Sono possibili anche forme più complesse di manifestazioni comportamentali del disturbo, come perdita di coordinazione, crisi molto simili alle crisi epilettiche ed episodi di perdita di coscienza come svenimenti. Lamentele di dolore in assenza di una causa organica erano precedentemente considerate un sintomo di disturbo di conversione, ma nella pratica psichiatrica moderna la diagnosi di conversione non viene fatta per questo sintomo.
La ricerca sul disturbo di conversione iniziò nella seconda metà del XIX secolo, quando il neurologo francese J.-M. Charcot studiò pazienti con paralisi, convulsioni e altri sintomi di conversione, considerati manifestazioni di isteria. Il nome "isteria" ci riporta all'antica teoria che spiegava questi sintomi come un utero "errante" ( Guarda anche ISTERIA). Charcot studiò l'isteria usando l'ipnosi; grazie al suo lavoro, lo studio di questo problema divenne un'attività di tutto rispetto. Prima dell’era di Charcot, l’isteria era vista come una finzione o, nella migliore delle ipotesi, un frutto dell’immaginazione. L'interesse di Charcot per lo studio dell'isteria stimolò S. Freud, che venne da lui per uno stage, a intraprendere lo studio di questo disturbo ( Guarda anche FREUD, SIGMONDO).
I sintomi di conversione si riscontrano spesso in altre condizioni psicologiche, come la sindrome di Briquet (un disturbo di somatizzazione, caratterizzato dalla presenza di disturbi somatici persistenti e ad ampio raggio e un pronunciato bisogno di aiuto e supporto psicologico) e i disturbi antisociali di personalità. Il disturbo di conversione isolato è raro. Di solito si sviluppa improvvisamente in una situazione di estremo stress psicologico, come un trauma, la morte di una persona cara o una situazione terribile. I sintomi di conversione possono persistere per anni e trasformarsi in veri e propri disturbi organici. Ad esempio, una persona con paralisi "isterica" di un braccio o di una gamba può eventualmente sviluppare una grave atrofia dei muscoli non utilizzati o una contrattura dei muscoli che mantengono l'arto nella stessa posizione. Tuttavia, la maggior parte dei sintomi di conversione scompare molto più rapidamente.
Clinicamente, quando si verificano sintomi di conversione, è necessario escludere disturbi neurologici o altri disturbi organici che essi mimano. Ad esempio, se non vengono rilevati segni di danno al sistema nervoso quando un'area della pelle è insensibile, l'intorpidimento può essere considerato un sintomo di conversione. L'ipnosi viene spesso utilizzata come metodo per modificare un sintomo e persino come trattamento per eliminarlo. Va notato che i sintomi del disturbo di conversione non sono una frode o una finzione consapevole, ma sono assolutamente reali per il paziente.
Gli psicoterapeuti spesso sottolineano due ragioni inconsce che spingono un paziente a “aggrapparsi” a un sintomo nei disturbi di conversione. Uno di questi, il cosiddetto. il vantaggio principale è la protezione dalla consapevolezza del conflitto interno. Un altro beneficio – secondario – è la capacità di evitare situazioni pericolose grazie alla malattia o diventare oggetto di attenzione e cura. Il trattamento del disturbo di conversione può comportare l’eliminazione del guadagno secondario o, come avviene nella terapia psicoanalitica, la scoperta del conflitto inconscio. Guarda anche CATALESSI.
Isteria e sintomi di conversione. Psicoterapia dell'isteria. Cos’è la conversione isterica?
Durante le conversioni i sintomi somatici esprimono inconsciamente e in forma distorta impulsi pulsionali repressi.
Qualsiasi sintomo nevrotico interferirà con la soddisfazione dell'istinto. Poiché l'eccitazione e la soddisfazione sono fenomeni che si manifestano a livello somatico, il “salto” nella sfera somatica caratteristico della conversione in linea di principio non sorprende. Tuttavia, i sintomi di conversione non sono semplicemente un’espressione somatica degli affetti, ma una rappresentazione molto specifica di pensieri che possono essere ritradotti dal “linguaggio somatico” al linguaggio verbale originario.
I sintomi di conversione possono essere considerati per analogia con gli attacchi affettivi. Questi attacchi si verificano quando la stimolazione intensa (o la normale stimolazione in condizioni di "smorzamento") interrompe temporaneamente la capacità dell'Io di controllare i movimenti e le sindromi di scarica arcaica interferiscono con azioni dirette a uno scopo (tali sindromi vengono successivamente "addomesticate" e utilizzate dall'Io restaurato). . I sintomi di conversione si verificano anche quando si verifica un'improvvisa interruzione della capacità dell'Io di controllare i movimenti e il rilascio somatico involontario. La differenza, però, è che negli affetti normali le sindromi che interferiscono con le azioni sono simili in tutte le persone (non ne conosciamo l'origine e nel tentativo di spiegarle ci rivolgiamo alla filogenesi). Le sindromi dei sintomi di conversione sono uniche in ogni caso. La psicoanalisi mostra che la loro origine è determinata dalle caratteristiche dell'ontogenesi, dalle esperienze dell'individuo, rimosse nel passato. Queste sindromi esprimono in modo distorto bisogni istintuali repressi, la specificità della distorsione è determinata dagli eventi del passato che hanno causato la rimozione.
Prerequisiti per lo sviluppo della conversione
Ci sono due prerequisiti per lo sviluppo della conversione: somatico e mentale. La precondizione somatica è l'erogeneità generale del corpo umano, che rende possibile ad ogni organo e ad ogni funzione di esprimere l'eccitazione sessuale. Il prerequisito mentale è, prima di tutto, la capacità di allontanarsi dalla realtà verso la fantasia, di sostituire oggetti sessuali reali con rappresentazioni immaginarie di oggetti infantili. Questo processo è chiamato "introversione".
Ricordiamo che dopo aver assegnato al pensiero la funzione di predire le azioni, si distinguono due tipi di pensiero: preparare le azioni e sostituire le azioni. Il primo tipo di pensiero è logico e verbale, le sue funzioni corrispondono al principio di realtà; il secondo è arcaico, figurato, magico, le sue funzioni corrispondono al principio del piacere. Le fantasie rappresentano il secondo tipo di pensiero, sono un piacevole sostituto della realtà dolorosa, le fantasie spesso rivelano una connessione con bisogni repressi, vengono investite eccessivamente dal trasferimento di energia dal materiale represso e ne diventano così i derivati.
Nell'introversione, gli isterici regrediscono dalla realtà disgustata al pensiero magico nella fantasia. Questo processo può essere realizzato finché le fantasie sono sufficientemente lontane dal contenuto del materiale rimosso, in particolare dal riprovevole complesso di Edipo, ma se le fantasie oltrepassano la linea proibita, vengono anch'esse rimosse. Poi ritornano dalla repressione sotto mentite spoglie sotto forma di sintomi di conversione.
In accordo con l'introversione, gli individui isterici si rivolgono al loro mondo interiore. La loro attività, invece di azioni dirette verso l'esterno (attività alloplastica), è semplicemente “innervazione interna” (attività autoilastica). In altre parole, le fantasie degli individui isterici, essendo represse, trovano espressione plastica nei cambiamenti delle funzioni somatiche. A questo proposito Ferenczi parla di “materializzazione isterica” delle fantasie. Negli isterici, durante la "materializzazione" esagerano solo ciò che si manifesta in modo simile durante la fantasia normale, e di fatto in tutto il pensiero. Pensare, sostituire le azioni, tuttavia, è il loro “granulo”: nel processo di pensiero, l'innervazione delle azioni pensate avviene, solo in misura minore rispetto alla loro effettiva attuazione. Questa “componente di azione”, particolarmente evidente negli isterici introversi, costituisce la base dell’innervazione che costituisce i sintomi di conversione.
Copia il codice qui sotto e incollalo nella tua pagina - come HTML.
Iscriviti alla newsletter
Articoli sulla psicologia
Per i pazienti:
- Aiuto psicologico
- Cos'è l'aiuto psicologico?
- Chi ha bisogno di aiuto psicologico?
- Psicoterapia: com'è?
- Meccanismi di assistenza psicologica
- Migliorare le tecniche di trattamento psicoanalitico
- Epidemiologia delle malattie psicogene
- Psicoanalisi e psicoterapia analitica
- Focus terapia - intervento d'urgenza - consulenza psicoanalitica
- Psicoterapia psicoanalitica di gruppo
- Terapia familiare psicoanalitica
- Psicoanalisi delle coppie sposate
- Psicoanalisi infantile
- Gruppi Balint
- La psicoanalisi in ambito ospedaliero
- In che modo la psicoanalisi aiuta?
- Come superare lo stress?
- Perché hai bisogno di uno psichiatra? Consultazione dello psichiatra
- Sofferenza mentale: cosa fare?
- Informazioni sui requisiti per il paziente
- Di che tipo di specialista hai bisogno?
- Psicoanalisi e consultazione con uno psicoanalista
- Differenze tra psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista
- Cosa dovrebbe saper fare uno psicoterapeuta?
- Qualità professionali di uno psicoterapeuta
- Cosa “tratta” in psicoterapia?
- Interpretazione psicoanalitica
- Transfert e controtransfert come fattore di guarigione
- Sulla collaborazione con uno psicoterapeuta
- Alleanza di lavoro con uno psicoterapeuta
- Alleanza per il trattamento psicoanalitico
- Disturbi nevrotici
- Neurosi. Trattamento delle nevrosi
- Psicoanalisi delle ossessioni
- Stati e pensieri ossessivi
- "Io" ossessivo
- Disturbo ossessivo-compulsivo della personalità
- Azioni ossessive (compulsioni)
- Metodi psicoanalitici per il trattamento delle ossessioni
- Psicoterapia comportamentale per le ossessioni
- Psicoterapia cognitiva per le ossessioni
- Teoria biologica delle ossessioni e farmacoterapia
- Il fenomeno della costrizione
- Attrazione e difesa nella nevrosi compulsiva
- Regressione mentale nella nevrosi compulsiva
- Erotismo anale e carattere anale
- Sistemi compulsivi
- Meccanismi di difesa nella nevrosi compulsiva
- Pensare nella nevrosi compulsiva
- Magia e superstizione nella nevrosi compulsiva
- Atteggiamento somatico nella nevrosi compulsiva
- Psicoanalisi della nevrosi compulsiva
- Nevrosi ossessivo-compulsiva
- Pensiero magico e indagine magica
- Richiesta magica ad uno psicologo
- Psicologia della magia
- Depressione e mania. Trattamento della depressione
- La depressione è una condanna a morte?
- Nevrosi depressive
- Psicoterapia e psicoanalisi della depressione
- Pulsioni e affetti nella depressione
- Difese psicologiche per la depressione
- Relazioni umane nella depressione
- Depressione e autostima
- Sulla complessità dei meccanismi della depressione
- Tristezza e depressione
- Mania: sintomi e trattamento della mania
- Psicoanalisi sulla depressione
- La psicoterapia della depressione in analisi esistenziale
- Psicoterapia per il suicidio
- L’umore depresso non è sempre depressione
- Nevrosi traumatica
- Cos'è il trauma mentale?
- Attacchi emotivi
- L'insonnia nella nevrosi traumatica
- Complicanze della nevrosi traumatica
- Psicoanalisi delle nevrosi traumatiche
- Disturbi sessuali
- Impotenza (disfunzione erettile)
- Frigidità: sintomi e trattamento della frigidità
- Concetto di transessualismo
- Travestitismo
- Feticismo: psicoanalisi e trattamento del feticismo
- Sadismo: psicoanalisi e trattamento del sadismo
- Masochismo: cosa potrebbe esserci di meglio del dolore?
- Sadomasochismo
- Perversione
- Omosessualità: il punto di vista di uno psicoanalista
- Psicoanalisi del masochismo
- Cos'è il voyeurismo?
- Omosessualità maschile
- Omosessualità femminile
- Esibizionismo
- Coprofilia
- Psicologia della dipendenza sessuale
- Transessualismo: il punto di vista di uno psicoanalista
- Relazione oggettuale feticistica
- Disturbi psicotici
- Sintomi e trattamento della psicosi
- Sintomi e trattamento della schizofrenia
- Psicoterapia di natura schizoide
- Psicoterapia della psicosi e della schizofrenia
- Il bambino odiato
- Paranoia: sintomi e trattamento
- Psicodinamica delle psicosi
- Studi psicoanalitici sulle psicosi
- Sintomi di regressione nella schizofrenia
- Relazioni con le persone e sessualità nella schizofrenia
- Divario con la realtà nella schizofrenia
- Casi limite
- Terapia psicoanalitica per la schizofrenia
- Simbolizzazione e psicosi
- Incontro con Raskolnikov. Caso di un paziente borderline
- Isteria e sintomi di conversione. Psicoterapia dell'isteria
- Origine dell'isteria
- Psicoanalisi dell'isteria
- Ansia con isteria ansiosa
- Cos’è la conversione isterica?
- Attimi isterici
- Dolori isterici
- Allucinazioni isteriche e disturbi del movimento
- Disturbi sensoriali isterici
- Complesso di Edipo, masturbazione e pregenitalità nell'isteria
- Repressione mentale e scissione nell'isteria
- Isteria: crisi della libido dovuta alla differenziazione di genere
- Rifiuto di una donna in una persona isterica
- Isteria e stati borderline. Chiasmo: nuove prospettive
- Isteria nei bambini e negli adolescenti
- Balbuzie. Tic psicogeni
- Psicologia della balbuzie
- Psicologia dei tic
- Paura, fobie e attacchi di panico
- Fobie e paure. Trattamento delle fobie
- Cos'è il panico e l'attacco di panico?
- Classificazione delle fobie
- Paura della morte. Ho paura della morte, cosa devo fare?
- Voglio l'amore, ma ho paura di amare
- Ho paura di volare, paura degli aeroplani
- Ho paura del sesso! Paura del sesso: cause e trattamento
- Le paure delle donne: ho paura di partorire!
- Paura della vita: la vita è una cosa pericolosa!
- Condizioni psicosomatiche. Neurosi degli organi
- Il concetto di psicosomatica
- Tratto gastrointestinale. Ulcera allo stomaco
- Asma bronchiale
- Cuore e sistema vascolare: tachicardia e aritmia
- Malattie della pelle
- Deficit visivo
- Ipocondria: sintomi e trattamento
- Malattia ipertonica
- Sincope vasodepressiva (vago-vasale).
- Mal di testa: cause e trattamento
- Emicrania (mal di testa): cosa fare?
- Ipocondria. Anatomia dell'ipocondrio
- Psicoanalisi e psicoterapia dell'ipocondria
- Psicosomatica psicoanalitica
- Disfunzioni ormonali e autonomiche
- La natura dei sintomi organo-nevrotici
- Ipo e ipersessualità
- Cause psicogene delle ulcere allo stomaco
- Sistema muscolare
- Patologie del sistema respiratorio
- Nevrosi cardiaca e ipertensione essenziale
- Malattie della pelle
- Psicogenesi delle malattie organiche
- Cause dell'ipocondria
- Terapia psicoanalitica delle nevrosi d'organo
- Epilessia
- Dipendenze psicologiche
- Meccanismi della tossicodipendenza
- Dipendenza dal gioco d'azzardo: passione per il gioco d'azzardo
- Piromania
- Cleptomania
- Dipendenza senza droghe
- Problemi alimentari
- Psicoanalisi e psicoterapia
- Sigmund Freud e la psicoanalisi
- Identità della psicoanalisi
- La psicologia è la “ancella” della psicoanalisi?
- S. Freud: cenni biografici
- Psicoterapia psicoanalitica
- La teoria delle pulsioni di Freud
- La psicologia dell’io in psicoanalisi
- La psicoanalisi sulle relazioni umane
- Psicologia del Sé
- Perché la psicoanalisi è importante?
- Freud e il suo tempo
- Passioni nella storia della psicoanalisi
- Le opere di Anna Freud
- La psicoanalisi sull'inconscio
- Inconscio
- Nevrosi e inconscio
- Concetto di inconscio
- L'inconscio: storia del concetto
- Psicoanalisi sullo sviluppo mentale
- Identificazione primaria del bambino
- Onnipotenza e rispetto di sé
- Sviluppo della sfera motoria
- Ansia
- Pensiero e sviluppo del senso della realtà
- Protezione dagli stimoli
- Classificazione degli istinti
- Esiste una pulsione di morte?
- Cos'è la sessualità? Psicoanalisi sulla sessualità
- Concetto di sessualità
- Masturbazione: normale e nevrotica
- Il concetto di masturbazione in psicoanalisi
- Cos'è l'attrazione?
- Sessualità infantile e perversioni polimorfiche
- Stadio orale dello sviluppo psicosessuale
- Stadio sadico-anale
- Erotismo uretrale
- Zone erogene
- Scopofilia, esibizionismo, sadismo e masochismo
- Paura della castrazione
- Invidia del pene
- Tipi arcaici di relazioni
- Amore e odio
- La madre come primo oggetto sessuale
- complesso di Edipo
- Dal desiderio sessuale all'eros freudiano
- Sessualizzazione e desessualizzazione in psicoanalisi
- La nuova misoginia
- La scatola e il suo segreto: la sessualità femminile
- Psicoanalisi della bisessualità
- Psicologia del conflitto nevrotico
- Tipologia di conflitti
- complesso di Edipo
- Le idee di Freud sul complesso di Edipo
- Sulla dinamica del complesso di Edipo
- Conflitto nevrotico
- Triangolazione psichica "precoce".
- Formazione del complesso di Edipo
- Cos’è il conflitto nevrotico?
- Colpevolezza
- Disgusto e vergogna
- Sintomi di conflitti nevrotici
- Inibizione delle funzioni sessualizzate
- Difese psicologiche
- Meccanismi di difesa della psiche
- Isolamento primitivo
- Negazione
- Controllo onnipotente
- Idealizzazione primitiva (e svalutazione)
- Proiezione, introiezione e identificazione proiettiva
- Scissione del Sé
- Dissociazione
- Repressione (spostamento)
- Regressione
- Isolamento
- Intellettualizzazione
- Razionalizzazione
- Moralizzazione
- Compartimentalizzazione (pensiero separato)
- Cancellazione
- Rivoltarsi contro te stesso
- Pregiudizio
- Educazione reattiva
- Reversione
- Identificazione
- Reazione (azione esterna, acting out)
- Sessualizzazione
- Sublimazione
- Il concetto di protezione
- Classificazione dei tipi di protezione
- Tipi di difesa patogeni
- Protezione dagli affetti
- Il fenomeno della proiezione in psicoanalisi
- Sintomi nevrotici
- Formazione di sintomi
- Effetto sintomatico
- Nevrosi reale
- Trauma mentale e traumatizzazione
- Teoria psicoanalitica delle nevrosi
- Nevrosi attuali, sintomi di inibizione delle pulsioni.
- Nevrosi d'ansia
- Disturbi del sonno, insonnia
- Nevrastenia cronica
- La natura dei sintomi nevrotici
- Caso dell'angelo
- Psicoanalisi teorica
- La teoria della pulsione in psicoanalisi
- Teoria psicoanalitica delle relazioni oggettuali
- Teoria del narcisismo in psicoanalisi
- Psicologia del Sé
- Psicoanalisi e scienze cognitive
- Psicoanalisi delle differenze sessuali
- Studi empirico-nomotetici in psicoanalisi
- Ermeneutica profonda e teoria della coerenza in psicoanalisi
- La teoria dell'Io in psicoanalisi
- Concezione psicoanalitica dello sviluppo psicologico
- Psicologia sociale psicoanalitica
- La ricerca psicoanalitica empirica
- Cos'è il Super-Io? Sviluppo del Super-Io
- Sogni. Interpretazione dei sogni
- Perché vediamo i sogni? Meccanismi del sogno
- Regole per l'interpretazione dei sogni
- Depressione e sogni
- Sogni ansiosi. Sogni con stalking
- Sogni e psicosi
- Morte e omicidio nei sogni
- L’incesto è un crimine in una società civile
- Il motivo del dolore nei sogni
- Sogni con case
- Le automobili nei sogni
- Alcol e droghe nei sogni
- Serpenti nei sogni
- Esperienze sessuali in un sogno
- Risposte a domande sui sogni
- Sogno
- La funzione comunicativa dei sogni
- Sogni magici
- Psicoanalisi infantile
- Nevrosi infantile
- Caratteristiche della psicoanalisi infantile
- Psicoanalisi dell'adolescenza
- Ricerca su neonati e bambini piccoli
- Isteria d'ansia nei bambini piccoli
- Depressione nei neonati e autismo nella prima infanzia
- Psicoanalisi dei bambini
- Teoria dell'attaccamento e psicoanalisi
- Crisi adolescenziale
- Trasmissione transgenerazionale e interazione fantastica
- Metodi di neuropsichiatria infantile
- Movimento e discorso di un bambino nel processo psicoterapeutico
- Psicoterapia di gruppo per bambini con disturbi dello sviluppo
- Psicoterapia delle psicosi della prima infanzia
- Storia della psicoanalisi
- La psicoanalisi negli anni '90 del XX secolo
- Psicoanalisi e psicologia accademica
- Critica alla psicoanalisi per la mancanza di ricerca empirica
- Critica delle istituzioni psicoanalitiche
- Critica della critica alla psicoanalisi
- Psicoterapia comportamentale e psicoanalisi
- Psicoterapia e psicoanalisi aziendale
- Heines Hartmann e la psicoanalisi moderna
- Sviluppo della psicoanalisi in America Latina
- La psicoanalisi moderna
- Obiettivi terapeutici della psicoanalisi
- L'interpretazione psicoterapeutica in psicoanalisi
- Note sulla teoria dell'aggressività
- Cenni sulla teoria dell'aggressività. Parte 2.
- Cambiare gli obiettivi e le tecniche terapeutiche in psicoanalisi
- Sul controtransfert in psicoanalisi
- Il problema dell'interpretazione in psicoanalisi
- Applicazione della tecnica psicoanalitica
- Tecnica della psicoanalisi. Parte 2.
- Psicoanalisi e psicoterapia esplorativa
- Oggetti transitori. Oggetto "Non-Io".
- Psicoanalisi e psicoterapia psicodinamica
- Senso interiore di sicurezza e suo significato
- Introspezione, empatia e psicoanalisi.
- Realtà multipla
- Attacchi alla comunicazione
- Sui problemi legati al raggiungimento dell'insight in psicoanalisi
- Sul lavoro terapeutico in psicoanalisi
- Sul lavoro terapeutico in psicoanalisi. Parte 2.
- Pensiero operativo
- Organizzazione borderline della personalità
- Organizzazione borderline della personalità. Parte 2
- Il ruolo dell'investimento omosessuale nel trattamento psicoanalitico
- Capacità di solitudine
- Inibizione, sintomo e paura: quarant'anni dopo
- Inibizione e paura. Fine.
- Psicodramma psicoanalitico
- Psicoanalisi di M. Balint
- Il contributo di Mikael Balint alla psicoanalisi
- Origine delle relazioni interumane
- Ocnofilia e filobatismo
- Soddisfazione genitale e amore genitale
- Il contributo dello psicoanalista al processo di psicoanalisi
- Ipnosi. Trattamento ipnotico e psicoanalisi
- Svantaggi dell'ipnosi
- L'ipnosi in prospettiva storica
- Associazione libera o ipnosi?
- Psicologo infantile sui bambini e le loro madri
- Psicologia dell'allattamento al seno
- Una normale madre devota
- Cosa dovrebbe imparare una neo mamma?
- Neonato e sua madre
- Ambiente sano durante l'infanzia
- Il contributo della psicoanalisi all'ostetricia
- Dipendenza e cura dei figli
- Interazione e comunicazione tra bambino e madre
- Concetti di base della psicologia del profondo e della psicoanalisi
- Glossario
- C. G. Jung e la psicologia analitica
- Schizzo biografico di K.G. mozzo
- Introversione ed estroversione
- L'inconscio e gli archetipi
- Archetipi di base
- Simboli e immaginazione attiva
- Sogni e interpretazione dei sogni
- Individuazione
- Religione e misticismo
- Psicoterapia junghiana
- Psicologia popolare
- Pensieri del terapeuta su amore, famiglia e relazioni
- Bisogno nevrotico di amore
- Perché l'amore a volte è così doloroso?
- Se una donna guadagna più di un uomo.
- Di mia suocera e non solo di lei. Problemi di una giovane famiglia.
- Mio figlio mi raccontava tutto.
- Sesso non noioso. Romanticismo delle relazioni
- Dove sei, vacanza?
- "Fathers and Sons" - il punto di vista di uno psicologo
- Come gestire i tuoi sentimenti?
- Concezione psicoanalitica dell'amore
- Come costruire relazioni strette? Il consiglio dello psicologo
- Psicologia popolare. Consigli di uno psicologo per tutti i giorni
- Come affrontare l'insonnia?
- Lo stress nelle donne: impara ad alleviare lo stress
- Sintomi della depressione: quando rivolgersi ad uno psicologo?
- Paura. Cosa fare?
- Lo stress negli uomini
- Monotonia della vita sessuale
- Stress stradale
- Paura del fallimento sessuale
- Solitudine
- Come affrontare la rabbia?
- Rapporti dolorosi nelle donne
- Quattro miti sulla tossicodipendenza
- Articoli promozionali
- TRASCRIZIONE IN INGLESE
- Una casa di cura confortevole è una soluzione civile a un problema delicato
- Vacanze terapeutiche in Montenegro: guarisci e rilassati!
- Adoro i tuoi denti di leone!
- Infermieristica: come evitare di diventare vittima di idee sbagliate?
- Il giuramento in ufficio: origini, cause, conseguenze
- Particolarità delle conversazioni telefoniche
- Psicologia e vita
- Psicoanalisi applicata
- Psicoanalisi e politica
- Psicoanalisi e letteratura
- Libri di psicologia e filosofia
- Libri da Yoga X-Press
- S. "Follia metafisica"
- S. "Nuova deontologia"
- Analisi esistenziale della depressione
- Kagarlitskaya G.S. "Per cosa e perché?"
- S. "Scuse per la follia"
- Notizie di psicologia
Chi siamo
Una caratteristica del nostro approccio e della nostra ideologia è la nostra attenzione all’aiuto reale alle persone. Vogliamo aiutare il cliente (paziente) e non solo “consultare”, “condurre psicoanalisi” o “fare psicoterapia”.
Come sapete, ogni specialista ha dietro di sé il potenziale di conoscenze, competenze e capacità professionali in cui crede e invita il suo cliente a credere. A volte, purtroppo, questo potenziale diventa per il cliente un “letto di Procuste” in cui si sente, con tutte le sue caratteristiche e sintomi, inappropriato, incompreso e non necessario. Il cliente può anche sentirsi fuori posto durante un appuntamento con uno specialista troppo appassionato di se stesso e delle sue idee. Dare assistenza psicologica o offrire “servizi psicologici” sono cose completamente diverse >>>
12.7. Disturbi di conversione isterica
Conversioneè considerato uno dei meccanismi di difesa psicologica (vedi sezione 1.1.4 e tabella 1.4). Si presume che durante la conversione, le esperienze dolorose interne associate allo stress emotivo si trasformino in sintomi somatici e neurologici che si sviluppano attraverso il meccanismo dell'autosuggestione. La conversione è una delle manifestazioni più importanti di un'ampia gamma di disturbi isterici (nevrosi isterica, psicopatia isterica, reazioni isteriche).
La sorprendente varietà dei sintomi di conversione e la loro somiglianza con un’ampia varietà di malattie organiche permisero a J. M. Charcot (1825-1893) di chiamare l’isteria “la grande simulazione”. Allo stesso tempo, i disturbi isterici dovrebbero essere chiaramente distinti dalla simulazione reale, che è sempre intenzionale, completamente soggetta al controllo della volontà e può essere prolungata o interrotta su richiesta dell’individuo. I sintomi isterici non hanno uno scopo specifico, causano una vera sofferenza interna nel paziente e non possono essere fermati dalla sua volontà.
Secondo il meccanismo isterico si formano disfunzioni di un'ampia varietà di sistemi corporei. Nel secolo scorso i sintomi neurologici erano più comuni di altri: paresi e paralisi, svenimenti e convulsioni, disturbi sensoriali, astasia-abasia, mutismo, cecità e sordità. . Nel nostro secolo i sintomi corrispondono a malattie diffusesi negli ultimi anni. Si tratta di dolori cardiaci, mal di testa e “radicolari”, sensazione di mancanza d'aria, difficoltà di deglutizione, debolezza alle braccia e alle gambe, balbuzie, afonia, sensazione di brividi, vaghe sensazioni di formicolio e gattonamento.
Con tutta la varietà dei sintomi di conversione, è possibile identificare una serie di proprietà comuni caratteristiche di ognuno di essi. Innanzitutto, questa è la natura psicogena dei sintomi. Non solo l'insorgenza del disturbo è associata a psicotrauma, ma il suo ulteriore decorso dipende dalla rilevanza delle esperienze psicologiche e dalla presenza di ulteriori fattori traumatici. In secondo luogo, bisogna tenere conto di uno strano insieme di sintomi che non corrisponde al quadro tipico di una malattia somatica. Le manifestazioni dei disturbi isterici sono come le immagina il paziente, quindi il fatto che il paziente abbia una certa esperienza di comunicazione con pazienti somatici rende i suoi sintomi più simili a quelli organici. In terzo luogo, va tenuto presente che i sintomi di conversione hanno lo scopo di attirare l'attenzione degli altri, quindi non si verificano mai quando il paziente è solo con se stesso. I pazienti spesso cercano di enfatizzare l’unicità dei loro sintomi. Maggiore è l'attenzione che il medico presta al disturbo, più pronunciato diventa. Ad esempio, chiedere a un medico di parlare un po’ più forte può causare la completa perdita della voce. Al contrario, distogliere l'attenzione del paziente porta alla scomparsa dei sintomi. Infine, va tenuto presente che non tutte le funzioni del corpo possono essere controllate attraverso l'autoipnosi. Per una diagnosi affidabile è possibile utilizzare numerosi riflessi incondizionati e indicatori oggettivi del funzionamento del corpo.
Occasionalmente, i sintomi di conversione inducono i pazienti a rivolgersi ripetutamente ai chirurghi con la richiesta di eseguire interventi chirurgici seri e procedure diagnostiche traumatiche. Questo disturbo è noto come Sindrome di Munchausen. L'assenza di scopo di tale finzione, la sofferenza delle numerose procedure subite e l'evidente natura disadattiva del comportamento distinguono questo disturbo dalla simulazione.
Per continuare il download, è necessario raccogliere l'immagine:
Disturbo di conversione: cause, sintomi e trattamento
La conversione è il processo di rifiuto del contenuto mentale del subconscio, sostituendolo con forme corporee di manifestazione di vari fenomeni. Da qui deriva il nome di una sindrome come disturbo di conversione: si tratta di una reazione mentale in cui, sullo sfondo di situazioni stressanti, depressione e risentimento, vengono sostituiti a livello subconscio, portando allo sviluppo di sintomi fisiologici disturbi e malattie del corpo.
Definizione della sindrome
Il disturbo di conversione (conversione isterica, isteria) è una malattia psicologica. Inoltre, il fenomeno è chiamato disturbo dissociativo di conversione. Con questa sindrome, le funzioni sensoriali o motorie di una persona sono compromesse, per questo motivo inizia a notare sintomi reali di varie malattie. In effetti, non ci sono disturbi funzionali nel corpo, nonostante i loro sintomi evidenti, e la persona si sente male (il subconscio sostituisce le situazioni stressanti con malattie imitative).
Successivamente, informazioni sul disturbo sono apparse nelle opere di S. Freud, il quale ha spiegato che l'energia mentale di un paziente con disturbo di conversione si trasforma in energia somatica. La sostituzione degli stati depressivi con il subconscio porta a fantasie sulla malattia corporea e allo sviluppo di un quadro clinico di conversione.
La sindrome si manifesta con la perdita del controllo cosciente sulla memoria e sulle sensazioni, nonché sulla funzione motoria del corpo. Nei disturbi dissociativi, il processo di controllo è così compromesso che può cambiare ogni giorno e persino ogni ora. È difficile scoprire quanto siano danneggiate le funzioni di controllo della coscienza sul corpo; è stato stabilito che il disturbo di conversione della personalità è caratterizzato da una stretta connessione temporanea con eventi traumatici della vita, situazioni di conflitto, rottura delle relazioni con un partner e altri eventi insopportabili per la psiche.
Ragioni per lo sviluppo
È stato stabilito che le donne, così come i giovani e gli anziani, sono più suscettibili allo sviluppo della sindrome di conversione, poiché è proprio in queste categorie di persone che la sfera emotiva è la più vulnerabile e instabile.
La causa principale del disturbo di conversione è considerata un conflitto psicologico interno, in cui una persona è prevenuta nei confronti degli altri, fa richieste eccessive e smette di valutare realisticamente la situazione che la circonda. Nella maggior parte dei casi, questo comportamento è caratteristico delle persone con bassi livelli di autostima, in cui il desiderio di aumentare la propria importanza agli occhi degli altri porta alla conversione - la sostituzione subconscia di situazioni stressanti con lo sviluppo di sintomi di malattie. Pertanto, anche attraverso varie malattie, una persona cerca di essere al centro dell'attenzione se non riesce a raggiungere questo obiettivo in altri modi.
Il secondo motivo della reazione di conversione del corpo per sostituire l’energia psichica con l’energia somatica è il desiderio di fuggire da un conflitto interno o esterno esistente. Il corpo costruisce una reazione difensiva sotto forma di una malattia immaginaria per nascondersi da situazioni stressanti.
Una persona non può controllare consapevolmente entrambi i fattori; sperimenta una forte convinzione di essere gravemente malato e inizia a sperimentare effettivamente sintomi e segni di qualsiasi malattia.
Un fattore psicologico comune nel disturbo di conversione della personalità è ricevere qualche tipo di beneficio inconscio dalla sindrome. Pertanto, una persona con un disturbo dissociativo cerca di manipolare l'oggetto dell'amore e di tenerlo vicino, almeno con l'aiuto di una malattia immaginaria.
Sintomi
I dati di ricerche condotte nel 19° secolo affermano che i sintomi del disturbo di conversione della personalità si riducono a svenimenti, disturbi mentali, attacchi isterici e paralisi di vari gradi di gravità. Studi successivi hanno dimostrato che i sintomi di questa sindrome possono diffondersi a qualsiasi sistema del corpo, nonché a qualsiasi organo del corpo umano. Le manifestazioni più comuni sono la sensazione di nodo alla gola, difficoltà a deglutire e perdita di uno dei sensi della percezione sensoriale.
I sintomi di conversione sono divisi in diversi gruppi:
- Motore – una violazione delle funzioni fisiche del corpo, fino alla loro completa perdita. Si manifestano come disturbi della coordinazione e dell'andatura, paralisi e convulsioni dimostrative. Durante un attacco, il paziente può cadere a terra, piegarsi, assumere posizioni innaturali o urlare. Le convulsioni si verificano improvvisamente e durano da alcuni minuti a diverse ore. Un attacco si verifica dopo la comparsa di uno stimolo sotto forma di un suono forte, di una persona sconosciuta.
- Sensibile: si manifesta sotto forma di disfunzione sensoriale. Una persona cessa di sentire gli effetti del dolore e della temperatura; se queste funzioni non vengono perse, sono notevolmente ridotte. Le manifestazioni sotto forma di cecità temporanea, sordità, disturbi del gusto e della percezione olfattiva possono assumere durate e gamma di sensazioni diverse.
- Vegetativo - manifestato da spasmi della muscolatura liscia, che possono comparire in qualsiasi organo del corpo umano, così come nei vasi sanguigni e nel cuore. Questa vasta gamma di sintomi rende difficile la diagnosi perché i sintomi possono corrispondere a molte malattie.
- Mentale – chiamato anche sintomo di conversione isterica. Si manifestano come stati isterici, fantasie deliranti, allucinazioni e amnesia simulata (perdita di memoria a breve termine).
I sintomi possono essere piuttosto gravi, da periodici (che si verificano di tanto in tanto) a cronici. La manifestazione regolare dei segni del disturbo rende difficile per una persona funzionare sia socialmente, professionalmente e nella vita familiare.
Trattamento
Il trattamento dei disturbi dissociativi comprende farmaci e psicoterapia.
La farmacoterapia per i disturbi di conversione comprende farmaci:
Molto spesso, nel trattamento della conversione isterica vengono utilizzati farmaci dei gruppi di antidepressivi e tranquillanti. L'effetto del trattamento farmacologico è ridotto a sintomatico e patogenetico. Il miglioramento delle condizioni del paziente dopo l'assunzione dei farmaci può trasformarsi in uno stato di remissione stabile.
Il trattamento psicoterapeutico è un insieme di misure:
La terapia psicodinamica viene utilizzata per trattare bambini e adolescenti utilizzando approcci cognitivo comportamentali. La terapia familiare è indicata per le coppie il cui disturbo di conversione è associato a problemi familiari. Nel trattamento degli adolescenti, la terapia di gruppo viene utilizzata per sviluppare capacità di sopravvivenza in un ambiente sociale.
Se il trattamento ambulatoriale non produce risultati, vi sono indicazioni al ricovero ospedaliero del paziente. In ambito ospedaliero viene effettuata una diagnosi più approfondita dei disturbi organici e le condizioni del paziente migliorano al di fuori delle condizioni disfunzionali.
I sintomi notati nei propri cari che segnalano la presenza di una condizione come il disturbo di conversione della personalità non dovrebbero passare inosservati. Solo il contatto tempestivo con uno psicoterapeuta qualificato e l'eliminazione dei fattori provocatori - stress, incomprensioni e conflitti in famiglia e sul lavoro - saranno il percorso verso una terapia e un recupero di successo.
Quando si copiano materiali da questo sito, è richiesto un collegamento attivo al portale http://depressio.ru!
Tutte le foto e i video sono presi da fonti aperte. Se sei l'autore delle immagini utilizzate, scrivici e il problema verrà tempestivamente risolto. Informativa sulla privacy | Contatti | Informazioni sul sito | Mappa del sito
1.Concetto di conversione e disturbi di conversione Il termine "conversione" (letteralmente "trasformazione", "trasformazione") si riferisce alla causa del disturbo, che, essendo puramente psicologico, si esprime non a livello psicologico (ad esempio, ansia), ma attraverso sintomi somatici (corporei). Il disturbo di conversione è un tipo di disturbo somatoforme in cui motivazioni inconsce portano a disturbi del movimento o della sensazione. I disturbi motori comprendono, ad esempio, abasia, tremore, paralisi, debolezza, afonia; per quelli sensibili: diminuzione della sensibilità (solitamente intorpidimento), iperestesia (bruciore alla testa o allo stomaco), cecità, restringimento del campo visivo (visione tubolare), perdita dell'udito. Sono possibili convulsioni e vomito. Esordio tipicamente acuto ("Mi sono svegliato e non potevo muovere il braccio destro"). È importante che un esame obiettivo non riveli alcun segno neurologico caratteristico (danno a un gruppo muscolare specifico o all'area di innervazione di un dermatomero, diminuzione della sensibilità come "guanti" o "calzini"). Un altro segno importante dei disturbi di conversione è la connessione tra riacutizzazioni e stress o altre emozioni forti (secondo il paziente stesso o gli altri). Disturbi improvvisi permettono al paziente di fuggire da una situazione difficile o di cercare aiuto e cure. C'è sempre una motivazione subconscia (ad esempio, la paura di essere aggressivi) o un beneficio (ad esempio, la capacità di manipolare gli altri). Spesso, però, le aspirazioni del subconscio possono essere molto complesse e il loro ruolo nella malattia può essere compreso solo attraverso un'analisi molto dettagliata. Alcuni vedono i disturbi nei disturbi di conversione come una sorta di segnali con l'aiuto dei quali il subconscio cerca di raccontare i processi mentali interni. I disturbi di conversione possono essere causati da una forte reazione emotiva a malattie fisiche e pertanto tali malattie dovrebbero essere identificate e trattate per prime. Tuttavia, con i disturbi somatoformi, a volte questo può essere particolarmente difficile: uno studio oggettivo (EMG, TC, MRI) può “piacere” così tanto al paziente che inizia a cambiare attivamente i medici alla ricerca di metodi diagnostici sempre più complessi. Nella sua forma pura, il disturbo di conversione è raro; nella maggior parte dei casi, i sintomi di conversione accompagnano alcuni disturbi dell’adattamento psicologico. Il meccanismo scatenante che innesca lo sviluppo del processo di conversione sono solitamente eventi psicotraumatici (malattia, morte, lesioni, situazioni pericolose per la vita, violenza) - e il corpo reagisce ad essi in modo simile, a prima vista, paradossale. Ci sono due problemi principali nella diagnosi di questi disturbi: Nella fase iniziale della malattia è quasi impossibile escludere completamente la patologia somatica che può causare sintomi dissociativi (conversione). Per fare questa diagnosi sono spesso necessarie l'osservazione a lungo termine del paziente e numerose procedure diagnostiche (ad esempio, la risonanza magnetica per escludere un tumore al cervello). In tutti i casi dubbi è meglio fare una diagnosi preliminare di disturbo dissociativo (di conversione) per non perdere una grave malattia somatica. In molti casi, è difficile determinare se i sintomi di un disturbo siano inconsci o consci e intenzionali (la riproduzione deliberata dei sintomi in psichiatria è chiamata simulazione). Nella maggior parte dei casi, la simulazione viene osservata tra gli indagati, i detenuti, i coscritti e anche durante la leva militare. I pazienti con disturbo dissociativo (di conversione) spesso esagerano consapevolmente e deliberatamente i sintomi inconsci della loro malattia. Tuttavia, la diagnosi di questo disturbo presuppone l'esistenza di una componente inconscia all'origine dei sintomi. .Principali caratteristiche cliniche I sintomi dissociativi (di conversione) non sono intrinsecamente intenzionali e premeditati, tuttavia si formano sotto l’influenza dell’idea del paziente su come dovrebbe manifestarsi la malattia fisica. Come affermato sopra, i pazienti con disturbo dissociativo (di conversione) spesso esagerano consciamente e intenzionalmente i propri sintomi, ma la malattia si basa sempre su meccanismi mentali inconsci e non intenzionali. I pazienti affetti da questo disturbo non sono consapevoli delle basi psicologiche alla base dei loro disturbi, quindi non possono controllarli volontariamente. Inoltre, è abbastanza ovvio che i sintomi dissociativi (di conversione) sono espressione di conflitto emotivo, cioè i sintomi tendono a svilupparsi in stretta associazione con lo stress psicologico e spesso compaiono all'improvviso. Assenza di fattore eziologico organico. La presenza nel presente o nel passato di veri disturbi neurologici o malattie sistemiche che colpiscono il sistema nervoso centrale è notata nel 40% dei pazienti con disturbo dissociativo (di conversione). I sintomi dissociativi e di conversione sono talvolta difficili da distinguere da una malattia somatica o neurologica, il che è particolarmente vero per i pazienti che sono ben informati sul quadro clinico e sul decorso di queste malattie. Ma durante la visita medica e l'esame del paziente non vengono rilevati evidenti disturbi somatici o neurologici. Va ricordato che la diagnosi di disturbo dissociativo (di conversione) viene stabilita solo in assenza di disturbi fisici o neurologici o in assenza di una connessione eziologica con questi disturbi. Discrepanza tra il quadro clinico del disturbo dissociativo (di conversione) e il quadro clinico di malattie somatiche e neurologiche simili. Le manifestazioni dissociative (di conversione) non corrispondono ai sintomi dei veri disturbi neurologici, riflettendo le idee ingenue dei pazienti sull'innervazione anatomica (ad esempio, l'anestesia caratteristica di un arto; emiaanestesia con un bordo di sensibilità che passa esattamente lungo la linea mediana). Questa discrepanza è estremamente importante per chiarire la diagnosi. Identificazione. I pazienti spesso copiano inconsciamente le manifestazioni sintomatiche che osservano negli altri, che sono estremamente significative per i pazienti, ad esempio i genitori. Pertanto, i pazienti sembrano identificarsi con queste persone. Casi tipici sono quando, ad esempio, dopo la morte del padre, una figlia adulta sviluppa una paralisi dissociativa, simile nel quadro clinico a quella osservata nel padre prima della sua morte. Il vantaggio principale è che attraverso i processi di dissociazione e conversione, il paziente riesce inconsciamente a evitare conflitti psicologici interni; ad esempio, con l'amnesia dissociativa, gli eventi più spiacevoli scompaiono dalla memoria del paziente. Il beneficio secondario (sociale) è che i pazienti ricevono benefici significativi a seguito della loro malattia. I pazienti riescono ad evitare le situazioni quotidiane obbligate e difficili perché tutto gli viene perdonato; dagli altri ricevono aiuto, sostegno e attenzione che senza di questo non avrebbero ricevuto; I pazienti, sfruttando la loro condizione, possono manipolare i sentimenti di altre persone. Ad esempio, la paralisi dissociativa aiuta un paziente a rifiutare cure indesiderate per un parente anziano. Il paziente solitamente non ha un'adeguata consapevolezza del guadagno secondario. Nonostante la natura del beneficio secondario per i disturbi dissociativi e di conversione, non può essere utilizzato per formulare una diagnosi. .Tipi di disturbo dissociativo (di conversione). disturbo di conversione emotivo somatico Esistono disturbi dissociativi motori e sensoriali e disturbi dissociativi con sintomi mentali. I disturbi del movimento nel disturbo dissociativo (di conversione) comprendono stupore, paralisi, disturbi dell'andatura, tremori e tic, afonia, mutismo e convulsioni. Ø Stupore dissociativo. Il comportamento del paziente soddisfa i criteri dello stupore: i movimenti volontari e le reazioni agli stimoli esterni (ad esempio luce, rumore, tatto) sono nettamente ridotti o assenti. Il paziente rimane immobile per molto tempo, non ci sono parole e movimenti spontanei e intenzionali. Ø La paralisi dissociativa è l'incapacità di muovere qualsiasi parte del corpo. La paralisi è causata dalla contrazione simultanea dei muscoli flessori ed estensori (che non sono paralizzati). La paralisi può coinvolgere uno, due o tutti e quattro gli arti, sebbene la distribuzione della lesione non corrisponda all'innervazione. I riflessi non sono modificati, non ci sono riflessi patologici; fascicolazioni, segni di atrofia muscolare, alterazioni del tono; sull'elettromiogramma non vengono rilevati cambiamenti patologici. Ø Disturbi dissociativi dell'andatura. L'andatura è scoordinata, atassica, barcollante ed è accompagnata da movimenti pronunciati, irregolari e sussultori del corpo, nonché da movimenti irregolari e oscillazioni delle braccia. I pazienti con disturbi dissociativi dell'andatura raramente cadono e, quando cadono, di solito non subiscono lesioni. I disturbi dell'andatura si intensificano quando gli altri prestano attenzione al paziente. Ø Il tremore dissociativo è spesso di natura grossolana e si diffonde all'intero arto. Il tremore dissociativo aumenta quando l'attenzione viene attirata sul paziente. Nel disturbo dissociativo si osservano anche tic dissociativi. Se un paziente sviluppa tremori e tic, è necessario escludere una malattia neurologica, perché i movimenti coreoatetoidi di eziologia organica possono essere facilmente confusi con sintomi psicogeni. Ø L'afonia dissociativa e il mutismo non sono accompagnati da malattie del cavo orale e delle corde vocali. Ø Le crisi dissociative devono essere differenziate dalle vere crisi epilettiche. Con le crisi dissociative, i pazienti non perdono conoscenza durante l'attacco e conservano la memoria degli eventi di questo periodo; I movimenti stereotipati non sono tipici. I pazienti con crisi dissociative raramente sbattono la testa quando cadono; i movimenti convulsivi sono teatrali e si verificano sempre in presenza di altre persone; con convulsioni dissociative, non si osservano cianosi, minzione e defecazione involontaria e mordersi la lingua. Nella maggior parte dei casi non si riscontra alcuna attività parossistica all'EEG (va tenuto presente che il 10-15% della popolazione adulta presenta anomalie all'EEG). I disturbi dissociativi sensoriali comprendono iperestesia, parestesia, anestesia, cecità, sordità e visione a tunnel. Le principali differenze tra questi disturbi e le malattie organiche sono che la loro prevalenza non corrisponde all'innervazione, la gravità di questi disturbi è variabile e i sintomi del disturbo possono diminuire con la suggestione e l'autoipnosi. Ø L'anestesia, la parestesia e l'iperestesia nel disturbo dissociativo (di conversione) non corrispondono all'innervazione; i sintomi si notano più spesso alle estremità. La parestesia e l'iperestesia sono descritte dai pazienti, di regola, come una sensazione di dolore o bruciore. Ad esempio, si possono osservare le caratteristiche parestesie delle estremità del tipo “calze” e “calzini”; emianestesia con un bordo di sensibilità che passa esattamente lungo la linea mediana. Ø Sordità dissociativa, cecità e visione a tunnel. Questi sintomi possono essere unilaterali o bilaterali. Tuttavia, l'esame neurologico rivela vie sensoriali intatte. Nella cecità da conversione, ad esempio, i pazienti possono muoversi senza assistenza e le pupille rispondono bene alla luce. Disturbi dissociativi con sintomi psichiatrici Ø L'amnesia dissociativa (amnesia psicogena) è un'improvvisa perdita di memoria in un paziente causata dallo stress o da un evento traumatico. Sotto l'influenza di una situazione psicotraumatica, tutto ciò che è connesso ad essa “cade”, viene “rimosso” dalla memoria. A volte il paziente dimentica temporaneamente non solo qualche episodio o singolo evento, ma tutta la sua vita, compreso il proprio nome e cognome. La coscienza del paziente non è compromessa, è consapevole della perdita di memoria e la capacità di assimilare nuove informazioni viene preservata. Durante un episodio amnestico, il paziente può apparire disorientato, confuso, vagare senza meta e potrebbe non riconoscere i volti familiari. A volte, esteriormente, il paziente può mantenere un comportamento normale e svolgere alcune attività quotidiane in modo soddisfacente. L'amnesia può portare al paziente benefici sia primari (ad esempio, la perdita di memoria della morte di persone care) che secondari (ad esempio, la rimozione di un soldato affetto da amnesia da una zona di combattimento). Le amnesie dissociative sono generalmente di breve durata e terminano con il completo ripristino della memoria. Il disturbo si manifesta solitamente durante la guerra o un disastro naturale, più spesso nelle giovani donne. Ø La fuga dissociativa (reazione di fuga psicogena, reazione di fuga dissociativa) è caratterizzata da una persona che fa inaspettatamente un viaggio o addirittura viaggia in uno stato corrispondente all'amnesia dissociativa. A differenza dell'amnesia psicogena, il paziente durante un episodio di fuga non è consapevole del disturbo della memoria e non appare disorientato. Il paziente può considerarsi una persona completamente diversa e svolgere un lavoro completamente diverso. La durata di una fuga è solitamente di diverse ore/giorni. I casi rari possono durare diversi mesi, durante i quali a volte il paziente riesce a percorrere migliaia di chilometri. La fine dell'episodio, come l'inizio, avviene all'improvviso, spesso all'uscita da una notte di sonno. Caratteristica è la successiva perdita parziale o totale della memoria del proprio passato, in molti casi senza consapevolezza di tale perdita. Ø Anche lo stupore dissociativo (stupore isterico, stupore psicogeno, stupore pseudocatatonico, stupore emotivo) ha un'origine psicogena; si manifesta come grave ritardo psicomotorio, accompagnato da mutismo e grave stress affettivo. Le espressioni facciali sono espressive e riflettono gli affetti (sofferenza, disperazione, rabbia). Quando si ricorda un trauma psicologico, il polso dei pazienti accelera, le lacrime si riempiono nei loro occhi e le loro palpebre e le ali del naso tremano. Caratterizzato dalla conservazione del normale tono muscolare, dalla respirazione e dalla capacità di mantenere autonomamente la posizione verticale del corpo. Ø La sindrome di Ganser è una condizione rara in cui il deterioramento della memoria dissociativa è accompagnato da sintomi somatici psicogeni, allucinazioni visive e stupore crepuscolare. Il disturbo è segnalato più spesso negli uomini, soprattutto tra i detenuti. Con la sindrome di Ganser, a volte si osserva un linguaggio mimico: risposte errate a semplici domande (alla domanda "Che cosa fa due volte sette?", il paziente risponde "Quindici"). Ø Il disturbo di personalità multipla (disturbo dissociativo dell'identificazione) è una condizione estremamente rara in cui una persona si identifica con diverse personalità che sembrano esistere solo in lui; ognuno di loro periodicamente domina, determinando le sue opinioni, il suo comportamento e il suo atteggiamento verso se stesso come se le altre personalità fossero assenti. Personalità diverse possono avere caratteristiche fisiologiche diverse, come la necessità di prescrizioni di occhiali diverse; Potrebbero esserci risposte diverse ai test psicometrici, ad esempio personalità diverse potrebbero avere QI diversi. Gli individui possono essere di sesso, età e nazionalità diversi, ciascuno di solito ha un nome o una descrizione diversa. Durante il periodo di predominanza di una delle personalità, il paziente non ricorda la sua personalità originaria e non è consapevole dell'esistenza di altre personalità. C'è una tendenza ad una transizione improvvisa dal dominio di una personalità al dominio di un'altra. Ø Disturbo dissociativo sotto forma di trance. Un disturbo della coscienza con una significativa diminuzione della capacità di rispondere agli stimoli esterni. Uno stato di trance si osserva nei medium durante le sedute spiritiche e nei piloti durante i voli lunghi a causa della monotonia del movimento ad alta velocità e della monotonia delle impressioni visive, che possono portare a incidenti aerei. Nei bambini, tali condizioni possono verificarsi dopo abusi fisici o traumi. Stati speciali di possessione si osservano in una certa regione o in una cultura particolare, ad esempio, "amok" tra i malesi (un improvviso attacco di rabbia seguito da amnesia, durante il quale il paziente corre, distruggendo tutto sul suo cammino, fino a paralizzare o si ucciderà), “piblokto” presso gli eschimesi (attacchi di eccitazione seguiti da amnesia, durante i quali i pazienti urlano, imitano i versi degli animali e si strappano i vestiti). 4.Diagnosi differenziale Nella maggior parte dei casi, i maggiori problemi sono causati dall'esclusione delle malattie organiche del sistema nervoso centrale. Ad esempio, si nota debolezza nella miastenia grave, nelle miopatie e nella sclerosi multipla. La neurite ottica può essere confusa con cecità dissociativa. Sintomi e segni che non corrispondono alle strutture anatomiche o ai meccanismi fisiopatologici noti di alcuna malattia, e che variano anche da una valutazione all'altra, hanno maggiori probabilità di essere dovuti a un disturbo dissociativo che a una malattia fisica. Pertanto, in tutti i casi è necessario condurre un esame somatico e neurologico approfondito del paziente. Sintomi. che scompaiono sotto l'influenza dell'ipnosi, della suggestione o della somministrazione endovenosa di barbamil, sono molto probabilmente psicogeni. Quando si effettua una diagnosi differenziale del disturbo dissociativo (di conversione), è necessario tenere conto delle seguenti caratteristiche cliniche: Età di insorgenza della malattia. I disturbi dissociativi vengono spesso diagnosticati per la prima volta prima dei 40 anni. La comparsa dei sintomi è provocata da situazioni stressanti. Se tali situazioni sono assenti, la diagnosi del disturbo è dubbia. Tuttavia, le situazioni stressanti di per sé non dimostrano una diagnosi di disturbo dissociativo, perché spesso precedono le malattie somatiche. Beneficio secondario (vedi sopra). In assenza di beneficio secondario, la diagnosi di disturbo dissociativo dovrebbe essere riconsiderata. Tuttavia, la sola presenza di guadagno secondario non dimostra una diagnosi del disturbo, perché A volte i pazienti con malattie fisiche sfruttano la loro condizione per raggiungere alcuni obiettivi (ad esempio, benefici per la disabilità). 5.Trattamento Innanzitutto è necessario, se possibile, eliminare le circostanze traumatiche o mitigarne l’impatto. A volte un cambiamento di ambiente ha un effetto positivo. Il posto principale nel trattamento dei disturbi dissociativi è dato alla psicoterapia, in particolare alla terapia razionale. È necessario spiegare con delicatezza al paziente che i sintomi non sono causati da una malattia fisica, ma da ragioni psicologiche, ad esempio si può dire al paziente che va tutto bene, che tutti i sintomi dolorosi passeranno col tempo e che sta bene indicato per il trattamento con metodi psicologici. Se dici a questi pazienti che tutte le loro lamentele sono frutto dell'immaginazione, ciò non porterà a un miglioramento, ma a un peggioramento. Ripetute conversazioni persistenti e mirate con il paziente lo aiutano a sviluppare l'atteggiamento corretto nei confronti delle cause della malattia. Trattamento psicologico. Il metodo di scelta è la psicoterapia psicoanalitica. In alcuni casi, l’ipnosi e la psicoterapia comportamentale hanno successo. Una condizione importante per il successo del trattamento è lo studio della situazione sociale del paziente al fine di eliminare i benefici secondari della malattia. La terapia farmacologica gioca un ruolo minore nel trattamento dei disturbi dissociativi, tranne nei casi in cui i sintomi di conversione si manifestano secondariamente a disturbi depressivi. Per l'ansia grave si consigliano tranquillanti, ad esempio diazepam 2-10 mg per via orale 2-4 volte al giorno (il trattamento a lungo termine non è indicato a causa dell'alto rischio di sviluppare dipendenza). Per gli stati depressivi vengono prescritti antidepressivi, ad esempio fluoxetina 20-40 mg/die. Guidare le tattiche. La maggior parte dei pazienti migliora con il trattamento. Se la terapia non ha alcun effetto, è necessario escludere ancora una volta la possibilità di una malattia somatica. Per trattare i disturbi dissociativi vengono utilizzati metodi di psicoterapia più brevi e più direttivi. Quanto più tempo questi pazienti trascorrono nel ruolo di pazienti, tanto peggio rispondono alla terapia. .Previsione Nella maggior parte dei casi, i sintomi di conversione sono di breve durata, iniziano improvvisamente e finiscono altrettanto improvvisamente. I disturbi dissociativi a lungo termine associati al guadagno secondario sono difficili da trattare. Amnesia dissociativa: fine improvvisa del disturbo, poche ricadute. Fuga dissociativa - di solito un disturbo a breve termine, il recupero avviene spontaneamente e rapidamente, le ricadute sono rare Il disturbo dissociativo dell’identità è il più grave dei disturbi dissociativi ed è più probabile che abbia un decorso cronico. I pazienti con disturbi dissociativi dell'identità per tutta la vita, pur rimanendo esteriormente assolutamente sani, possono soffrire di condizioni depressive. .Concetto di alessitimia L'alessitimia (dal greco a - negazione, greco lexis - parola, greco Thymos - sentimento, letteralmente "senza parole per i sentimenti") è una caratteristica psicologica di una persona, che include le seguenti caratteristiche: difficoltà nel definire e descrivere (verbalizzare) le proprie emozioni e quelle degli altri; difficoltà a distinguere tra emozioni e sensazioni corporee; diminuzione della capacità di simbolizzare, in particolare di fantasia; concentrarsi principalmente sugli eventi esterni, a scapito delle esperienze interne; una tendenza al pensiero concreto, utilitaristico e logico con una carenza di reazioni emotive. Tutte queste caratteristiche possono manifestarsi allo stesso modo, oppure una di esse può predominare. Il termine “alessitimia” fu introdotto da Sifneos nel 1973. Nella sua opera, pubblicata nel 1968, descrisse le caratteristiche osservate nei pazienti in una clinica psicosomatica, che erano espresse in un modo di pensare utilitaristico, una tendenza a usare le azioni in situazioni conflittuali e stressanti, una vita impoverita dalle fantasie, restringimento dell’esperienza affettiva e, soprattutto, difficoltà a trovare la parola giusta per descrivere i propri sentimenti. Questa è una limitazione delle connessioni sensoriali con il mondo e riduce la capacità di distinguere i sentimenti dalle sensazioni corporee, di rispondere adeguatamente a situazioni di stress e di conflitto, di comprendere il mondo in tutta la sua complessità e di costruire un contesto immaginativo della situazione. Pertanto, una persona ha la sensazione di essere perseguitata da fallimenti nelle sue attività, forse reali e forse esistenti solo nella sua coscienza. E questi fallimenti iniziano ad acquisire per una persona un significato emotivo e un significato personale maggiore rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. E poi la sfera motivazionale viene distorta, gli accenti semantici vengono spostati e sono loro che determinano in gran parte il rapporto di una persona con la realtà circostante. .Come si manifesta l'alessitimia? Tipicamente, l'alessitimia si manifesta in questo modo: “non hai parole” per esprimere sentimenti, oppure trovi difficile identificare una situazione emotivamente carica che sia significativa per la tua vita mentale interiore, oppure non sei in grado di spiegare, raccontare cosa ti sta accadendo a livello dei sentimenti. Di solito, con l'alessitimia, i sogni sono rari e sono vaghi e frammentari. Che aspetto ha questo nella vita reale? Se, ad esempio, a una persona che è semplicemente seduta su una sedia viene posta la domanda: "Cosa ti senti adesso?", molto spesso risponderà: "Niente. Come posso sentirmi se non succede nulla intorno a me? Sento che la sedia è morbida...” oppure inizierà a descrivere le sue azioni: “Sono seduto su una sedia. Sto guardando il quadro sul muro” oppure alla descrizione della situazione: “Fuori il tempo è bello. C'è un quadro sul muro...". Invece di dire: “Provo gioia perché fuori fa bel tempo e c’è un bel quadro sul muro”... .Come si manifesta l'alessitimia? L’alessitimia può essere un tratto permanente della personalità o può essere una reazione temporanea alla depressione o all’ansia. Se questo è un tratto umano, il suo sviluppo inizia nell'adolescenza. Se non insegni a un bambino a parlare di come si sente, di come lo esprime, non imparerà a entrare in empatia. E i genitori spesso non solo non chiedono al bambino i suoi sentimenti, ma, al contrario, insegnano loro a nasconderli in ogni modo possibile, dimostrando con l'esempio un comportamento adeguato. E le persone crescono con la capacità di comprendere ed esprimere sentimenti che non si è sviluppata all'età giusta: persone con alessitimia primaria. Consideriamo innanzitutto l'idea di esso come un processo primario in cui il ruolo principale può appartenere a meccanismi genetici, difetti o varianti speciali dello sviluppo del cervello. Alcuni autori considerano l'alessitimia primaria (costituzionale) nel quadro del modello del “deficit”, che definisce l'assenza di funzioni associate all'espressione degli affetti e delle fantasie. J. Nemiah e P. Sifnoes hanno collegato empiricamente il disturbo alessitimico con disturbi del tratto paleostriatale, che, a loro avviso, si traduce nella soppressione degli impulsi dal sistema limbico alla corteccia cerebrale. Vicino all'ipotesi neuroanatomica e neurofisiologica dichiarata ce n'è un'altra, che considera l'alessitimia come un difetto nello sviluppo del cervello. In questo caso si presuppone un difetto del corpo calloso o una localizzazione bilaterale o anormale del centro della parola nell'emisfero destro. Ma l’alessitimia può anche essere secondaria. Si sviluppa come risultato della predominanza dei meccanismi di difesa nel processo di sviluppo della personalità. Cioè, se l'espressione dei sentimenti in passato ha portato un risultato negativo - dolore, paura, senso di colpa, ecc., La persona ha ricevuto un'esperienza traumatica negativa e, di conseguenza, è giunta alla conclusione che è meglio non mostrare mai i suoi sentimenti sentimenti e non raccontarli a nessuno. E per non lasciarlo sfuggire accidentalmente, è meglio nasconderli a te stesso. Sfortunatamente, il rifiuto di un possibile dolore spesso implica il lato opposto: il rifiuto di una possibile gioia. L'alessitimia secondaria comprende, in particolare, uno stato di inibizione globale degli affetti o di “intorpidimento” che si verifica a seguito di un grave trauma psicologico (il modello della “negazione”). L'alessitimia in questo caso può riflettere dolore o depressione nascosta in forma patologica. In questo caso è considerato un “meccanismo di difesa”, sebbene non sia una difesa psicologica nel senso classico. Bisogna però tenere presente che gli individui alessitimici sono caratterizzati da un tipo di difesa cosiddetto “immaturo”, soprattutto dagli affetti superforti che risultano loro intollerabili. La scoperta dell'alessitimia nella depressione mascherata e nelle nevrosi ha dato ad alcuni autori motivo di considerarla dal punto di vista della nevrosi. I tratti alessitimici sono comuni nei pazienti con disturbo da stress post-traumatico. In numerosi disturbi mentali borderline è stata stabilita una relazione positiva tra il livello di alessitimia, depressione e ansia. A questo proposito, è stato suggerito che i tratti alessitimici si sviluppino sulla base di ansia e depressione preesistenti. Recentemente sono apparsi studi che mettono in luce un nuovo aspetto del problema dell'alessitimia, vale a dire il suo legame con il rischio di morte. Il punto è che la presenza di caratteristiche alessitimiche nella struttura della personalità degli uomini di età compresa tra 42 e 60 anni aumenta di 2-3 volte il rischio di morte prematura per varie cause (compresi incidenti, violenza, ecc.). Esistono anche una serie di cosiddette teorie sociologiche che spiegano l'emergere della sindrome di alessitimia in termini di fattori comportamentali, sociali e culturali. Krystal ritiene che lo sviluppo emotivo di una persona e, di conseguenza, la patologia dell'emotività dipendano direttamente da la natura della relazione nel sistema madre-bambino nella prima infanzia. Esistono studi in cui il ruolo principale nella formazione dell'alessitimia è attribuito alla famiglia: sono state notate difficoltà nel descrivere le proprie emozioni negli adulti sia con un basso livello di cure materne, sia con iperprotezione materna nell'infanzia. La letteratura affronta anche questioni di predisposizione allo sviluppo dell'alessitimia in base al sesso, all'età, all'istruzione, all'occupazione e al livello di cultura sociale. È stato notato che l’alessitimia è più comune tra la popolazione maschile con basso status sociale e reddito, nonché con un basso livello di istruzione. Si osserva una tendenza ad aumentare la frequenza dell'alessitimia (fino al 34%) in età avanzata (per confronto: tra gli studenti, l'8,2% degli uomini e l'1,8% delle donne presentano segni di alessitimia). Confrontando i punteggi medi che caratterizzano il livello di alessitimia in residenti sani di diversi paesi, si è riscontrato che il punteggio medio di alessitimia negli uomini di lingua inglese è inferiore a quello degli europei non di lingua inglese; I parlanti cinesi, a loro volta, hanno dimostrato un punteggio medio di alessitimia più elevato rispetto alla popolazione europea. Tali differenze sono ragionevolmente spiegate dalle caratteristiche culturali dei diversi popoli. È stato inoltre riscontrato che la caratteristica alessitimica, come la difficoltà a differenziare sentimenti e sensazioni corporee, è associata al numero totale di anni di istruzione di una persona, al suo status sociale e alla gravità della depressione; la difficoltà di verbalizzare i sentimenti dipende dall’età della persona, dallo status sociale, dalla depressione e dalle malattie pregresse; La povertà di fantasia e immaginazione è associata all’età di una persona e al suo adattamento sociale. Ampiamente dibattuta è la questione relativa alla predisposizione degli individui alessitimici allo sviluppo della patologia pulsionale - dipendenza da alcol e droghe. È stata notata una predisposizione delle persone con alessitimia all'alcolismo e alla tossicodipendenza, sebbene l'alessitimia svolga un ruolo minore nello sviluppo della dipendenza dalla nicotina. La questione della stabilità dell’alessitimia è di grande importanza clinica. Secondo J. Salminen, che ha osservato per un anno pazienti psichiatrici ambulatoriali, l'alessitimia è un disturbo molto stabile (a giudicare dalle caratteristiche, in questo caso si parlava di alessitimia primaria) .Costituzione psicologica di una persona Non dovresti pensare che l'alessitimia sia una malattia, no, è un fenomeno, una caratteristica complessa di una persona, una certa costituzione psicologica di una persona. Ma se non è una malattia, allora che senso ha parlarne? Tuttavia, non tutto è così semplice. Questo fenomeno indica che una persona è chiusa a nuove esperienze e si concentra su esperienze negative. Le persone con alessitimia sono più inclini di altre alla depressione e allo sviluppo di malattie psicosomatiche (malattia coronarica, ipertensione, ulcera peptica dello stomaco e del duodeno, asma bronchiale, ecc.), e il decorso di queste malattie è, in media, più grave rispetto ad altri pazienti. L'alessitimia può anche essere un segno caratteristico di una situazione stressante grave e persistente, alla quale una persona si è già abituata e la valuta come normale. E la conseguenza dell’alessitimia è spesso la solitudine. Inoltre, l'alessitimia è caratterizzata da alcuni disturbi nei processi emotivi e personali, nonché nella sfera del pensiero. Nella sfera emotiva, si manifesta come incapacità di riconoscere e descrivere con precisione il proprio stato emotivo e lo stato emotivo di altre persone, un coinvolgimento emotivo insufficiente in una situazione oggettiva (fissazione in misura maggiore su eventi esterni che su esperienze interne), difficoltà nel distinguere tra sentimenti e sensazioni corporee. Queste persone non sono in grado, ad esempio, di distinguere la stanchezza cronica dalla depressione. Nella sfera personale, l'alessitimia si manifesta con una riluttanza o incapacità a riflettere (il processo di autoconoscenza di una persona dei propri atti e stati mentali interni, il processo di pensare a ciò che sta accadendo nella propria mente), che, a sua volta , porta a una semplificazione dell'orientamento alla vita, all'impoverimento delle relazioni con il mondo esterno, a volte a una certa immaturità. Nella sfera del pensiero, una persona preferisce utilizzare il pensiero visivo-efficace piuttosto che il pensiero logico-astratto, non utilizza le possibilità della sua immaginazione, come dimostra la mancanza di inclinazione ai sogni e alle fantasie. Inoltre fa poco uso dei processi di categorizzazione (il processo mentale di assegnare un singolo oggetto, evento, esperienza a una determinata classe, cioè la categorizzazione è un processo di generalizzazione seguito dalla classificazione) e di simbolizzazione del pensiero. .Metodi per misurare l'alessitimia Per determinare la gravità dell'alessitimia sono stati utilizzati vari questionari: BIQ (questionario Beth, Israele), ARVQ (creato sulla base della scala BIQ), SSPS (scala della personalità Sifnoes); È stata utilizzata anche la scala di alessitimia a 22 item dell’MMPI. Ma tutti fornivano dati molto contraddittori, quindi non furono ampiamente utilizzati nella ricerca scientifica. Divenne più diffusa quella proposta nel 1985 da G. Taylor et al. Scala alessitimica di Toronto a 26 elementi (TAS). Numerosi studi che utilizzano la TAS hanno dimostrato la stabilità, l'affidabilità e la validità della sua struttura fattoriale e, di conseguenza, i risultati ottenuti. La versione russa di TAS è stata adattata presso l'Istituto Psiconeurologico da cui prende il nome. V.M. Bechterev. Durante la compilazione del questionario, il soggetto si caratterizza utilizzando una scala Likert per le risposte - da "completamente in disaccordo" a "completamente d'accordo". In questo caso, metà dei punti ha un codice positivo, l'altro - negativo. Sono considerate alessitimiche le persone che ottengono un punteggio pari o superiore a 74 punti alla TAS; un punteggio inferiore a 62 punti corrisponde all'assenza di alessitimia. .Scala alessitimica di Toronto Il test è stato adattato presso l'Istituto omonimo. V.M. Bechterev. Utilizzando questa scala, indica quanto sei d'accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti affermazioni (metti una X nello spazio appropriato). Dai una sola risposta per ciascuna affermazione: 1) completamente in disaccordo, 2) abbastanza in disaccordo, 3) né l'uno né l'altro, 4) abbastanza d'accordo, 5) completamente d'accordo. N. di affermazioni completamente in disaccordo piuttosto in disaccordo entrambe piuttosto d'accordo completamente d'accordo 123 451 Quando piango, so sempre perché 2 I sogni sono una perdita di tempo 3 Vorrei non essere così timido 4 Spesso trovo difficile determinare quali sentimenti provo 5 Sogno spesso il futuro 6 Penso di essere capace di fare amicizia con la stessa facilità degli altri 7Saper risolvere i problemi è più importante che comprendere le ragioni di quelle decisioni 8Ho difficoltà a trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti 9Mi piace far sapere la mia posizione su alcuni temi 10Ho sensazioni fisiche che nemmeno i medici riescono a comprendere 11 Non mi basta sapere cosa ha portato a questo risultato, ho bisogno di sapere perché e come avviene 12 Sono in grado di descrivere facilmente la mia sentimenti 13 Preferisco analizzare i problemi piuttosto che limitarsi a descriverli 14 Quando sono turbato, non so se sono triste, spaventato o arrabbiato 15 Spesso do libero sfogo alla mia immaginazione 16 Trascorro molto tempo a sognare ad occhi aperti quando non sono fare altro 17Sono spesso perplesso dalle sensazioni che appaiono nel mio corpo 18Raramente sogno ad occhi aperti 19Preferisco lasciare che le cose vadano da sole piuttosto che capire perché sono andate in quel modo 20U Ho delle sensazioni a cui non so dare una definizione molto precisa 21 It è molto importante essere in grado di comprendere le emozioni 22 È difficile per me descrivere i miei sentimenti nei confronti delle persone 23 Le persone mi dicono di esprimere di più i miei sentimenti 24 Dovrei cercare spiegazioni più profonde di ciò che sta accadendo 25 Non so cosa sta succedendo dentro io 26Spesso non so perché mi arrabbio ELABORAZIONE DATI Il punteggio viene calcolato come segue: “completamente in disaccordo” - 1 punto, “piuttosto in disaccordo” - 2, “né l’uno né l’altro” - 3, “piuttosto d'accordo” - 4, “completamente d'accordo” - 5. Ecco come vengono valutati i punti della scala: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26. I punti della scala vengono valutati diversamente: 1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 24. In essi mettiamo il punteggio opposto su questi punti (cioè, il punteggio 1 ottiene 5 punti; 2-4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 1); La somma dei punti ottenuti sommando tutti i punti è l'indicatore finale di "alessitimicità". I risultati possono essere distribuiti nell'intervallo da 26 a 130 punti. Il tipo di personalità “alessitimico” ottiene un punteggio pari o superiore a 74 punti. Sulla base dell'esperienza clinica, si ritiene opportuno classificare i soggetti del gruppo con punteggi compresi tra 62 e 74 punti come gruppo a rischio, condurre ulteriori diagnosi chiarificatrici, identificare i fattori che hanno un impatto negativo e quindi invitarli periodicamente a sottoporsi a test per escludere risultati negativi. dinamica. Il tipo di personalità “non alixitimico” ottiene un punteggio pari o inferiore a 62 punti. Conclusione Pertanto, le caratteristiche delle caratteristiche dell'alessitimia scoperte durante la ricerca psicologica includono: povertà del linguaggio nelle autodescrizioni e nella comunicazione; scarsa rappresentazione degli eventi della vita passata nel presente; l’impossibilità di una previsione adeguata della propria attività (anche in una situazione sperimentale); iniziativa e attività insufficienti nella ricerca di fondi, anche durante l'esecuzione di compiti sperimentali; dipendenza da un adulto vicino (madre) quando si eseguono insieme una serie di compiti; instabilità e indifferenziazione dell'autostima, in alcuni casi una proiezione completa delle valutazioni degli altri nella struttura dell'autostima del paziente; instabilità e inadeguatezza della definizione degli obiettivi quando si studia il livello delle aspirazioni; incertezza o totale mancanza di prospettive per il futuro. Una delle direzioni principali per la prevenzione delle violazioni delle relazioni interpersonali, dei disturbi psicosomatici, delle nevrosi, della depressione e del comportamento autodistruttivo è lo sviluppo della capacità e del desiderio di esprimere le proprie emozioni e bisogni con parole “piene”, di scambiarle liberamente con "altri significativi." La limitazione nella capacità di comprendere se stessi, associata a uno scarso utilizzo delle capacità di riflessione, diventa un ostacolo significativo alla comprensione di ciò che sta accadendo, alla possibilità di una visione olistica della propria vita. Dopotutto, la riflessione permette di guardarsi dall'esterno, di realizzare il significato della propria vita e delle proprie attività, permette di vederle in una relazione temporanea, di stabilire una connessione semantica tra il presente, il passato e il futuro, che consente a una persona di creare e mantenere l'armonia interiore, di cambiare il proprio mondo interiore in modo necessario e di non essere completamente in balia della situazione. L'autoregolamentazione consente a una persona di cambiare in base alle mutevoli circostanze del mondo esterno e alle condizioni della sua vita, supporta l'attività mentale necessaria per l'attività umana e garantisce l'organizzazione consapevole e la correzione delle sue azioni. La cosa principale è che una persona è consapevole dei motivi delle proprie attività e può gestire i propri bisogni, e questo gli dà l'opportunità di essere il maestro, il creatore della propria vita, la libertà dalle circostanze e la possibilità di autorealizzazione , un atteggiamento creativo attivo nei confronti della sua vita, una comprensione della sua identità personale. La capacità di controllare arbitrariamente le proprie motivazioni è una delle caratteristiche più importanti di una persona, un indicatore dell'armonia e della maturità dell'individuo, a cui si dovrebbe aspirare.
Questa patologia mentale è nota alle persone fin dai tempi dell'antica Grecia. L'isteria (nevrosi isterica, conversione o disturbo dissociativo secondo la moderna classificazione dell'ICD 10) è un disturbo della personalità caratterizzato dalla pronunciata dimostratività del paziente, dal suo aumentato bisogno di autoattenzione, dall'autostima gonfiata, dall'egocentrismo, nonché da un varietà di sintomi di conversione che insorgono quando una determinata personalità è scompensata.
. Canale Youtube.Storia dello studio sull'isteria (disturbo dissociativo)
La parola "isteria" deriva dal termine "hystera" (greco per "utero"). Nell'antica Grecia, erano fiduciosi nella possibilità che questa malattia si manifestasse solo nei rappresentanti del "gentil sesso" e nella sua connessione con la rottura dell'utero della donna. Credevano che "un utero insoddisfatto cammina per tutto il corpo del paziente, comprimendo se stesso e altri organi e vasi", e questo a sua volta porta a vari disturbi nel corpo. Si credeva che laddove l’utero “si fermava”, in quella parte del corpo o organo si sarebbe manifestato un “sintomo”. Oggi è stato dimostrato che l'insorgenza dell'isteria non ha nulla a che fare con il genere, tuttavia si manifesta molto meno frequentemente negli uomini che nelle donne. Queste caratteristiche sono associate ad una maggiore labilità emotiva delle donne.
Isteria (disturbo dissociativo) – una brava attrice
L'isteria è caratterizzata da sintomi estremamente diversi. Ovviamente è per questo che è stata soprannominata “la pretendente”, perché può assumere la forma di quasi tutte le malattie somatiche, ed è capace di manifestare sintomi corporei in assenza di veri e propri disturbi. Molto spesso si maschera da malattia sconosciuta che non risponde alla terapia medica convenzionale. Quasi ogni comportamento di un isterico è focalizzato sul pubblico: in sua assenza, tutte le manifestazioni emotive semplicemente non hanno senso. Queste persone si preoccupano dell'impressione che fanno. Vogliono essere amati, ammirati e vogliono attirare l'attenzione di tutti.
Nevrosi isterica o conversione, disturbo dissociativo secondo la classificazione moderna (ICD 10) è accompagnato da sintomi piuttosto insoliti che convertono lo stress mentale in sintomi somatici (corporei). Questi sintomi di conversione compaiono spesso durante un trauma psicologico e sono considerati uno scompenso della personalità. Questi sintomi includono: disturbi della sensibilità, della vista, dell'udito, della voce, disturbi del movimento, disturbi somatici (corporei). Una persona con nevrosi isterica vuole essere considerata malsana. Il suo bisogno di malattia è così attualizzato che si può parlare addirittura di dipendenza. Con questi sintomi, naturalmente, le malattie organiche sono escluse.
Il meccanismo con cui si formano i sintomi isterici (di conversione, dissociativi) è il seguente: vari disturbi psicologici spiacevoli, grazie ad un meccanismo protettivo chiamato “rimozione”, si trasformano in disturbi utilizzati dal paziente (spesso inconsciamente) per attirare l'attenzione delle persone. in giro. Di conseguenza, lo stato doloroso acquisisce il carattere non solo piacevole, ma anche desiderabile per il paziente. Ciò rende il processo di trattamento più difficile.
Netrusova Svetlana Grigorievna – candidata alle scienze mediche, professoressa associata, psichiatra della più alta categoria, psicoterapeuta. Puoi guardare altri video su questo argomento sul nostro Canale Youtube.Scompenso dell'isteria (personalità dissociativa) sotto forma di sintomi di conversione
Grande attacco isterico può essere definita una sorta di “performance”, che comprende diversi “atti” (fasi). A volte il personale ospedaliero può vedere le condizioni indotte dei pazienti che si trovano nella stessa stanza. La crisi di un paziente viene “raccolta” da altri pazienti del reparto, e ognuno mostra contemporaneamente i suoi “lati migliori”. Durante tali convulsioni, una persona può eseguire una serie di movimenti caotici con le mani o, al contrario, può rimanere immobilizzata per qualche tempo. A volte si verificano attacchi di letargo isterico (attacchi letargici), ripetuti più volte al giorno. In questa condizione non è possibile svegliare una persona utilizzando i metodi consueti. Con una lunga durata di tali stati, sono classificati come stupore isterico.
È necessario distinguere tra crisi isteriche e crisi di grande male nell'epilessia. Durante un attacco epilettico, una persona non ha bisogno di un pubblico ("spettatori") e si verifica un disturbo della coscienza (coma), che non si osserva negli isterici. Lo stato di coma può essere rilevato da tali segni, in particolare, come soppressione dei riflessi, dilatazione delle pupille, mancanza di reazione alla luce, assenza di riflessi corneali (non si osserva il battito delle palpebre quando si tocca la cornea dell'occhio) , riflessi addominali. Dopo un attacco, i pazienti con epilessia sperimentano un'amnesia, quando non ricordano cosa è successo. Questo non si può dire dei pazienti con isteria che sono in condizioni eccellenti dopo un attacco.
Manifestazioni di conversione
I sintomi di conversione possono assumere la forma di disturbi del movimento: paralisi, paresi, ipercinesia, ecc. Tali “lesioni” colpiscono solitamente gli arti. È curioso che in questi casi le gambe siano colpite più spesso (astasia - incapacità di stare in piedi, abasia - incapacità di camminare) rispetto alle braccia. Ciò è dovuto al fatto che le persone usano le mani per mangiare e servirsi. Inoltre, nelle persone affette da conversione, disturbo dissociativo (nevrosi isterica), i muscoli del viso, del collo o della lingua vengono colpiti molto raramente (al contrario della vera paralisi). Anche questo fatto non sorprende, dal momento che gli isterici senza le parti del corpo di cui sopra semplicemente non saranno in grado di "eseguire spettacoli". Il paziente a volte può assumere pose davvero bizzarre, assolutamente insolite per le persone con lesioni organiche. Con la vera paralisi, si osserva l'estinzione dei riflessi e una significativa diminuzione del tono muscolare, ma nel corso della conversione, dei disturbi dissociativi (isterici) questo non è il caso. Tutti i riflessi sono preservati e il tono muscolare è normale.
Un altro tipo di conversione - disturbi della sensibilità, manifestato da un cambiamento nella soglia del dolore e dal dolore isterico (algia). Ma la distribuzione delle aree di disturbo non corrisponde affatto a quelle aree innervate dai nervi sensoriali, ma corrisponde solo alle idee soggettive del paziente sulla distribuzione delle funzioni. Se il paziente impara quali aree devono essere innervate nel “modo corretto”, le aree di perdita di sensibilità esistenti cambiano la loro posizione. L'algia durante l'isteria può essere di diversa natura, origine e localizzazione. Spesso il dolore appare in luoghi in cui il paziente aveva precedentemente qualche tipo di lesione o danno. L'algia della genesi isterica (conversione) è abbastanza difficile da distinguere dal dolore fisico. In questo caso i medici utilizzano un metodo speciale utilizzando un placebo. Se, quando si assume un analgesico all'insaputa del paziente, il dolore fisico diventa meno pronunciato, il dolore isterico non scompare con la farmacoterapia. Ma se il paziente è convinto che il dolore diminuisce grazie all’azione di qualche “agente medicinale”, bere anche acqua normale allevia la condizione. Questa è una caratteristica del dolore psicogeno, che consente al medico di distinguerlo dal dolore fisico.
 Spesso soffrono di isteria (disturbo dissociativo). disturbi di conversione degli organi interni. Ad esempio, c'è uno spasmo dei muscoli esofagei, che ricorda una sensazione di “nodo alla gola”, difficoltà a spostare il cibo attraverso l'esofago, vomito isterico, casi di pseudoappendicite, mancanza di respiro e gonfiore, il cosiddetto. asma bronchiale con attacchi pseudoasmatici, angina isterica, pseudoinfarto, tachicardia e disturbi cardiovascolari. Le pseudomanifestazioni citate si distinguono dalle malattie vere e proprie per il fatto che si basano su un meccanismo di beneficio o gradevolezza condizionale per il paziente, spesso subconscio. Tali disturbi sono vantaggiosi per il paziente (ad esempio, possono salvarlo dall'essere in una situazione spiacevole, dargli l'opportunità di non lavorare, creare una certa “posizione” a casa tra i parenti).
Spesso soffrono di isteria (disturbo dissociativo). disturbi di conversione degli organi interni. Ad esempio, c'è uno spasmo dei muscoli esofagei, che ricorda una sensazione di “nodo alla gola”, difficoltà a spostare il cibo attraverso l'esofago, vomito isterico, casi di pseudoappendicite, mancanza di respiro e gonfiore, il cosiddetto. asma bronchiale con attacchi pseudoasmatici, angina isterica, pseudoinfarto, tachicardia e disturbi cardiovascolari. Le pseudomanifestazioni citate si distinguono dalle malattie vere e proprie per il fatto che si basano su un meccanismo di beneficio o gradevolezza condizionale per il paziente, spesso subconscio. Tali disturbi sono vantaggiosi per il paziente (ad esempio, possono salvarlo dall'essere in una situazione spiacevole, dargli l'opportunità di non lavorare, creare una certa “posizione” a casa tra i parenti).
Con disturbi visivi di conversione isterica, i cosiddetti restringimento dei campi visivi. Un tale disordine non pregiudica in alcun modo l'orientamento nello spazio e nel terreno. Quando si verifica la cecità isterica di un occhio, la visione binoculare rimane invariata: in questi casi i pazienti fanno un uso eccellente del loro occhio "non vedente". In caso di completa cecità isterica di entrambi gli occhi, i pazienti sono completamente sicuri della propria totale incapacità di vedere, ma durante l'esame non vi è alcuna patologia dell'analizzatore visivo.
Manifestazioni sordità isterica verificarsi più frequentemente. Di solito, con la sordità isterica, si manifesta una diminuzione o una completa assenza di sensibilità delle orecchie stesse, cosa che di per sé non è possibile. In altre parole, la sordità isterica (di conversione) è di natura selettiva, quindi tutte le informazioni relative alla personalità del paziente vengono perfettamente percepite.
Mutismo completo ( perdita della sonorità della voce) è un evento comune anche tra gli isterici. Parlando del mutismo, che si basa su uno spasmo pronunciato delle corde vocali, è importante notare che la tosse nei pazienti è sonora, il che non è tipico di una tosse con mutismo organico.
Il disturbo isterico può spesso essere accompagnato da una varietà di disturbi a breve termine disordini mentali, con una brillante colorazione affettiva e teatralità. Spesso tali disturbi mentali riflettono un evento o un argomento emozionante per una persona. Questo tipo di disturbo si manifesta spesso nel formato amnesia, peraltro, selettivo o condizionatamente redditizio. L'amnesia isterica può coprire un periodo di tempo strettamente associato dal paziente a un evento spiacevole della sua vita. Quando l’amnesia non è più rilevante e non è più benefica, la “memoria perduta” ritorna. A volte gli isterici sembrano recitare scene e, nel corso di esse, esprimono idee deliranti e sperimentano vivide allucinazioni simili a scene. A causa di varie idee autoindotte, alcuni individui sono suscettibili ad attacchi di glossolalia isterica (discorso involontario in una lingua inesistente).
Parlare di stati crepuscolari coscienza nell'isteria, vale la pena menzionare le differenze qualitative con quelle dell'epilessia e dei disturbi organici. Il “crepuscolo” isterico (dissociativo) è caratterizzato da teatralità e finzione. Se durante la “performance” ai pazienti viene chiesto qualcosa, potrebbero benissimo dare una risposta, anche se stupidamente, ma sempre sull'argomento della domanda posta. Per altri disturbi organici o mentali la risposta è del tutto fuori luogo e di per sé abbastanza assurda.
L'isteria può assumere un'ampia varietà di maschere e può durare da alcune ore a diversi anni (a condizione che l'individuo si trovi in circostanze traumatiche per tutto questo tempo). Quando l'influenza del passato trigger fa una pausa o si ferma completamente, possiamo parlare dell'eliminazione dei fattori che minacciano il benessere del paziente e della realtà dell'eliminazione dei sintomi di conversione. A volte l'eliminazione dei sintomi dissociativi avviene in uno stato di passione.

Nel trattamento dell’isteria è necessario un approccio integrato
Nel trattamento della nevrosi isterica (disturbo di conversione o dissociativo), la psicoterapia (individuale, di gruppo) e la terapia occupazionale svolgono un ruolo più significativo. La terapia viene spesso integrata con farmaci (tranquillanti, piccole dosi di neurolettici sedativi) o viene eseguita una terapia sintomatica per aumento di ansia, depressione, attacchi di panico e fobie. La psicocorrezione può rivelare traumi psicologici infantili o “sindrome da iperprotezione”. Nella vita adulta, lo scompenso del disturbo dissociativo (di conversione) si verifica dopo o sullo sfondo di una situazione traumatica, conflitti frequenti, insoddisfazione per qualsiasi area della propria vita (principalmente personale), disadattamento sociale e mancanza di soddisfazione in qualcosa.
Una visita tempestiva a uno specialista aiuterà a far fronte rapidamente allo psicotrauma in questi pazienti e ciò porterà a un miglioramento (compensazione) dello stato mentale e stabilirà anche relazioni armoniose con gli altri. Pertanto, se voi o i vostri cari sperimentate i sintomi sopra descritti, non esitate a consultare il medico, ma risolvete i problemi psicologici il prima possibile e godetevi la vita!