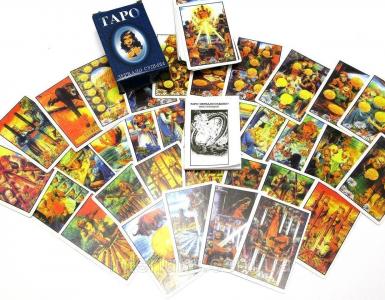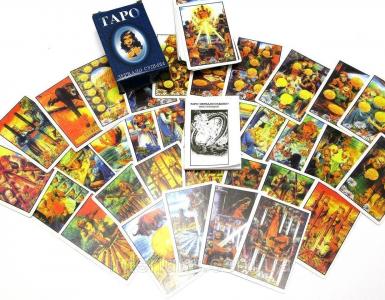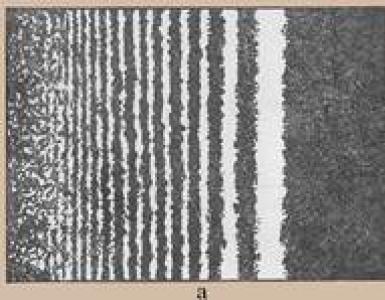Iperemia ed edema polmonare. Edema polmonare negli animali. Conoscenza preliminare con un animale malato
L'iperemia e l'edema polmonare (iperemia et edema pulmonum) è una malattia caratterizzata da traboccamento sanguigno dei capillari polmonari con conseguente fuoriuscita di plasma sanguigno nel lume degli alveoli e infiltrazione trasudata del tessuto connettivo interlobulare.
Esistono iperemia attiva e passiva, edema polmonare attivo e ipostatico. La malattia si manifesta in tutti i tipi di animali da allevamento, ma più spesso nei cavalli e nei cani.
Eziologia. L'iperemia attiva può essere una conseguenza del surriscaldamento degli animali durante il trasporto, del lavoro intenso nella stagione calda, dell'inalazione di gas irritanti, del colpo di sole e di calore. Può complicare il pneumotorace e la trombosi dell'arteria polmonare.
La causa dell'iperemia passiva è molto spesso la debolezza della metà sinistra del cuore a causa dei suoi difetti nella fase di scompenso o in malattie di pericardite, miocardite o altre patologie accompagnate da indebolimento dell'attività cardiaca.
L'edema polmonare è una conseguenza della sua iperemia, nonché il risultato dell'avvelenamento con alcuni veleni e dell'intossicazione.
Sintomi e decorso. I segni clinici di iperemia attiva compaiono improvvisamente e si sviluppano rapidamente. Si osserva immediatamente una grave mancanza di respiro mista. L'animale sta con il collo teso, le zampe divaricate, il respiro intenso, le narici dilatate. Il battito cardiaco batte forte, il polso è debole. A volte c'è tosse. Alla percussione, il suono è normale o sordo e all'auscultazione a volte si sente un respiro sibilante.
Con l'iperemia passiva, i segni clinici si sviluppano lentamente. Dispnea. Il liquido schiumoso e sanguinante viene rilasciato dalle cavità nasali, soprattutto quando si tossisce. All'auscultazione: indebolimento della respirazione vescicolare, respiro sibilante.
L'edema polmonare è accompagnato da grave mancanza di respiro, tosse e secrezione schiumosa rosa dalle aperture nasali. Alla percussione il suono è opaco e all'auscultazione si osserva un indebolimento della respirazione vescicolare e un respiro sibilante.
Diagnosi. La malattia viene diagnosticata sulla base dell’anamnesi e dei sintomi clinici caratteristici.
Diagnosi differenziale. Il colpo di calore, la bronchite diffusa, l'emorragia polmonare e la polmonite lobare dovrebbero essere distinti dall'iperemia e dall'edema polmonare.
Trattamento. Il trattamento dovrebbe essere urgente e mirato a prevenire lo sviluppo dell'edema. A questo scopo si consiglia il salasso (fino al 10% del peso dell’animale). Una soluzione di cloruro di calcio al 5-10% viene iniettata per via endovenosa. Sul petto vengono applicati cerotti di senape. Per alleviare i crampi dei muscoli bronchiali ed espandere il lume dei bronchi, vengono somministrate atropina, efedrina e aminofillina. L'uso del blocco della novocaina su due lati dei nervi splancnici toracici secondo Shakurov è efficace.
Viene utilizzata la terapia sintomatica.
Prevenzione. È necessario proteggere gli animali dall'inalazione di gas irritanti, osservare il regime operativo per i cavalli da lavoro e sportivi e per i cani da caccia.
L'enfisema (enfisema pulmonum) è un'espansione patologica e un aumento del volume polmonare causato dall'eccessiva espansione degli alveoli o dall'accumulo di aria nel tessuto connettivo interlobulare. Si distingue tra enfisema alveolare, quando l'espansione dei polmoni avviene a causa di un aumento del contenuto di aria negli alveoli, e enfisema interstiziale, quando l'aria penetra nel tessuto interstiziale.
L'enfisema alveolare può essere acuto o cronico; a seconda della sua distribuzione si può distinguere l'enfisema locale da quello diffuso.
L'enfisema alveolare polmonare si verifica in tutti i tipi di animali da allevamento, ma più spesso nei cavalli e nei cani; l'enfisema interstiziale si verifica principalmente nei bovini.
Eziologia. L'enfisema alveolare acuto può essere una conseguenza di un'inspirazione ed espirazione eccessivamente aumentate nei cavalli durante andature pesanti, di un abbaiare prolungato nei cani o di uno stress eccessivo durante la caccia. Può verificarsi anche in malattie accompagnate da stenosi delle vie respiratorie (bronchite, polmonite, ecc.).
L'enfisema alveolare cronico è causato dagli stessi fattori acuti se agiscono per lungo tempo.
Sintomi e decorso. Nell'enfisema alveolare acuto, la percussione dei polmoni determina uno spostamento del loro bordo caudale di 1-2 costole indietro, il suono della percussione è a forma di scatola. All'auscultazione - indebolimento della respirazione vescicolare e con bronchite - respiro sibilante. Grave mancanza di respiro mista.
Con l'enfisema alveolare cronico, all'esordio della malattia si manifesta difficoltà respiratoria, mancanza di respiro, che aumenta gradualmente, mentre la fase espiratoria si allunga e aumenta il lavoro dei muscoli addominali. Si verifica una costante retrazione degli spazi intercostali, delle parti ventrali del torace e degli ilia, con conseguente formazione di un solco di accensione. Il torace è espanso, a forma di botte. La fase di espirazione si svolge in due fasi. I risultati della percussione e dell'auscultazione dei polmoni sono gli stessi della forma acuta.
La manifestazione clinica dell'enfisema interstiziale è caratterizzata da un'insorgenza improvvisa e da un progressivo peggioramento della mancanza di respiro. Aumentano i sintomi di insufficienza respiratoria. Con la percussione del torace vengono rilevati suoni scatolari o timpanici e con l'auscultazione vengono rilevati un indebolimento della respirazione vescicolare e la presenza di rantoli crepitanti. Alla palpazione nel collo, nel torace e talvolta nella parte posteriore del corpo, si avverte un crepitio.
I sintomi dell'enfisema alveolare acuto, dopo aver eliminato le cause e un trattamento adeguato, scompaiono dopo pochi giorni. L'enfisema cronico si sviluppa gradualmente e i cambiamenti strutturali che si verificano nei polmoni sono irreversibili.
La diagnosi viene effettuata sulla base di un'anamnesi attentamente raccolta e dei sintomi clinici caratteristici.
Diagnosi differenziale. Va tenuto presente l'enfisema vicario, che si sviluppa come fenomeno compensatorio per altre malattie dell'apparato respiratorio.
Trattamento. Agli animali viene concesso riposo completo. Il blocco della novocaina dei linfonodi stellati viene effettuato o la novocaina viene somministrata per via endovenosa sotto forma di una soluzione all'1% per animali di grandi dimensioni 100-150 ml, animali piccoli - 10-20 ml, 2-3 iniezioni a giorni alterni. Viene somministrata per via sottocutanea una soluzione di atropina allo 0,1% o una soluzione di efedrina al 5%; ai cavalli vengono somministrati 10-15 ml per iniezione e ai cani viene somministrata 0,1-0,2 g di aminofillina per via orale. Come rimedi sintomatici vengono utilizzati farmaci per il cuore.
Il trattamento degli animali con enfisema interstiziale viene effettuato allo stesso modo dell'enfisema alveolare.
Prevenzione. Organizzazione del corretto funzionamento e mantenimento degli animali.
La broncopolmonite è una malattia animale caratterizzata dallo sviluppo di un processo infiammatorio a livello dei bronchi e degli alveoli con versamento di essudato sieroso-mucoso in questi ultimi. Esistono broncopolmoniti acute, subacute e croniche e, a seconda dell'origine, primarie e secondarie. Sono colpiti tutti i tipi di animali di tutte le età, ma più spesso gli animali giovani (vedi Malattie degli animali giovani).
Eziologia. La broncopolmonite è una malattia di natura polietiologica. Tutti i fattori eziologici della malattia possono essere suddivisi in 2 gruppi: 1. riduzione della resistenza naturale del corpo e 2. batteri e virus opportunistici.
I fattori che riducono la resistenza naturale includono disturbi nell'allevamento e nell'alimentazione degli animali (microclima insoddisfacente, contenuto insufficiente di macro e microelementi e vitamine nella dieta, in particolare vitamina A).
Sullo sfondo di una ridotta resistenza, viene interrotto l'equilibrio evolutivamente sviluppato tra macroorganismi e microrganismi opportunisti, virus, micoplasmi, il cui numero totale di specie può superare le 60. La violazione di questo equilibrio provoca l'insorgenza della malattia.
La broncopolmonite secondaria può essere un sintomo o complicare il decorso di broncopolmonite, PCVD, gastroenterite nei cavalli, malattie dell'utero, della mammella, PCH, dittoocaulosi nei bovini, dittoocaulosi, mulleriosi, necrobatteriosi negli ovini, peste, metastrongilosi, carenza vitaminica nei suini.
Sintomi e decorso. All'inizio della malattia, la temperatura corporea aumenta di 1-1,5 0, tuttavia in seguito potrebbe tornare alla normalità. Febbre in remissione. La respirazione è rapida, superficiale, con respiro corto misto. La tosse è breve, ovattata e dolorosa nei casi acuti. Lo scolo nasale è sieroso-mucoso e nelle forme subacute e croniche è mucopurulento e purulento. Con la percussione, nelle lesioni si identifica il suono timpanico, che successivamente diventa sordo e sordo, e con l'auscultazione si sente la respirazione bronchiale e rantoli a bolle fini e medie. Nelle aree sane, all'auscultazione, si stabilisce una respirazione vescicolare aspra. Il funzionamento del sistema cardiaco e digestivo viene interrotto.
La forma subacuta e cronica della malattia si presenta con gli stessi sintomi di quella acuta, ma meno pronunciati.
Nelle forme acute e subacute, il numero di globuli rossi e di emoglobina nel sangue diminuisce e si verifica la leucocitosi. Il leucogramma mostra neutrofilia. Nella broncopolmonite cronica si osserva un ispessimento del sangue, accompagnato da un relativo aumento dei globuli rossi e dell'emoglobina, leucocitosi con un aumento del numero dei linfociti.
Con un trattamento adeguatamente organizzato, la forma acuta della malattia dura 8-12 giorni, subacuta 3-4 settimane, cronica - mesi e persino anni.
La diagnosi viene effettuata sulla base dell'anamnesi, delle manifestazioni cliniche, della fluoroscopia e degli esami di laboratorio.
Diagnosi differenziale. Da tenere presente la polmonite lobare e quella sintomatica nelle malattie infettive e invasive. (vedi Malattie degli animali giovani).
Trattamento. Le misure terapeutiche hanno l’effetto maggiore nelle fasi iniziali della malattia. Una condizione indispensabile per un esito favorevole nel trattamento dei pazienti è l'eliminazione delle cause della malattia e la creazione di condizioni ottimali di alimentazione e mantenimento.
Gli antimicrobici e i farmaci sulfamidici vengono utilizzati come agenti antimicrobici dopo averli titolati nella microflora secreta. Tra gli antibiotici è possibile utilizzare penicillina, novocillina, ampicillina, ampiox, streptomicina, gentamicina, cloramfenicolo, ossitetraciclina e tetraciclina, morfociclina, olimorfociclina, ecc. Secondo le raccomandazioni per l'uso. Tra gli altri agenti antimicrobici, è efficace l'uso di Farmazin-50 o 200 nei suini, per via intramuscolare, 5 mg una volta al giorno, tilan - 10 mg, per via orale, 2 volte al giorno. Tra i preparati a base di sulfamidici vengono utilizzati norsulfazolo, sulfadimizina, sulfadimetossina e sulfamonometossina. Efficace l’uso combinato di antibiotici e sulfamidici.
Nei casi subacuti e cronici, è indicato l'uso di antibiotici e sulfamidici solubili per via intratracheale e, in caso di malattia di massa, con il metodo aerosol (vedi Broncopolmonite di animali giovani).
Buoni risultati nelle forme acute e subacute si ottengono utilizzando i blocchi con novocaina del ganglio stellato, dei nervi splancnici e dei tronchi simpatici secondo Shakurov. L'efficacia del trattamento aumenta con l'uso della fisioterapia (irradiazione ultravioletta, ionizzazione dell'aria). È necessario includere farmaci sintomatici (farmaci cardiaci e digestivi) nella terapia complessa.
Per aumentare la resistenza naturale del corpo, vengono utilizzati stimolanti.
Prevenzione. La prevenzione della broncopolmonite comprende un complesso di misure veterinarie organizzative, economiche e speciali volte a rispettare gli standard zooigienici per la detenzione e l'alimentazione degli animali, aumentando la resistenza naturale del corpo (vedi Broncopolmonite degli animali giovani).
La cancrena polmonare (gangrena pulmonum) è una malattia caratterizzata da necrosi e decadimento putrefattivo del tessuto polmonare. Si verifica principalmente nei cavalli, meno spesso in altre specie animali.
Eziologia. La malattia si verifica quando si verifica l'aspirazione del cibo o del contenuto dello stomaco a causa di vomito o disturbi della deglutizione. Può complicare il decorso della polmonite, in particolare della polmonite aspirazione e metastatica, della bronchite purulenta-putrefattiva, della tubercolosi e dell'echinococcosi. La cancrena polmonare può verificarsi anche quando emboli infetti vengono introdotti nei polmoni durante processi purulento-necrotici in altri organi.
Sintomi e decorso. Un sintomo tipico all'inizio della malattia è un odore putrido e fetido nell'aria espirata. Dalle cavità nasali si osserva una secrezione bilaterale grigio-verde o marrone, che si intensifica quando si tossisce o si abbassa la testa. La temperatura sale a 420, la febbre è costante o in remissione. La tosse è umida e dolorosa.
Quando si percuote il torace, vengono identificati i focolai di ottusità e, in presenza di caverne, vengono rilevati suoni timpanici e "pentola incrinata". L'auscultazione rivela la respirazione bronchiale o anforica, nonché il respiro sibilante sotto forma di schizzi o gorgoglii.
L'esame ematologico rivela leucocitosi neutrofila, eosinopenia e VES accelerata.
Il decorso è acuto, la morte avviene entro pochi giorni.
La diagnosi viene fatta sulla base dei dati anamnestici, dei segni clinici e dell'esame microscopico della secrezione nasale. In caso di cancrena, al microscopio si trovano fibre elastiche degli alveoli e pezzi di tessuto polmonare che rifrangono la luce.
Diagnosi differenziale. La cancrena dovrebbe essere differenziata dalla polmonite lobare, dalla tubercolosi polmonare, dalle malattie necrotiche purulente.
Trattamento. Trattano animali di alto valore e riproduttori.
Per fermare il decadimento putrefattivo dei polmoni, si consiglia l'inalazione di trementina, ittiolo e creolina. Siero di canfora secondo Kadykov, alcool 330, soluzione di glucosio al 40% viene somministrato per via endovenosa. Antibiotici, sulfamidici e farmaci nitrofurani vengono utilizzati nei dosaggi massimi consentiti. È indicata la loro somministrazione intratracheale.
I farmaci per il cuore sono usati come farmaci sintomatici.
La prevenzione consiste nella prevenzione delle malattie dell'apparato respiratorio nel suo insieme, nel trattamento qualificato dei processi purulento-necrotici in vari organi.
La polmonite lobare (polmonite cruposa) è una malattia caratterizzata da un'infiammazione acuta lobare (fibrinosa), che coinvolge interi lobi del polmone, con sintomi allergici pronunciati e tipiche alterazioni delle fasi del processo fibrinoso. La malattia viene diagnosticata principalmente nei cavalli, meno spesso nei bovini e negli ovini e molto raramente in altre specie animali.
Eziologia. La polmonite lobare è una malattia di origine allergica che si verifica in un organismo precedentemente sensibilizzato o in un tessuto polmonare sensibilizzato. Gli allergeni sono microrganismi delle vie respiratorie, e l'ipotermia, i traumi, i microrganismi sia coinvolti nella sensibilizzazione che non in essa, nonché numerosi fattori di stress possono agire come fattori risolutivi.
Sintomi e decorso. La manifestazione clinica della polmonite lobare avviene in 3 stadi: iperemia, epatizzazione e risoluzione.
L'esordio della malattia è caratterizzato da depressione, aumento della temperatura fino a 41-42°C e febbre persistente. La reazione termica dura 6-8 giorni fino alla fine della fase di epatizzazione. Le mucose sono itteriche, talvolta giallo limone.
Durante la percussione nel 1o stadio, nel lobo interessato si stabilisce un suono timpanico, che nello stadio di epatizzazione diventa sordo e sordo, mentre il bordo superiore dell'ottusità è sempre arcuato verso l'alto. Durante la fase di risoluzione, il suono della percussione acquista nuovamente una connotazione timpanica e vira gradualmente in atimpanico.
All'auscultazione, si rilevano rantoli crepitanti allo stadio di iperemia. Con lo sviluppo dello stadio di epatizzazione, il respiro sibilante e la respirazione vescicolare scompaiono e appare la respirazione bronchiale. Durante la fase di risoluzione si sentono rantoli umidi che attutiscono la respirazione bronchiale. Quindi la sonorità del respiro sibilante diminuisce gradualmente, la respirazione bronchiale si indebolisce e quindi si trasforma in un normale rumore vescicolare.
Un sintomo caratteristico della polmonite lobare è la comparsa di secrezioni nasali di colore giallo zafferano o marrone ruggine durante la fase di epatizzazione. Nello stadio iniziale della polmonite lobare è tipica anche una discrepanza tra l'aumento della frequenza cardiaca e l'aumento della temperatura corporea; se il polso aumenta di 10-15 battiti, la temperatura aumenta di 3-4°C. Successivamente, si verifica un aumento significativo della frequenza cardiaca, della sua debolezza e aritmia e si sviluppa insufficienza cardiovascolare.
La leucocitosi viene rilevata nel sangue, neutrofilia, aneosinofilia, eritropenia vengono rilevate nel leucogramma, la VES è accelerata.
Il decorso della malattia nei casi tipici è acuto e dura 8-14 giorni.
La diagnosi viene posta sulla base dei dati anamnestici e dei sintomi clinici tipici.
Diagnosi differenziale. Nella diagnosi differenziale sono escluse la broncopolmonite, la pleurite, le malattie infettive acute accompagnate da polmonite (pleuropolmonite equina contagiosa, peripneumonite e pasteurellosi nei bovini, peste suina, ecc.).
Trattamento. Gli animali malati devono essere immediatamente isolati in una stanza separata e ben ventilata. La dieta dovrebbe consistere in alimenti facilmente digeribili, ricchi di vitamine e a basso volume.
Il trattamento deve essere completo, tenendo conto della fase del processo. Nella 1a fase si consiglia di effettuare il salasso (nei cavalli fino a 2-3 litri). In questa fase, è indicata la somministrazione endovenosa di una soluzione al 10% di cloruro di calcio o gluconato alle dosi abituali, la somministrazione endovenosa di una soluzione al 10-20% di iposolfito di sodio in una dose di 200-300 ml per cavalli e bovini, viene iniettata difenidramina per via sottocutanea alla dose di 0,1-0 per cavalli 5 g, bovini 0,3-0,6 g, cani 0,02-0,04 g, pipolfen per via orale alla dose di 0,503 mg/kg di peso corporeo.
Nella fase di epatizzazione viene effettuata l'inalazione di vapore acqueo caldo con l'aggiunta di soda, catrame o trementina.
Una componente obbligatoria della terapia complessa è l'uso di agenti antibatterici, principalmente antibiotici e sulfamidici. È indicato l'uso di blocchi di novocaina (vedi Broncopolmonite), terapia stimolante e farmaci cardiaci.
Durante la fase risolutiva vengono prescritti espettoranti e diuretici.
Tra i metodi di fisioterapia è stato testato l'uso dell'irradiazione infrarossa e della ionizzazione dell'aria.
Prevenzione. È necessario osservare il regime di funzionamento e alimentazione degli animali, che mira ad aumentare la resistenza del corpo.
Inviare il tuo buon lavoro nella knowledge base è semplice. Utilizza il modulo sottostante
Studenti, dottorandi, giovani scienziati che utilizzano la base di conoscenze nei loro studi e nel loro lavoro ti saranno molto grati.
Pubblicato su http://www.allbest.ru/
Storia educativa delle malattie animali
Tipologia animale: cavallo Genere: cavalla Soprannome: Aliva
Colore e caratteristiche: rosso, macchia bianca sotto la frangia Razza: Sconosciuta
Condizione corporea: emaciato
Data di nascita: 12 marzo 2007. Peso vivo: 450 kg.
Proprietà dell'animale: L'animale serve nelle case private per arare, per aiutare il proprietario nel giardino, nei campi e anche per spostarsi su un carro in campagna.
Data della malattia: 19 luglio 2015
Data di ammissione al trattamento: 19/07/2015
Data di smaltimento: 26/07/2015 Durata del trattamento: 7 giorni.
Diagnosi iniziale: edema polmonare
Diagnosi successiva: edema polmonare secondario a insufficienza cardiaca acuta
Complicazioni della malattia: nessuna
Esito della malattia: sfavorevole
Anamnesi vitae)
L'animale è di nostra produzione. Un cavallo di razza sconosciuta, di 8 anni, di nome Aliva. Stalla estiva e invernale tenuta in condizioni non conformi ai requisiti veterinari e zootecnici. Illuminazione artificiale (lampada), umidità dell'aria 70%, temperatura nella stalla 27 C in estate, assenza di ventilazione, odore di urina e letame nell'aria. La lettiera è in segatura, spessa 1,5 cm, la pulizia viene effettuata una volta alla settimana mediante lavoro manuale. Non c'è esercizio. Le procedure igieniche non sono regolari. Non vengono eseguite disinfezione, disinfezione e deratizzazione. Alimentazione inadeguata. La dieta comprende i seguenti mangimi: paglia, pula, fieno, cereali, crusca, ortaggi a radice, avena, ecc. Acqua in quantità illimitata. Non sono state effettuate vaccinazioni e sverminazioni.
Lo stato epizootico dell’economia privata e della regione nel suo insieme per quanto riguarda le malattie infettive e invasive è favorevole.
L'animale serve in fattoria per arare, per aiutare il proprietario in giardino, nei campi e anche per spostarsi su un carro in campagna. Il cavallo lavora tutti i giorni dalla mattina presto fino alla sera.
Storia della malattia (Anamnesis morbi)
Un proprietario che si lamenta: il cavallo è depresso, rifiuta il lavoro e il cibo. Respiro forte, rapido, affannoso. Le narici sono costantemente dilatate, umide e dal naso viene rilasciato un fluido schiumoso. Le prime manifestazioni cliniche della malattia sono state rilevate 1,5 ore fa.
Le condizioni dell'animale al momento dell'esame.
Temperatura: 39,0 C Polso 56 battiti/min Respirazione 27 battiti/min
fisico: debole
Costituzione: densa
Grassezza: insoddisfacente
posizione del corpo nello spazio: posizione eretta forzata
temperamento: flemmatico
tipo di attività nervosa: tipo flemmatico
Personalità: gentile
Esame della pelle
Colore della pelle. Nelle zone con pelo nero, la pelle ha un colore cianotico.
Temperatura. Alla palpazione, la temperatura locale e generale è leggermente aumentata, la pelle su tutta la superficie del corpo è calda.
Umidità. La pelle è elastica, elastica, umida.
L'odore del fieno.
Non sono presenti eruzioni cutanee (eritemi, macchie, roseola, noduli, vescicole, pustole, vesciche, squame, croste, erosioni, screpolature, ulcere, cicatrici, piaghe da decubito).
Non c'è dolore, la sensibilità è preservata.
Tessuto sottocutaneo
La quantità di grasso nel tessuto sottocutaneo è insufficiente e si verifica emaciazione. Il tessuto sottocutaneo ha consistenza elastica, debolmente mobile e non presenta sensibilità al dolore. Non c'è gonfiore.
Membrane mucose
Le mucose della congiuntiva, del naso, della bocca, della vagina sono cianotiche, non pigmentate, l'integrità non è rotta, moderatamente umida, sono assenti gonfiore, eruzioni cutanee, emorragie, è assente la sensibilità al dolore.
I linfonodi
Sono stati esaminati le pieghe sottomandibolari, il ginocchio e i linfonodi pudendi del cavallo. I linfonodi non sono ingrossati, di forma ovale, di consistenza elastica, moderatamente mobili, con temperatura normale della pelle che ricopre il nodo, sensibilità al dolore non rilevata, la superficie è liscia e bitorzoluta, non delimitata dai tessuti circostanti.
La massa muscolare è ridotta, l'integrità e la simmetria non sono compromesse, il tono è ridotto a causa dell'asfissia. Non sono presenti paresi, paralisi o contratture muscolari. La sensibilità al dolore non è stata rilevata.
Sistema scheletrico.
Non sono presenti deformazioni, periostiti o riassorbimenti di ossa di valore di supporto secondario. Non sono presenti anomalie dello sviluppo. La sensibilità è preservata, il dolore è assente.
La mobilità articolare è attiva, non sono stati rilevati scricchiolii o lussazioni. Alla palpazione non sono stati rilevati cambiamenti di configurazione (deformazione, gonfiore, ispessimento, nodularità). Nessun dolore è stato rilevato durante la palpazione, né durante i movimenti attivi o passivi.
Organi e sistemi interni
Alla palpazione nell'area del 6o spazio intercostale a sinistra e del 5o spazio intercostale a destra, 7-8 cm sotto la linea dell'articolazione gleno-omerale, viene rilevato un impulso cardiaco laterale indebolito. L'impulso cardiaco è indebolito, alla palpazione si rileva solo a sinistra ed è localizzato nel 6o spazio intercostale 7-8 cm sotto la linea dell'articolazione gleno-omerale, positivo. Non c'è dolore nell'area del battito cardiaco. La dimensione dell'area dell'impulso cardiaco è 5-7 cm2, l'impulso cardiaco è spostato caudalmente da 2 costole.
Percussione della zona cardiaca
I confini del cuore sono determinati dalla percussione in base all'ottusità relativa e assoluta del cuore. In un cavallo sano, un'ottusità cardiaca relativa normale a sinistra occupa l'area dai muscoli del gomito al bordo anteriore della 6a costola; il suo bordo superiore si trova 4 cm sotto la linea dell'articolazione scapolo-omerale. L'ottusità cardiaca assoluta a sinistra ha la forma di un triangolo scaleno, il suo bordo posteriore inizia nel 3o spazio intercostale, 3-4 cm sotto il bordo superiore dell'ottusità relativa, e va ad arco fino all'estremità inferiore della 6a costola. L'ottusità assoluta a destra è di dimensioni più piccole e occupa la parte inferiore del 3° e 4° spazio intercostale.
Confini della zona di ottusità cardiaca assoluta e relativa (ottusità) a sinistra e a destra. Utilizzando un plessimetro e un martello a percussione, la percussione ha evidenziato una zona ridotta di ottusità assoluta (suono sordo) a sinistra nei 4 spazi intercostali; l'ottusità relativa del cuore si trova alla periferia della zona di ottusità assoluta, dove un suono sordo viene ascoltato. La zona smussata si estende tra la 3a e la 5a costola. Il bordo posteriore del cuore si sposta caudalmente e si localizza nel 7° spazio intercostale.
Auscultazione della zona cardiaca
Luoghi di migliore udibilità dei soffi endocardici e dei suoni cardiaci in un cavallo: valvola bicuspide - nel 5o spazio intercostale sinistro a livello della metà del terzo inferiore del torace; valvola tricuspide - nel 3o e 4o spazio intercostale destro a livello della metà del terzo inferiore del torace; arteria polmonare - nel 3o spazio intercostale sinistro sotto la linea che divide a metà il terzo inferiore del torace; aorta - nel 4o spazio intercostale sinistro (a volte a destra) 1 o 2 dita sotto la linea dell'articolazione scapolo-omerale.
I suoni cardiaci utilizzando uno stetofonendoscopio dopo l'esercizio possono essere ascoltati per aumentare i suoni diastolici, vale a dire nel 4o spazio intercostale, sotto la linea che divide a metà il terzo inferiore del torace, un accento del 2o tono sulla valvola semilunare dell'arteria polmonare, così come la sua biforcazione e scissione, si può sentire l'indebolimento del 1° tono.
I soffi endocardici all'auscultazione vengono uditi come suoni soffi persistenti.
I soffi extracardiaci a seguito dell'auscultazione hanno rivelato soffi cardiopolmonari che si presentano nei polmoni e si sentono durante l'inspirazione, in coincidenza con la sistole.
Non sono state eseguite elettrocardiografia, vettorcardiografia, pletismografia e balistocardiografia.
Studio delle arterie e delle vene
Il polso arterioso è stato esaminato mediante palpazione dell'arteria caudale mediana (a. sossudea) e dell'arteria safena (a. Safena). Al momento dell'esame iniziale la frequenza cardiaca era di 56 battiti al minuto.
Il polso è aritmico. La qualità del polso è morbida, il grado di riempimento è vuoto, l'altezza dell'onda del polso è piccola e la forma delle onde del polso è alternata.
Alla palpazione non è stata rilevata dolorabilità delle arterie.
La pulsazione delle vene giugulari è positiva.
Vene varicose collaterali trovate sulle estremità
Non sono stati rilevati ispessimenti, nodularità o dolorabilità delle vene.
Non è stata eseguita la sfigmoflebografia
AKD massimo (mm Hg) 90 mm. rt. st, AKD min (mm Hg st.) 35 mm. rt. Arte.
Forza sistolica del cuore (mm Hg) 55 mm. rt. Arte.
EVA (mm colonna d'acqua) 200 mm. acqua Arte.
Apparato digerente.
Non c'è appetito e sete, non c'è dolore durante la masticazione del cibo, l'atto di deglutire un bolo alimentare è libero e indolore (secondo il proprietario), l'animale non ha vomitato al momento dell'esame. Non si osserva eruttazione.
Odore dal cavo orale: odore debolmente acido di fieno e avena, non sono stati rilevati odori patologici.
Le gengive sono cianotiche, indolori, l'integrità è preservata, non sono presenti sovrapposizioni o ulcere.
All'esame esterno, la bocca è chiusa, le labbra si adattano perfettamente l'una all'altra. La mucosa orale è cianica, la sua integrità è preservata. La lingua è umida, senza placca, densa, mobile, elastica, l'integrità della lingua è preservata. Non ci sono cambiamenti patologici nella lingua. La salivazione è moderata. Denti: l'integrità non è rotta, di colore giallastro, immobile, indolore. Gli incisivi sono moderatamente usurati, l'instabilità è insignificante. Formula dentale: 3I 0C 3P 3M *2 - mascella superiore, 3I 1C 3P 3M *2 - mascella inferiore.
All'esame esterno, la testa è leggermente abbassata, non vi è alcun cambiamento di volume, interruzione dell'integrità dei tessuti nella zona della faringe e assenza di salivazione. Alla palpazione esterna la sensibilità è preservata, non c'è dolore, la pelle è calda, i compattamenti dei tessuti e i corpi estranei sono assenti. All'esame interno, la mucosa è cianotica, moderatamente umida, l'integrità non è rotta. Alla palpazione interna, la sensibilità è preservata, non c'è dolore, la mucosa è calda, sono assenti compattazioni tissutali e corpi estranei.
Un esame esterno nella zona dell'esofago ha rivelato il libero passaggio del bolo alimentare ingerito. Alla palpazione non si nota dolorabilità dell'esofago e dei tessuti circostanti, non viene rilevata la presenza di corpi estranei.
L'addome su entrambi i lati e dietro non è aumentato di volume, le pareti addominali destra e sinistra sono simmetriche, la parete addominale inferiore non è cambiata.
La palpazione dell'addome ha evidenziato quanto segue: non è stato rilevato alcun dolore nella zona addominale, la temperatura locale in questa zona non è aumentata, la parete addominale era di moderata tensione, non è stata rilevata la presenza di ernie e gonfiori.
Frequenza e forza delle contrazioni del rumine: a causa della posizione mediale dello stomaco del cavallo, l'auscultazione è difficile.
L'auscultazione dell'intestino del cavallo è stata effettuata con metodi diretti e strumentali. Non ci sono suoni peristaltici nell'intestino tenue. I rumori peristaltici nell'intestino crasso sono debolmente udibili e assomigliano a un rimbombo distante.
La percussione dello stomaco non è stata eseguita a causa della sua posizione mediale.
La sezione dell'intestino tenue è stata percussata a sinistra, nel terzo medio dell'addome, nella zona dell'ileo e della fossa affamata sinistra; allo stesso tempo si udì un suono sordo provenire dal cavallo. Nel terzo inferiore dell'addome sono state percusse le posizioni ventrale sinistra e dorsale del grosso colon, mentre nel terzo superiore, sopra la sezione dell'intestino tenue, è stato percusso il colon piccolo. Queste parti dell'intestino producono suoni sordi e sordi. Il cieco è stato percussato a destra, nella zona della fossa e dell'ileo affamati di destra. Qui sono state identificate varie sfumature di suono sordo-timpanico. Le posizioni giuste del grosso colon sono state percusse a destra e nel terzo inferiore e medio della cavità addominale. Il suono durante le percussioni è opaco con varie sfumature di ottusità.
Quando si sondava lo stomaco attraverso la sonda, veniva rilasciata una piccola quantità del suo contenuto.
Il fegato non si estende oltre il bordo polmonare, quindi non può essere palpato. Il fegato stesso si trova a destra nell'area del 14-15 spazio intercostale, lungo la linea maculare.
Milza. Durante la percussione a sinistra è stato riscontrato ottusità splenica nella zona della parte superiore dell'ultimo spazio intercostale dietro il bordo di percussione posteriore del polmone. Durante l'esame della milza non sono stati rilevati cambiamenti patologici, pertanto non è stata eseguita una biopsia.
Sistema respiratorio.
La forza del flusso d'aria da entrambe le narici dell'animale è debole, l'aria espirata è ritmica, moderatamente simmetrica, inodore, all'esame, l'inspirazione e l'espirazione sono difficili, l'integrità dei passaggi nasali non è compromessa.
Passaggi nasali: le narici sono simmetriche, allargate, a virgola, dai contorni lisci, mucosa cianotica, molto umide; caldo alla palpazione; Non ci sono gonfiori, eruzioni cutanee, ulcerazioni, tumori o danni meccanici.
Lo scolo nasale viene emesso in grandi quantità, di natura schiumosa, bilaterale, bianco trasparente, inodore. Non c'è sangue dal naso.
La tosse è rara e umida.
Nessun dolore o fastidio è stato rilevato durante la palpazione delle cavità annessiali. Non si è verificato alcun aumento di volume, protrusione o deformazione dei seni mascellari. Anche la palpazione del seno frontale non ha rivelato edema infiammatorio, la placca ossea non era assottigliata ed era forte. Quando si percuotono i seni con il calcio di un martello a percussione, viene rilevato un suono di scatola.
Come risultato della palpazione delle sacche d'aria non è stata rilevata alcuna tensione, fluttuazione o dolore, la temperatura era moderatamente calda. La percussione utilizzando un plessimetro e un martello a percussione ha rivelato un suono timpanico
All'esame esterno della laringe, la testa è abbassata ed è presente edema infiammatorio. Alla palpazione esterna, la temperatura cutanea locale nella zona laringea non aumenta, ha una consistenza pastosa, la sensibilità è preservata, non si notano dolore, retrazione, curvatura o spostamento delle cartilagini aritenoidi; la palpazione provoca anche tosse grassa. Quando si ausculta la laringe, si sentono rantoli umidi che ricordano lo scoppio di bolle. Durante un esame interno della laringe, la mucosa risulta color cianina e non deformata.
Non c'è sensibilità al dolore nell'area della tiroide, la temperatura cutanea locale in quest'area non aumenta. I lobi della tiroide non sono ingranditi. La consistenza dell'organo è elastica-densa, la forma è grumosa.
Dall'esame della zona tracheale non sono state riscontrate distorsioni o rotture degli anelli. Alla palpazione la temperatura cutanea nella zona tracheale non risulta aumentata, l'integrità non è compromessa, non si avverte dolore né deformazione, la sensibilità è preservata. All'auscultazione si sentono rantoli umidi.
Esame del torace.
All'esame esterno il torace è a forma di botte. Non sono presenti deformità del torace. La respirazione è superficiale. Durante l'esame è stata rilevata la normale vestibilità delle scapole e la respirazione addominale. I movimenti respiratori del torace sono simmetrici. L'esame ha rivelato la respirazione saccadica. È presente dispnea espiratoria. Durante la percussione del torace sono stati stabiliti i confini dei polmoni e la natura del suono della percussione. Il suono percussivo è sordo, il campo polmonare è allargato sia a sinistra che a destra, si sposta caudalmente: lungo la linea maculare: 18a costa, lungo la tuberosità ischiatica: 16; lungo la linea dell'articolazione della spalla: 13. Alla palpazione del torace, la sensibilità al dolore è debolmente presente, l'integrità del torace è preservata, viene rilevata la retrazione dei muscoli intercostali, la presenza di un solco di accensione, sono forme distrofiche delle costole non palpabile.
Con la plegafonia si sente un forte suono di percussione, che è un segno di edema polmonare.
L'auscultazione rivela una respirazione vescicolare difficoltosa. In tutte le aree del triangolo polmonare su entrambi i lati si sentono rantoli melodiosi umidi e persistenti.
Durante l'auscultazione si sente un aumento della respirazione mista (broncovescicolare).
Non c'è rumore di attrito pleurico.
Non c'è rumore di schizzi nella cavità pleurica.
Non è stata eseguita la toracentesi.
Sistema genito-urinario.
La frequenza della minzione è 4-6 volte al giorno. La quantità di urina escreta al giorno è di 3-5 litri. La minzione è volontaria, la postura è naturale, non si osserva dolore durante la minzione. Come risultato dello studio delle proprietà fisiche dell'urina, non sono stati trovati sangue, pus e altre impurità, ad eccezione del muco, che normalmente si trova nell'urina dei cavalli.
Il colore è giallo scuro. L'odore del fieno cotto a vapore (non sono stati rilevati odori patologici). Opaco, nuvoloso. Come risultato della palpazione esterna nell'area dei processi delle 3-4 vertebre lombari a sinistra e 2-3 vertebre lombari a destra, non si avverte alcun dolore. Anche le percussioni in mongolfiera non causano dolore. Si osserva la condizione dei genitali esterni all'esame, la cianosi dei genitali esterni e un leggero gonfiore. Alla palpazione non si rileva dolore, infiammazione o danno all'integrità.
Il colore della mammella è nero. La sua integrità non è compromessa. Non c'è dolore. Forma ovale. Non allatta. La mastite e i corpi di acetone sono assenti.
Sistema nervoso.
Temperamento: flemmatico, tipo di attività nervosa: tipo flemmatico. Personalità: gentile
Secondo il proprietario dell'animale, il cavallo presentava i seguenti segni clinici: stato depressivo, affaticamento. Reagisce male alla risposta del proprietario. Quando uno sconosciuto o un cane da cortile si avvicina a un animale, la reazione è calma. C'è oppressione, l'animale si comporta in modo irrequieto. La coordinazione dei movimenti non è compromessa.
All'esame esterno non sono presenti protuberanze, neoplasie o lesioni traumatiche al cranio e non sono presenti curvature della colonna vertebrale. Alla palpazione, la forma delle ossa non cambia, le ossa sono simmetriche, non ci sono curvature, non è doloroso, il cuoio capelluto è caldo, l'integrità delle ossa non è compromessa, non c'è ammorbidimento; non c'è dolore, fratture, spostamento o deformazione delle vertebre, la pelle della colonna vertebrale è calda, la sensibilità è preservata. Alla percussione non sono stati rilevati tumori, vesciche cenurose ed echinococciche, emorragie cerebrali e idrocele dei ventricoli cerebrali; l'eccitabilità meccanica dei muscoli della colonna vertebrale è preservata, non c'è dolore.
Reparto somatico: sensibilità superficiale della pelle e delle mucose: la sensibilità tattile nell'animale studiato è preservata: con tocchi leggeri nella zona del garrese si osserva la contrazione della pelle.
La sensibilità al dolore è preservata: con un'impercettibile puntura della pelle con la punta di un ago, l'animale si guarda intorno e si allontana. La sensibilità tattile è preservata: con un leggero tocco impercettibile sul pelo nella zona del garrese, dell'addome e del padiglione auricolare, i muscoli sottocutanei dell'animale si contraggono, gira la testa e muove le orecchie. La sensibilità alla temperatura è preservata: l'animale reagisce al contatto della pelle con oggetti caldi e freddi contraendo i muscoli sottocutanei e girando la testa verso la sostanza irritante. La sensibilità profonda è preservata: quando si sposta in avanti l'arto toracico, l'animale si sforza di riportarlo nella posizione originale.
I riflessi della pelle sono preservati: riflesso del garrese - contrazione del muscolo sottocutaneo in risposta a un leggero tocco sulla pelle nella zona del garrese, riflesso addominale - quando si tocca la parete addominale in punti diversi - forte contrazione dei muscoli addominali, riflesso della coda - pressione la coda al perineo in risposta al contatto con la pelle della coda dalla superficie interna, riflesso anale - quando si tocca la pelle dell'ano - contrazione dello sfintere esterno, riflesso della corolla dello zoccolo - sollevamento dell'arto quando si preme sulla corolla lo zoccolo, riflesso del triangolare - quando si preme sullo zoccolo, i muscoli dell'avambraccio si contraggono, riflesso dell'orecchio - quando la pelle è irritata canale uditivo esterno, l'animale gira la testa e muove le orecchie.
I riflessi profondi sono preservati: riflesso del ginocchio - con un leggero colpo con un martello sui legamenti diritti della rotula - estensione dell'arto nell'articolazione del ginocchio, riflesso di Achille - dopo la flessione delle articolazioni sotto il garretto e un colpo al tendine di Achille , si osserva una debole estensione del garretto.
Non c'è prurito.
Stato della vista: visione preservata. Posizione delle palpebre: occhi aperti; le violazioni dell'integrità delle palpebre non sono state rilevate, indolori. La fessura palpebrale non è ristretta; la cornea è trasparente, liscia, non sono presenti ferite, ulcere o emorragie; la superficie dell'iride è liscia, il disegno è preservato; la pupilla è di forma rotonda.
L'udito è preservato: l'animale risponde bene ai suoni familiari. Risponde immediatamente al nickname. L'integrità dei padiglioni auricolari è preservata, il condotto uditivo è pulito, indolore e non sono presenti contenuti estranei.
Stato dell'olfatto: l'olfatto è preservato. Bendato, l'animale annusa e cerca il suo cibo preferito; quando si porta alle narici un batuffolo di cotone con una soluzione di ammoniaca, l'animale si allontana rapidamente.
Il gusto è preservato, la reazione agli stimoli gustativi non è compromessa: quando si applica sale, senape, succo di limone sulla lingua, la secrezione di saliva aumenta, l'animale scuote la testa, tira fuori la lingua e mastica con riluttanza quando gli viene somministrato il suo cibo preferito.
Risultati dell'esame rettale
L'esame rettale del cavallo ha evidenziato: tono sfinterico moderato, nessun dolore nella zona dell'intestino crasso, sensibilità preservata, integrità non compromessa, riempimento rettale moderato, feci dense, mucosa leggermente umida, calda, intatta.
All'esame interno (rettale), il rene sinistro si estende dall'ultima costola ai processi trasversali della 3a-4a vertebra lombare. È mobile, abbiamo potuto afferrarla con le dita, palparla e nel mesentere abbiamo potuto palpare l'arteria renale. Il rene destro si trova nella regione dei processi trasversali della 2a-3a vertebra lombare a destra. La superficie dei reni è liscia e indolore al tatto. Il rene sinistro è leggermente spostato in direzione craniale, il rene destro è immobile.
Durante la maschiatura non è stato rilevato alcun dolore nella zona dei reni.
Vescia.
Durante l'esame rettale, la vescica si trova palpabilmente sulle ossa pubiche, il suo fondo pende nella cavità addominale, a forma di pera, mediamente piena, indolore.
Descrizione del processo patologico: durante l'esame sono stati identificati sintomi di edema polmonare, vale a dire: mancanza di respiro espiratorio dell'animale, difficoltà di respirazione, respirazione addominale. Un liquido schiumoso di natura schiumosa viene rilasciato dai passaggi nasali. All'auscultazione della trachea e dei polmoni si sentono chiaramente rantoli umidi, simili allo scoppio di bolle. Nella plegafonia si ha un aumento del suono della percussione. Ed anche il suono percussivo è sordo, il campo polmonare è allargato sia a sinistra che a destra, si sposta caudalmente: lungo la linea della maculare: 18a costa, lungo la linea della tuberosità ischiatica: 16; lungo la linea dell'articolazione della spalla: 13. Durante l'auscultazione del cuore si sentono soffi endocardici persistenti. La percussione ha rivelato una zona ridotta di ottusità assoluta (suono sordo) a sinistra nei 4 spazi intercostali; l'ottusità relativa del cuore si trova alla periferia della zona di ottusità assoluta, dove si sente un suono sordo. La zona smussata si estende tra la 3a e la 5a costola. Il bordo posteriore del cuore si sposta caudalmente e si localizza nel 7° spazio intercostale. Il polso è aritmico. La qualità del polso è morbida, il grado di riempimento è vuoto, l'altezza dell'onda del polso è piccola, la forma delle onde del polso è alternata, mentre il polso nelle vene è pieno. AKD massimo (mm Hg) 90 mm. rt. st, AKD min (mm Hg st.) 35 mm. rt. Art., Forza sistolica del cuore (mm Hg. Art.) 55 mm. rt. art., VKD (mm colonna d'acqua) 200 mm. acqua Arte.
trattamento del cavallo sangue urina
Ricerca di laboratorio
Analisi del sangue
|
Risultato |
Valori di riferimento |
||
|
Leucociti (numero *109/l) |
|||
|
Emoglobina (g/l) |
|||
|
Globuli rossi (numero *1012/l) |
|||
|
Ematocrito |
|||
|
Volume medio degli eritrociti (fL) |
|||
|
Mercoledì Concentrato Emoglobina. In eritre. (g/l) |
|||
|
Piastrine (numero *109/l) |
|||
|
Formula dei leucociti |
|||
|
Asta |
|||
|
Segmentato |
|||
|
Linfociti |
|||
|
Monociti |
|||
|
Eosinofili |
|||
|
Basofili |
Analisi delle urine
|
INDICATORI |
DATA DELLO STUDIO E RISULTATO |
||
|
a) Proprietà fisiche |
|||
|
Quantità, ml |
|||
|
giallo rotto |
|||
|
Odore di cibo |
L'odore del cibo che viene mangiato |
||
|
Trasparenza |
|||
|
Consistenza |
membrana mucosa |
membrana mucosa |
|
|
Peso specifico |
|||
|
assente |
assente |
||
|
neutro |
Neutro-leggermente alcalino (6,8-8,5) |
||
|
Corpi chetonici |
nessuno |
Nessuno |
|
|
assente |
|||
|
assente |
assente |
||
|
Urobilinogeno |
assente |
assente |
|
|
Bilirubina |
assente |
assente |
|
|
L'epitelio è piatto |
negativo |
negativo |
|
|
Epitelio di transizione |
assente |
assente |
|
|
Epitelio renale |
assente |
assente |
|
|
globuli rossi |
assente |
assente |
|
|
Cilindri |
presente |
assente |
|
|
assente |
assente |
||
|
assente |
assente |
||
|
presente |
presente |
||
|
Batteri |
assente |
assente |
Esame del sangue biochimico (profilo standard)
|
ALT (U/l) |
|||
|
AST (U/l) |
|||
|
Albumina (g/l) |
|||
|
Amilasi (U/l) |
|||
|
Bilirubina totale (μmol/l) |
|||
|
Bilirubina diretta (μmol/l) |
|||
|
Gamma-GT (U/l) |
|||
|
Glucosio (mmol/l) |
|||
|
Creatinina (μmol/l) |
|||
|
Creatina chinasi (U/l) |
|||
|
LDH (U/l) |
|||
|
Acido urico (μmol/l) |
|||
|
Urea (mmol/l) |
|||
|
Proteine totali (g/l) |
|||
|
Trigliceridi (mmol/l) |
|||
|
Fosfatasi alcalina (U/l) |
|||
|
Globuline (g/l) |
|||
|
Coefficiente albumina-globulina |
|||
|
Coefficiente di De Ritis |
|||
|
Bilirubina indiretta (μmol/l) |
Decorso e trattamento della malattia
Terapia: riposo completo. Conservare in un'area fresca e ben ventilata. Ossigeno sottocutaneo. Per via endovenosa - soluzione al 10% di cloruro di calcio, soluzione di strofantina allo 0,05% con 5 ml. Soluzione di glucosio o cloruro di sodio allo 0,9%.
Conclusione
L'edema polmonare si è verificato sullo sfondo di insufficienza cardiaca acuta. La ragione di ciò era la scarsa cura del cavallo. Il cavallo non fa alcun esercizio fisico e segue una dieta squilibrata. L'animale ha lavorato su terreni coltivabili oltre la norma consentita per le sue condizioni fisiche. Il lavoro è stato svolto sotto il sole cocente. Il cavallo è tenuto in una stanza non ventilata dove è molto soffocante e umida. Tutti questi fattori hanno contribuito allo sviluppo di insufficienza cardiaca acuta e, di conseguenza, di edema polmonare. La diagnosi è stata confermata durante l'esame clinico dell'animale malato e i risultati dei test. Il trattamento sarà farmacologico.
Prevenzione: gli animali non dovrebbero essere sovraccaricati di lavoro e il lavoro dovrebbe essere limitato durante i periodi caldi della giornata. Un trattamento appropriato dovrebbe essere effettuato per le malattie accompagnate da insufficienza cardiaca.
Bibliografia
1. Diagnosi clinica delle malattie animali interne non contagiose. Autori: B.V. Usha., I.M. Belyakov., R.P. Pushkarev.
3. http://moykon.ru/
Pubblicato su Allbest.ru
Documenti simili
Storia della vita e della malattia, complicanze, condizioni dell'animale al momento dello studio. Studio della pelle, delle mucose, dei muscoli, delle ossa, del sistema cardiovascolare, digestivo, genito-urinario, nervoso e di altro tipo, della respirazione. Risultati dell'esame rettale.
storia medica, aggiunta il 29/09/2009
Anamnesi dell'animale domestico (cavallo) e suo esame clinico al momento del ricovero, risultati degli esami del sangue, delle urine, delle feci e del succo gastrico. Fare una diagnosi e la sua logica. Cause, patogenesi, sintomi e piano di trattamento della malattia (polmonite).
anamnesi, aggiunta il 09/11/2014
Considerazione dell'anamnesi medica, della storia della vita e dell'esame dell'animale. Esami di laboratorio su urine e feci, esame del sangue biochimico. Diario del decorso della malattia e diagnosi: glomerulonefrite. Metodi di base di trattamento e prevenzione.
storia medica, aggiunta il 18/04/2012
Eziologia, patogenesi e sintomi dell'epatite. Diagnosi, decorso e prognosi della malattia, trattamento dei cani. Risultati dello studio sull'animale, conferma della diagnosi precedente sulla base dei dati dell'esame clinico. Risultati della ricerca biochimica.
lavoro del corso, aggiunto il 17/01/2014
Storia della vita e della malattia di una mucca. Effettuare una diagnosi di "bronchite" sulla base dei dati di uno studio clinico sui sistemi nervoso cardiovascolare, respiratorio, digestivo e autonomo dell'animale e diagnosticare lo stato del metabolismo minerale.
abstract, aggiunto il 31/01/2012
Registrazione e raccolta della storia medica del cane. Caratteristiche dello studio clinico. Determinazione dell'abitudine, dei capelli, della pelle, delle mucose, dei sistemi linfatici, della termometria. Esame dei sistemi di organi e ulteriori studi su sangue, urina e feci.
lavoro del corso, aggiunto il 12/04/2010
Descrizione dei bovini di piccola taglia ricoverati presso la clinica veterinaria. Storia della vita, stato della famiglia. Risultati di uno studio generale dei sistemi e degli organi animali. Fare una diagnosi di una ferita incisa postoperatoria. Diario del trattamento quotidiano, prognosi.
anamnesi, aggiunta il 06/10/2013
Storia della vita e della malattia del cane. Determinazione del comportamento dell'animale, del pelo, della pelle e del tessuto sottocutaneo. Studio delle mucose, dei linfonodi, del sistema cardiovascolare, respiratorio, digestivo, genito-urinario e nervoso.
test, aggiunto il 22/12/2014
Una panoramica delle caratteristiche della malattia polmonare cronica, che si manifesta come insufficienza respiratoria e interferisce con lo scambio di gas nei polmoni. Studio del sistema cardiovascolare, respiratorio, digestivo e nervoso del cavallo. Diagnosi e trattamento dell'eczema polmonare.
test, aggiunto il 12/11/2014
Procedura per l'esame di un cavallo se vi è il sospetto di una malattia degli zoccoli. Raccolta dati anamnestici. Esame generale del cavallo, esame esterno dello zoccolo e dell'articolazione della bara. Ferratura diagnostica e radiografia per confermare la diagnosi.
La malattia è caratterizzata dal traboccamento di sangue dei capillari polmonari, accompagnato da infiltrazione del tessuto connettivo interlobulare e essudazione di liquido sieroso nella cavità degli alveoli. L'iperemia può essere attiva e passiva (stagnante) e l'edema può essere ipostatico (stagnante). Cavalli e maiali si ammalano più spesso, pecore, cani e animali di altre specie sono meno comuni.
Eziologia. Le principali cause della malattia sono le seguenti. Aumento del flusso sanguigno ai polmoni a causa di un aumento della respirazione, soprattutto in climi caldi e secchi, sole e colpi di calore, ristagno di sangue nei polmoni a causa di insufficienza cardiaca, intossicazione e prolungata posizione degli animali in una posizione. La malattia può verificarsi anche durante l'avvelenamento con alcuni veleni di origine vegetale, animale e minerale, nonché durante l'autointossicazione. L'edema polmonare può accompagnare malattie infettive, pasteurellosi, edema maligno, antrace, pleuropolmonite contagiosa, peste canina, ecc. I fattori che predispongono alla malattia sono il sovraccarico prolungato nel lavoro, nell'allenamento e nello stress.
I danni materiali consistono in una diminuzione della produttività, delle prestazioni degli animali, del costo del trattamento dei pazienti o della loro possibile morte.
Patogenesi. Il significato patogenetico dei processi patologici considerati è molto significativo. I capillari polmonari pieni di sangue aumentano di volume, riducono il lume degli alveoli e dei bronchi, il che provoca una diminuzione della mobilità dei polmoni, della loro capacità di espandersi e, quindi, difficoltà di respirazione e comparsa di mancanza di respiro. A causa del riempimento degli alveoli con liquido edematoso, si creano condizioni favorevoli per l'attività vitale e la riproduzione della microflora opportunistica, la formazione e l'accumulo delle sue tossine nei polmoni. Di conseguenza, il funzionamento di quasi tutti i sistemi nel corpo animale viene interrotto, in particolare
cardiovascolare.
Sintomi. Più spesso, la malattia è acuta ed è accompagnata da aumento della respirazione, mancanza di respiro, dilatazione delle narici e secrezione di schiuma rossastra dalle aperture nasali. Gli animali di solito stanno con gli arti anteriori divaricati ai lati. L'auscultazione della trachea e dei polmoni rivela sibili. Nei casi più gravi, gli animali possono mostrare segni di agitazione, paura e soffocamento (asfissia). Le mucose diventano bluastre, il polso è debole. Il suono della percussione dei polmoni durante l'iperemia e l'insorgenza dell'edema polmonare è timpanico e successivamente sordo.
Nell'iperemia passiva e nell'edema polmonare ipostatico, i segni clinici aumentano lentamente, nell'arco di diversi giorni e sono meno pronunciati.
In tutte le forme della malattia, se gli animali non ricevono cure mediche, possono morire a causa dell'asfissia.
Cambiamenti patomorfologici. L'iperemia attiva è accompagnata da un aumento del volume polmonare. Sembrano gonfi, più densi, di colore rosso scuro. I capillari polmonari traboccanti di sangue sporgono nel lume degli alveoli. Quando viene tagliato un polmone, esce più sangue del normale.
Nell'iperemia passiva, i polmoni sono leggermente aumentati di volume, compattati e punteggiati da numerose emorragie, che di solito si verificano con un ristagno venoso prolungato e successivamente sono accompagnati dalla formazione di macchie pigmentarie. Di conseguenza, i polmoni diventano marroni.
Con un decorso a lungo termine di questa forma di iperemia, gli alveoli si riempiono della parte liquida del sangue, che è accompagnata da atelettasia di alcune aree dei polmoni. In questo caso, nella loro densità e pesantezza, nonché nella superficie tagliata, diventano simili alla milza.
Con l'edema, i polmoni sono aumentati di volume, gonfi, di consistenza pastosa, di colore rosso scuro, ricoperti da un sottile strato di liquido leggero. In alcuni posti hanno emorragie. Nei bronchi e nella trachea si trova un fluido schiumoso, spesso misto a sangue. Quando il polmone viene tagliato, viene rilasciata una grande quantità di liquido schiumoso e sanguinante. Questi cambiamenti patologici confermano la presenza di edema polmonare.
Diagnosi e diagnosi differenziale. La diagnosi viene effettuata sulla base dell'anamnesi, dei sintomi clinici e di metodi di ricerca speciali. Le radiografie rivelano ampie aree d'ombra, soprattutto nelle parti inferiori del campo polmonare.
Quando si differenzia la malattia, è necessario tenere conto dello shock solare e termico; bronchite diffusa e sanguinamento dai polmoni. In questi casi il caldo e l'insolazione sono caratterizzati da fattori eziologici specifici che li provocano. La bronchite diffusa si distingue per la sua caratteristica temperatura corporea generale elevata, tosse, secrezione nasale e russamento, nonché risultati negativi alle percussioni. Il sanguinamento dai polmoni è escluso dalla presenza della caratteristica anemia crescente delle mucose.
Previsione. Fare attenzione, soprattutto con l'iperemia passiva (congestizia) e l'edema polmonare, poiché in questi casi si verifica spesso la morte degli animali per asfissia.
Trattamento. Si inizia posizionando gli animali in una stanza fresca, si rilascia fino allo 0,5% del peso dell'animale in una sola volta e si somministra per via endovenosa una soluzione al 10% di cloruro di calcio, gluconato di calcio, soluzione allo 0,9% di cloruro di sodio, soluzione isotonica di glucosio al 5% in dosi a seconda del tipo e dell'età dell'animale. Per l'iperemia passiva, l'edema ipostatico e lo sviluppo di insufficienza cardiaca, vengono prescritti farmaci cardiaci. caffeina, cordiamina, corazol, ecc. Iniezioni sottocutanee di ossigeno, blocco del ganglio stellato con una soluzione allo 0,25% o allo 0,5% di novocaina in ragione di 1 e 0,5 ml per 1 kg di peso animale, rispettivamente, piccole dosi di iolitico bronchiale farmaci (atropina, efedrina, aminofillina, ecc.), strofinando il petto con unguenti irritanti, trementina, tazze e cerotti di senape. Con lo sviluppo della polmonite ipostatica, accompagnato da un aumento della temperatura corporea generale, viene effettuato un ciclo di trattamento con antibiotici, farmaci sulfamidici, ecc.
Prevenzione. Evitare il sovraccarico e il surriscaldamento degli animali, eliminare le malattie cardiovascolari.
Le malattie sono caratterizzate da traboccamento sanguigno dei capillari polmonari con conseguente fuoriuscita di plasma nella cavità degli alveoli e infiltrazione del tessuto connettivo interlobulare.
Eziologia. La causa dell'iperemia attiva e dell'edema polmonare è il duro lavoro intenso, la corsa veloce prolungata (nei cavalli, nei cani), la detenzione di animali in stanze soffocanti e scarsamente ventilate durante la stagione calda, il trasporto di animali in carrozze soffocanti e affollate, l'inalazione di aria calda, sostanze velenose e gas irritanti. L'iperemia passiva e l'edema polmonare si verificano a causa del ristagno del sangue nella circolazione polmonare durante l'insufficienza cardiaca causata da miocardite, miocardosi, pericardite, difetti cardiaci, ecc. L'edema polmonare è spesso una conseguenza del surriscaldamento generale del corpo (ipertermia, colpo di calore o iperinsolazione (colpo di sole).
Sintomi. La malattia si sviluppa rapidamente ed è accompagnata da un aumento della mancanza di respiro misto, tachicardia e attacchi di soffocamento. Le mucose sono cianotiche, dalle aperture nasali viene rilasciata schiuma con una tinta rossastra. Durante l'auscultazione nella trachea, nei bronchi e nei polmoni si sentono rantoli umidi, gorgoglianti e crepitanti, causati dal fluido sieroso che è penetrato negli alveoli e nei bronchi. È possibile una tosse soffocata. Nei casi più gravi, gli animali mostrano agitazione, paura e segni di asfissia. Con iperemia passiva ed edema polmonare si osservano segni di danno cardiaco caratteristici di una determinata patologia (distrofia miocardica, pericardite, stenosi dell'orifizio atrioventricolare sinistro, insufficienza della valvola bicuspide, ecc.).
Broncopolmonite
Infiammazione dei bronchi e dei polmoni. La malattia è caratterizzata dalla sudorazione di essudato infiammatorio di vario tipo nelle cavità dei bronchi e degli alveoli. Poiché il processo infiammatorio raramente si limita alla mucosa degli alveoli (polmonite) e coinvolge i bronchi o, al contrario, inizia nella mucosa dei bronchi (bronchite), e successivamente, proseguendo, passa agli alveoli, il la malattia è più spesso chiamata broncopolmonite. Nella broncopolmonite, il coinvolgimento della pleura costale o polmonare o di entrambe contemporaneamente nel processo infiammatorio è chiamato pleuropolmonite. La polmonite, a seconda della natura dell'essudato formato, può essere catarrale, purulenta, fibrinosa, a seconda del suo decorso - acuta, cronica, a seconda della sua eziologia - primaria, secondaria.
A seconda della dimensione delle lesioni nei polmoni, la polmonite è divisa in focale (infiammazione dei singoli lobuli - polmonite lobulare) e focale (coinvolgimento di grandi lobi polmonari nel processo - polmonite lobare). Una tipica polmonite lobare è la polmonite lobare.
Clinicamente, la broncopolmonite è caratterizzata da una varietà di manifestazioni e caratteristiche eziologiche, quindi viene solitamente divisa in tipi separati. Alcuni di loro hanno preso il nome in base alle proprietà del versamento infiammatorio risultante e alle caratteristiche del suo decorso, altri - ai segni eziologici. Nella pratica clinica si distinguono i seguenti tipi di polmonite: catarrale, lobare, aspirazione, ipostatica, metastatica, atelettasica. Di tutte le forme di polmonite nominate, la più comune è la broncopolmonite catarrale.
Eziologia. Le cause primarie della broncopolmonite sono gli stessi fattori della bronchite acuta e cronica (raffreddore, cattivo microclima, polvere, gas).
La broncopolmonite, che si verifica a causa dell'aumentata attività della normale microflora dovuta alla congestione nei polmoni, è chiamata ipostatica. Se la causa della sua comparsa è stata l'atelettasia, allora si parla di broncopolmonite atelettasica. Quest'ultimo si forma quando gli alveoli vengono compressi dal tessuto connettivo in crescita (pneumosclerosi) oppure i bronchi vengono chiusi dall'essudato (in questo caso una sezione del polmone si svuota). La disfunzione di quest'area può portare all'attivazione della microflora e allo sviluppo di un focolaio infiammatorio. Anche l'essudato risultante è di natura catarrale.
La broncopolmonite da aspirazione si riferisce a casi di malattia che si verificano a seguito dell'ingresso di particelle di cibo nei polmoni durante la paresi, paralisi della faringe o sostanze medicinali quando vengono somministrate per via orale senza successo.
A volte la broncopolmonite appare quando l'agente eziologico della malattia viene introdotto per via ematogena o linfogena dal focolaio infettivo primario. Tale polmonite si osserva in caso di lavaggio, necrobatteriosi, endometrite, processo purulento-necrotico nell'area del garrese e della cartilagine del mysterium e dermatite. La broncopolmonite in questo caso è chiamata metastatica. Va menzionato un altro tipo di polmonite, che deriva da lesioni e dall'introduzione di un agente patogeno nel tessuto polmonare dalla rete, esofago con corpi estranei (polmonite traumatica).
Come processo secondario, la broncopolmonite si verifica in molte malattie infettive e invasive (tubercolosi polmonare, febbre catarrale, pasteurellosi, vaiolo delle pecore, morva, cimurro, polmonite virale nei suini, influenza e influenza equina, echinococcosi, ascariasis nei suini, dittoocaulosi, mulleriosi). .
Segni clinici. Aumento della temperatura corporea generale, depressione, aumento della respirazione sono i primi segni della malattia. A questi si aggiungono presto tosse e muco nasale, quindi secrezione purulenta dalle fosse nasali e sibilo crepitante. Se la malattia è stata preceduta da bronchite, prima si verifica una tosse e poi si sviluppano segni che indicano la polmonite nell'animale.
La comparsa di respiro sibilante (crepitante, con bolle fini) è causata dalla sudorazione di essudato liquido negli alveoli, che fa aderire le pareti degli alveoli durante l'espirazione. Durante l'inspirazione le pareti si separano e viene prodotto il suono. Quando gli alveoli sono completamente pieni di essudato, l'aria non vi entra, e in tali luoghi l'intensità del respiro sibilante diminuisce o scompaiono completamente; Anche la respirazione vescicolare, causata dall'ingresso di aria negli alveoli, è indebolita. Se il fuoco si trova poco lontano dalla superficie del polmone e ha un'area sufficientemente ampia, la percussione in tali aree può stabilire l'ottusità del suono. I segni descritti riscontrati in un luogo, dopo un certo periodo di tempo, si rivelano in un altro, il che corrisponde all'emergere di un nuovo focolaio infiammatorio. Tuttavia, spesso l'unico segno di una focalizzazione è un aumento della temperatura corporea, che in precedenza era normale o vicina ad essa. Una distinta ottusità del suono della percussione viene stabilita solo quando diversi focolai infiammatori si fondono in uno e formano un focus. L'auscultazione di tali aree può rivelare un suono vescicolare duro lungo la loro periferia. Questi cambiamenti si stabiliscono nelle aree enfisematose a causa della maggiore immissione di aria al loro interno.
La mancanza di respiro si verifica quando le aree colpite coprono ampie porzioni del polmone. Di solito si osserva una respirazione frequente e aumentata (ma non difficile).
Vari gradi di depressione della condizione generale, aumento della frequenza cardiaca, deterioramento dell'appetito, nonché i cambiamenti rilevati durante l'esame dei polmoni mediante auscultazione e percussione, sono in connessione diretta con le dimensioni e il grado del processo infiammatorio negli organi respiratori.
Qualsiasi animale domestico può ammalarsi di pasteurellosi, essendo stato infettato da animali già malati o da portatori dell'agente eziologico della malattia. Inoltre, i bovini, non meno degli altri rappresentanti dell'azienda agricola, corrono il rischio di contrarre la malattia della pastorellosi bovina.
Il bacillo della pasteurellosi entra nel corpo delle mucche attraverso l'aria, il cibo o, talvolta, attraverso le ferite sulla pelle. Il periodo di incubazione può durare da alcune ore a due o tre giorni. Il decorso della malattia varia. Si manifesta in modo iperacuto o acuto, oppure può avere un decorso subacuto e persino cronico.
Esistono tre forme di pasteurellosi: intestinale, edematosa e toracica. Ognuna di queste forme differisce per le sue caratteristiche e per gli organi dell'animale colpito. Cioè, con la forma intestinale, l'intestino è interessato, con la forma toracica sono colpiti gli organi respiratori e con la forma edematosa si osserva gonfiore in diverse parti del corpo.
Con la forma intestinale della malattia compaiono diarrea grave e debolezza. Spesso si osserva sangue nelle feci. Gli animali mostrano uno stato depressivo, hanno una forte sete e le mucose pallide. Molto spesso, gli animali giovani soffrono della forma intestinale di pasteurellosi, ma sono frequenti i casi di questa forma che colpisce le mucche adulte.
L'agente eziologico della pasteurellosi viene rilasciato dal corpo di un animale malato nelle feci, nelle urine, nel sangue e nelle secrezioni nasali quando si tossisce o si sbuffa. Nelle mucche, i coli possono essere escreti anche nel latte, quindi tale latte non dovrebbe essere consumato in nessun caso.
Quando la pasteurellosi si manifesta nella forma toracica, gli animali presentano tutti i segni della pleuropolmonite fibrinosa, vale a dire: difficoltà e respiro accelerato, tosse, secrezione nasale, polso accelerato. Le secrezioni sono inizialmente di tipo sieroso, poi di tipo sieroso-purulento. Quando ascolti il torace di un animale malato, puoi sentire una respirazione bronchiale pesante o persino attrito e rumore. Nella fase finale della malattia e nella forma toracica può comparire diarrea con sangue nelle feci. Dopo alcuni giorni, se la mucca non muore, la pasteurellosi può diventare subacuta o addirittura cronica.
Anche la forma edematosa è molto pericolosa. I bovini sviluppano gonfiore in tutto il corpo. Il tessuto adiposo sottocutaneo e i tessuti connettivi si gonfiano. In un tale animale, le mucose della bocca e della lingua si gonfiano, diventano di colore bluastro. La morte avviene per soffocamento e insufficienza cardiaca.
Con una qualsiasi delle tre forme di pasteurellosi acuta nei bovini, si osserva una temperatura corporea elevata. Se la malattia ha un decorso iperacuto, la temperatura sale improvvisamente fino a quarantuno gradi Celsius e l'animale muore nel giro di poche ore per insufficienza cardiaca ed edema polmonare.
Con la pasteurellosi subacuta o cronica nel bestiame compaiono segni di polmonite (lobare o catarrale). artrite, mastite, cheratocongiuntivite. Il decorso subacuto o cronico della malattia può durare da due a tre mesi.
L'agente eziologico della pasteurellosi può sopravvivere nell'acqua fredda, nel letame o nel sangue per due o tre settimane. Rimane nei cadaveri fino a quattro mesi e, una volta congelato, non muore fino a un anno, ma rimanere esposto alla luce solare diretta per alcuni minuti gli è fatale.
Per trattare la malattia, il siero contro la pasteurellosi bovina viene utilizzato in combinazione con antibiotici e sulfamidici. Il dosaggio di tutti i farmaci deve essere controllato con il veterinario.
Gli animali che si sono ripresi dalla malattia acquisiscono l'immunità all'agente eziologico della pasteurellosi per un periodo da sei mesi a un anno, ma tutti gli altri devono essere vaccinati per la profilassi al fine di prevenire l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia di massa tra i bovini. A tal fine esiste un vaccino contro la pasteurellosi bovina. Recentemente il vaccino è stato ampiamente utilizzato per la vaccinazione di bovini, bufali e ovini. Si chiama “Vaccino contro la pastorellosi bovina, emulsionato”. Gli animali giovani dovrebbero essere vaccinati all'età di tre mesi, quindi la vaccinazione dovrebbe essere ripetuta quando raggiungono l'anno di età. Le vaccinazioni possono essere somministrate solo ad animali assolutamente sani e senza segni di disturbi.
Pasteurellosi
La pastorellosi (inglese latino - Pasteurellosi; setticemia emorragica) è una malattia infettiva contagiosa di animali di molte specie, caratterizzata nei casi acuti da fenomeni settici, polmonite lobare, pleurite, edema in varie zone del corpo, e nei decorsi subacuti e cronici da fenomeni purulenti -polmonite necrotizzante, danni agli occhi, alle articolazioni, alle ghiandole mammarie ed enterite emorragica.
L'agente eziologico della malattia
L'agente eziologico della pasteurellosi - Pasteurellamultocida - è un bastoncino ellissoidale immobile, polimorfico, spesso corto, gram-negativo, situato separatamente, in coppie o, meno spesso, in catene; non forma spore; aerobi e anaerobi facoltativi. Gli strisci di sangue e organi sono caratterizzati da colorazione bipolare, spesso con una capsula pronunciata. Sui normali terreni nutritivi danno una buona crescita tipica.
Antigenicamente, P. multocida è eterogeneo; ha 4 sierotipi capsulari (A, B, D, E) e 12 tipi somatici. La determinazione della struttura antigenica dei ceppi di P. multocida gioca un ruolo importante nella selezione dei ceppi vaccinali, in particolare per la preparazione di un vaccino contro la pasteurellosi nei bovini - sierotipo B, negli uccelli - A e D e nei suini - A, B, D.
Le proprietà patogene e virulente dei vari sierotipi dell'agente patogeno nelle diverse specie animali variano ampiamente.
Nella comparsa della pasteurellosi tra gli animali, soprattutto negli allevamenti di piccole e grandi dimensioni, di particolare importanza è la pasteurella emolitica (P. haemolytica), che presenta due biotipi: A e T, attualmente tassonomicamente inclusa nel genere Actinobacillus. Per differenziare P. multocida da P. haemolytica si utilizzano la crescita su agar MacConkey, il test di resistenza su topo bianco e l'emolisi su agar sangue (positivo per quest'ultimo).
Pasteurella è stabile nel letame, nel sangue, nell'acqua fredda per 2,3 settimane, nei cadaveri fino a 4 mesi, nella carne congelata per 1 anno. La luce solare diretta li uccide in pochi minuti, ad una temperatura di 70,90 °C muoiono entro 5,10 minuti. Il trattamento con una soluzione di acido fenico al 5% neutralizza la pasteurella dopo 1 minuto, con una soluzione al 3% dopo 2 minuti, con una soluzione al 5% di latte di calce (idrossido di calcio) dopo 4,5 minuti, con una soluzione calda al 3% (50 °C ) soluzione di bicarbonato di sodio e candeggina all'1% - dopo 3 minuti.
Epizootologia
Tutte le specie di mammiferi domestici e uccelli sono sensibili alla pasteurellosi. I bovini sono i più sensibili. La pasteurellosi appare sotto forma di casi sporadici, ma in condizioni favorevoli alla sua diffusione può acquisire il carattere di un'epizoozia.
La principale fonte dell'agente infettivo sono gli animali malati e guariti, nonché gli animali clinicamente sani che sono stati in stretto contatto con pazienti affetti da pasteurellosi. Di grande importanza è il portatore di pastorellosi nell'epizootologia della malattia, che negli allevamenti svantaggiati tra i bovini raggiunge il 70%.
I fattori che contribuiscono alla diffusione epizootica della pasteurellosi comprendono movimenti di massa di animali senza la dovuta considerazione del grado di benessere degli allevamenti dovuto alla pasteurellosi, la mancanza di un'adeguata organizzazione di misure economiche e veterinarie-sanitarie negli allevamenti di bestiame e pollame e l'uso diffuso di rifiuti di macellazione non sufficientemente neutralizzati come mangime.
Le modalità di escrezione degli agenti patogeni da un corpo infetto sono diverse: con le feci, l'urina, soprattutto con la secrezione dal naso durante la tosse, lo sbuffo, con il sangue durante il sanguinamento. Le mucche malate possono anche espellere la pasteurella nel latte.
L'agente patogeno si trasmette attraverso il contatto diretto (tenere insieme animali sani e malati), nonché attraverso mangimi infetti, acqua, terreno, articoli per la cura, latte, rifiuti dell'industria di lavorazione della carne, roditori simili a topi, insetti, uccelli selvatici e esseri umani .
L'infezione degli animali è possibile attraverso il sistema respiratorio (via aerogena), la pelle ferita e le mucose.
La morbilità e la mortalità da pasteurellosi possono variare notevolmente a seconda della virulenza del patogeno, della struttura immunologica della mandria, delle condizioni di stabulazione e di alimentazione, della presenza di infezioni concomitanti e della tempestività delle misure sanitarie. Nelle moderne condizioni di allevamento degli animali, la pasteurellosi può manifestarsi contemporaneamente ad altre malattie: parainfluenza, rinotracheite infettiva, infezione da adenovirus, salmonellosi, streptococcosi, diplococcosi. Le infezioni miste di solito hanno un decorso più lungo e più maligno.
La pasteurellosi nei bovini si osserva principalmente in luglio-agosto e settembre-novembre.
Segni clinici
A seconda delle proprietà virulente e delle vie di penetrazione dell'agente patogeno, il periodo di incubazione della pasteurellosi dura da alcune ore a 3 giorni. La malattia può manifestarsi in modo iperacuto, acuto, subacuto e cronico.
Nei bovini con decorso iperacuto si osserva un improvviso aumento della temperatura corporea fino a 41 °C, gravi disturbi cardiaci e talvolta diarrea con sangue. La morte dell'animale avviene dopo poche ore con sintomi di debolezza cardiaca in rapido aumento ed edema polmonare.
La pasteurellosi acuta, di regola, si verifica con un danno primario all'intestino (forma intestinale), o al sistema respiratorio (forma toracica), o con la comparsa di edema in varie parti del corpo (forma edematosa). La temperatura corporea è elevata in tutte le forme di pasteurellosi acuta.
La forma intestinale si verifica più spesso negli animali giovani ed è caratterizzata da diarrea progressiva e debolezza degli animali. Sono frequenti i casi di presenza di sangue nelle feci. Gli animali sperimentano sete, mucose anemiche e crescente depressione.
Nella forma toracica si notano segni di pleuropolmonite fibrinosa acuta: respiro accelerato e affannoso, tosse, secrezione dalle aperture nasali, prima sierosa e poi sieroso-purulenta, polso aumentato. L'auscultazione del torace rivela aree di ottusità, aumento della respirazione bronchiale e talvolta suoni di attrito. Verso la fine della malattia si sviluppa spesso diarrea mista a sangue. La malattia dura diversi giorni. Molti animali malati muoiono oppure la malattia assume un decorso subacuto o cronico.
La forma edematosa è caratterizzata dalla formazione di edema infiammatorio a rapida diffusione del tessuto sottocutaneo e del tessuto connettivo intermuscolare nella testa, nel collo, nella giogaia, nelle labbra e talvolta nelle estremità. La mucosa del cavo orale, il frenulo della lingua e la lingua sono gonfie e di colore bluastro. La respirazione è difficile, sibilante. La saliva appiccicosa viene rilasciata dall'angolo della bocca. Gli animali muoiono a causa dei sintomi di crescente insufficienza cardiaca e asfissia.
Lo sviluppo e la gravità del processo patologico durante la pasteurellosi dipendono dallo stato del corpo dell'animale e dalla virulenza dell'agente patogeno. Nei siti di penetrazione, Pasteurella si moltiplica, penetra nella linfa e nel sangue, causando setticemia e morte dell'animale nella maggior parte dei casi dopo 12-36 ore.I prodotti tossici di Pasteurella svolgono un ruolo importante nello sviluppo di processi patologici: endotossine e soprattutto le aggressioni, prodotte dall'agente patogeno e che sopprimono la resistenza del corpo. La generalizzazione del processo è facilitata dall'inibizione della fagocitosi da parte di Pasteurella (fagocitosi incompleta) e dal massiccio danno ai capillari. Di conseguenza, si sviluppa un ampio gonfiore nel tessuto sottocutaneo e intermuscolare.
Gli animali guariti dalla pasteurellosi acquisiscono l'immunità per un periodo di 6,12 mesi. Per la prevenzione specifica della malattia in Russia sono consigliati più di 15 vaccini, per lo più inattivati: ad esempio quelli liofilizzati contro la pasteurellosi dei bovini e dei bufali. I vaccini vengono utilizzati a scopo preventivo e involontario in caso di problemi di stazionamento negli allevamenti. L'immunità intensa si forma il 7.10 giorno dopo la rivaccinazione e dura fino a 6 mesi.
Per l'immunizzazione passiva si utilizzano sieri iperimmune contro la pasteurellosi bovina.
Cambiamenti patologici
Nei bovini con pasteurellosi iperacuta e acuta, i cambiamenti patologici sono caratterizzati da emorragie multiple sulle membrane sierose, ingrossamento e gonfiore dei linfonodi, gastroenterite acuta, spesso di natura emorragica, ma la milza non è ingrossata. Inoltre, un sintomo tipico è il gonfiore del tessuto sottocutaneo e del tessuto intermuscolare nella testa (faringe e spazio intermascellare), nel collo, nella giogaia, nei genitali e nell'ano. Si notano cambiamenti distrofici nel fegato, nei reni e nel cuore.
Nella forma toracica della malattia si riscontrano cambiamenti particolarmente pronunciati nell'area polmonare: polmonite lobare o necrotizzante e pleuropolmonite. Il processo colpisce singole sezioni dei polmoni e talvolta interi lobi. Nella pasteurellosi, la polmonite lobare è leggermente diversa dalla polmonite classica - di solito si diffonde rapidamente, a causa della quale la marmorizzazione appare indistinta, l'essudato contiene molti globuli rossi, compaiono rapidamente focolai necrotici - di colore opaco, grigiastro sporco o marrone scuro, il dimensioni di un pisello a un pugno. I linfonodi regionali sono ingrossati, succosi, con emorragie puntiformi.
Diagnosi e diagnosi differenziale
La diagnosi di pasteurellosi viene stabilita sulla base di un complesso di studi epizootici, clinici, patologici e di laboratorio.
La diagnosi di laboratorio della pasteurellosi prevede: 1) l'esame microscopico di strisci di sangue e impronte digitali degli organi colpiti; 2) isolamento della coltura pura su terreni nutritivi con identificazione mediante proprietà biochimiche; 3) isolamento della pasteurella infettando animali da laboratorio (topi bianchi o conigli) con una sospensione da materiale patologico e una coltura da un mezzo nutritivo; 4) determinazione della virulenza di colture isolate per topi bianchi e conigli. Per determinare la virulenza della pasteurella emolitica vengono utilizzati embrioni di pollo di 7 giorni; 5) determinazione dell'affiliazione sierovariante di Pasteurella.
Come materiale di prova, il sangue dei vasi superficiali e il muco nasale vengono prelevati da animali malati e, dopo la morte o la macellazione forzata, sangue dal cuore, linfonodi (mesenterici, retrofaringei, mediastinici, sovrauterini, ecc.), Pezzi di polmoni, fegato , milza, cuore, rene, osso tubolare. In estate, durante il trasporto a lungo termine, il materiale patologico viene conservato con una soluzione di glicerina sterile al 30%.
La diagnosi di pasteurellosi causata da P. multocida si considera stabilita: 1) quando si isolano pasteurella virulente dal sangue o contemporaneamente da più organi parenchimali; 2) quando si isola la coltura solo dai polmoni del bestiame.
L'isolamento dai polmoni sia di P. multocida debolmente virulenta che di P. haemolytica indica una malattia mista di pasteurellosi causata da Pasteurella di entrambe le specie. Tale pasteurellosi viene diagnosticata come polmonite da pasteurellosi.
Quando si effettua una diagnosi, la pasteurellosi deve essere differenziata dalle malattie febbrili di natura settica, che sono anche accompagnate dalla comparsa di edema infiammatorio sotto la pelle: carbonchio, carbonchio enfisematoso ed edema maligno.
Trattamento e prevenzione
Per prevenire la malattia, i dirigenti e gli specialisti delle aziende agricole e i proprietari di animali devono garantire che siano adottate le seguenti misure: tutti gli animali che entrano nell'azienda agricola vengono tenuti in quarantena per 30 giorni sotto controllo veterinario e, se indicato, vaccinati contro la pasteurellosi; allevamenti con animali provenienti solo da allevamenti esenti da pasteurellosi; non consentire il contatto tra animali da allevamento e animali ad uso personale; disporre di controlli sanitari nelle aziende agricole e fornire al personale di servizio un cambio di vestiti e scarpe; proteggere gli animali da varie influenze stressanti; nelle zone sfavorevoli alla pasteurellosi, vaccinare sistematicamente gli animali; gli allevamenti in cui è stata registrata la pasteurellosi devono essere dotati durante tutto l'anno di solo bestiame vaccinato.
Agli animali malati viene somministrato siero iperimmune contro la pasteurellosi in una dose terapeutica e uno degli antibiotici (terramicina, ossitetraciclina, biomicina, clortetraciclina, tetraciclina, streptomicina, cloramfenicolo), farmaci a lunga durata d'azione (dibiomicina, ditetraciclina, disreptomidazolo, bicillina-3) o più farmaci moderni - enrofloxacina, ecc. Per scopi terapeutici possono essere utilizzati agenti patogenetici e sintomatici.
Quando viene accertata una malattia animale con pasteurellosi, l'azienda (azienda agricola, brigata, reparto, ecc.) viene dichiarata sfavorevole alla pasteurellosi; con decisione dell'amministrazione territoriale vengono introdotte restrizioni e un piano di misure organizzative, economiche e veterinario-sanitarie per eliminare la malattia è approvato.
In un allevamento non affetto da pasteurellosi, è vietato: 1) importare (esportare) animali al di fuori dell'allevamento per scopi di allevamento e consumo, ad eccezione dell'esportazione di animali clinicamente sani verso un impianto di lavorazione della carne; importare (esportare) animali sensibili alla pasteurellosi; 2) raggruppare, contrassegnare (con violazione dell'integrità della pelle) gli animali, nonché eseguire operazioni chirurgiche e vaccinazioni contro altre malattie; 3) pascolare animali appartenenti a gruppi svantaggiati e dare loro acqua da corpi idrici aperti; 4) vendere latte di animali malati o sospettati di pasteurellosi. Il latte deve essere pastorizzato per 5 minuti a 90 °C e utilizzato come mangime per animali. Il latte di mucche sane viene utilizzato senza restrizioni; 5) rimuovere (rimuovere) mangimi, attrezzi, attrezzature e altri oggetti dai locali delle aziende agricole disfunzionali; 6) trasportare il letame e la frazione liquida nei campi in forma non disinfettata.
I prodotti della macellazione animale sono sottoposti a trattamento veterinario. ispezione nel luogo di macellazione. Se si verificano alterazioni degenerative o altre patologie (ascessi, ecc.) nei muscoli, la carcassa con gli organi interni viene avviata allo smaltimento. In assenza di alterazioni patologiche nella carcassa e negli organi interni, i prodotti della macellazione vengono inviati a un impianto di lavorazione della carne, soggetto alle attuali norme veterinarie e sanitarie per il trasporto di prodotti a base di carne.
Al fine di localizzare il focolaio epizootico ed eliminare la malattia, i gestori degli allevamenti e gli specialisti veterinari devono garantire le seguenti attività: 1) esame clinico e termometria di tutti gli animali del gruppo svantaggiato; 2) isolamento in una stanza separata di animali malati e sospetti e assegnazione loro di attrezzature speciali e mezzi sanitari e igienici, nonché del personale di servizio, compresi i veterinari. specialista; 3) animali clinicamente sani, indipendentemente dalla loro ubicazione, essere immunizzati contro la pasteurellosi con uno dei vaccini secondo le istruzioni per l'uso.
La disinfezione ordinaria nei locali in cui sono tenuti gli animali viene effettuata immediatamente quando compaiono i primi casi di malattia o di morte, e poi quotidianamente durante la pulizia mattutina dei locali in cui si trovano animali malati e sospettati di malattia. I locali, i cortili, le gabbie (e il terreno sottostante) in cui sono tenuti animali sospettati di essere infetti (condizionatamente sani) devono essere disinfettati dopo ogni caso di isolamento di un animale malato e successivamente ogni 10 giorni fino alla revoca delle restrizioni, in conformità con le attuali istruzioni “Esecuzione della disinfezione veterinaria delle strutture zootecniche”.
Prima che le restrizioni vengano revocate, in un punto problematico vengono adottate le seguenti misure: 1) riparazioni dei locali in cui erano tenuti animali malati e sospetti; 2) disinfezione e pulizia di tutta l'area aziendale da letame e detriti, quindi ripetuta disinfezione e aratura; 3) disinfezione, derattizzazione e disinfezione finale dei locali.
La restrizione negli allevamenti (allevamento, scuderia, cortile) viene revocata 14 giorni dopo la vaccinazione generale degli animali e l'ultimo caso di guarigione o morte per pasteurellosi, nonché una serie di misure organizzative, economiche, veterinarie e sanitarie con disinfezione finale.
/ Nefrite acuta in una mucca
Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa
Dipartimento per la Politica del Personale e l'Istruzione
Istituto statale federale di istruzione superiore
formazione professionale
Accademia agricola statale di Irkutsk
1. Registrazione degli animali…………………………………6
2. Anamnesis vitae (storia di vita)………………………………………..6
3. Anamnesis morbi (storia di malattia)……………………………….8
StatusPraesens – ricerca personale su un animale malato al momento……………………………….9
2. 1. Esame generale dell'animale………………………9
2. 2. Studio speciale dell'animale……………. 10
2. 2. 1. La ricerca sul sistema cardiovascolare………………10
2. 2. 2. Studio dell'apparato respiratorio……………. 10
2. 2. 3. Studio dell'apparato digerente……………..10
2. 2. 4. Esame dell'apparato urinario…………………….11
2. 2. 5. Studio del sistema nervoso…………………….11
2. 2. 6. Esame del sangue e delle urine……………………………. 12
3. Diario………………………………13
4. Epicrisi…………………..…………………..19
5. Analisi dettagliata della malattia dell'animale sorvegliato…………….20
5. 1. Definizione di malattia……………..………..20
5.2. Brevi dati anatomici e fisiologici dell'organo………………. 20
5. 3. Eziologia……………..………..………..21
5. 4. Patogenesi…………………………..21
5. 5. Sintomi………………
5. 6. Diagnosi, diagnosi differenziale e prognosi……………. 23
5. 7. Motivazione del trattamento……………..……………24
5. 8. Esito della malattia e una serie di misure preventive………………….26
6. Elenco dei riferimenti ................................................................27
introduzione
Gli organi urinari svolgono un ruolo importante nei processi di osmoregolazione, mantenendo l'equilibrio idrico e la concentrazione di ioni come sodio, potassio, cloro, calcio, fosforo e altri elementi, rimuovendo i prodotti finali del metabolismo e le sostanze estranee al corpo. Il sistema urinario garantisce l'omeostasi nel corpo sotto influenze avverse (fattori di stress, tossine della microflora opportunistica), portando alla sua interruzione.
In condizioni di tecnologia di allevamento intensivo, una diagnosi clinica approfondita delle malattie del sistema urinario è di grande importanza.
Grazie alla funzione dei reni, l'organismo mantiene la pressione osmotica e l'equilibrio acido-base ottimali nel sangue. Le sostanze estranee all'organismo vengono eliminate attraverso i reni; questo organo ha funzioni di sintesi e ossidative. L'acido ipurico e l'ammoniaca prodotti nei reni sono coinvolti nella regolazione dell'equilibrio acido-base nel corpo. I reni hanno la capacità di ossidare l'acido β - idrossibutirrico, che si forma in grandi quantità quando il metabolismo dei grassi e delle proteine viene interrotto e in essi si verifica l'ossidazione dei pigmenti del sangue.
Malattie dei reni e delle vie urinarie si registrano negli animali di tutte le specie, soprattutto tra le mucche altamente produttive, i giovani bovini da ingrasso e i carnivori.
L'argomento di questo lavoro è la nefrite acuta. Questa malattia si riferisce alle malattie del sistema urinario e, secondo me, questo argomento è il più rilevante al momento.
Articolo di letteratura
Negli animali da allevamento, la patologia renale si verifica entro il 5,3% negli allevamenti commerciali e nell'8,2% nei complessi specializzati (V.I. Fedyuk, 1992) e negli animali domestici (cani, gatti) - entro l'1-2% (V D. Sokolov, 2003).
Le cause della nefrite possono essere l'avvelenamento con nefrotossine o sostanze tossiche, come trementina, catrame, erbicidi (I.M. Belyakov, 2004), l'alimentazione di rami di conifere, foglie di betulla, ontano, canne, l'uso di alcuni farmaci (preparati di arsenico, FOS, creolina ), punture di insetti (A.F. Kuznetsov, 2002; B.M. Anokhin, 1991). Secondo I.M. Belyakov (2004), il ruolo sensibilizzante è solitamente svolto dall'ipotermia, dall'alimentazione di scarsa qualità e dalle condizioni di vita insoddisfacenti.
La nefrite acuta può manifestarsi con leptospirosi, afta epizootica, babesiosi, theileriosi nei bovini; mastite parenchimale, endometrite, vaginite, reticoloperitonite traumatica e pericardite, flemmone, sepsi chirurgica, ustioni, blocchi intestinali (B. M. Anokhin, 1991) e la dipendenza diretta e la costanza nello sviluppo della nefrite dall'intensità del processo infettivo non è tipica (I M. Belyakov, 2004).
Gli agenti infettivi possono entrare nell'apparato glomerulare dei reni in diversi modi: linfogeno (attraverso la linfa), ematogeno (attraverso il sangue), dai tessuti vicini e dagli organi genitali. Le infezioni del tratto genitale sono la causa più comune e importante di nefrite negli animali (A.F. Kuznetsov, 2002). Sotto l'influenza di agenti patogeni, nei reni si verifica una reazione immuno-biologica di natura autoimmune (A. V. Aganin, 1996).
La patogenesi della malattia non è stata sufficientemente studiata (V.N. Zhulenko, 2000). La nefrite acuta è caratterizzata da disturbi metabolici, funzioni dei sistemi endocrino, nervoso e vascolare (I.M. Belyakov, 2004). Di norma, prima di tutto, si verificano disturbi circolatori nell'apparato vascolare dei reni (B. M. Anokhin, 1991). I cambiamenti morfologici nei reni durante la nefrite sono rappresentati dalla proliferazione delle cellule mesangiali, endoteliali ed epitelioidi del glomerulo, ispessimento e spaccatura della membrana basale dei capillari glomerulari, sclerosi delle anse vascolari e degenerazione dell'epitelio tubulare (20).
I segni clinici sono molto diversi, quindi di solito sono combinati in sindromi: sindrome da infiammazione glomerulare acuta, sindrome cardiovascolare, sindrome dell'edema, sindrome cerebrale (A.F. Kuznetsov, 2002).
La nefrite si sviluppa rapidamente (B. M. Anokhin, 1991). Si verificano depressione, perdita di appetito e febbre (V.N. Zhulenko, 2000). Uno dei sintomi principali e ad esordio precoce è l'ipertensione arteriosa e l'edema rapido (B. M. Anokhin, 1991). L'urina ha il colore del lavaggio della carne e contiene molti elementi formati di sangue (I.M. Belyakov, 2004).
Le complicanze derivanti dalla nefrite comprendono: insufficienza cardiovascolare acuta (insufficienza ventricolare sinistra, edema cardiaco polmonare); eclampsia (perdita di coscienza, convulsioni cloniche e toniche); sanguinamento nel cervello; deficit visivo acuto (a volte cecità dovuta a spasmo e gonfiore della retina) (A.F. Kuznetsov, 2002).
Per prevenire la nefrite, è necessario prevenire le malattie infettive e settiche purulente, trattarle vigorosamente e in modo tempestivo. Agli animali vengono fornite buone condizioni di vita, vengono rispettati gli standard zooigienici e vengono eliminati i fattori che riducono la resistenza del corpo (B. M. Anokhin, 1991). È inoltre necessario diagnosticare tempestivamente e correttamente la nefrite con un test di laboratorio obbligatorio sulle urine, identificare ed eliminare la causa della malattia. Durante il trattamento non è consentita l'ipotermia del paziente e l'ingresso di sostanze tossiche e irritanti nel corpo dell'animale tramite cibo, acqua o farmaci (A.F. Kuznetsov, 2002).
1. Conoscenza preliminare dell'animale malato
1.1. Registrazione degli animali
Tipo di animale: bestiame
Paolo è una mucca
Razza: nera e eterogenea
Data di nascita: 2002
Soprannome o numero di inventario - N. 4427. Salice
Chi possiede l'animale - OPH "Belskoye", MTF "Elan"
Indirizzo del proprietario: regione di Irkutsk, distretto di Cheremkhovo, villaggio. Yelan
1.2. Anamnesisvitae (storia della vita)
Una mucca, razza bianca e nera, n. 4427, soprannominata Verba, di 5 anni, tenuta in una stalla standard a quattro file al guinzaglio, con processi meccanizzati di alimentazione e rimozione del letame e irrigazione automatica.
L'alimentazione viene effettuata utilizzando attrezzature speciali - un miscelatore meccanico per la distribuzione del mangime - 2 volte al giorno.
L'irrigazione viene effettuata utilizzando abbeveratoi automatici fissi a tazza singola della modifica PA - 1M - in abbondanza senza restrizioni.
La mungitura viene effettuata 3 volte al giorno, utilizzando apposite macchine mungitrici: al mattino, al pomeriggio e alla sera. Al mattino, la mungitura inizia alle 6 e termina alle 9. Durante la giornata la mungitura inizia alle ore 13:00 e termina alle ore 16:00. La sera inizia alle 20 e termina alle 23.
Il fienile dispone di illuminazione naturale (attraverso le finestre) e di illuminazione artificiale - 4 - 5 W/m². La stanza ha ventilazione naturale, i cancelli sono spesso aperti e ci sono correnti d'aria. I pavimenti nella stanza sono di cemento; la segatura viene utilizzata come lettiera. La temperatura dell'aria nella stalla va da 0 a 16° C, c'è una maggiore umidità (umidità nella stanza).
All'animale viene fornito esercizio attivo quotidiano.
Razione alimentare (kg) - fieno - 5, insilato di mais - 15, barbabietola da foraggio - 4, mangime composto - 3,5, sale da cucina - 80 g/giorno.