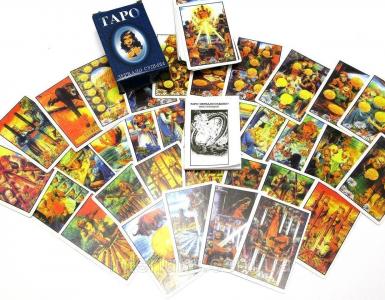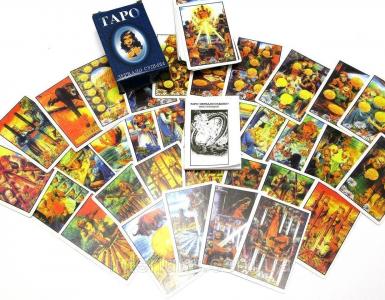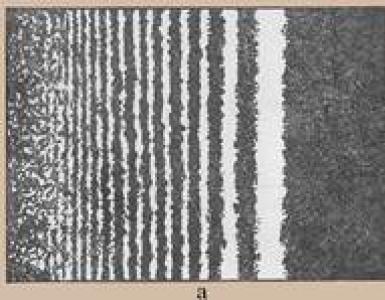Problemi ambientali dell'industria. L’industria chimica è il primo produttore di rifiuti non riciclabili
Il sistema “uomo-ambiente” è in uno stato di equilibrio dinamico, in cui viene mantenuto uno stato ecologicamente equilibrato dell’ambiente naturale, in cui gli organismi viventi, compreso l’uomo, interagiscono tra loro e con l’ambiente abiotico (non vivente) circostante. senza disturbare questo equilibrio.
Nell'era della rivoluzione scientifica e tecnologica, il ruolo crescente della scienza nella vita della società porta spesso a tutti i tipi di conseguenze negative dell'uso delle conquiste scientifiche negli affari militari (armi chimiche, armi atomiche), nell'industria (alcuni progetti di armi nucleari reattori), energia (centrali idroelettriche di pianura), agricoltura (salinizzazione del suolo, avvelenamento del deflusso dei fiumi), sanità (produzione di farmaci non testati) e altri settori dell’economia nazionale. Una violazione dello stato di equilibrio tra una persona e il suo ambiente può già avere conseguenze globali sotto forma di deterioramento dell'habitat, distruzione dei sistemi ecologici naturali e cambiamenti nel pool genetico della popolazione. Secondo l'OMS, il 20-40% della salute delle persone dipende dallo stato dell'ambiente, il 20-50% dallo stile di vita, il 15-20% da fattori genetici.
In base alla profondità della reazione ambientale si dividono in:
Disturbo, cambiamento temporaneo e reversibile dell'ambiente.
Inquinamento, accumulo di impurità tecnogeniche (sostanze, energia, fenomeni) provenienti dall'esterno o generate dall'ambiente stesso a seguito dell'impatto antropico.
Anomalie, deviazioni quantitative stabili ma locali dell'ambiente dallo stato di equilibrio. Con un impatto antropico prolungato, può verificarsi quanto segue:
Crisi ambientale, uno stato in cui i suoi parametri si avvicinano ai limiti consentiti delle deviazioni.
Distruzione dell'ambiente, una condizione in cui diventa inadatto all'abitazione umana o all'uso come fonte di risorse naturali.
Per prevenire un effetto così dannoso del fattore antropico, è stato introdotto il concetto di concentrazioni massime ammissibili di sostanze (concentrazioni massime ammissibili di sostanze): una concentrazione di sostanze che non ha un effetto diretto o indiretto su una persona, non riduce le prestazioni e non influisce sulla salute e sull'umore.
Concentrazioni massime di alcuni inquinanti nell'aria dell'area di lavoro



Per valutare la tossicità si determinano le proprietà della sostanza (solubilità in acqua, volatilità, pH, temperatura e altre costanti) e le proprietà dell'ambiente in cui è entrata (caratteristiche climatiche, proprietà del giacimento e del suolo).
Monitoraggio: osservazione (tracciamento) dello stato dell'ambiente al fine di rilevare i cambiamenti in questo stato, la loro dinamica, velocità e direzione. I dati di sintesi ottenuti a seguito di osservazioni a lungo termine e di numerose analisi consentono di prevedere la situazione ambientale con diversi anni di anticipo e di adottare misure per eliminare impatti e fenomeni negativi. Questo lavoro è svolto professionalmente da organizzazioni speciali: riserve della biosfera, stazioni sanitarie ed epidemiologiche, ospedali ambientali, ecc.
Campionamento dell'aria.
Il campione biologico di aria può essere relativamente piccolo;
In condizioni di laboratorio, un campione biologico è formato da aria allo stato liquido;
Il campione biologico viene prelevato utilizzando un dispositivo di raccolta: un aspiratore di campionamento, un dispositivo di assorbimento Rychter con una soluzione di assorbimento. La durata di conservazione dei campioni prelevati non è superiore a 2 giorni;
In uno spazio confinato viene prelevato un campione d'aria al centro della stanza, ad un'altezza compresa tra 0,75 e 1,5 m dal pavimento
Campionamento dell'acqua.
I campioni vengono prelevati utilizzando pipette, burette e matracci tarati (dimostrazione per gli studenti).
Un campione liquido viene prelevato da un volume chiuso dopo che è stato accuratamente miscelato.
Un campione biologico di un liquido omogeneo viene prelevato dal flusso a determinati intervalli di tempo e in luoghi diversi.
Per ottenere risultati affidabili, i campioni biologici di acqua naturale devono essere analizzati entro 1-2 ore dalla raccolta.
Per prelevare campioni biologici a diverse profondità, vengono utilizzati speciali dispositivi di campionamento: batometri, la cui parte principale è un recipiente cilindrico con una capacità di 1-3 litri, dotato di coperchi nella parte superiore e inferiore. Dopo l'immersione nel liquido ad una determinata profondità, i coperchi dei cilindri vengono chiusi e il recipiente del campione viene sollevato in superficie.
Campionamento di materia solida.
Un campione biologico di sostanze solide deve essere rappresentativo del materiale da testare (contenere la massima diversità possibile nella composizione del materiale da testare; ad esempio, per controllare la qualità delle compresse, è consigliabile analizzare non una singola compressa, ma mescolare una certa quantità e prelevare da questa miscela un campione corrispondente al peso medio di una compressa).
Nel prelievo dei campioni si cerca la massima omogeneizzazione possibile del materiale, ottenuta meccanicamente (macinazione, frantumazione).
I campioni biologici provenienti da biosubstrati solidi vengono convertiti in un campione biologico in fase liquida.
A tale scopo vengono utilizzate tecniche tecnologiche speciali: preparazione di soluzioni, sospensioni, colloidi, paste e altri mezzi liquidi.
Preparazione dell'estratto acquoso del terreno.
Procedura: macinare accuratamente il campione di terreno in un mortaio. Prelevare 25 g di terreno, trasferirlo in un pallone da 200 ml e aggiungere 50 ml di acqua distillata. Agitare bene il contenuto del matraccio e lasciarlo riposare per 5-10 minuti, quindi, dopo aver agitato brevemente, filtrare in un matraccio da 100 ml attraverso un filtro fitto. Se il filtrato è torbido, ripetere la filtrazione attraverso lo stesso filtro fino ad ottenere un filtrato limpido.
Determinazione degli indicatori che caratterizzano le proprietà organolettiche dell'acqua.
Le proprietà organolettiche sono standardizzate in base all'intensità della loro percezione da parte dell'uomo. Questi sono odore, sapore, colore, trasparenza, torbidità, temperatura, impurità (pellicola, organismi acquatici).
Esperimento n. 1. Determinazione della trasparenza dell'acqua.
Reagenti: 3 campioni di acqua (provenienti da diverse zone di Penza).
Dotazione: 3 cilindri graduati, piastra in plastica, pennarello.
Progresso. Versare diversi campioni d'acqua in un cilindro graduato. Posiziona un piatto di plastica bianca con una croce permanente nera sopra sul fondo di ciascun cilindro. Agitare l'acqua prima di misurare. La trasparenza, a seconda della quantità di particelle sospese, è determinata dall'altezza della colonna d'acqua nel cilindro (in cm), attraverso la quale è visibile il contorno della croce.
Determinazione dell'odore dell'acqua.
Gli odori naturali dell'acqua sono associati all'attività vitale di piante e animali o alla decomposizione dei loro resti; odori artificiali all'ingresso di acque industriali o reflue.
Ci sono odori aromatici, paludosi, putrefattivi, legnosi, terrosi, ammuffiti, di pesce, di idrogeno solforato, erbosi e vaghi.
L'intensità dell'odore viene determinata utilizzando un sistema a 5 punti:
punteggio: nessun odore o molto debole (di solito non evidente).
punteggio - debole (scoperto se presti attenzione).
punto - evidente (facilmente notabile e può causare commenti di disapprovazione sull'acqua).
punto - distinto (in grado di provocare l'astinenza dal bere).
punti - molto forti (così forti che l'acqua è completamente imbevibile).
Determinazione del colore dell'acqua.
Il colore è una proprietà naturale dell'acqua dovuta alla presenza di sostanze umiche, che le conferiscono un colore dal giallastro al marrone. Le sostanze umiche si formano durante la distruzione dei composti organici nel suolo, vengono lavate via ed entrano nei corpi idrici aperti. Pertanto, il colore è caratteristico dell'acqua dei bacini aperti e aumenta bruscamente durante il periodo di piena.
Reagenti: campioni di acqua, acqua distillata.
Attrezzatura: 4 bicchieri, un foglio di carta bianca.
Avanzamento del lavoro: La determinazione viene effettuata confrontandola con acqua distillata. Per fare questo, prendi 4 bicchieri identici e riempili con acqua - uno distillato, l'altro - quello di prova. Sullo sfondo di un foglio di carta bianca, confronta il colore osservato: incolore, marrone chiaro, giallastro.
Determinazione di indicatori che caratterizzano la composizione chimica e le proprietà dell'acqua.
Indicatori come residuo secco, durezza totale, pH, alcalinità, contenuto di cationi e anioni: Ca 2+, Na +, HCO 3 -, Cl -, Mg 2+ caratterizzano la composizione naturale dell'acqua.
Determinazione della densità dell'acqua.
Determinazione del pH (indice di idrogeno).
Il valore del pH è influenzato dal contenuto di carbonati, idrossidi, sali idrolizzabili, sostanze umiche, ecc. Questo indicatore è un indicatore dell'inquinamento dei serbatoi aperti quando vengono rilasciate acque reflue acide o alcaline. A causa dei processi chimici e biologici che si verificano nell'acqua e della perdita di anidride carbonica, il pH dell'acqua può cambiare rapidamente e questo indicatore dovrebbe essere determinato immediatamente dopo il campionamento, preferibilmente nel sito di campionamento.
Rilevazione di sostanze organiche.
Procedura: prendere 2 provette, versare in una 5 ml di acqua distillata e nell'altra la provetta. Aggiungere una goccia di soluzione di permanganato di potassio al 5% in ciascuna provetta.
Esperimento n. 7. Rilevazione di ioni cloruro.
L'elevata solubilità dei cloruri spiega la loro diffusa distribuzione in tutte le acque naturali. Nei corpi idrici correnti il contenuto di cloruri è solitamente basso (20-30 mg/l). Le acque sotterranee non contaminate in aree con terreno non salino contengono solitamente fino a 30-50 mg/l di cloro. Nell'acqua filtrata attraverso il terreno salino, 1 litro può contenere centinaia e persino migliaia di milligrammi di cloruri. L'acqua contenente cloruri in una concentrazione superiore a 350 mg/l ha un sapore salato e con una concentrazione di cloruri di 500-1000 mg/l ha un effetto negativo sulla secrezione gastrica. Il contenuto di cloruro è un indicatore della contaminazione delle fonti d'acqua sotterranee e superficiali e delle acque reflue.
I problemi ambientali dell'industria chimica hanno una qualità molto spiacevole. Come risultato della produzione di questo ramo dell'attività economica umana, compaiono o vengono sintetizzate sostanze che sono artificiali al 100% e non sono cibo per nessun organismo sulla Terra. Non entrano nella catena alimentare e quindi non vengono lavorati naturalmente. Possono accumularsi, essere smaltiti o trasformati nello stesso modo industriale artificiale. Oggi la loro lavorazione è molto indietro rispetto alla produzione e all’accumulo. E questo è il principale problema ambientale.
Storia dell'origine, tipologie
 Le prime imprese da cui ebbe inizio la nascita di una nuova industria chimica furono gli impianti per la produzione di acido solforico nel 1736 in Gran Bretagna e nel 1766 in Francia, per poi proseguire con il carbonato di sodio. A metà del XIX secolo, l’industria chimica iniziò a produrre fertilizzanti minerali artificiali per l’agricoltura, plastica, gomma sintetica e fibre artificiali.
Le prime imprese da cui ebbe inizio la nascita di una nuova industria chimica furono gli impianti per la produzione di acido solforico nel 1736 in Gran Bretagna e nel 1766 in Francia, per poi proseguire con il carbonato di sodio. A metà del XIX secolo, l’industria chimica iniziò a produrre fertilizzanti minerali artificiali per l’agricoltura, plastica, gomma sintetica e fibre artificiali.
L'industria chimica ha i suoi sottosettori: chimica inorganica e organica, ceramica, chimica petrolifera e agricola, polimeri, elastomeri, esplosivi, chimica farmaceutica e profumi. I principali prodotti che produce sono: ammoniaca, acidi e alcali, fertilizzanti minerali, soda, cloro, alcoli, idrocarburi, coloranti, resine, plastica, fibre sintetiche, prodotti chimici domestici e molto altro.
Le più grandi aziende chimiche del mondo: BASF AG (Germania), BayerAG (Germania), ShellChemicals (Olanda e Gran Bretagna), INEOS (Regno Unito) e DowChemicals (USA).
Fonti di inquinamento
 Problemi dell'industria chimica legati all'ambiente non solo nei prodotti fabbricati, ma anche nei rifiuti e nelle emissioni nocive derivanti dal processo e come risultato della produzione.
Problemi dell'industria chimica legati all'ambiente non solo nei prodotti fabbricati, ma anche nei rifiuti e nelle emissioni nocive derivanti dal processo e come risultato della produzione.
Queste sostanze sono secondarie o sottoprodotti, ma indipendenti e forse le principali fonti di inquinamento ambientale.
Le emissioni e i rifiuti della produzione chimica sono principalmente miscele e pertanto la loro pulizia o smaltimento di alta qualità è difficile. Si tratta di anidride carbonica, ossidi di azoto e zolfo, fenoli, alcoli, eteri, fluoruri, ammoniaca, gas di petrolio e altre sostanze pericolose e tossiche. Inoltre, l'industria chimica produce essa stessa sostanze tossiche. Non solo per le esigenze agricole, ma anche per le forze armate, il cui stoccaggio e smaltimento richiede un regime speciale.
La tecnologia di produzione chimica richiede un maggiore consumo di acqua. Qui viene utilizzato per varie esigenze, ma dopo l'uso non viene sufficientemente purificato e ritorna nei fiumi e nei bacini artificiali sotto forma di rifiuti.
L'introduzione di fertilizzanti minerali e sostanze fitosanitarie durante i lavori agricoli di per sé influisce negativamente sulla composizione, sulla struttura e sulle connessioni del biosistema che si è sviluppato in un dato territorio. Alcune specie di flora e fauna vengono soppresse e, allo stesso tempo, viene stimolata la crescita e la riproduzione di altre, spesso insolite per essa. Alcuni residui di sostanze tossiche penetrano in profondità nel suolo e influenzano negativamente gli strati più profondi della terra e delle acque sotterranee. L'altra parte, con lo scioglimento della neve e le precipitazioni, viene lavata via dalla superficie dei terreni arati e finisce nei fiumi e nei bacini artificiali, dove colpisce il suolo e la flora di altre regioni.
Industria della Russia
 In Russia i problemi ambientali dell’industria chimica sono simili. La formazione dell'industria iniziò nel 1805 con i primi stabilimenti per la produzione di acido solforico. Al giorno d'oggi l'industria è estremamente sviluppata ed è rappresentata in quasi tutte le aree esistenti nel mondo. Le più grandi imprese di questo settore in Russia sono: nel settore petrolchimico - Sibur Holding (Mosca), Salavatnefteorgsintez (Salavat, Bashkortostan), nella produzione di gomme sintetiche - Nizhnekamskneftekhim (Nizhnekamsk, Tatarstan), fertilizzanti - Eurochem (Mosca) e altri. La posizione di leader nel settore è occupata dalle imprese che utilizzano idrocarburi come materie prime. E questo è del tutto naturale.
In Russia i problemi ambientali dell’industria chimica sono simili. La formazione dell'industria iniziò nel 1805 con i primi stabilimenti per la produzione di acido solforico. Al giorno d'oggi l'industria è estremamente sviluppata ed è rappresentata in quasi tutte le aree esistenti nel mondo. Le più grandi imprese di questo settore in Russia sono: nel settore petrolchimico - Sibur Holding (Mosca), Salavatnefteorgsintez (Salavat, Bashkortostan), nella produzione di gomme sintetiche - Nizhnekamskneftekhim (Nizhnekamsk, Tatarstan), fertilizzanti - Eurochem (Mosca) e altri. La posizione di leader nel settore è occupata dalle imprese che utilizzano idrocarburi come materie prime. E questo è del tutto naturale.
L'area di inquinamento derivante dalla produzione petrolchimica può trovarsi fino a 20 km dalla fonte delle emissioni. Il volume delle emissioni dipende principalmente dalla capacità delle apparecchiature tecnologiche e dalla loro qualità, nonché dai sistemi di trattamento dell'acqua, dai gas di scarico e dai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Video - Impatto dell'industria chimica sull'ambiente
Il sistema “uomo-ambiente” è in uno stato di equilibrio dinamico, in cui viene mantenuto uno stato ecologicamente equilibrato dell’ambiente naturale, in cui gli organismi viventi, compreso l’uomo, interagiscono tra loro e con l’ambiente abiotico (non vivente) circostante. senza disturbare questo equilibrio.
Nell'era della rivoluzione scientifica e tecnologica, il ruolo crescente della scienza nella vita della società porta spesso a tutti i tipi di conseguenze negative dell'uso delle conquiste scientifiche negli affari militari (armi chimiche, armi atomiche), nell'industria (alcuni progetti di armi nucleari reattori), energia (centrali idroelettriche di pianura), agricoltura (salinizzazione del suolo, avvelenamento del deflusso dei fiumi), sanità (produzione di farmaci non testati) e altri settori dell’economia nazionale. Una violazione dello stato di equilibrio tra una persona e il suo ambiente può già avere conseguenze globali sotto forma di deterioramento dell'habitat, distruzione dei sistemi ecologici naturali e cambiamenti nel pool genetico della popolazione. Secondo l'OMS, il 20-40% della salute delle persone dipende dallo stato dell'ambiente, il 20-50% dallo stile di vita, il 15-20% da fattori genetici.
In base alla profondità della reazione ambientale si dividono in:
Disturbo, cambiamento temporaneo e reversibile dell'ambiente.
Inquinamento, accumulo di impurità tecnogeniche (sostanze, energia, fenomeni) provenienti dall'esterno o generate dall'ambiente stesso a seguito dell'impatto antropico.
Anomalie, deviazioni quantitative stabili ma locali dell'ambiente dallo stato di equilibrio. Con un impatto antropico prolungato, può verificarsi quanto segue:
Crisi ambientale, uno stato in cui i suoi parametri si avvicinano ai limiti consentiti delle deviazioni.
Distruzione dell'ambiente, una condizione in cui diventa inadatto all'abitazione umana o all'uso come fonte di risorse naturali.
Per prevenire un effetto così dannoso del fattore antropico, è stato introdotto il concetto di concentrazioni massime ammissibili di sostanze (concentrazioni massime ammissibili di sostanze): una concentrazione di sostanze che non ha un effetto diretto o indiretto su una persona, non riduce le prestazioni e non influisce sulla salute e sull'umore.
Concentrazioni massime di alcuni inquinanti nell'aria dell'area di lavoro



Per valutare la tossicità si determinano le proprietà della sostanza (solubilità in acqua, volatilità, pH, temperatura e altre costanti) e le proprietà dell'ambiente in cui è entrata (caratteristiche climatiche, proprietà del giacimento e del suolo).
Monitoraggio: osservazione (tracciamento) dello stato dell'ambiente al fine di rilevare i cambiamenti in questo stato, la loro dinamica, velocità e direzione. I dati di sintesi ottenuti a seguito di osservazioni a lungo termine e di numerose analisi consentono di prevedere la situazione ambientale con diversi anni di anticipo e di adottare misure per eliminare impatti e fenomeni negativi. Questo lavoro è svolto professionalmente da organizzazioni speciali: riserve della biosfera, stazioni sanitarie ed epidemiologiche, ospedali ambientali, ecc.
Campionamento dell'aria.
Il campione biologico di aria può essere relativamente piccolo;
In condizioni di laboratorio, un campione biologico è formato da aria allo stato liquido;
Il campione biologico viene prelevato utilizzando un dispositivo di raccolta: un aspiratore di campionamento, un dispositivo di assorbimento Rychter con una soluzione di assorbimento. La durata di conservazione dei campioni prelevati non è superiore a 2 giorni;
In uno spazio confinato viene prelevato un campione d'aria al centro della stanza, ad un'altezza compresa tra 0,75 e 1,5 m dal pavimento
Campionamento dell'acqua.
I campioni vengono prelevati utilizzando pipette, burette e matracci tarati (dimostrazione per gli studenti).
Un campione liquido viene prelevato da un volume chiuso dopo che è stato accuratamente miscelato.
Un campione biologico di un liquido omogeneo viene prelevato dal flusso a determinati intervalli di tempo e in luoghi diversi.
Per ottenere risultati affidabili, i campioni biologici di acqua naturale devono essere analizzati entro 1-2 ore dalla raccolta.
Per prelevare campioni biologici a diverse profondità, vengono utilizzati speciali dispositivi di campionamento: batometri, la cui parte principale è un recipiente cilindrico con una capacità di 1-3 litri, dotato di coperchi nella parte superiore e inferiore. Dopo l'immersione nel liquido ad una determinata profondità, i coperchi dei cilindri vengono chiusi e il recipiente del campione viene sollevato in superficie.
Campionamento di materia solida.
Un campione biologico di sostanze solide deve essere rappresentativo del materiale da testare (contenere la massima diversità possibile nella composizione del materiale da testare; ad esempio, per controllare la qualità delle compresse, è consigliabile analizzare non una singola compressa, ma mescolare una certa quantità e prelevare da questa miscela un campione corrispondente al peso medio di una compressa).
Nel prelievo dei campioni si cerca la massima omogeneizzazione possibile del materiale, ottenuta meccanicamente (macinazione, frantumazione).
I campioni biologici provenienti da biosubstrati solidi vengono convertiti in un campione biologico in fase liquida.
A tale scopo vengono utilizzate tecniche tecnologiche speciali: preparazione di soluzioni, sospensioni, colloidi, paste e altri mezzi liquidi.
Preparazione dell'estratto acquoso del terreno.
Procedura: macinare accuratamente il campione di terreno in un mortaio. Prelevare 25 g di terreno, trasferirlo in un pallone da 200 ml e aggiungere 50 ml di acqua distillata. Agitare bene il contenuto del matraccio e lasciarlo riposare per 5-10 minuti, quindi, dopo aver agitato brevemente, filtrare in un matraccio da 100 ml attraverso un filtro fitto. Se il filtrato è torbido, ripetere la filtrazione attraverso lo stesso filtro fino ad ottenere un filtrato limpido.
Determinazione degli indicatori che caratterizzano le proprietà organolettiche dell'acqua.
Le proprietà organolettiche sono standardizzate in base all'intensità della loro percezione da parte dell'uomo. Questi sono odore, sapore, colore, trasparenza, torbidità, temperatura, impurità (pellicola, organismi acquatici).
Esperimento n. 1. Determinazione della trasparenza dell'acqua.
Reagenti: 3 campioni di acqua (provenienti da diverse zone di Penza).
Dotazione: 3 cilindri graduati, piastra in plastica, pennarello.
Progresso. Versare diversi campioni d'acqua in un cilindro graduato. Posiziona un piatto di plastica bianca con una croce permanente nera sopra sul fondo di ciascun cilindro. Agitare l'acqua prima di misurare. La trasparenza, a seconda della quantità di particelle sospese, è determinata dall'altezza della colonna d'acqua nel cilindro (in cm), attraverso la quale è visibile il contorno della croce.
Determinazione dell'odore dell'acqua.
Gli odori naturali dell'acqua sono associati all'attività vitale di piante e animali o alla decomposizione dei loro resti; odori artificiali all'ingresso di acque industriali o reflue.
Ci sono odori aromatici, paludosi, putrefattivi, legnosi, terrosi, ammuffiti, di pesce, di idrogeno solforato, erbosi e vaghi.
L'intensità dell'odore viene determinata utilizzando un sistema a 5 punti:
punteggio: nessun odore o molto debole (di solito non evidente).
punteggio - debole (scoperto se presti attenzione).
punto - evidente (facilmente notabile e può causare commenti di disapprovazione sull'acqua).
punto - distinto (in grado di provocare l'astinenza dal bere).
punti - molto forti (così forti che l'acqua è completamente imbevibile).
Determinazione del colore dell'acqua.
Il colore è una proprietà naturale dell'acqua dovuta alla presenza di sostanze umiche, che le conferiscono un colore dal giallastro al marrone. Le sostanze umiche si formano durante la distruzione dei composti organici nel suolo, vengono lavate via ed entrano nei corpi idrici aperti. Pertanto, il colore è caratteristico dell'acqua dei bacini aperti e aumenta bruscamente durante il periodo di piena.
Reagenti: campioni di acqua, acqua distillata.
Attrezzatura: 4 bicchieri, un foglio di carta bianca.
Avanzamento del lavoro: La determinazione viene effettuata confrontandola con acqua distillata. Per fare questo, prendi 4 bicchieri identici e riempili con acqua - uno distillato, l'altro - quello di prova. Sullo sfondo di un foglio di carta bianca, confronta il colore osservato: incolore, marrone chiaro, giallastro.
Determinazione di indicatori che caratterizzano la composizione chimica e le proprietà dell'acqua.
Indicatori come residuo secco, durezza totale, pH, alcalinità, contenuto di cationi e anioni: Ca 2+, Na +, HCO 3 -, Cl -, Mg 2+ caratterizzano la composizione naturale dell'acqua.
Determinazione della densità dell'acqua.
Determinazione del pH (indice di idrogeno).
Il valore del pH è influenzato dal contenuto di carbonati, idrossidi, sali idrolizzabili, sostanze umiche, ecc. Questo indicatore è un indicatore dell'inquinamento dei serbatoi aperti quando vengono rilasciate acque reflue acide o alcaline. A causa dei processi chimici e biologici che si verificano nell'acqua e della perdita di anidride carbonica, il pH dell'acqua può cambiare rapidamente e questo indicatore dovrebbe essere determinato immediatamente dopo il campionamento, preferibilmente nel sito di campionamento.
Rilevazione di sostanze organiche.
Procedura: prendere 2 provette, versare in una 5 ml di acqua distillata e nell'altra la provetta. Aggiungere una goccia di soluzione di permanganato di potassio al 5% in ciascuna provetta.
Esperimento n. 7. Rilevazione di ioni cloruro.
L'elevata solubilità dei cloruri spiega la loro diffusa distribuzione in tutte le acque naturali. Nei corpi idrici correnti il contenuto di cloruri è solitamente basso (20-30 mg/l). Le acque sotterranee non contaminate in aree con terreno non salino contengono solitamente fino a 30-50 mg/l di cloro. Nell'acqua filtrata attraverso il terreno salino, 1 litro può contenere centinaia e persino migliaia di milligrammi di cloruri. L'acqua contenente cloruri in una concentrazione superiore a 350 mg/l ha un sapore salato e con una concentrazione di cloruri di 500-1000 mg/l ha un effetto negativo sulla secrezione gastrica. Il contenuto di cloruro è un indicatore della contaminazione delle fonti d'acqua sotterranee e superficiali e delle acque reflue.
Tabella 2. Determinazione della concentrazione di ioni cloruro
La concentrazione degli ioni SO 2-4 può essere determinata confrontando il risultato ottenuto con i dati contenuti nella Tabella 3:
Esperimento n. 9. Determinazione degli ioni ferro (II) e ferro (III).
Un elevato contenuto di ferro peggiora le proprietà organolettiche dell'acqua, rende l'acqua inadatta alla produzione di burro, formaggio e prodotti tessili e aumenta la proliferazione di microrganismi che assorbono il ferro nelle condutture dell'acqua, con conseguente crescita eccessiva delle tubazioni. Il contenuto di ferro nell'acqua del rubinetto non deve superare 0,3 mg/l. Il ferro si trova in grandi quantità in alcune acque reflue, ad esempio nelle acque reflue dei laboratori di decapaggio, nelle acque reflue della tintura dei tessili, ecc.
Durezza complessiva ( N totale) - Questa è una proprietà naturale dell'acqua dovuta alla presenza in essa di cationi bivalenti (principalmente calcio e magnesio).
Esistono durezze generali, carbonatiche, permanenti e rimovibili.
Rimovibile‚ o temporaneo‚ ( N volte) e carbonato ( N k) la durezza è causata dalla presenza di bicarbonati (e carbonati) di calcio e magnesio.
L'acqua con una durezza superiore a 10 mEq/L ha spesso un sapore sgradevole. Una brusca transizione durante l'utilizzo da acqua dolce a acqua dura (e talvolta viceversa) può causare sintomi dispeptici nelle persone.
Il decorso della malattia renale peggiora quando si utilizza acqua molto dura. L'acqua dura contribuisce alla comparsa di dermatiti. Con un aumento dell'apporto di calcio nel corpo dall'acqua potabile sullo sfondo della carenza di iodio, il gozzo si verifica più spesso.
Durante l'ebollizione, i bicarbonati si trasformano in carbonati scarsamente solubili e precipitano, il che porta alla formazione di incrostazioni e la durezza dell'acqua diminuisce. Ma l'ebollizione non distrugge completamente i bicarbonati e alcuni di essi rimangono in soluzione. La durezza rimovibile (temporanea) viene determinata sperimentalmente e mostra quanto è diminuita la durezza dell'acqua dopo 1 ora di ebollizione. La durezza rimovibile è sempre inferiore alla durezza carbonatica. Durezza irreversibile, permanente (H POST) e non carbonatica ( N Nk) causato da cloruro, solfato e altri sali non carbonati di calcio e magnesio. Questi tipi di rigidità sono calcolati dalla differenza:
N post.= N totale - N tempo ; Nnc = N Di. - N a
Acqua dolce - durezza totale< 3,5 мг-экв/л.
Acqua di media durezza - durezza totale da 3,5 a 7 mEq/l.
Acqua dura - durezza totale da 7 a 10 mEq/l.
Acqua molto dura - durezza totale > 10 mEq/l.
Per bere preferiscono l'acqua di media durezza, per scopi domestici e industriali - acqua dolce.
In base a ciò la durezza totale dell'acqua non sottoposta a trattamenti speciali è fissata a 7 mEq/l.
Per determinare la durezza totale viene utilizzato il metodo trilonometrico. La principale soluzione di lavoro è Trilon B - sale disodico dell'acido etilendiamminotetraacetico:

La determinazione del contenuto totale di ioni calcio e magnesio si basa sulla capacità di Trilon B di formare composti forti e complessi con questi ioni in un ambiente alcalino, sostituendo gli ioni idrogeno liberi con cationi Ca2+ E M g2+:
Ca2+ + Na 2 H2 R→ Na 2 Auto+2H+,
dove R è il radicale dell'acido etilendiamminotetraacetico.
Il cromogeno nero viene utilizzato come indicatore, dando un composto rosso vinoso con Mg 2+, quando scompare M g2+ assume un colore blu. La reazione avviene a pH-10, che si ottiene aggiungendo una soluzione tampone di ammoniaca al campione ( NH4 OH+ NH4 CI). Gli ioni calcio si legano per primi, seguiti dal magnesio.
La determinazione è disturbata da ioni rame (>0,002 mg/l), manganese (>0,05 mg/l), ferro (>1,0 mg/l), alluminio (>2,0 mg/l).
La durezza totale in mEq/l si calcola utilizzando la formula:
N generale mg/eq = n∙N ∙ 1000/V‚
n è la quantità di Trilon B spesa per la titolazione, in ml;
V- volume del campione, in ml;
N- normalità di Trilon B.
Determinazione del residuo secco
Il residuo secco è la quantità di sali disciolti in milligrammi contenuta in 1 litro di acqua.T. poiché la massa di sostanze organiche nel residuo secco non supera il 10-15%, il residuo secco dà un'idea del grado di mineralizzazione dell'acqua.
La composizione minerale dell'acqua è determinata per l'85% o più da cationi Ca2+ M g2+, Na+ e anioni NSO 3 - , CI-, SO 4 2-
Il resto della composizione minerale è rappresentato da macroelementi Na+, K + , PO 4 3 - ecc. e microelementi Fe 2+, Fe 3+, io - , C 2+ , Mo e così via.
L'acqua con un residuo secco fino a 1000 mg/l è detta fresca, oltre 1000 mg/l mineralizzata. L'acqua contenente una quantità eccessiva di sali minerali non è potabile, perché ha un sapore salato o amaro-salato e il suo consumo (a seconda della composizione dei sali) porta a varie anomalie fisiologiche sfavorevoli nell'organismo. D'altro canto un'acqua poco mineralizzata con residuo secco inferiore a 50-100 mg/l è sgradevole al gusto; un uso prolungato può portare anche ad alcune modificazioni fisiologiche sfavorevoli nell'organismo (diminuzione del contenuto di cloruro nei tessuti, ecc.). Tale acqua, di regola, contiene poco fluoro e altri oligoelementi.
Acqua poco mineralizzata - contiene< 20-100 мг/л солей.
Acqua sufficientemente mineralizzata - 100-300 mg/l di sali.
Acqua altamente mineralizzata - contiene 300-500 mg/l di sali.
Determinazione della struttura del suolo.
La struttura del suolo si riferisce alla sua capacità di scomporsi in singole particelle, chiamate unità strutturali. Possono avere forme diverse: grumi, prismi, piastre, ecc.
L'applicazione errata ed eccessiva di fertilizzanti minerali e i metodi di conservazione causano la contaminazione del suolo e dei prodotti agricoli. Forme solubili in acqua di fertilizzanti azotati fluiscono in stagni, fiumi, ruscelli e raggiungono le acque sotterranee, causando un aumento del contenuto di nitrati, che influisce negativamente sulla salute umana.
Molto spesso, i fertilizzanti vengono applicati al terreno non purificati, il che provoca la contaminazione del suolo con sostanze radioattive (ad esempio, isotopi di potassio quando si utilizzano fertilizzanti di potassio), nonché sostanze tossiche. Varie forme di superfosfati, avendo una reazione acida, contribuiscono all'acidificazione del suolo, cosa indesiderabile per le aree in cui il pH del suolo è basso. Quantità eccessive di fertilizzanti al fosforo, che scorrono in acque stagnanti e che scorrono lentamente, causano lo sviluppo di un gran numero di alghe e altra vegetazione, che peggiora il regime di ossigeno dei corpi idrici e contribuisce alla loro crescita eccessiva.
I nitrati sono parte integrante di tutti gli ecosistemi terrestri e acquatici, poiché il processo di nitrificazione, che porta alla formazione di composti azotati inorganici ossidati, è di natura globale. Allo stesso tempo, a causa dell’uso su larga scala di fertilizzanti azotati, aumenta la fornitura di composti azotati inorganici alle piante. Il consumo eccessivo di azoto fertilizzante non solo porta all'accumulo di nitrati nelle piante, ma contribuisce anche all'inquinamento dei bacini idrici e delle falde acquifere con residui di fertilizzanti, con conseguente espansione dell'area dei prodotti agricoli contaminati da nitrati. Tuttavia, l'accumulo di nitrati nelle piante può verificarsi non solo per un eccesso di fertilizzanti azotati, ma anche per una mancanza di altri tipi di fertilizzanti (fosforo, potassio, ecc.) Sostituendo parzialmente gli ioni mancanti con ioni nitrato durante la nutrizione minerale, così come quando l'attività enzimatica di un certo numero di piante diminuisce la nitrato reduttasi, che converte i nitrati in proteine.
In considerazione di ciò, esiste una chiara differenza tra specie e varietà vegetali nell'accumulo e nel contenuto di nitrati. Pertanto, le famiglie della zucca, del cavolo e del sedano sono accumulatori di nitrati. La quantità maggiore si trova nelle verdure in foglia: prezzemolo, aneto, sedano (Appendice 3), la quantità minore in pomodori, melanzane, aglio, piselli, uva, mele, ecc. E ci sono forti differenze a questo riguardo tra le singole varietà. Pertanto, le varietà di carote "Chantenay" e "Pioneer" si distinguono per il loro basso contenuto di nitrati, mentre "Nantes" e "Losinoostrovskaya" si distinguono per il loro alto contenuto. Le varietà di cavolo invernale accumulano pochi nitrati rispetto alle varietà estive.
La maggior quantità di nitrati è contenuta negli organi succhianti e conduttori delle piante: radici, steli, piccioli e nervature delle foglie. Nelle zucchine, nei cetrioli, ecc. Nei frutti i nitrati diminuiscono dal gambo all'apice (Appendice 4).
Come risultato del consumo di alimenti contenenti elevate quantità di nitrati, una persona può sviluppare metaemoglobinia. In questa malattia, lo ione NO 3 interagisce con l'emoglobina nel sangue, ossidando il ferro contenuto nell'emoglobina in trivalente e la metaemoglobina risultante non è in grado di trasportare ossigeno e la persona sperimenta carenza di ossigeno e soffoca durante lo sforzo fisico. Nel tratto gastrointestinale, quantità eccessive di nitrati sotto l'influenza della microflora intestinale vengono convertite in nitriti tossici e quindi possono essere convertiti in nitrosammine, forti veleni cancerogeni che causano tumori. A questo proposito, quando si mangiano piante che immagazzinano nitrati, è importante diluire i nitrati e consumarli a piccole dosi. Il contenuto di nitrati può essere ridotto mediante ammollo, bollitura dei prodotti (se non si utilizza il decotto) ed eliminando le parti che contengono una grande quantità di nitrati.
Le norme consentite dei nitrati (secondo l'OMS) sono 5 mg (basati sullo ione nitrato) al giorno per 1 kg di peso di un adulto, vale a dire con un peso di 50-60 kg è 220-300 mg e con un peso di 60-70 kg è 300-350 mg.
Si può anche osservare un effetto di sinergia (intensificazione) e di antagonismo, poiché le fabbriche inquinano la biosfera in modo complesso.
Risolvere i problemi ambientali:
1. Modificare il diagramma di flusso della produzione (cessazione o riduzione della produzione di rifiuti, massimo isolamento dei prodotti intermedi e loro utilizzo nei processi ciclici).
2. Selezionare il numero massimo di elementi provenienti dai rifiuti per altre industrie.
3. Neutralizzazione delle emissioni industriali.
Metodi per risolvere i problemi ambientali:
Rifiuti gassosi (omogenei: ossidi di zolfo e di azoto, sostanze organiche sotto forma di gas - ed eterogenei: nebbie, polveri, aerosol).
Fonti di inquinamento atmosferico.
L'atmosfera è divisa nella troposfera (7-8 km dalla superficie terrestre). Sopra c'è la stratosfera: da 8-17 a 50-55 km. La temperatura dell'aria qui è più alta, a causa della presenza di ozono qui.
Nella troposfera esistono diverse forme di vita. Pertanto, la troposfera viene definita biosfera. L'inquinamento che entra nella troposfera si sposta molto lentamente verso gli strati più alti. Le principali fonti di inquinamento di origine antropica sono:
centrali termoelettriche che funzionano a carbone ed emettono nell'atmosfera fuliggine, ceneri e anidride solforosa;
impianti metallurgici le cui emissioni contengono fuliggine, polvere, ossido di ferro, anidride solforosa, fluoruri;
cementifici che emettono enormi quantità di polvere;
grandi imprese che producono prodotti chimici inorganici: anidride solforosa, acido fluoridrico, ossidi di azoto, cloro, ozono;
impianti per la produzione di cellulosa, raffinazione del petrolio - rifiuti gassosi (odoranti);
imprese petrolchimiche - servono come fonte di idrocarburi e composti organici di altre classi, come ammine, mercaptani, solfuri, aldeidi, chetoni, alcoli, acidi, ecc.
gas di scarico dei veicoli, nonché processi di evaporazione del carburante: monossido di carbonio, idrocarburi gassosi e componenti invariati del carburante, idrocarburi policiclici aromatici altobollenti e fuliggine, prodotti di ossidazione incompleta del carburante (ad esempio aldeidi), idrocarburi alogenati, metalli pesanti e ossidi di azoto, la cui formazione contribuisce ai processi che si verificano durante la combustione del carburante;
incendi boschivi, che rilasciano nell’aria quantità significative di idrocarburi e ossidi di carbonio.
A seconda della fonte e del meccanismo di formazione, si distinguono gli inquinanti atmosferici primari e secondari.
Gli inquinanti primari sono sostanze immesse nell'aria direttamente da fonti fisse o mobili, mentre gli inquinanti secondari si formano a seguito delle interazioni tra gli inquinanti primari presenti nell’atmosfera e con sostanze presenti nell'aria (ossigeno, ozono, ammoniaca, acqua) sotto l'influenza delle radiazioni ultraviolette.
La maggior parte del particolato e degli aerosol presenti nell’aria sono inquinanti secondari, spesso molto più tossici di quelli primari. I gas di scarico sono costituiti da varie sostanze e, sotto l'influenza della radiazione solare, possono entrare in reazioni fotochimiche nell'atmosfera, portando alla formazione di smog tossico.
Criteri inquinanti(per i quali sono introdotti criteri MPC speciali) - monossido di carbonio, anidride solforosa, ossidi di azoto, idrocarburi, particolato e ossidanti fotochimici
Uno degli inquinanti atmosferici più dannosi è l'anidride solforosa, coinvolta nella formazione dello smog fotochimico.
Sebbene la sua concentrazione media nell'aria delle grandi città non sia così elevata rispetto ad altri componenti, questo ossido è considerato il più pericoloso per la salute dei residenti urbani, causando malattie respiratorie e indebolimento generale del corpo. Se combinato con altri inquinanti, porta ad una riduzione dell’aspettativa di vita media.
Ma il danno causato dal biossido di zolfo non può essere attribuito direttamente a questo composto. Il principale colpevole è l'anidride solforosa SO 3, che si forma a seguito della reazione: 2SO 2 + O 2 = SO 3
L'effetto della SO 2 è più forte al buio che alla luce. Quale pensi sia la ragione di ciò?
Conoscete tutti l'ossido di CO. Una persona che inala per diverse ore aria con un contenuto di CO pari solo allo 0,1%, ne assorbe così tanta che la maggior parte dell'emoglobina (60%) si lega all'HbCO. Questo processo è accompagnato da mal di testa e diminuzione dell'attività mentale. In caso di avvelenamento da CO viene utilizzata una miscela di CO 2 e O 2 (la frazione volumetrica del primo è del 3 - 5%), chiamata carbogeno. L'aumento delle concentrazioni di questi gas nella miscela consente di spostare il monossido di carbonio dai tessuti nel sangue.
Elevate concentrazioni locali di CO2, anche a breve termine, causate nelle grandi città principalmente dal trasporto stradale, sono le cosiddette trappole ambientali. Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore, difficile da rilevare dai nostri sensi. Tuttavia, i primi sintomi di avvelenamento (comparsa di mal di testa) si verificano in una persona che si trova in un ambiente con una concentrazione di CO di 200 - 220 mg/m 3 in sole 2 ore.
Pertanto, una persona può trovarsi vittima di una trappola ambientale. I fumatori sono esposti a effetti simili della CO.
Tracce di elementi chimici nell'atmosfera includono inquinanti altamente tossici come arsenico, berillio, cadmio, piombo, magnesio e cromo (solitamente presenti nell'aria come sali inorganici adsorbiti sul particolato). Circa 60 metalli sono presenti nei prodotti della combustione del carbone e nei gas di scarico delle centrali termoelettriche. Ogni anno un'enorme quantità di piombo entra nel bacino aereo. Il mercurio metallico e il piombo, così come i loro composti organometallici, sono molto tossici.
Accumulandosi nell'atmosfera, gli inquinanti interagiscono tra loro, si idrolizzano e si ossidano sotto l'influenza di umidità e ossigeno, e cambiano anche la loro composizione sotto l'influenza delle radiazioni.Miscele di vari inquinanti, la concentrazione dei singoli componenti in cui è inferiore al massimo consentito concentrazione, rappresentano anche un grande pericolo. Insieme, tali miscele possono rappresentare una minaccia significativa per tutti gli esseri viventi a causa dell’effetto cumulativo. La durata della permanenza nell'aria dei composti a bassa attività - gas permanenti (freon e anidride carbonica) è lunga. Tra i pesticidi spruzzati dagli aerei, i pesticidi organofosforici sono particolarmente tossici; quando fotolizzati nell'atmosfera, si formano prodotti che sono ancora più tossici dei composti originali.
Le cosiddette particelle abrasive, tra cui silice e amianto, causano gravi malattie quando entrano nel corpo attraverso l'inalazione.
Lo smog ambientale è un inquinamento atmosferico complesso causato dal ristagno delle masse d'aria nelle grandi città con industrie sviluppate e un gran numero di trasporti. L'origine di questa parola inglese è chiara dal seguente diagramma: SMOKE + FOG = fumo e nebbia.
Lo smog di tipo londinese è una combinazione di inquinanti gassosi (principalmente anidride solforosa), particelle di polvere e nebbia. È particolarmente caratteristico dell'atmosfera inquinata sopra Londra, dove la principale fonte di inquinamento atmosferico è costituita dai prodotti della combustione di carbone e olio combustibile. Nel dicembre del 1952, più di 4.000 persone morirono a Londra a causa di uno smog durato circa due settimane. Effetti simili dello smog furono notati a Londra nel 1873, 1882, 1891, 1948. Questo tipo di smog si osserva solo in autunno e in inverno (da ottobre a febbraio), quando il benessere delle persone peggiora drasticamente, il numero di raffreddori aumenta, ecc.
Smog fotochimico (tipo Los Angeles) - si verifica a seguito di reazioni fotochimiche in presenza nell'atmosfera di un'alta concentrazione di ossidi di azoto, idrocarburi, ozono, intensa radiazione solare e calma o scambio molto debole di masse d'aria nello strato terrestre. A differenza dello smog di tipo londinese, è stato scoperto negli anni '30 del XX secolo a Los Angeles in condizioni di tempo soleggiato con concentrazioni significative di gas di scarico dei veicoli nell'atmosfera, e ora è un evento comune nelle grandi città di tutto il mondo.
I motori a combustione interna delle automobili sono la principale fonte di questo complesso inquinamento. In Russia, i veicoli a motore emettono ogni giorno nell’atmosfera 16,6 milioni di tonnellate di sostanze inquinanti. Una situazione ambientale particolarmente difficile si è sviluppata a Mosca, San Pietroburgo, Tomsk, Krasnodar: il 30% delle malattie dei residenti delle città sono direttamente correlate all'inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico. I motori delle automobili emettono nell’aria delle città più del 95% del monossido di carbonio, circa il 65% degli idrocarburi e il 30% degli ossidi di azoto. La natura delle impurità nocive rilasciate dipende dal tipo di motore, che si divide in benzina e diesel. Le principali impurità nocive contenute nei gas di scarico sono: ossidi di azoto, ossidi di carbonio, vari idrocarburi, tra cui il benzopirene cancerogeno, aldeidi, ossidi di zolfo. I motori a benzina, inoltre, emettono prodotti contenenti piombo e cloro, mentre i motori diesel emettono quantità significative di fuliggine e particelle di fuliggine.
1. Metodo di dispersione del tubo.
2. Filtri.
3. Purificazione catalitica del gas:
S-> S0 2 -> S0 3 -> H 2 SO 4
CO -> CH 4
4. Metodi di pulizia chimica:
a) assorbimento - assorbimento di gas liquidi a bassa temperatura e alta pressione (acqua, assorbenti organici, permanganato di potassio, soluzione di potassio, mercaptoetanolo); b) adsorbimento (carbone attivo, gel di silice, cialiti).
Trattamento acque reflue da impianti chimici.
L'idrosfera funge da accumulatore naturale per la maggior parte degli inquinanti che entrano nell'atmosfera o nella litosfera. Ciò è dovuto all'elevato potere dissolvente dell'acqua, al ciclo dell'acqua in natura e anche al fatto che i serbatoi sono la destinazione finale del percorso di varie acque reflue.
A seguito dello scarico di acque reflue non trattate da parte di imprese, strutture comunali e agricole, le proprietà naturali dell'acqua cambiano a causa dell'aumento delle impurità nocive di natura inorganica e organica. A impurità inorganiche comprendono metalli pesanti, acidi, alcali, sali minerali e fertilizzanti con elementi biogenici (azoto, fosforo, carbonio, silicio). Tra impurità organiche emettono sostanze facilmente ossidabili (sostanze organiche provenienti dalle acque reflue di imprese alimentari e altre sostanze biologicamente morbide) e difficili da ossidare e quindi difficili da rimuovere dall'acqua (petrolio e suoi prodotti, residui organici, sostanze biologicamente attive, pesticidi, ecc.).
I cambiamenti nei parametri fisici dell'acqua sono possibili a causa di tre tipi di impurità che vi entrano: meccanico ( particelle solide insolubili: sabbia, argilla, scorie, inclusioni di minerali); termico ( scarico di acqua riscaldata da centrali termoelettriche, centrali nucleari e imprese industriali); radioattivo ( prodotti di imprese per l'estrazione di materie prime radioattive, fabbriche di arricchimento, centrali nucleari, ecc.) - L'influenza delle impurità meccaniche e radioattive sulla qualità dell'acqua è chiara e le impurità termiche possono portare a reazioni chimiche esotermiche dei componenti disciolti o sospesi in acqua, e la sintesi di sostanze ancora più pericolose.
I cambiamenti nelle proprietà dell'acqua si verificano a seguito di un aumento del numero di microrganismi, piante e animali provenienti da fonti esterne: batteri, alghe, funghi, vermi, ecc. (scarico di acque reflue domestiche e rifiuti di alcune imprese). La loro attività vitale può essere fortemente attivata dall'inquinamento fisico (soprattutto da quello termico).
L'inquinamento termico provoca un'intensificazione dei processi vitali degli organismi acquatici, che sconvolge l'equilibrio dell'ecosistema.
I sali minerali sono pericolosi per gli organismi unicellulari che scambiano osmoticamente con l'ambiente esterno.
Le particelle sospese riducono la trasparenza dell'acqua, riducono la fotosintesi delle piante acquatiche e l'aerazione dell'ambiente acquatico, contribuiscono all'insabbiamento del fondo in aree con bassa velocità della corrente e hanno un effetto negativo sulla vita degli organismi acquatici che filtrano. Vari inquinanti possono essere adsorbiti sulle particelle sospese; depositandosi sul fondo, possono diventare una fonte di inquinamento secondario delle acque.
L’inquinamento dell’acqua causato dai metalli pesanti non solo provoca danni ambientali, ma provoca anche notevoli danni economici. Le fonti di inquinamento dell'acqua da metalli pesanti sono officine galvaniche, imprese minerarie, metallurgia ferrosa e non ferrosa.
Quando l'acqua è contaminata da prodotti petroliferi, sulla superficie si forma una pellicola che impedisce lo scambio gassoso dell'acqua con l'atmosfera. Altri inquinanti si accumulano in esso, così come nell'emulsione di frazioni pesanti; inoltre, i prodotti petroliferi stessi si accumulano negli organismi acquatici. Le principali fonti di inquinamento delle acque dovuto ai prodotti petroliferi sono il trasporto idrico e il deflusso superficiale dalle aree urbane. L'inquinamento dell'ambiente acquatico con sostanze nutritive porta all'eutrofizzazione dei corpi idrici.
Le sostanze organiche - coloranti, fenoli, tensioattivi, diossine, pesticidi, ecc. creano il pericolo di una situazione tossicologica nel serbatoio. Le diossine sono particolarmente tossiche e persistenti nell’ambiente. Si tratta di due gruppi di composti organici contenenti cloro correlati alle dibenzodiossine e ai dibenzofurani. Uno di questi, 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzodiossina (2, 3, 7, 8 - TCDD), è il composto più tossico conosciuto dalla scienza. L'effetto tossico di varie diossine è simile, ma differisce in intensità. Le diossine si accumulano nell'ambiente e la loro concentrazione è in aumento.
Se analizziamo condizionatamente la massa d'acqua con un piano verticale, possiamo identificare aree di diversa reattività: il film superficiale, la massa d'acqua principale e il sedimento di fondo.
I sedimenti del fondo e il film superficiale sono aree in cui si concentrano gli inquinanti. I composti insolubili in acqua si depositano sul fondo e il sedimento è un buon assorbente per molte sostanze.
Contaminanti non degradabili possono entrare nell'acqua. Ma sono in grado di reagire con altri composti chimici, formando prodotti finali stabili che si accumulano negli oggetti biologici (plancton, pesci, ecc.) ed entrano nel corpo umano attraverso la catena alimentare.
Quando si sceglie un luogo in cui prelevare un campione d'acqua, vengono prese in considerazione tutte le circostanze che possono influenzare la composizione del campione prelevato.
Esistono due campioni principali: singolo e medio. Si ottiene un singolo campione raccogliendo il volume d'acqua richiesto alla volta. Il campione medio si ottiene miscelando volumi uguali di campioni prelevati ad intervalli regolari. Quanto più piccoli sono gli intervalli tra i campioni dei singoli componenti, tanto più accurato è il campione medio.
L'acqua per analisi viene prelevata in un contenitore pulito, dopo averlo prima risciacquato 2-3 volte con l'acqua da analizzare. Dai serbatoi aperti, i campioni vengono prelevati nel fairway del fiume da una profondità di 50 cm, una bottiglia con un carico viene abbassata a una profondità, dopodiché il tappo viene aperto utilizzando un supporto ad esso collegato. A questo scopo è meglio utilizzare dispositivi speciali: i batometri, che consentono l'uso di piatti di diverse forme e capacità. Il bagnometro è costituito da una pinza che stringe saldamente il contenitore e da un dispositivo per aprire il tappo alla profondità desiderata.
Quando un campione giace per lungo tempo, possono verificarsi cambiamenti significativi nella composizione dell'acqua; pertanto, se è impossibile iniziare l'analisi dell'acqua immediatamente dopo il campionamento o 12 ore dopo il campionamento, viene conservata per stabilizzare la composizione chimica. Non esiste un conservante universale.
Esistono 3 gruppi di indicatori che determinano la qualità dell'acqua (lo analizzeremo in dettaglio e sperimentalmente nel workshop):
A - indicatori che caratterizzano le proprietà organolettiche;
B - indicatori che caratterizzano la composizione chimica dell'acqua;
B - indicatori che caratterizzano la sicurezza epidemica dell'acqua.
Affinché una persona possa utilizzare l'acqua per bere, viene prima purificata.
Fasi di purificazione dell'acqua:
Difesa
Filtrazione
Disinfezione
I gas utilizzati per la disinfezione sono cloro e ozono.
Viene utilizzata anche la depurazione chimica e biologica dell'acqua. Le fosse settiche sono colonizzate dalla clorella. Questa pianta unicellulare, moltiplicandosi rapidamente, assorbe CO 2 e alcune sostanze nocive dall'acqua. Di conseguenza, l'acqua viene purificata e la clorella viene utilizzata come mangime per il bestiame.
Preparazione dell'acqua potabile.
Fiume, lago o bacino idrico - separazione di grandi impurità - clorazione preliminare - precipitazione di fiocchi - sedimentazione delle impurità mediante sedimentazione - filtraggio attraverso sabbia - clorazione - trattamento aggiuntivo - nel sistema di approvvigionamento idrico cittadino.
Per sopravvivere, una persona ha bisogno di circa 1,5 litri di acqua al giorno. Ma ogni cittadino spende ogni anno fino a 600 litri d'acqua per i bisogni domestici. L’industria consuma molta acqua.
Ad esempio, per produrre 1 kg di carta sono necessari 20.000 litri di acqua dolce. Il principale inquinante dell’acqua è l’agricoltura. Per aumentare la resa, sul campo vengono applicati vari fertilizzanti. Ciò può portare ad un aumento delle concentrazioni di vari composti negli alimenti e nell’acqua potabile, il che è pericoloso per la salute. Tra gli altri inquinanti, i più evidenti sono il petrolio e i prodotti petroliferi che entrano nelle acque naturali durante le operazioni delle petroliere.
Secondo l’OMS, l’80% di tutte le malattie infettive nel mondo sono associate alla qualità insoddisfacente dell’acqua potabile e alla violazione degli standard sanitari e igienici di approvvigionamento idrico. Nel mondo, 2 miliardi di persone soffrono di malattie croniche dovute all’uso di acqua contaminata (Appendice 2, Tabella 1).
Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, fino all’80% dei composti chimici prima o poi finisce nelle fonti d’acqua. Ogni anno nel mondo vengono scaricati più di 420 km 3 di acque reflue, il che rende inutilizzabili circa 7mila km 3 di acqua. La composizione chimica dell’acqua rappresenta un grave pericolo per la salute pubblica. In natura non si trova mai sotto forma di composto chimicamente puro. Trasporta costantemente un gran numero di elementi e composti diversi, il cui rapporto è determinato dalle condizioni di formazione dell'acqua e dalla composizione delle rocce di idrogeno.
Metodi di depurazione dell'acqua nella vita di tutti i giorni.
Il metodo più semplice e accessibile a tutti è sostenendo acqua di rubinetto. In questo caso il cloro libero residuo evapora. Sotto l'influenza delle forze gravitazionali, avviene la precipitazione di sospensioni relativamente grandi e particelle colloidali in sospensione. Il sedimento potrebbe diventare giallo. Cosa pensi che indichi questo? (precipitazione di Fe (OH) 3).
Bollente.
Lo scopo principale di questo metodo è la disinfezione dell'acqua. A causa dell’esposizione termica, virus e batteri muoiono. Inoltre, l'acqua viene degasata, rimuovendo tutti i gas disciolti in essa, compresi quelli utili. Quale? (O2, CO2). Questi gas migliorano le proprietà organolettiche dell'acqua.
Spiegare perché l'acqua bollita è insapore e di scarso beneficio per la flora intestinale?
Metodo congelamento acqua.
Usato molto meno frequentemente. Basato sulla differenza tra la temperatura di congelamento dell'acqua pura e quella della salamoia (una soluzione di sali minerali). Innanzitutto, l'acqua pura si congela e i sali si concentrano nel volume rimanente. Si ritiene che tale acqua abbia proprietà curative dovute alla speciale struttura dei cluster d'acqua - gruppi di molecole d'acqua orientate reciprocamente.
Pulizia degli scarichi
La tecnologia di pulizia comprende diverse fasi.
Tabella 2. Trattamento delle acque reflue.
| Prodotto da neutralizzare |
MPC (mg/l) |
Metodo di pulizia |
Grado di purificazione,% |
| Composti organici aromatici |
Adsorbimento su filtri a carbone |
||
| Ossidazione biochimica |
|||
| Impurità grossolane |
Difesa |
||
| Idrossido di ferro (III). |
Filtrazione attraverso uno strato di materiali ausiliari |
||
| Sali di ferro(II). |
Clorazione |
||
| Filtrazione a sabbia. Cattura in trappole per idrocarburi. Ossidazione biochimica. |
|||
| Idrogeno solforato |
Aria che soffia dall'acqua |
||
| Estrazione. Ozonizzazione. Ossidazione biochimica. |
Innanzitutto, le acque reflue vengono purificate dalle impurità insolubili. Gli oggetti di grandi dimensioni vengono rimossi filtrando (ricordate cos'è la filtrazione) l'acqua attraverso griglie e reti.
L'acqua entra poi in una vasca di decantazione, dove piccole particelle si depositano gradualmente.
Per rimuovere le sostanze organiche disciolte (NH 3 e cationi ammonio), queste vengono ossidate con l'aiuto di batteri. Il processo procede più intensamente in condizioni di aerazione. Quali sono le condizioni aerobiche? Aerazione? (saturazione dell'acqua con ossigeno dell'aria)
I nitrati vengono convertiti in gas azoto utilizzando microrganismi speciali. I composti del fosforo vengono precipitati sotto forma di ortofosfato di calcio scarsamente solubile.
Quindi eseguire:
assestamenti ripetuti;
assorbimento delle impurità rimanenti mediante carbone attivo;
disinfezione.
Solo dopo l'acqua potrà essere restituita ai bacini naturali.
Lo scarico delle acque reflue nell’ambiente non si ferma. Quasi 1/3 finisce nei corpi idrici naturali senza alcun trattamento. Ciò non è solo pericoloso per la vita degli organismi, ma porta anche a un deterioramento della qualità dell'acqua potabile. La prevenzione dell’inquinamento idrico rimane uno dei compiti più importanti per proteggere l’ambiente e preservare la salute umana.
1. Filtrazione.
2. Sedimentazione e filtrazione.
3. Flottazione.
4. Distillazione.
5. Scambio ionico.
6. Biochimico (per il petrolio).
7. Microrganismi per acque ad alto contenuto di azoto, fosforo e tensioattivi.
8. Creazione di cicli di circolazione dell'acqua.
Malattie derivanti dagli effetti tossici di elementi e sostanze chimiche presenti nell'acqua potabile
Tabella 1.
| Fattore emozionante |
|
| Arsenico, boro, fluoro, rame, cianuro, tricloroetene. |
|
| Malattie dell'apparato digerente a) danno b) mal di stomaco c) disturbi funzionali |
Arsenico, berillio, boro, cloroformio, dinitrofenoli. Mercurio, pesticidi |
| Malattie cardiache: a) danno al muscolo cardiaco b) disfunzione cardiaca c) cambiamenti cardiovascolari d) trachicardia d) tachicordia |
Boro, zinco, fluoro, rame, piombo, mercurio Benzene, cloroformio, cianuro Tricloroetilene Aloformi, tripalometani, aldrin (insetticida) e suoi derivati Dinitrofenoli |
| Calvizie |
Boro, mercurio |
| Cirrosi epatica |
Cloro, magnesio, benzene, cloroformio, metalli pesanti. |
| Tumori renali maligni |
Arsenico, aloformi |
| Tumori maligni del polmone |
Arsenico, benzopirene |
| Tumori cutanei maligni |
Arsenico, benzopirene, prodotti di distillazione del petrolio (oli) |
| Arsenico, piombo, mercurio |
|
| Asma bronchiale |
|
| Leucemia |
Fenoli clorurati, benzene. |
Rifiuti solidi (materie prime non reagite, filtri e catalizzatori).
1. Estrazione di componenti utili mediante estrazione (metalli nobili da catalizzatori esauriti).
2. Metodi termici.
3. Riempimenti sanitari.
4. Sepoltura nell'oceano.
Nei secoli XIX e XX, l’interazione umana con l’ambiente, o le attività antropiche, avviene sotto forma di produzione materiale su larga scala.
L'inquinamento ambientale è un cambiamento indesiderato delle sue proprietà, che porta o può portare a effetti dannosi sugli esseri umani o sui sistemi naturali. Il tipo più noto di inquinamento è quello chimico (il rilascio di sostanze e composti nocivi nell'ambiente), ma tipi di inquinamento come radioattivo, termico (il rilascio incontrollato di calore nell'ambiente può portare a cambiamenti globali nel clima naturale) , e il rumore non rappresenta una minaccia meno potenziale. L'inquinamento ambientale è principalmente associato all'attività economica umana (inquinamento ambientale antropico), ma l'inquinamento è possibile a causa di fenomeni naturali, come eruzioni vulcaniche, terremoti, cadute di meteoriti, ecc. Tutti i gusci della Terra sono soggetti a inquinamento.
In tutte le fasi del suo sviluppo, l'uomo era strettamente connesso con il mondo che lo circondava. Ma dall'emergere di una società altamente industrializzata, l'intervento pericoloso dell'uomo nella natura è aumentato notevolmente, la portata di questo intervento si è ampliata, è diventato più diversificato e ora minaccia di diventare un pericolo globale per l'umanità. Il consumo di materie prime non rinnovabili è in aumento, sempre più terreni coltivabili stanno abbandonando l'economia, quindi su di essi vengono costruite città e fabbriche. L'uomo deve interferire sempre di più nell'economia della biosfera, quella parte del nostro pianeta in cui esiste la vita. La biosfera terrestre è attualmente soggetta a un crescente impatto antropico. Allo stesso tempo, si possono identificare alcuni dei processi più significativi, nessuno dei quali non migliora la situazione ambientale del pianeta.
Il più diffuso e significativo è l'inquinamento chimico dell'ambiente con sostanze di natura chimica insolite per esso. Tra questi ci sono inquinanti gassosi e aerosol di origine industriale e domestica. Progredisce anche l’accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera. L'ulteriore sviluppo di questo processo rafforzerà la tendenza indesiderata all'aumento della temperatura media annuale del pianeta. Gli ambientalisti sono preoccupati anche per il continuo inquinamento degli oceani da parte di petrolio e prodotti petroliferi, che ha già raggiunto 1/5 della sua superficie totale. Un inquinamento petrolifero di queste dimensioni può causare interruzioni significative nello scambio di gas e acqua tra l’idrosfera e l’atmosfera. Non vi è dubbio sull’importanza della contaminazione chimica del suolo con pesticidi e sulla sua maggiore acidità, che portano al collasso dell’ecosistema. In generale, tutti i fattori considerati riconducibili all'effetto inquinante hanno un impatto notevole sui processi che avvengono nella biosfera.
Le principali fonti di inquinamento pirogenico sul pianeta sono le centrali termoelettriche, le imprese metallurgiche e chimiche e gli impianti di caldaie, che consumano oltre il 70% del combustibile solido e liquido prodotto annualmente. Le principali impurità nocive di origine pirogenica sono le seguenti:
Monossido di carbonio. È prodotto dalla combustione incompleta di sostanze carboniose. Entra nell'aria a seguito della combustione di rifiuti solidi, gas di scarico ed emissioni di imprese industriali. Ogni anno entrano nell'atmosfera almeno 1.250 milioni di tonnellate di questo gas.Il monossido di carbonio è un composto che reagisce attivamente con i componenti dell'atmosfera e contribuisce all'aumento della temperatura sul pianeta e alla creazione dell'effetto serra.
Diossido di zolfo. Rilasciato durante la combustione di combustibili contenenti zolfo o la lavorazione di minerali di zolfo (fino a 170 milioni di tonnellate all'anno). Alcuni composti dello zolfo vengono rilasciati durante la combustione dei residui organici nelle discariche minerarie. Solo negli Stati Uniti, la quantità totale di anidride solforosa rilasciata nell’atmosfera ammonta al 65% delle emissioni globali.
Anidride solforica. Formato dall'ossidazione del biossido di zolfo. Il prodotto finale della reazione è un aerosol o una soluzione di acido solforico nell'acqua piovana, che acidifica il terreno e aggrava le malattie delle vie respiratorie umane. La ricaduta di aerosol di acido solforico derivante dalle fiamme di fumo degli impianti chimici si osserva in condizioni di nuvole basse e elevata umidità dell'aria. Le lame fogliari delle piante che crescono a una distanza inferiore a 11 km da tali imprese sono solitamente densamente punteggiate da piccole macchie necrotiche formate nei luoghi in cui si depositano gocce di acido solforico. Le imprese pirometallurgiche della metallurgia non ferrosa e ferrosa, nonché le centrali termiche, emettono ogni anno decine di milioni di tonnellate di anidride solforica nell'atmosfera.
Solfuro di idrogeno e disolfuro di carbonio. Entrano nell'atmosfera separatamente o insieme ad altri composti dello zolfo. Le principali fonti di emissioni sono le imprese che producono fibre artificiali, zucchero, cokerie, raffinerie di petrolio e giacimenti petroliferi. Nell'atmosfera, quando interagiscono con altri inquinanti, subiscono una lenta ossidazione ad anidride solforica.
Ossido d'azoto. Le principali fonti di emissioni sono le aziende che producono fertilizzanti azotati, acido nitrico e nitrati, coloranti all'anilina, composti nitro, seta viscosa e celluloide. La quantità di ossidi di azoto che entrano nell'atmosfera è di 20 milioni di tonnellate all'anno.
Composti del fluoro. Fonti di inquinamento sono le imprese che producono alluminio, smalti, vetro, ceramica, acciaio e fertilizzanti fosfatici. Le sostanze contenenti fluoro entrano nell'atmosfera sotto forma di composti gassosi: acido fluoridrico o polvere di fluoruro di sodio e calcio. I composti sono caratterizzati da un effetto tossico. I derivati del fluoro sono potenti insetticidi.
Composti del cloro. Vengono nell'atmosfera da impianti chimici che producono acido cloridrico, pesticidi contenenti cloro, coloranti organici, alcol idrolitico, candeggina e soda. Nell'atmosfera si trovano come impurità di molecole di cloro e vapori di acido cloridrico. La tossicità del cloro è determinata dal tipo di composti e dalla loro concentrazione. Nell'industria metallurgica, durante la fusione della ghisa e la trasformazione in acciaio, vengono rilasciati nell'atmosfera vari metalli pesanti e gas tossici. Pertanto, per 1 tonnellata di ghisa, vengono rilasciati oltre a 12,7 kg di anidride solforosa e 14,5 kg di particelle di polvere, che determinano la quantità di composti di arsenico, fosforo, antimonio, piombo, vapori di mercurio e metalli rari, sostanze resinose e acido cianidrico.
Inquinamento atmosferico da aerosol. Gli aerosol sono particelle solide o liquide sospese nell'aria. In alcuni casi, i componenti solidi degli aerosol sono particolarmente pericolosi per gli organismi e causano malattie specifiche nelle persone. Nell'atmosfera, l'inquinamento da aerosol è percepito come fumo, nebbia, foschia o foschia. Una parte significativa degli aerosol si forma nell'atmosfera attraverso l'interazione di particelle solide e liquide tra loro o con il vapore acqueo. La dimensione media delle particelle di aerosol è 1-5 micron. Ogni anno circa 1 metro cubo entra nell'atmosfera terrestre. km di particelle di polvere di origine artificiale. Un gran numero di particelle di polvere si formano anche durante le attività produttive umane. Le informazioni su alcune fonti di polvere tecnogenica sono fornite nella Tabella 1.
Tabella 1 – Fonti di polveri artificiali
|
Processo di fabbricazione |
Emissioni di polveri, t/anno |
|
Carbone che brucia |
93,600 |
|
Fusione del ferro |
20,210 |
|
Fusione del rame (senza purificazione) |
6,230 |
|
Fusione dello zinco |
0,180 |
|
Fusione dello stagno (senza purificazione) |
0,004 |
|
Fusione del piombo |
0,130 |
|
Produzione di cemento |
53,370 |
Le principali fonti di inquinamento atmosferico da aerosol artificiale sono le centrali termoelettriche che consumano carbone ad alto contenuto di ceneri, impianti di lavaggio, fabbriche metallurgiche, di cemento, magnesite e fuliggine. Le particelle di aerosol provenienti da queste fonti hanno un'ampia varietà di composizioni chimiche. Molto spesso, nella loro composizione si trovano composti di silicio, calcio e carbonio, meno spesso - ossidi metallici: ferro, magnesio, manganese, zinco, rame, nichel, piombo, antimonio, bismuto, selenio, arsenico, berillio, cadmio, cromo, cobalto, molibdeno e amianto. Una varietà ancora maggiore è caratteristica delle polveri organiche, compresi gli idrocarburi alifatici e aromatici e i sali acidi. Si forma durante la combustione di prodotti petroliferi residui, durante il processo di pirolisi nelle raffinerie di petrolio, nel settore petrolchimico e in altre imprese simili. Fonti costanti di inquinamento da aerosol sono le discariche industriali: argini artificiali di materiale ridepositato, principalmente rocce di copertura formate durante l'estrazione mineraria o da rifiuti di imprese dell'industria di trasformazione, centrali termoelettriche. Le massicce operazioni di sabbiatura costituiscono una fonte di polvere e gas tossici. Pertanto, a seguito di un'esplosione di massa media (250-300 tonnellate di esplosivo), vengono rilasciati nell'atmosfera circa 2mila metri cubi. m di monossido di carbonio convenzionale e più di 150 tonnellate di polvere. Anche la produzione di cemento e altri materiali da costruzione è una fonte di inquinamento da polveri. I principali processi tecnologici di queste industrie sono la macinazione e il trattamento chimico di cariche, semilavorati e prodotti risultanti in flussi di gas caldi, che sono sempre accompagnati da emissioni di polveri e altre sostanze nocive nell'atmosfera. Gli inquinanti atmosferici includono idrocarburi - saturi e insaturi, contenenti da 1 a 13 atomi di carbonio. Subiscono varie trasformazioni, ossidazione, polimerizzazione, interagendo con altri inquinanti atmosferici dopo eccitazione da parte della radiazione solare. Come risultato di queste reazioni si formano composti di perossido, radicali liberi e composti di idrocarburi con ossidi di azoto e zolfo, spesso sotto forma di particelle di aerosol. In determinate condizioni meteorologiche nello strato d'aria terrestre possono formarsi accumuli particolarmente grandi di impurità gassose e aerosol nocive.
Ciò di solito si verifica nei casi in cui si verifica un'inversione dello strato d'aria direttamente sopra le fonti di emissione di gas e polveri - la posizione di uno strato di aria più fredda sotto aria più calda, che impedisce le masse d'aria e ritarda il trasferimento verso l'alto delle impurità. Di conseguenza, le emissioni nocive si concentrano sotto lo strato di inversione, il loro contenuto vicino al suolo aumenta notevolmente, il che diventa uno dei motivi della formazione di nebbia fotochimica, precedentemente sconosciuta in natura.
La nebbia fotochimica è una miscela multicomponente di gas e particelle di aerosol di origine primaria e secondaria. Tra i componenti principali dello smog figurano l'ozono, gli ossidi di azoto e di zolfo, e numerosi composti organici di natura perossidica, collettivamente chiamati fotoossidanti. Lo smog fotochimico si verifica a seguito di reazioni fotochimiche in determinate condizioni: presenza nell'atmosfera di un'elevata concentrazione di ossidi di azoto, idrocarburi e altri inquinanti, intensa radiazione solare e calma, o scambio d'aria molto debole nello strato superficiale con un potente e aumento dell'inversione per almeno un giorno. Per creare alte concentrazioni di reagenti è necessario un clima stabile e calmo, solitamente accompagnato da inversioni.
Tali condizioni si creano più spesso in giugno-settembre e meno spesso in inverno. Durante periodi prolungati di tempo sereno, la radiazione solare provoca la rottura delle molecole di biossido di azoto per formare ossido nitrico e ossigeno atomico. L'ossigeno atomico e l'ossigeno molecolare danno ozono. Sembrerebbe che quest'ultimo, ossidando l'ossido nitrico, debba nuovamente trasformarsi in ossigeno molecolare e l'ossido nitrico in biossido. Ma questo non accade. L'ossido di azoto reagisce con le olefine presenti nei gas di scarico, che si scindono in corrispondenza del doppio legame e formano frammenti di molecole ed ozono in eccesso. Come risultato della continua dissociazione, nuove masse di biossido di azoto vengono scomposte e producono ulteriori quantità di ozono. Si verifica una reazione ciclica, a seguito della quale l'ozono si accumula gradualmente nell'atmosfera. Questo processo si interrompe di notte. A sua volta, l'ozono reagisce con le olefine. Nell'atmosfera sono concentrati vari perossidi, che insieme formano gli ossidanti caratteristici della nebbia fotochimica. Questi ultimi sono fonte dei cosiddetti radicali liberi, che sono particolarmente reattivi. Tali smog sono un evento comune a Londra, Parigi, Los Angeles, New York e in altre città in Europa e America. A causa dei loro effetti fisiologici sul corpo umano, sono estremamente pericolosi per il sistema respiratorio e circolatorio e spesso causano la morte prematura dei residenti urbani con cattive condizioni di salute.
Dal punto di vista della medicina del lavoro, la metallurgia ferrosa è caratterizzata dalla presenza di numerose fonti di rischi professionali: polveri, sostanze tossiche gassose (triossido di ferro, benzene, acido cloridrico, manganese, piombo, mercurio, fenolo, formaldeide, triossido di cromo, biossido di azoto , monossido di carbonio, ecc.), calore radiante e convettivo, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e magnetici, elevata gravità e intensità del travaglio.
Ogni specchio d'acqua o sorgente d'acqua è collegato con l'ambiente esterno circostante. È influenzato dalle condizioni per la formazione del flusso d'acqua superficiale o sotterraneo, da vari fenomeni naturali, dall'industria, dall'edilizia industriale e municipale, dai trasporti, dalle attività umane economiche e domestiche. La conseguenza di questi influssi è l'introduzione nell'ambiente acquatico di sostanze nuove e insolite: sostanze inquinanti che peggiorano la qualità dell'acqua. Gli inquinanti che entrano nell'ambiente acquatico sono classificati in modo diverso, a seconda degli approcci, dei criteri e degli obiettivi. Pertanto, i contaminanti chimici, fisici e biologici vengono solitamente isolati. L'inquinamento chimico è un cambiamento nelle proprietà chimiche naturali dell'acqua dovuto ad un aumento del contenuto di impurità nocive in essa contenute, sia inorganiche (sali minerali, acidi, alcali, particelle di argilla) che organiche (petrolio e prodotti petroliferi, residui organici, tensioattivi , pesticidi).
2. IONI ELEMENTARI NECESSARI NELL'ACQUA E NEGLI ALIMENTI
Quando si valuta la qualità dell'acqua, è innanzitutto necessario prestare attenzione alle concentrazioni di elementi biologicamente attivi (essenziali) coinvolti in tutti i processi fisiologici. Influenza negativa di basse concentrazioni di elementi essenziali nell'acqua potabile. Un aumento del contenuto di qualsiasi elemento nella dieta provoca varie conseguenze negative. Tuttavia anche un basso contenuto di alcuni elementi rappresenta un pericolo per il corpo umano.
Tra le malattie più comuni associate a bassi livelli di microelementi nell'acqua potabile vi sono il gozzo endemico (basso contenuto di iodio), la carie (basso contenuto di fluoro) e l'anemia da carenza di ferro (basso contenuto di ferro e rame). Tra le malattie più comuni associate a bassi livelli di microelementi nell'acqua potabile vi sono il gozzo endemico (basso contenuto di iodio), la carie (basso contenuto di fluoro) e l'anemia da carenza di ferro (basso contenuto di ferro e rame). Ad esempio, possiamo citare i risultati del lavoro della spedizione sovietico-finlandese, che ha scoperto che a causa del basso contenuto di selenio nell'acqua e nel suolo, la popolazione di un certo numero di distretti della regione di Chita è minacciata dalla carenza di selenio. cardiopatia - malattia di Keshan. Nella composizione dei macrocomponenti dell'acqua, il basso contenuto di calcio e magnesio nell'acqua potabile ha un effetto particolarmente negativo sul corpo umano. Ad esempio, i risultati delle indagini sanitarie ed epidemiologiche sulla popolazione condotte nell'ambito dei programmi dell'OMS mostrano che bassi livelli di Ca e Mg nell'acqua potabile portano ad un aumento del numero di malattie cardiovascolari. Come risultato di una ricerca condotta in Inghilterra, sono state selezionate sei città con l'acqua potabile più dura e sei con quella più dolce. La mortalità per malattie cardiovascolari nelle città con acqua dura era inferiore al normale, mentre nelle città con acqua dolce era più alta. Inoltre, la popolazione che vive in città con acqua dura ha parametri cardiovascolari migliori: pressione sanguigna complessiva più bassa, frequenza cardiaca a riposo più bassa e livelli di colesterolo nel sangue più bassi. Il fumo, i fattori socioeconomici e altri fattori non hanno influenzato queste correlazioni. In Finlandia, la mortalità più elevata per malattie cardiovascolari, pressione alta e colesterolo nel sangue nella parte orientale del paese rispetto a quella occidentale sembra essere associata anche all’uso di acqua dolce, poiché altri parametri (dieta, esercizio fisico) , ecc.) .d.) le popolazioni di questi gruppi praticamente non differiscono.
Il 60 - 80% del fabbisogno giornaliero di Ca e Mg di una persona viene soddisfatto attraverso il cibo. Ma l'importanza di Ca e Mg nella dieta quotidiana può essere valutata se si tiene conto che i requisiti dell'OMS per il contenuto di questi cationi nell'acqua per il Ca sono 80 - 100 mg/l (circa 120-150 mg al giorno), e per il Mg - fino a 150 mg/l l (circa 200 mg al giorno) con un fabbisogno giornaliero totale, ad esempio, di Ca pari a 500 mg. È stato dimostrato che Ca e Mg vengono assorbiti completamente dall'acqua nell'intestino, ma solo per 1/3 dai prodotti in cui sono associati a proteine.
Il livello di Ca nella cellula è un fattore universale nella regolazione di tutte le funzioni cellulari, indipendentemente dal tipo di cellula. La carenza di Ca nell'acqua influisce sull'aumento dell'assorbimento e degli effetti tossici dei metalli pesanti (Cd, Hg, Pb, Al, ecc.). I metalli pesanti competono con il Ca nella cellula, poiché utilizzano le sue vie metaboliche per entrare nel corpo e sostituire gli ioni Ca nelle più importanti proteine regolatrici, interrompendo così il loro normale funzionamento.
Ad oggi si può affermare con sicurezza che l'acqua potabile dolce, caratteristica delle regioni settentrionali del pianeta, con un basso contenuto di cationi bivalenti (Ca e Mg) vitali per l'organismo, rappresenta un significativo fattore di rischio ambientale per patologie cardiovascolari e altre patologie. malattie regionali diffuse Ca-Mg-dipendenti.
Pertanto, quando si sviluppano i requisiti per la qualità dell'acqua utilizzata per scopi potabili, è necessario standardizzare il limite inferiore per il contenuto di un numero di componenti.
In un'analisi più dettagliata dell'influenza degli elementi biologicamente attivi contenuti nell'acqua sulla salute umana, è anche necessario tenere conto della forma della loro presenza in soluzione. Pertanto, il fluoro in forma ionica, essendo tossico per l'uomo a concentrazioni superiori a 1,5 mg/l, cessa di essere tossico quando è in soluzione sotto forma di composto complesso BF4-. È stato stabilito sperimentalmente che l'introduzione di una quantità significativa di fluoro nel corpo umano sotto forma del composto complesso specificato elimina il pericolo di fluorosi umana, poiché, essendo stabile in ambienti acidi, questo composto non viene assorbito dall'organismo. Pertanto, quando si parla delle concentrazioni ottimali di fluoro, si dovrebbe tener conto della possibilità della sua presenza nell'acqua sotto forma di composti complessi, poiché è lo ione F che in determinate concentrazioni ha un effetto positivo sull'uomo.
Come è noto, la composizione chimica analitica (determinata in laboratorio) delle acque naturali non corrisponde alla composizione reale. La maggior parte dei componenti disciolti in acqua, che partecipano alle reazioni di complessazione, idrolisi e dissociazione acido-base, sono combinati in varie associazioni ioniche stabili: ioni complessi, coppie ioniche, ecc. La moderna idrogeochimica le chiama forme migratorie. L'analisi chimica fornisce solo la concentrazione lorda (o lorda) di un componente, ad esempio il rame, mentre in realtà il rame può trovarsi quasi interamente sotto forma di carbonato, cloruro, solfato, complessi fulvici o idrossilati, a seconda della composizione generale del componente. l'acqua (gli ioni biologicamente attivi e quindi gli ioni Cu2+ non complessi sono noti per essere tossici in alte concentrazioni.
Le attività di BASF comprendono la produzione di materie prime e risorse energetiche, vari prodotti chimici, prodotti agricoli, plastica, coloranti, ausiliari tessili, nonché prodotti di consumo come vernici, vernici, sistemi informativi e medicinali.
Basato sulle principali materie prime: nafta, gas naturale, zolfo, ecc. l'azienda produce più di 8mila prodotti diversi. Un gran numero di sottoprodotti ottenuti non vengono distrutti, ma servono come materia prima per altre industrie.
Strategia aziendale
Già nel 1985 BASF è stata una delle prime nelle sue attività a ispirarsi alla “legge fondamentale” volta a risolvere i problemi ambientali. Le regole stabilite sono incluse nella strategia aziendale, che è obbligatoria per tutti gli stabilimenti produttivi BASF, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica.
Tra le norme aziendali si segnalano in particolare le seguenti:
- Seguendo i principi dello sviluppo sostenibile.
Il concetto di “Sviluppo Sostenibile” è stato formulato alla conferenza delle Nazioni Unite nel 1992 a Rio de Janeiro e implica un processo che soddisfa le esigenze economiche, ambientali e sociali della società moderna, consentendo allo stesso tempo alle generazioni future di raggiungere i propri obiettivi.
- Partecipazione all'iniziativa "Responsible Care" - un programma di produttori chimici globali, che prevede una serie di misure volontarie volte a preservare l'ambiente, garantendo sicurezza e salute.
- Gli interessi economici non hanno la precedenza sulle questioni legate alla sicurezza, alla salute e all’ambiente
- Rilascio di prodotti sicuri da produrre, utilizzare e distruggere
- Impatto ambientale minimo durante la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo dei prodotti
- Aiutare i consumatori a utilizzare i prodotti in modo sicuro
- Sviluppo continuo della scienza e della tecnologia per migliorare la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
Da queste regole emerge chiaramente che BASF considera le questioni relative alla sicurezza, alla salute e alla tutela dell'ambiente della massima importanza e priorità, sia negli impianti di produzione esistenti che nello sviluppo di nuovi prodotti e processi.
Misure per ridurre le emissioni
Solo nel 1998 i costi sostenuti dall'azienda per la tutela dell'ambiente ammontavano a oltre 1,5 miliardi di marchi. (Fig. 1). Un esempio del successo dell'azienda in questa attività è la riduzione delle emissioni presso la sede centrale di BASF a Ludwigshafen, volume? che negli ultimi anni è diminuito di un ordine di grandezza (Fig. 2).
La natura complessa e integrata della produzione chimica, che comprende circa 350 officine solo nel sito di Ludwigshafen, pone particolari esigenze in termini di monitoraggio ambientale. Quest'ultimo consiste nel monitoraggio ambientale (aria, rumore, qualità dell'acqua, monitoraggio del suolo in 43 punti all'interno e all'esterno del sito), gestione dell'energia e dell'acqua e gestione dei rifiuti e degli effluenti. Per lo smaltimento dei rifiuti BASF si avvale dell'impianto speciale più grande d'Europa, in 8 forni di cui ogni anno vengono trattate 200mila tonnellate di rifiuti.
Il concetto di sicurezza ambientale si basa su personale qualificato e ben addestrato, moderne tecnologie di produzione con i più alti standard di sicurezza per tutti i paesi in cui BASF produce.
Questi standard, che includono anche la minimizzazione dei rifiuti, sono stabiliti già in fase di progettazione, il che consente di evitare gli scarti di produzione, ridurli o riciclarli.
Esempi di risoluzione dei problemi ambientali.
Diamo un'occhiata ad alcuni esempi tratti dall'esperienza dell'azienda nella chimica catalitica e nei prodotti chimici di processo.
BASF produce catalizzatori per l'ossidazione dei gas di scarico di vari settori, comprese le industrie chimiche. L'utilizzo di questi catalizzatori ha portato ad una riduzione delle emissioni indesiderate nell'atmosfera. Recentemente, l'azienda ha sviluppato nuovi catalizzatori a nido d'ape per la rimozione delle diossine, che vengono utilizzati con successo non solo nell'industria chimica, ma anche nel trattamento dei rifiuti negli impianti di incenerimento dei rifiuti in molte città in tutto il mondo.
Nella produzione chimica, l'utilizzo dei principi base della catalisi è molto efficace, poiché consente di aumentare la selettività del processo riducendo contemporaneamente i costi energetici. Nell'industria chimica odierna i catalizzatori svolgono un ruolo chiave in circa l'80% dei vari processi. Un esempio dei progressi significativi compiuti dall'azienda nel ridurre gli effetti nocivi dei sottoprodotti sull'ambiente è il catalizzatore per la sintesi dell'acido acrilico. Quest'ultimo è ampiamente utilizzato nella produzione varianze?, vernici, superassorbenti, ecc. La sintesi dell'acido acrilico dal propilene avviene attraverso due passaggi catalitici. In 25 anni di ricerca, la quantità di sottoprodotti indesiderati è diminuita del 75%. L'effetto positivo del catalizzatore si è manifestato sia in un utilizzo più completo della materia prima per lo scopo previsto (maggiore selettività) sia nella formazione di meno rifiuti, che ha portato ad una significativa riduzione del consumo energetico. Quest'ultimo è dovuto al fatto che i costi nelle fasi di rettifica ed estrazione sono diminuiti. Inoltre, si è rivelato possibile rigenerare il catalizzatore esaurito.
Un altro esempio è la produzione di cloruro di vinile presso lo stabilimento BASF di Anversa. L'officina del cloruro di vinile è stata messa in funzione più di 30 anni fa, quindi era necessario un suo completo ammodernamento, anche a causa del fatto che la vita utile consentita dalla legislazione fiamminga stava per scadere. Un importante intermedio nella produzione del cloruro di vinile è il dicloroetano, ottenuto mediante ossiclorurazione dell'etilene in presenza di HCl e aria. Questo processo è accompagnato dalla formazione di gas sottoprodotti: CO, idrocarburi clorurati. Inoltre la miscela di reazione contiene azoto presente nell'aria. Per ridurre la quantità di gas, si è deciso di utilizzare l'ossigeno come agente ossidante.
Dopo la modernizzazione, dell'attrezzatura sono rimasti solo i reattori e alcune unità di apparecchiature di scambio termico, tutto il resto è stato sostituito.
Attualmente, questa produzione produce una quantità notevolmente inferiore di gas sottoprodotti; inoltre, viene utilizzato il 20% in più di HCl rispetto a prima dalle officine vicine, che non veniva utilizzato prima della modernizzazione.
L'acqua prodotta nel processo è contaminata da composti organoclorurati. Per ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, si è deciso di installare una colonna aggiuntiva, un rigeneratore, in cui vengono rimossi gli organoclorurati.
Questa produzione utilizza anche l'acqua di raffreddamento, che prima dell'ammodernamento dell'officina veniva inviata direttamente alla piscina del vicino porto. Dopo aver effettuato le necessarie opere ingegneristiche è stato realizzato un doppio sistema chiuso che impedisce completamente la possibilità di ingresso di sostanze organiche nell'acqua di mare. Sono stati inoltre installati due nuovi impianti di stoccaggio di dicloroetano liquido con una capacità di 8mila m 3 con doppio conchiglia? per una maggiore sicurezza. Sono stati apportati i necessari miglioramenti anche al sistema di gestione della produzione. In questo progetto sono stati investiti complessivamente circa 70 milioni di marchi.
Consideriamo un esempio relativo alla rimozione dei gas di processo acidi. Si tratta di un processo ad alta intensità energetica che, inoltre, di solito porta alla corrosione profonda delle apparecchiature. A questo proposito, BASF ha sviluppato il processo aMDEA (metildietanolamina attivata), che garantisce elevata produttività, basso consumo energetico e maggiore resistenza alla corrosione delle apparecchiature. Ad oggi, più di 100 unità utilizzano questo processo e molte altre unità sono in fase di progettazione, ristrutturazione o costruzione.
Il principio di funzionamento del metodo aMDEA si basa sull'elevata capacità di assorbimento dell'ammina terziaria (N-metil-dietanolammina) rispetto ai gas acidi CO 2 e H 2 S. La possibilità di modificare la concentrazione dell'attivatore in un ampio intervallo consente di sfruttare i metodi di purificazione sia chimici che fisici. L'elevata solubilità dei gas acidi porta ad una riduzione dei costi energetici e la bassa solubilità degli inerti contribuisce ad una purificazione più fine. Altri vantaggi del solvente includono l'elevata stabilità chimica e termica, la bassa pressione del vapore saturo, che riduce significativamente le perdite di solvente. La bassa corrosione, ottenuta selezionando l'attivatore ottimale, elimina la necessità di utilizzare inibitori di corrosione, ha un effetto positivo sull'economia dell'intero processo e minimizza l'impatto negativo sull'ambiente.
Nel campo dei prodotti chimici di processo prodotti da BASF, oltre all'aMDEA, un altro solvente che si è dimostrato eccellente è l'N-metilpirrolidone (NMP). Il suo campo di applicazione è la produzione industriale di idrocarburi mediante distillazione estrattiva. Questa tecnologia sfrutta l'elevata solubilità degli idrocarburi nell'NMP. Rispetto ad altri solventi tecnici, l'NMP presenta una serie di importanti vantaggi: non forma azeotropi con idrocarburi e ha un'elevata stabilità termica e chimica. Inoltre, rispetto ad altri estraenti, l'N-metilpirrolidone presenta caratteristiche più favorevoli dal punto di vista tossicologico ed ecologico.
Informazione pubblica
Sebbene la chimica svolga un ruolo chiave nel mantenimento e nel miglioramento della qualità della vita, questo non è sempre riconosciuto dalla società. Pertanto, un sondaggio d’opinione condotto dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) nel 1994 ha mostrato che circa il 60% degli intervistati aveva un atteggiamento negativo nei confronti dell’industria chimica. Solo un intervistato su tre ritiene che l’industria chimica abbia a cuore l’ambiente e meno della metà ritiene che l’industria stia ricercando e implementando tecnologie che risolvono i problemi ambientali.
Per correggere questo squilibrio nell’opinione pubblica, BASF si impegna a educare i dipendenti, i consumatori e il pubblico sull’uso e la manipolazione sicuri dei prodotti chimici e sui suoi sforzi per affrontare le questioni ambientali. Periodicamente vengono pubblicati i rapporti dell'azienda che descrivono in dettaglio sia lo stato attuale dell'ambiente nella produzione sia gli obiettivi ambientali futuri di BASF.
Sono diventati una tradizione gli incontri con rappresentanti di vari partiti politici, ambientalisti e giornate porte aperte, durante le quali si tiene un dialogo aperto su tutte le questioni di reciproco interesse. In tutte queste interazioni, l'obiettivo di BASF è allineare gli interessi dell'azienda con i bisogni della società, il che è fondamentale per il successo futuro.
Murzin D.Yu.