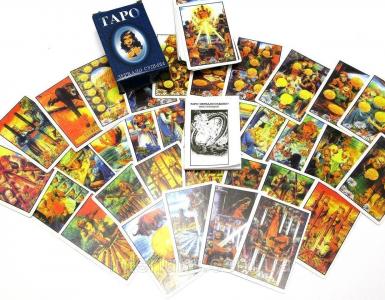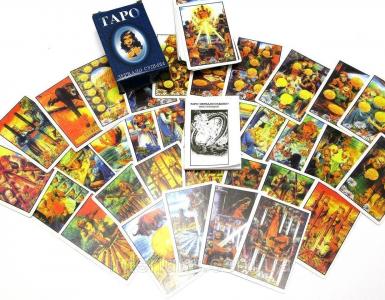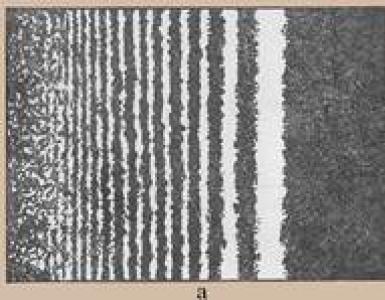Lo scheletro dei vertebrati è costituito da. Riassunti di anatomia animale: colonna vertebrale. Scheletro assiale dello scheletro del torso
Nel processo di evoluzione, gli animali hanno dominato sempre più nuovi territori, tipi di cibo e si sono adattati alle mutevoli condizioni di vita. L'evoluzione ha gradualmente cambiato l'aspetto degli animali. Per sopravvivere era necessario cercare il cibo più attivamente, nascondersi meglio o difendersi dai nemici e muoversi più velocemente. Cambiando insieme al corpo, il sistema muscolo-scheletrico ha dovuto garantire tutti questi cambiamenti evolutivi. Il più primitivo protozoi non hanno strutture di sostegno, si muovono lentamente, fluiscono con l'aiuto di pseudopodi e cambiano continuamente forma.
La prima struttura di supporto ad apparire è membrana cellulare. Non solo separava l'organismo dall'ambiente esterno, ma permetteva anche di aumentare la velocità di movimento grazie ai flagelli e alle ciglia. Gli animali multicellulari hanno un'ampia varietà di strutture di supporto e dispositivi per il movimento. Aspetto esoscheletro aumento della velocità di movimento grazie allo sviluppo di gruppi muscolari specializzati. Scheletro interno cresce con l'animale e gli permette di raggiungere velocità record. Tutti i cordati hanno uno scheletro interno. Nonostante le differenze significative nella struttura delle strutture muscolo-scheletriche in diversi animali, i loro scheletri svolgono funzioni simili: supporto, protezione degli organi interni, movimento del corpo nello spazio. I movimenti dei vertebrati vengono eseguiti grazie ai muscoli degli arti, che eseguono tipi di movimento come correre, saltare, nuotare, volare, arrampicarsi, ecc.
Scheletro e muscoli
Il sistema muscolo-scheletrico è rappresentato da ossa, muscoli, tendini, legamenti e altri elementi del tessuto connettivo. Lo scheletro determina la forma del corpo e, insieme ai muscoli, protegge gli organi interni da ogni tipo di danno. Grazie alle articolazioni, le ossa possono muoversi l'una rispetto all'altra. Il movimento delle ossa avviene a seguito della contrazione dei muscoli ad esse attaccati. In questo caso lo scheletro è una parte passiva dell'apparato motorio che svolge una funzione meccanica. Lo scheletro è costituito da tessuti densi e protegge gli organi interni e il cervello, formando per loro contenitori ossei naturali.
Oltre alle funzioni meccaniche, il sistema scheletrico svolge una serie di funzioni biologiche. Le ossa contengono la principale riserva di minerali che vengono utilizzati dall'organismo secondo necessità. Le ossa contengono midollo osseo rosso, che produce globuli rossi.
Lo scheletro umano comprende un totale di 206 ossa: 85 pari e 36 spaiate.

Struttura ossea
Composizione chimica delle ossa
Tutte le ossa sono costituite da sostanze organiche e inorganiche (minerali) e acqua, la cui massa raggiunge il 20% della massa delle ossa. Materia organica delle ossa - osseina- ha proprietà elastiche e dona elasticità alle ossa. I minerali - sali di anidride carbonica e fosfato di calcio - conferiscono durezza alle ossa. L'elevata resistenza ossea è garantita dalla combinazione dell'elasticità dell'osseina e della durezza della sostanza minerale del tessuto osseo.

Struttura ossea macroscopica
All'esterno, tutte le ossa sono ricoperte da una pellicola sottile e densa di tessuto connettivo - periostio. Solo le teste delle ossa lunghe non hanno periostio, ma sono ricoperte di cartilagine. Il periostio contiene molti vasi sanguigni e nervi. Fornisce nutrimento al tessuto osseo e partecipa alla crescita dello spessore osseo. Grazie al periostio, le ossa rotte guariscono.
Ossa diverse hanno strutture diverse. Un osso lungo sembra un tubo, le cui pareti sono costituite da una sostanza densa. Questo struttura tubolare le ossa lunghe conferiscono loro forza e leggerezza. Nelle cavità delle ossa tubolari c'è midollo osseo giallo- tessuto connettivo lasso ricco di grasso.

Le estremità delle ossa lunghe contengono sostanza ossea spongiosa. È costituito anche da placche ossee che formano molti setti intersecanti. Nei luoghi in cui l'osso è soggetto al massimo carico meccanico, il numero di queste partizioni è maggiore. La sostanza spugnosa contiene midollo osseo rosso, le cui cellule danno origine alle cellule del sangue. Anche le ossa corte e piatte hanno una struttura spugnosa, solo all'esterno sono ricoperte da uno strato di sostanza simile a una diga. La struttura spugnosa conferisce alle ossa robustezza e leggerezza.
Struttura microscopica dell'osso
Il tessuto osseo appartiene al tessuto connettivo e contiene molta sostanza intercellulare, costituita da osseina e sali minerali.

Questa sostanza forma placche ossee disposte concentricamente attorno a tubuli microscopici che corrono lungo l'osso e contengono vasi sanguigni e nervi. Le cellule ossee, e quindi l'osso, sono tessuti viventi; riceve nutrienti dal sangue, in esso avviene il metabolismo e possono verificarsi cambiamenti strutturali.

Tipi di ossa
La struttura delle ossa è determinata dal processo di lungo sviluppo storico, durante il quale il corpo dei nostri antenati è cambiato sotto l'influenza dell'ambiente e si è adattato attraverso la selezione naturale alle condizioni dell'esistenza.
A seconda della forma si distinguono ossa tubolari, spugnose, piatte e miste.
Ossa tubolari si trovano in organi che effettuano movimenti rapidi ed estesi. Tra le ossa tubolari si distinguono le ossa lunghe (omero, femore) e le ossa corte (falangi delle dita).
Le ossa tubolari hanno una parte centrale - il corpo e due estremità - le teste. All'interno delle lunghe ossa tubolari è presente una cavità piena di midollo osseo giallo. La struttura tubolare determina la resistenza ossea richiesta dal corpo richiedendo la minima quantità di materiale. Durante il periodo di crescita ossea, tra il corpo e la testa delle ossa tubolari si trova la cartilagine, grazie alla quale l'osso cresce in lunghezza.
Ossa piatte Limitano le cavità all'interno delle quali sono posizionati gli organi (ossa del cranio) o fungono da superfici per l'attaccamento dei muscoli (scapola). Le ossa piatte, come le ossa tubolari corte, sono composte prevalentemente da sostanza spugnosa. Le estremità delle ossa tubolari lunghe, così come delle ossa tubolari corte e piatte, non presentano cavità.

Ossa spugnose costituito prevalentemente da sostanza spugnosa ricoperta da un sottile strato di compatta. Tra questi ci sono le ossa spugnose lunghe (sterno, costole) e corte (vertebre, carpo, tarso).
A ossa miste Questi includono ossa costituite da più parti che hanno strutture e funzioni diverse (osso temporale).
Protuberanze, creste e rugosità sull'osso sono luoghi in cui i muscoli sono attaccati alle ossa. Quanto meglio sono espressi, tanto più sviluppati sono i muscoli attaccati alle ossa.
Scheletro umano.
Lo scheletro umano e la maggior parte dei mammiferi hanno lo stesso tipo di struttura, costituita dalle stesse sezioni e ossa. Ma l'uomo differisce da tutti gli animali per la sua capacità di lavoro e intelligenza. Ciò ha lasciato un'impronta significativa sulla struttura dello scheletro. In particolare, il volume della cavità cranica umana è molto più grande di quello di qualsiasi animale che abbia un corpo delle stesse dimensioni. La dimensione della parte facciale del cranio umano è inferiore a quella del cervello, ma negli animali, al contrario, è molto più grande. Ciò è dovuto al fatto che negli animali le mascelle sono un organo di difesa e di acquisizione del cibo e sono quindi ben sviluppate, e il volume del cervello è inferiore a quello dell'uomo.
Le curve della colonna vertebrale, associate allo spostamento del baricentro dovuto alla posizione verticale del corpo, aiutano una persona a mantenere l'equilibrio e ad attenuare gli shock. Gli animali non hanno tali curve.
Il torace umano è compresso dalla parte anteriore a quella posteriore e vicino alla colonna vertebrale. Negli animali è compresso dai lati ed esteso verso il basso.
L'ampia e massiccia cintura pelvica umana ha la forma di una ciotola, sostiene gli organi addominali e trasferisce il peso corporeo agli arti inferiori. Negli animali, il peso corporeo è distribuito equamente tra i quattro arti e la cintura pelvica è lunga e stretta.
Le ossa degli arti inferiori degli esseri umani sono notevolmente più spesse di quelle superiori. Negli animali non vi è alcuna differenza significativa nella struttura delle ossa degli arti anteriori e posteriori. Una maggiore mobilità degli arti anteriori, in particolare delle dita, consente a una persona di eseguire una varietà di movimenti e tipi di lavoro con le mani.
Scheletro del busto scheletro assiale
Scheletro del busto comprende una colonna vertebrale composta da cinque sezioni e la forma delle vertebre toraciche, delle costole e dello sterno Petto(Vedi la tabella).

Scull
Il cranio è diviso nelle sezioni cerebrale e facciale. IN cervello La sezione del cranio - il cranio - contiene il cervello, lo protegge dai colpi, ecc. Il cranio è costituito da ossa piatte collegate fissamente: la frontale, due parietali, due temporali, occipitale e sfenoide. L'osso occipitale è collegato alla prima vertebra della colonna vertebrale tramite un'articolazione ellissoidale, che consente alla testa di inclinarsi in avanti e di lato. La testa ruota insieme alla prima vertebra cervicale grazie alla connessione tra la prima e la seconda vertebra cervicale. C'è un foro nell'osso occipitale attraverso il quale il cervello si collega al midollo spinale. Il pavimento del cranio è formato dall'osso principale con numerose aperture per nervi e vasi sanguigni.

Facciale la sezione del cranio forma sei ossa accoppiate: la mascella superiore, lo zigomatico, il nasale, il palatino, la conca nasale inferiore, nonché tre ossa spaiate: la mascella inferiore, il vomere e l'osso ioide. L'osso mandibolare è l'unico osso del cranio collegato in modo mobile alle ossa temporali. Tutte le ossa del cranio (ad eccezione della mascella inferiore) sono collegate in modo immobile, il che è dovuto alla loro funzione protettiva.
La struttura del cranio facciale umano è determinata dal processo di “umanizzazione” della scimmia, cioè il ruolo guida del travaglio, il trasferimento parziale della funzione di presa dalle mascelle alle mani, che sono diventate organi del travaglio, lo sviluppo del linguaggio articolato, il consumo di cibo preparato artificialmente, che facilita il lavoro dell'apparato masticatorio. Il cranio si sviluppa parallelamente allo sviluppo del cervello e degli organi di senso. A causa dell'aumento del volume del cervello, il volume del cranio è aumentato: nell'uomo è di circa 1500 cm 2.
Scheletro del busto
Lo scheletro del corpo è costituito dalla colonna vertebrale e dalla gabbia toracica. Colonna vertebrale- la base dello scheletro. Consiste di 33-34 vertebre, tra le quali ci sono cuscinetti cartilaginei - dischi, che conferiscono flessibilità alla colonna vertebrale.
La colonna vertebrale umana forma quattro curve. Nella colonna cervicale e lombare sono convessi rivolti in avanti, nella colonna toracica e sacrale - all'indietro. Nello sviluppo individuale di una persona, le curve appaiono gradualmente, in un neonato la colonna vertebrale è quasi dritta. Prima si forma la curva cervicale (quando il bambino inizia a tenere la testa dritta), poi la curva toracica (quando il bambino inizia a sedersi). La comparsa delle curve lombari e sacrali è associata al mantenimento dell'equilibrio in posizione eretta del corpo (quando il bambino inizia a stare in piedi e camminare). Queste curve hanno un importante significato fisiologico: aumentano le dimensioni delle cavità toracica e pelvica; rendere più facile per il corpo mantenere l'equilibrio; ammorbidire gli shock quando si cammina, si salta, si corre.

Con l'aiuto della cartilagine intervertebrale e dei legamenti, la colonna vertebrale forma una colonna flessibile ed elastica con mobilità. Non è lo stesso nelle diverse parti della colonna vertebrale. La colonna cervicale e lombare hanno una maggiore mobilità; la colonna toracica è meno mobile, poiché è collegata alle costole. L'osso sacro è completamente immobile.

Ci sono cinque sezioni nella colonna vertebrale (vedi diagramma “Divisioni della colonna vertebrale”). La dimensione dei corpi vertebrali aumenta dal cervicale al lombare a causa del maggior carico sulle vertebre sottostanti. Ogni vertebra è costituita da un corpo, un arco osseo e diversi processi a cui sono attaccati i muscoli. C'è un'apertura tra il corpo vertebrale e l'arco. Si formano i forami di tutte le vertebre canale vertebrale dove si trova il midollo spinale.
Gabbia toracica formato dallo sterno, dodici paia di costole e vertebre toraciche. Serve come contenitore per importanti organi interni: cuore, polmoni, trachea, esofago, grandi vasi e nervi. Partecipa ai movimenti respiratori dovuti al ritmico sollevamento e abbassamento delle costole.
Nell'uomo, in connessione con il passaggio alla deambulazione eretta, la mano viene liberata dalla funzione di movimento e diventa un organo del travaglio, a seguito del quale il torace subisce una trazione dai muscoli attaccati degli arti superiori; gli interni non premono sulla parete anteriore, ma su quella inferiore, formata dal diaframma. Ciò fa sì che il torace diventi piatto e largo.
Scheletro dell'arto superiore
Scheletro degli arti superioriè costituito dal cingolo scapolare (scapola e clavicola) e dall'arto superiore libero. La scapola è un osso piatto e triangolare adiacente alla parte posteriore della gabbia toracica. La clavicola ha una forma curva, che ricorda la lettera latina S. Il suo significato nel corpo umano è che allontana l'articolazione della spalla dal torace, garantendo una maggiore libertà di movimento dell'arto.
Le ossa dell'arto superiore libero comprendono l'omero, le ossa dell'avambraccio (radio e ulna) e le ossa della mano (ossa del polso, ossa del metacarpo e falangi delle dita).

L'avambraccio è rappresentato da due ossa: l'ulna e il radio. Per questo motivo è capace non solo di flessione ed estensione, ma anche di pronazione, ovvero di rotazione verso l'interno e verso l'esterno. L'ulna nella parte superiore dell'avambraccio ha una tacca che si collega alla troclea dell'omero. L'osso del radio si collega alla testa dell'omero. Nella parte inferiore, il raggio ha l'estremità più massiccia. È lei che, con l'aiuto della superficie articolare, insieme alle ossa del polso, prende parte alla formazione dell'articolazione del polso. Al contrario, l'estremità dell'ulna qui è sottile, ha una superficie articolare laterale, con l'aiuto della quale si collega al radio e può ruotare attorno ad esso.

La mano è la parte distale dell'arto superiore, il cui scheletro è costituito dalle ossa del polso, del metacarpo e delle falangi. Il carpo è costituito da otto ossa corte e spugnose disposte su due file, quattro per ciascuna fila.
Mano scheletrica
Mano- l'arto superiore o anteriore dell'uomo e delle scimmie, per il quale in precedenza era considerata caratteristica la capacità di opporre il pollice a tutti gli altri.
La struttura anatomica della mano è abbastanza semplice. Il braccio è attaccato al corpo attraverso le ossa del cingolo scapolare, delle articolazioni e dei muscoli. Composto da 3 parti: spalla, avambraccio e mano. Il cingolo scapolare è il più potente. Piegare le braccia all'altezza del gomito conferisce alle braccia maggiore mobilità, aumentandone l'ampiezza e la funzionalità. La mano è composta da molte articolazioni mobili, è grazie a loro che una persona può fare clic sulla tastiera di un computer o di un telefono cellulare, puntare il dito nella direzione desiderata, portare una borsa, disegnare, ecc.

Le spalle e le mani sono collegate attraverso l'omero, l'ulna e il radio. Tutte e tre le ossa sono collegate tra loro tramite articolazioni. All'articolazione del gomito, il braccio può essere piegato ed esteso. Entrambe le ossa dell'avambraccio sono collegate in modo mobile, quindi durante il movimento delle articolazioni, il radio ruota attorno all'ulna. La spazzola può essere ruotata di 180 gradi.
Scheletro degli arti inferiori
Scheletro dell'arto inferioreè costituito dalla cintura pelvica e dall'arto inferiore libero. La cintura pelvica è costituita da due ossa pelviche, articolate posteriormente con l'osso sacro. L'osso pelvico è formato dalla fusione di tre ossa: l'ileo, l'ischio e il pube. La complessa struttura di questo osso è dovuta a una serie di funzioni che svolge. Collegandosi alla coscia e all'osso sacro, trasferendo il peso del corpo agli arti inferiori, svolge la funzione di movimento e di sostegno, oltre che una funzione protettiva. A causa della posizione verticale del corpo umano, lo scheletro pelvico è relativamente più largo e massiccio di quello degli animali, poiché sostiene gli organi che si trovano sopra di esso.
Le ossa dell'arto inferiore libero comprendono il femore, la tibia (tibia e perone) e il piede.

Lo scheletro del piede è formato dalle ossa del tarso, del metatarso e delle falangi delle dita. Il piede umano differisce da quello animale per la sua forma arcuata. L'arco plantare attenua gli shock che il corpo riceve quando cammina. Le dita del piede sono poco sviluppate, ad eccezione del grande, che ha perso la sua funzione di presa. Il tarso, al contrario, è molto sviluppato, il calcagno è particolarmente grande al suo interno. Tutte queste caratteristiche del piede sono strettamente correlate alla posizione verticale del corpo umano.

La camminata eretta umana ha portato al fatto che la differenza nella struttura degli arti superiori e inferiori è diventata significativamente maggiore. Le gambe umane sono molto più lunghe delle braccia e le loro ossa sono più massicce.
Connessioni ossee
Nello scheletro umano esistono tre tipi di connessioni ossee: fisse, semimobili e mobili. Fisso tipo di connessione è una connessione dovuta alla fusione di ossa (ossa pelviche) o alla formazione di suture (ossa del cranio). Questa fusione è un adattamento per sopportare il carico pesante sperimentato dall'osso sacro umano a causa della posizione verticale del busto.
Semimobile la connessione viene effettuata utilizzando la cartilagine. I corpi vertebrali sono collegati tra loro in questo modo, il che contribuisce all'inclinazione della colonna vertebrale in diverse direzioni; costole con lo sterno, che consente al torace di muoversi durante la respirazione.
Mobile connessione, o giunto, è la forma più comune e allo stesso tempo complessa di connessione ossea. L'estremità di una delle ossa che forma l'articolazione è convessa (la testa dell'articolazione) e l'estremità dell'altra è concava (la cavità glenoidea). La forma della testa e dell'incavo corrispondono tra loro e corrispondono ai movimenti effettuati nell'articolazione.

Superficie articolare Le ossa articolari sono ricoperte da cartilagine articolare bianca lucida. La superficie liscia della cartilagine articolare facilita il movimento e la sua elasticità attenua lo shock e lo shock subiti dall'articolazione. Tipicamente, la superficie articolare di un osso che forma un'articolazione è convessa e viene chiamata testa, mentre l'altro è concava e viene chiamato alveolo. Grazie a ciò, le ossa di collegamento si adattano perfettamente l'una all'altra.
Bursa teso tra le ossa articolari, formando una cavità articolare ermeticamente sigillata. La capsula articolare è composta da due strati. Lo strato esterno passa nel periostio, lo strato interno rilascia fluido nella cavità articolare, che agisce come lubrificante, garantendo il libero scorrimento delle superfici articolari.
Caratteristiche dello scheletro umano associate al lavoro e alla postura eretta
Attività lavorativa
Il corpo di una persona moderna è ben adattato al lavoro e al camminare in posizione eretta. La camminata eretta è un adattamento alla caratteristica più importante della vita umana: il lavoro. È lui che traccia una linea netta tra l'uomo e gli animali superiori. Il travaglio ha avuto un impatto diretto sulla struttura e sulla funzione della mano, che ha iniziato a influenzare il resto del corpo. Lo sviluppo iniziale della camminata eretta e l'emergere dell'attività lavorativa hanno comportato ulteriori cambiamenti nell'intero corpo umano. Il ruolo guida del travaglio è stato facilitato dal trasferimento parziale della funzione di presa dalle mascelle alle mani (che in seguito divennero organi del travaglio), dallo sviluppo della parola umana e dal consumo di cibo preparato artificialmente (facilita il lavoro dell'apparato masticatorio apparato). La parte cerebrale del cranio si sviluppa parallelamente allo sviluppo del cervello e degli organi di senso. A questo proposito, il volume del cranio aumenta (nell'uomo - 1.500 cm 3, nelle scimmie - 400–500 cm 3).
Camminare in posizione eretta
Una parte significativa delle caratteristiche inerenti allo scheletro umano è associata allo sviluppo dell'andatura bipede:
- piede di sostegno con alluce molto sviluppato e potente;
- mano con pollice molto sviluppato;
- la forma della colonna vertebrale con le sue quattro curve.
La forma della colonna vertebrale è stata sviluppata grazie ad un adattamento elastico alla camminata su due gambe, che garantisce movimenti fluidi del busto e lo protegge dai danni durante movimenti improvvisi e salti. Il corpo nella regione toracica è appiattito, il che porta alla compressione del torace dalla parte anteriore a quella posteriore. Anche gli arti inferiori hanno subito cambiamenti in relazione alla camminata eretta: le articolazioni dell'anca ampiamente distanziate danno stabilità al corpo. Nel corso dell'evoluzione si è verificata una ridistribuzione della gravità corporea: il centro di gravità si è abbassato e ha preso posizione a livello di 2-3 vertebre sacrali. Una persona ha un bacino molto ampio e le sue gambe sono ampiamente distanziate, questo consente al corpo di essere stabile quando si muove e sta in piedi.
Oltre alla colonna vertebrale curva, alle cinque vertebre del sacro e al torace compresso, si nota l'allungamento della scapola e il bacino espanso. Tutto ciò ha comportato:
- forte sviluppo del bacino in larghezza;
- fissaggio del bacino all'osso sacro;
- sviluppo potente e un modo speciale per rafforzare i muscoli e i legamenti nella zona dell'anca.
Il passaggio degli antenati umani alla camminata eretta ha comportato lo sviluppo delle proporzioni del corpo umano, distinguendolo dalle scimmie. Pertanto, gli esseri umani sono caratterizzati da arti superiori più corti.
Camminare e lavorare in posizione eretta ha portato alla formazione di asimmetria nel corpo umano. Le metà destra e sinistra del corpo umano non sono simmetriche nella forma e nella struttura. Un esempio lampante di ciò è la mano umana. La maggior parte delle persone è destrorsa e circa il 2-5% è mancino.
Lo sviluppo della camminata eretta, che ha accompagnato il passaggio dei nostri antenati alla vita in spazi aperti, ha portato a cambiamenti significativi nello scheletro e nell'intero corpo nel suo complesso.
Domanda 1.
Scheletro svolge le seguenti funzioni:
1) supporto - per tutti gli altri sistemi e organi;
2) motore: garantisce il movimento del corpo e delle sue parti nello spazio;
3) protettivo: protegge gli organi del torace e della cavità addominale, il cervello, i nervi e i vasi sanguigni dalle influenze esterne.
Domanda 2.
Distinguere due tipi di scheletro– esterni ed interni. Alcuni protozoi, molti molluschi, artropodi hanno un esoscheletro: questi sono i gusci di lumache, cozze, ostriche, i gusci duri di gamberi, granchi e i rivestimenti chitinosi leggeri ma resistenti degli insetti. I radiolari invertebrati, i cefalopodi e i vertebrati hanno uno scheletro interno.
Domanda 3.
Il corpo dei molluschi è solitamente racchiuso in una conchiglia. Il lavandino può essere costituito da due ante o avere un'altra forma sotto forma di tappo, ricciolo, spirale, ecc. Il guscio è formato da due strati: quello esterno, organico, e quello interno, fatto di carbonato di calcio. Lo strato calcareo è diviso in due strati: dietro lo strato organico si trova uno strato porcellanato formato da cristalli prismatici di carbonato di calcio, e sotto c'è uno strato madreperlaceo, i cui cristalli hanno la forma di lamelle sottili su in cui si verifica l'interferenza luminosa.
La conchiglia è uno scheletro duro esterno.
Domanda 4.
Il corpo e gli arti degli insetti hanno una copertura chitinizzata: la cuticola, che è l'esoscheletro. La cuticola di molti insetti è dotata di un gran numero di peli che svolgono la funzione del tatto.
Domanda 5.
I protozoi possono formare scheletri esterni sotto forma di conchiglie o conchiglie (foraminiferi, radiolari, flagellati corazzati), nonché scheletri interni di varie forme. La funzione principale dello scheletro del protozoo è protettiva.
Domanda 6.
La presenza di coperture rigide negli artropodi impedisce la crescita continua degli animali. Pertanto, la crescita e lo sviluppo degli artropodi sono accompagnati da una muta periodica. La vecchia cuticola cade e finché quella nuova non si indurisce, l'animale cresce.
Domanda 7.
I vertebrati hanno uno scheletro interno, il cui principale elemento assiale è la notocorda. Nei vertebrati lo scheletro interno è costituito da tre sezioni: lo scheletro della testa, lo scheletro del tronco e lo scheletro degli arti. I vertebrati (pesci anfibi, rettili, uccelli, mammiferi) hanno uno scheletro interno.
Domanda 8.
Piante quindi Sono inoltre dotati di strutture di sostegno, con l'aiuto delle quali trasportano le foglie verso il sole e le mantengono in una posizione tale che le lamine fogliari siano illuminate al meglio dalla luce solare. Nelle piante legnose il supporto principale è il tessuto meccanico. Esistono tre tipi di tessuti meccanici:
1) il collenchima è formato da cellule viventi di varie forme. Si trovano negli steli e nelle foglie delle piante giovani;
2) le fibre sono rappresentate da cellule morte allungate con membrane uniformemente ispessite. Le fibre fanno parte del legno e della rafia. Un esempio di fibre liberiane non lignificate è il lino;
3) le cellule pietrose hanno forma irregolare e gusci lignificati molto ispessiti. Queste cellule formano gusci di noci, noccioli di drupe, ecc. Le cellule pietrose si trovano nella polpa dei frutti di pera e mela cotogna.
In combinazione con altri tessuti, il tessuto meccanico forma una sorta di “scheletro” della pianta, sviluppato soprattutto nel fusto. Qui spesso forma una sorta di cilindro che corre all'interno dello stelo, o si trova lungo di esso in filamenti separati, fornendo resistenza alla flessione dello stelo. Nella radice, al contrario, il tessuto meccanico si concentra al centro, aumentando la resistenza alla trazione della radice. Il legno svolge anche un ruolo meccanico; anche dopo la morte, le cellule del legno continuano a svolgere una funzione di sostegno.
2.1. Origine e funzioni dello scheletro animale.
Le strutture portanti degli animali invertebrati che forniscono loro una forma corporea permanente sono molto diverse. Sono di origine ecto, ento e mesodermica. Nei vertebrati lo scheletro è principalmente di origine mesodermica.
Lo scheletro nel corpo animale svolge varie funzioni:
Garantire una forma corporea costante;
Parte passiva del sistema muscolo-scheletrico;
Protezione da influenze meccaniche e di altro tipo;
Funzione emopoietica.
2.2. Evoluzione dello scheletro negli animali invertebrati.
Nelle spugne le strutture portanti sono rappresentate da aghi aventi diverse composizioni chimiche.
Nei celenterati appare una densa placca di supporto (mesoglea), che occupa lo spazio tra l'ecto e l'endoderma. Lo scheletro dei polipi corallini si sviluppa dall'ectoderma. Negli artropodi, l'esoscheletro è rappresentato da una copertura chitinizzata, che comprende le funzioni di protezione dai danni meccanici e dall'esoscheletro, a cui sono attaccati i muscoli striati apparsi per la prima volta negli artropodi.
Bivalvi e gasteropodi hanno conchiglie formate da secrezioni del mantello. I cefalopodi hanno complesse formazioni cartilaginee che proteggono i centri nervosi e gli organi sensoriali.
2.3. Evoluzione dello scheletro nei cordati.
Come negli invertebrati, lo scheletro dei cordati funge da protezione per gli organi e funge da supporto per gli organi di locomozione.
Scheletro assiale ha subito grandi cambiamenti nel processo di evoluzione.
Nei cordati inferiori, lo scheletro assile è la notocorda, mentre nei cordati superiori viene gradualmente sostituito dalle vertebre in via di sviluppo. Le vertebre sono divise in corpo, arcata superiore e inferiore.
Pertanto, nei ciclostomi, la notocorda si conserva per tutta la vita, ma compaiono gli anlage vertebrali, che sono piccole formazioni cartilaginee situate metamericamente sopra la notocorda. Sono chiamati archi superiori.
Nei pesci primitivi, oltre agli archi superiori, compaiono gli archi inferiori e nei pesci più alti compaiono i corpi vertebrali. I corpi vertebrali nella maggior parte dei pesci e negli animali superiori sono formati dal tessuto che circonda la notocorda, nonché dalle basi degli archi. Gli archi superiore e inferiore sono fusi con i corpi vertebrali. Le estremità delle arcate superiori crescono insieme, formando il canale spinale. Sulle arcate inferiori compaiono processi a cui sono attaccate le nervature. I pesci hanno due sezioni della colonna vertebrale: il tronco e la caudale. I resti della notocorda nei pesci sono conservati tra i corpi vertebrali.
Negli anfibi, nelle prime fasi dello sviluppo, la notocorda è sostituita da una colonna vertebrale. La colonna vertebrale ha già quattro sezioni: cervicale, toracica, sacrale e caudale. La regione cervicale ha una sola vertebra, la regione toracica è composta da cinque vertebre. Piccole costole che terminano liberamente sono attaccate alle vertebre toraciche. La regione sacrale, come la regione cervicale, comprende una vertebra, che funge da supporto per le ossa del bacino e degli arti posteriori. La regione caudale negli anfibi senza coda è fusa in un unico osso, mentre negli anfibi dalla coda è costituita da un gran numero di vertebre.
I rettili hanno cinque sezioni nella colonna vertebrale: cervicale, toracica, lombare, sacrale e caudale. Nella regione cervicale, diverse specie di rettili hanno un numero diverso di vertebre, ma il massimo è otto. La prima vertebra si chiama atlante e ha la forma di un anello, la seconda si chiama epistrofeo e presenta un processo odontoideo su cui ruota la prima vertebra. Nella regione toracica, il numero di vertebre non è costante, ad esse sono attaccate le costole, la maggior parte delle quali sono collegate allo sterno, formando per la prima volta la gabbia toracica negli animali superiori. Ci sono solo 22 vertebre nella regione toracolombare e due nella regione sacrale. Le costole sono attaccate anche alle vertebre lombari e sacrali. Nella regione caudale il numero delle vertebre varia, a volte ce ne sono diverse dozzine.
Negli uccelli la colonna vertebrale è simile a quella dei rettili, ma presenta una certa specializzazione nella connessione caudale. e la colonna vertebrale: le costole del tronco. Si trova dall'IVDr che circonda la notocorda, così come dalla base della formazione dell'arco, con il modo di vivere. La regione cervicale comprende fino a 25 vertebre, che forniscono una maggiore mobilità.
Nei mammiferi, la colonna vertebrale ha cinque sezioni: toracica cervicale, lombare, sacrale e caudale. Sono presenti sette vertebre nella regione cervicale, e un numero variabile di vertebre in quella toracica (da 9 a 24, ma più spesso 12-13). Le vertebre toraciche sono unite da costole, gran parte delle quali sono collegate allo sterno. La regione lombare comprende da tre a nove vertebre. Le vertebre sacrali sono fuse per formare l'osso sacro e la colonna vertebrale caudale contiene un numero variabile di vertebre nelle diverse specie di mammiferi.
Scheletro della testa. Lo scheletro della testa è il cranio. Si trova all'estremità anteriore dello scheletro ed è costituito da due parti: il cranio e lo scheletro viscerale, che differiscono tra loro sia per origine che per funzione. Il cranio funge da contenitore per il cervello e lo scheletro viscerale fornisce supporto agli organi della parte anteriore del canale digestivo.
Durante il processo di evoluzione, i maggiori cambiamenti si verificano nella regione viscerale. Negli embrioni di tutti i vertebrati, e nei vertebrati inferiori per tutta la vita, lo scheletro viscerale è costituito da archi che ricoprono la parte anteriore del tubo digerente. Nei pesci si differenziano in arco mascellare (cattura del cibo), arco ioide (attaccamento al cranio) e arco branchiale (attaccamento alle branchie).
Negli animali terrestri, lo scheletro viscerale è notevolmente trasformato e ridotto: la parte superiore dell'arco mascellare si fonde con la parte inferiore del cranio e dall'arco ioide si formano piccole ossa, che fanno parte dell'orecchio medio. Il secondo e il terzo arco branchiale nei mammiferi formano la cartilagine tiroidea, mentre il quarto e il quinto arco formano le restanti cartilagini della laringe.
Scheletro degli arti. Esistono due tipi di arti liberi. Queste sono le pinne dei pesci e gli arti a cinque dita dei mammiferi. Gli arti a cinque dita dei vertebrati hanno una struttura molto diversificata, che è associata all'esecuzione di varie funzioni. Ad esempio, gli arti scavatori di una talpa, gli arti natatori di una foca, gli arti arrampicatori delle scimmie, ecc. Tuttavia, nonostante le differenze, gli arti dei vertebrati mantengono un piano strutturale generale, che dimostra la loro origine comune.
Per la prima volta nei pesci apparvero gli arti e furono rappresentati dalle pinne. Queste sono pinne pettorali e ventrali accoppiate. Nella maggior parte dei pesci, le pinne sono costituite da sottili raggi ossei radiali e hanno la funzione di cambiare la direzione del nuoto, piuttosto che di sostenere il corpo. Nei pesci con pinne lobate, si prevede che i raggi si ingrandiscano a causa della fusione e dell'uso delle pinne come supporto e del movimento lungo la base solida dei corpi idrici in prosciugamento. Pertanto, le pinne degli antichi pesci con pinne lobate costituivano la base per lo sviluppo degli arti dei vertebrati. Una caratteristica importante della trasformazione delle pinne negli arti dei vertebrati terrestri è stata la sostituzione della forte connessione degli elementi scheletrici con una connessione mobile sotto forma di articolazioni. Di conseguenza, l'arto si è trasformato in una complessa leva mobile, in cui si distinguono tre ossa: la spalla, l'avambraccio e la mano. Ci sono due cingoli degli arti: spalla e pelvico.
Inoltre, l'evoluzione dell'arto anteriore ha seguito il percorso dell'allungamento della spalla e dell'avambraccio, dell'accorciamento del polso, della riduzione del numero di ossa nella regione carpale (negli anfibi - 3 file, nei mammiferi - 2 file) e dell'allungamento delle sezioni distali, cioè. falangi delle dita.
Lo scheletro della mano umana è caratterizzato anche da un piano strutturale generale con gli arti anteriori dei vertebrati, ma insieme a questo presenta anche importanti differenze, poiché le mani umane non sono solo armi di lavoro, ma anche il suo risultato e sono capaci di compiere una serie di azioni.
2.4. Anomalie e malformazioni dello scheletro umano.
1. La presenza di costole nella vertebra cervicale inferiore o nella prima vertebra lombare. In conformità con l'evoluzione dei vertebrati nell'uomo, durante lo sviluppo embrionale, le costole si formano in tutte le parti della colonna vertebrale, ma successivamente vengono conservate solo nella regione toracica, e in altre parti le costole si riducono. Ma a volte una persona sperimenta atavismi simili.
2. Presenza di vertebre caudali. Durante l'embriogenesi negli esseri umani, come nei vertebrati, si formano 8-11 vertebre caudali, poi si riducono e rimangono 4-5 vertebre sottosviluppate, formando il coccige. A volte compaiono segni atavici sotto forma di presenza della spina caudale.
3. Spina bifida- Questa è un'anomalia comune che si verifica quando la fusione degli archi vertebrali superiori viene interrotta. Si manifesta più spesso nella regione lombosacrale della colonna vertebrale e, a seconda della profondità e dell'estensione della fessura, può avere diversi gradi di gravità.
4. La presenza nella cavità timpanica di un solo ossicolo uditivo: la colonna. Questo disturbo, corrispondente alla struttura dell'apparato di trasmissione del suono di anfibi e rettili, è il risultato di un'errata differenziazione degli elementi dell'arco branchiale mascellare negli ossicini uditivi. Questa è una ricapitolazione delle principali fasi della filogenesi del cranio viscerale nell'ontogenesi.
5. Eterotopia del cingolo degli arti superiori. Questo è il movimento del cingolo degli arti superiori dalla regione cervicale al livello di 1-2 vertebre toraciche. Questa anomalia è chiamata malattia di Sprengel o scapola alta congenita. Si esprime nel fatto che il cingolo scapolare su uno o entrambi i lati è più alto di diversi centimetri rispetto alla posizione normale. Il meccanismo di tale disturbo è associato sia a una violazione del movimento degli organi sia a una violazione delle correlazioni morfogenetiche.
6. Polidattilia- il risultato dello sviluppo degli anlages di dita aggiuntive, caratteristiche di forme ancestrali lontane.
7. Piedi piatti, piedi torti, torace stretto, mancanza di protuberanza del mento– anomalie scheletriche ataviche, che si riscontrano spesso e sono anobolie (supertensioni) insorte durante la filogenesi dei primati.
Il concetto " filogenesi"(dal greco phyle - "clan, tribù" e genesi - "nascita, origine") fu introdotto nel 1866 dal biologo tedesco Ernst Haeckel per denotare lo sviluppo storico degli organismi nel processo di evoluzione.
Consideriamo come la colonna vertebrale si è sviluppata e migliorata dagli organismi più semplici agli esseri umani. È necessario distinguere tra scheletro esterno e interno.
Esoscheletro svolge una funzione protettiva. È inerente ai vertebrati inferiori e si trova sul corpo sotto forma di scaglie o conchiglia (tartaruga, armadillo). Nei vertebrati superiori, lo scheletro esterno scompare, ma rimangono i suoi singoli elementi, cambiando scopo e posizione, diventando le ossa tegumentarie del cranio. Situati già sotto la pelle, sono collegati allo scheletro interno.
Scheletro interno svolge principalmente una funzione di supporto. Durante lo sviluppo, sotto l'influenza del carico biomeccanico, cambia costantemente. Negli animali invertebrati assomiglia a partizioni a cui sono attaccati i muscoli.
Nei cordati primitivi (lancette), insieme ai setti, appare un asse: la notocorda (cordone cellulare), ricoperta da membrane di tessuto connettivo. Nei pesci, la colonna vertebrale è relativamente semplice ed è composta da due sezioni (tronco e caudale). La loro spina dorsale morbida e cartilaginea è più funzionale di quella dei cordati; Il midollo spinale si trova nel canale vertebrale. Lo scheletro del pesce è più perfetto, consentendo movimenti più rapidi e precisi con meno peso.
Con il passaggio allo stile di vita terrestre, si forma una nuova parte dello scheletro: lo scheletro degli arti. E se negli anfibi lo scheletro è costituito da tessuto osseo fibroso grossolano, negli animali terrestri più altamente organizzati è già costituito da tessuto osseo lamellare, costituito da placche ossee contenenti fibre di collagene ordinate.
Lo scheletro interno dei vertebrati attraversa tre fasi di sviluppo nella filogenesi: tessuto connettivo (membranoso), cartilagineo e osseo.
Scheletro di mammifero (a sinistra) e pesce (a destra)
La decodifica del genoma delle lancette, completata nel 2008, ha confermato la vicinanza delle lancette all'antenato comune dei vertebrati. Secondo gli ultimi dati scientifici le lancette sono parenti dei vertebrati, anche se i più lontani.
La colonna vertebrale dei mammiferi è costituita dalle sezioni cervicale, toracica, lombare, sacrale e caudale. La sua caratteristica è la forma platyceliale (con superfici piatte) delle vertebre, tra le quali si trovano i dischi intervertebrali cartilaginei. Le arcate superiori sono ben definite.
Nella regione cervicale, tutti i mammiferi hanno 7 vertebre, la cui lunghezza determina la lunghezza del collo. Le uniche eccezioni sono due animali: il lamantino ha 6 di queste vertebre, e diversi tipi di bradipi ne hanno da 8 a 10. Nella giraffa, le vertebre cervicali sono molto lunghe, e nei cetacei, che non hanno intercettazione cervicale, sono sono, al contrario, estremamente brevi.
Le costole sono attaccate alle vertebre toraciche per formare la gabbia toracica. Lo sterno che lo chiude è piatto e solo nei pipistrelli e nei rappresentanti di specie scavatrici con potenti arti anteriori (ad esempio le talpe) ha una piccola cresta (chiglia) alla quale sono attaccati i muscoli pettorali. La regione toracica contiene 9-24 (solitamente 12-15) vertebre, le ultime 2-5 recano false costole che non raggiungono lo sterno.
Nella regione lombare sono presenti da 2 a 9 vertebre; Le costole rudimentali si fondono con i loro grandi processi trasversali. La sezione sacrale è formata da 4-10 vertebre fuse, di cui solo le prime due sono veramente sacrali, mentre le restanti sono caudali. Il numero di vertebre caudali libere varia da 3 (nel gibbone) a 49 (nella lucertola dalla coda lunga).
La mobilità delle singole vertebre dipende dallo stile di vita. Pertanto, nei piccoli animali che corrono e si arrampicano, è alto lungo l'intera lunghezza della colonna vertebrale, quindi il loro corpo può piegarsi in direzioni diverse e persino raggomitolarsi in una palla. Le vertebre delle regioni toracica e lombare sono meno mobili negli animali grandi e veloci. Nei mammiferi che si muovono sulle zampe posteriori (canguri, jerboa, saltatori), le vertebre più grandi si trovano alla base della coda e dell'osso sacro, quindi le loro dimensioni diminuiscono successivamente. Negli ungulati, al contrario, le vertebre e soprattutto i loro processi spinosi sono più grandi nella parte anteriore della regione toracica, dove ad esse sono attaccati i potenti muscoli del collo e in parte gli arti anteriori.
Negli uccelli, gli arti anteriori (ali) sono adatti al volo e gli arti posteriori sono adatti al movimento sul terreno. Caratteristica peculiare dello scheletro è la pneumaticità delle ossa: sono più leggere perché contengono aria. Anche le ossa degli uccelli sono piuttosto fragili, poiché sono ricche di sali di calcio, e quindi la forza dello scheletro è in gran parte ottenuta dalla fusione di molte ossa.
Il sistema muscolo-scheletrico garantisce il movimento e il mantenimento della posizione del corpo dell'animale nello spazio, forma la forma esterna del corpo e partecipa ai processi metabolici. Rappresenta circa il 60% del peso corporeo di un animale adulto.
Convenzionalmente, il sistema muscolo-scheletrico è diviso in parti passive e attive. A parte passiva comprendono le ossa e le loro connessioni, da cui dipende la natura della mobilità delle leve ossee e dei collegamenti del corpo dell'animale (15%). Parte attivaè costituito dai muscoli scheletrici e dalle loro inserzioni ausiliarie, grazie alle cui contrazioni vengono messe in movimento le ossa dello scheletro (45%). Sia la parte attiva che quella passiva hanno un'origine comune (mesoderma) e sono strettamente interconnesse.
Funzioni dell'apparato motorio:
1) L'attività motoria è una manifestazione dell'attività vitale dell'organismo; è ciò che distingue gli organismi animali da quelli vegetali e determina l'emergere di un'ampia varietà di modalità di movimento (camminare, correre, arrampicarsi, nuotare, volare).
2) Il sistema muscolo-scheletrico forma la forma del corpo - esterno animale, poiché la sua formazione è avvenuta sotto l'influenza del campo gravitazionale terrestre, le sue dimensioni e forma negli animali vertebrati si distinguono per una significativa diversità, che si spiega con diverse condizioni di vita (terrestre, terrestre-legnoso, arioso, acquatico).
3) Inoltre, l'apparato motorio fornisce una serie di funzioni vitali del corpo: cercare e catturare il cibo; attacco e difesa attiva; svolge la funzione respiratoria dei polmoni (respiratorio capacità motorie); Aiuta il cuore a spostare il sangue e la linfa attraverso i vasi (“cuore periferico”).
4) Negli animali a sangue caldo (uccelli e mammiferi), l'apparato motorio assicura il mantenimento di una temperatura corporea costante;
Le funzioni dell'apparato motorio sono fornite dai sistemi nervoso e cardiovascolare, organi respiratori, digestivi e urinari, pelle, ghiandole endocrine. Poiché lo sviluppo dell'apparato motorio è indissolubilmente legato allo sviluppo del sistema nervoso, quando queste connessioni vengono interrotte, prima paresi, poi paralisi apparato motorio (l'animale non può muoversi). Con una diminuzione dell'attività fisica, i processi metabolici vengono interrotti e l'atrofia dei tessuti muscolari e ossei.
Gli organi del sistema muscolo-scheletrico hanno proprietà delle deformazioni elastiche, quando si muovono, in essi si forma energia meccanica sotto forma di deformazioni elastiche, senza le quali non possono verificarsi la normale circolazione sanguigna e gli impulsi del cervello e del midollo spinale. L'energia delle deformazioni elastiche nelle ossa viene convertita in energia piezoelettrica e nei muscoli in energia termica. L'energia rilasciata durante il movimento sposta il sangue dai vasi e provoca l'irritazione dell'apparato recettore, da cui gli impulsi nervosi entrano nel sistema nervoso centrale. Pertanto, il lavoro dell'apparato motorio è strettamente connesso e non può essere svolto senza il sistema nervoso, e il sistema vascolare, a sua volta, non può funzionare normalmente senza l'apparato motorio.
La base della parte passiva dell'apparato motorio è lo scheletro. Scheletro (greco sceletos - essiccato, essiccato; lat. Scheletro) sono ossa collegate in un certo ordine che formano una struttura solida (scheletro) del corpo dell'animale. Poiché la parola greca per osso è “os”, viene chiamata la scienza dello scheletro osteologia.
Lo scheletro comprende circa 200-300 ossa (cavallo, r.s. -207-214; maiale, cane, gatto -271-288), che sono collegate tra loro tramite tessuto connettivo, cartilagineo o osseo. La massa scheletrica di un animale adulto varia dal 6% (maiale) al 15% (cavallo, bovino).
Tutto funzioni scheletriche possono essere divisi in due grandi gruppi: meccanici e biologici. A funzioni meccaniche includono: protettivo, supporto, locomotore, molla, antigravità e biologico – metabolismo ed emopoiesi (emocitopoiesi).
1) La funzione protettiva è che lo scheletro forma le pareti delle cavità corporee in cui si trovano gli organi vitali. Ad esempio, la cavità cranica contiene il cervello, il torace contiene il cuore e i polmoni e la cavità pelvica contiene gli organi genito-urinari.
2) La funzione di sostegno è che lo scheletro fornisce un supporto ai muscoli e agli organi interni che, una volta attaccati alle ossa, vengono mantenuti nella loro posizione.
3) La funzione locomotrice dello scheletro si manifesta nel fatto che le ossa sono leve azionate dai muscoli e assicurano il movimento dell'animale.
4) La funzione primaverile è dovuta alla presenza nello scheletro di formazioni che ammorbidiscono urti e shock (cuscinetti cartilaginei, ecc.).
5) La funzione antigravitazionale si manifesta nel fatto che lo scheletro crea supporto per la stabilità del corpo che si eleva dal suolo.
6) Partecipazione al metabolismo, in particolare al metabolismo minerale, poiché le ossa sono un deposito di sali minerali di fosforo, calcio, magnesio, sodio, bario, ferro, rame e altri elementi.
7) Funzione tampone. Lo scheletro agisce come un tampone che stabilizza e mantiene costante la composizione ionica dell'ambiente interno del corpo (omeostasi).
8) Partecipazione all'emocitopoiesi. Situato nelle cavità del midollo osseo, il midollo osseo rosso produce globuli. La massa del midollo osseo rispetto alla massa delle ossa negli animali adulti è di circa il 40-45%.
DIVISIONE SCHELETRICA
Lo scheletro è la struttura del corpo di un animale. Di solito è diviso in principale e periferico.
Allo scheletro assile comprendono lo scheletro della testa (cranio-cranio), lo scheletro del collo, del busto e della coda. Il cranio ha la struttura più complessa, poiché contiene il cervello, gli organi della vista, dell'olfatto, dell'equilibrio e dell'udito, le cavità orale e nasale. La parte principale dello scheletro del collo, del corpo e della coda è la colonna vertebrale (columna vertebralis).
La colonna vertebrale è divisa in 5 sezioni: cervicale, toracica, lombare, sacrale e caudale. La regione cervicale è costituita dalle vertebre cervicali (v.cervicalis); regione toracica - dalle vertebre toraciche (v.thoracica), costole (costa) e sterno (sternum); lombare: dalle vertebre lombari (v.lumbalis); sacro: dall'osso sacro (os sacrum); caudale - dalle vertebre caudali (v.caudalis). La struttura più completa presenta la sezione toracica del corpo, dove sono presenti le vertebre toraciche, le costole e lo sterno, che insieme formano il torace (torace), in cui si trovano il cuore, i polmoni e gli organi mediastinici. La regione della coda è la meno sviluppata negli animali terrestri, che è associata alla perdita della funzione locomotrice della coda durante la transizione degli animali allo stile di vita terrestre.
Lo scheletro assile è soggetto alle seguenti leggi della struttura corporea, che garantiscono la mobilità dell'animale. Questi includono :
1) La bipolarità (uniassialità) si esprime nel fatto che tutte le parti dello scheletro assile si trovano sullo stesso asse del corpo, con il cranio sul polo craniale e la coda sul polo opposto. Il segno di monoassialità permette di stabilire due direzioni nel corpo dell’animale: craniale – verso la testa e caudale – verso la coda.
2) La bilateralità (simmetria bilaterale) è caratterizzata dal fatto che lo scheletro, come il busto, può essere diviso dal piano sagittale mediale in due metà simmetriche (destra e sinistra), in base a ciò le vertebre saranno divise in due metà simmetriche. La bilateralità (antimerismo) consente di distinguere le direzioni laterale (laterale, esterna) e mediale (interna) sul corpo dell'animale.
3) La segmentazione (metamerismo) sta nel fatto che il corpo può essere diviso da piani segmentali in un certo numero di metameri - segmenti relativamente identici. I metameri seguono un asse dalla parte anteriore a quella posteriore. Sullo scheletro tali metameri sono vertebre con costole.
4) Tetrapodio è la presenza di 4 arti (2 toracici e 2 pelvici)
5) E l'ultima regolarità è, a causa della forza di gravità, la collocazione nel canale spinale del tubo neurale, e sotto di esso il tubo intestinale con tutti i suoi derivati. A questo proposito, sul corpo è segnata la direzione dorsale - verso la schiena e la direzione ventrale - verso l'addome.
Scheletro periferico rappresentato da due paia di arti: toracico e pelvico. Nello scheletro degli arti esiste un solo modello: bilateralità (antimerismo). Gli arti sono accoppiati, ci sono arti sinistro e destro. I restanti elementi sono asimmetrici. Sugli arti sono presenti cinture (toraciche e pelviche) e uno scheletro di arti liberi.
Utilizzando una cintura, l'arto libero è fissato alla colonna vertebrale. Inizialmente i cingoli degli arti avevano tre paia di ossa: una scapola, una clavicola e un osso coracoideo (tutti conservati negli uccelli); negli animali rimaneva solo una scapola; dell'osso coracoideo solo un processo sul tubercolo della scapola su il lato mediale è stato conservato; rudimenti della clavicola sono presenti nei predatori (cani) e gatti). Nella cintura pelvica, tutte e tre le ossa (iliaca, pubica e ischiatica) sono ben sviluppate e crescono insieme.
Lo scheletro degli arti liberi presenta tre maglie. Il primo anello (stilopodium) ha un raggio (greco stilos - colonna, podos - gamba): sull'arto toracico è l'omero, sull'arto pelvico è il femore. I secondi anelli (zeugopodium) sono rappresentati da due raggi (zeugos - coppia): sull'arto toracico sono presenti le ossa del radio e dell'ulna (ossa dell'avambraccio), sull'arto pelvico sono presenti le ossa della tibia e del perone (ossa della tibia) . I terzi collegamenti (autotipodio) si formano: sull'arto toracico - la mano, sull'arto pelvico - il piede. Si distinguono tra basipodi (la sezione superiore - le ossa del polso e, di conseguenza, il tarso), metapodio (al centro - le ossa del metacarpo e del metatarso) e acropodio (la sezione più esterna - le falangi delle dita).
FILOGENESI SCHELETRICA
Nella filogenesi dei vertebrati, lo scheletro si sviluppa in due direzioni: esterna e interna.
L'esoscheletro svolge una funzione protettiva, è caratteristico dei vertebrati inferiori e si trova sul corpo sotto forma di scaglie o conchiglia (tartaruga, armadillo). Nei vertebrati superiori, lo scheletro esterno scompare, ma rimangono i suoi singoli elementi, cambiando scopo e posizione, diventando le ossa di copertura del cranio e, situati sotto la pelle, collegati allo scheletro interno. Nella filoontogenesi, tali ossa attraversano solo due fasi di sviluppo (tessuto connettivo e osso) e sono chiamate primarie. Non sono in grado di rigenerarsi; se le ossa del cranio vengono ferite, sono costrette a essere sostituite con placche artificiali.
Lo scheletro interno svolge principalmente una funzione di sostegno. Durante lo sviluppo, sotto l'influenza del carico biomeccanico, cambia costantemente. Se consideriamo gli animali invertebrati, il loro scheletro interno ha la forma di partizioni a cui sono attaccati i muscoli.
Nel primitivo cordati animali (lancetta ), Insieme ai setti appare un asse: la notocorda (cordone cellulare), ricoperta da membrane di tessuto connettivo.
U pesci cartilaginei(squali, razze) gli archi cartilaginei si formano segmentalmente attorno alla notocorda, che successivamente formano le vertebre. Le vertebre cartilaginee, collegandosi tra loro, formano la colonna vertebrale e le costole sono attaccate ad essa ventralmente. Pertanto, la notocorda rimane sotto forma di nuclei polposi tra i corpi vertebrali. Il cranio si forma all'estremità craniale del corpo e, insieme alla colonna vertebrale, partecipa alla formazione dello scheletro assile. Successivamente lo scheletro cartilagineo viene sostituito da uno osseo, meno flessibile, ma più resistente.
U pesce ossuto lo scheletro assile è costituito da tessuto osseo più forte, fibroso, caratterizzato dalla presenza di sali minerali e da una disposizione casuale delle fibre di collagene (osseina) nella componente amorfa.
Con la transizione degli animali verso uno stile di vita terrestre, anfibi si forma una nuova parte dello scheletro: lo scheletro degli arti. Di conseguenza, negli animali terrestri, oltre allo scheletro assile, si forma anche uno scheletro periferico (lo scheletro degli arti). Negli anfibi, così come nei pesci ossei, lo scheletro è costituito da tessuto osseo fibroso grossolano, ma negli animali terrestri più altamente organizzati (rettili, uccelli e mammiferi) lo scheletro è già costituito da tessuto osseo lamellare, costituito da placche ossee contenenti fibre di collagene (osseina) disposte in modo ordinato.
Pertanto, lo scheletro interno dei vertebrati attraversa tre fasi di sviluppo nella filogenesi: tessuto connettivo (membranoso), cartilagineo e osseo. Le ossa dello scheletro interno che attraversano tutte queste tre fasi sono chiamate secondarie (primordiali).
ONTOGENESI DELLO SCHELETRO
Secondo la legge biogenetica fondamentale di Baer e E. Haeckel, anche nell'ontogenesi lo scheletro attraversa tre stadi di sviluppo: membranoso (tessuto connettivo), cartilagineo e osseo.
Nella prima fase dello sviluppo embrionale, la parte portante del suo corpo è il tessuto connettivo denso, che forma lo scheletro membranoso. Quindi nell'embrione appare una notocorda e attorno ad essa iniziano a formarsi prima la colonna vertebrale cartilaginea e poi quella ossea e il cranio, quindi gli arti.
Nel periodo prefetale l'intero scheletro, ad eccezione delle ossa tegumentarie primarie del cranio, è cartilagineo e costituisce circa il 50% del peso corporeo. Ogni cartilagine ha la forma di un futuro osso ed è ricoperta da pericondrio (una membrana di tessuto connettivo denso). Durante questo periodo inizia l'ossificazione dello scheletro, ad es. formazione di tessuto osseo al posto della cartilagine. L'ossificazione o ossificazione (latino os - bone, facio - do) avviene sia dalla superficie esterna (ossificazione pericondrale) che dall'interno (ossificazione encondrale). Al posto della cartilagine si forma tessuto osseo fibroso grossolano. Di conseguenza, nei frutti lo scheletro è costituito da tessuto osseo fibroso grossolano.
Solo nel periodo neonatale il tessuto osseo fibroso grossolano viene sostituito da tessuto osseo lamellare più avanzato. Durante questo periodo è necessaria un'attenzione particolare ai neonati, poiché il loro scheletro non è ancora forte. Per quanto riguarda la notocorda, i suoi resti si trovano al centro dei dischi intervertebrali sotto forma di nuclei polposi. Durante questo periodo, è necessario prestare particolare attenzione alle ossa tegumentarie del cranio (occipitale, parietale e temporale), poiché aggirano lo stadio cartilagineo. Tra di loro nell'ontogenesi si formano importanti spazi di tessuto connettivo chiamati fontanelle (fonticoli) che solo in età avanzata vanno incontro a completa ossificazione (ossificazione dell'endesma).