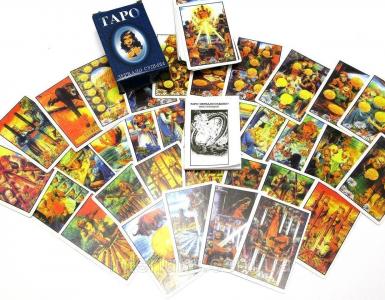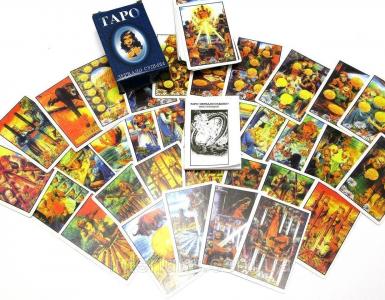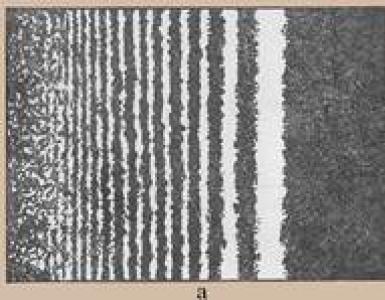Quali cellule producono anticorpi? Sintesi di anticorpi. Metodologia per la sintesi di anticorpi per infezioni virali. Immunoglobuline Cellula che sintetizza gli anticorpi
Immunoglobuline
Anticorpi(immunoglobuline, IG, Ig) sono proteine appartenenti alla sottoclasse delle gamma globuline presenti nel sangue, nella saliva, nel latte e in altri fluidi biologici degli animali vertebrati. Le immunoglobuline sono sintetizzate dai linfociti B in risposta a sostanze estranee di una certa struttura: gli antigeni. Gli anticorpi vengono utilizzati dal sistema immunitario per identificare e neutralizzare oggetti estranei, come batteri e virus. Gli anticorpi svolgono due funzioni: una funzione di legame con l'antigene e una funzione effettrice (ad esempio, avviando lo schema classico di attivazione del complemento e legame con le cellule), sono il fattore più importante nell'immunità umorale specifica e sono costituiti da due catene leggere e due catene pesanti. Nei mammiferi esistono cinque classi di immunoglobuline: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, che differiscono nella struttura e nella composizione aminoacidica delle catene pesanti.
Storia dello studio
Il primo anticorpo fu scoperto da Behring e Kitazato nel 1890, ma a quel tempo non si poteva dire nulla di preciso sulla natura dell'antitossina tetanica scoperta, oltre alla sua specificità e alla sua presenza nel siero di un animale immune. Solo nel 1937, con le ricerche di Tiselius e Kabat, iniziò lo studio della natura molecolare degli anticorpi. Gli autori hanno utilizzato il metodo dell'elettroforesi e hanno dimostrato un aumento della frazione gamma-globulina del siero sanguigno degli animali immunizzati. L'adsorbimento del siero da parte dell'antigene prelevato per l'immunizzazione ha ridotto la quantità di proteine in questa frazione al livello degli animali intatti.
Struttura degli anticorpi
Piano generale della struttura delle immunoglobuline: 1) Fc; 3) catena pesante; 4) catena leggera; 5) sito di legame con l'antigene; 6) sezione cerniera
Gli anticorpi sono glicoproteine relativamente grandi (~150 kDa - IgG) con una struttura complessa. Sono costituiti da due catene pesanti (catene H, a loro volta costituite dai domini VH, CH1, cerniera, CH2 e CH3) e due catene leggere (catene L, costituite dai domini VL e CL). Gli oligosaccaridi sono legati covalentemente alle catene pesanti. Usando la proteasi della papaina, gli anticorpi possono essere divisi in due Fc (dal frammento cristallizzabile - un frammento capace di cristallizzare). A seconda della classe e delle funzioni svolte, gli anticorpi possono esistere sia in forma monomerica (IgG, IgD, IgE, IgA sierica) che in forma oligomerica (IgA dimero-secernenti, pentamero - IgM). In totale, ci sono cinque tipi di catene pesanti (catene α, γ, δ, ε e μ) e due tipi di catene leggere (catena κ e catena λ).
Classificazione delle catene pesanti
Ci sono cinque classi (chiamate anche isotipi) anticorpi che differiscono per struttura e funzione. L'unità strutturale di base di tutti gli anticorpi è costituita da due identici pesante catene e due polmoni catene collegate da ponti disolfuro. Gli isotipi degli anticorpi differiscono nella struttura della catena pesante (IgG contiene due catene γ, IgA - due catene α, IgM - due catene μ, IgD - due catene δ, IgE - due catene ε), struttura oligomerica e sito di sintesi.
- L'IgG è la principale immunoglobulina nel siero di una persona sana (rappresenta il 70-75% della frazione immunoglobulinica totale) ed è più attiva nella risposta immunitaria secondaria e nell'immunità antitossica. A causa delle sue piccole dimensioni (coefficiente di sedimentazione 7S, peso molecolare 146 kDa) è l'unica frazione di immunoglobuline in grado di trasportare attraverso la barriera placentare e quindi fornire immunità al feto e al neonato.
- L'IgM è un pentamero di un'unità base a quattro catene contenente due catene μ. Compaiono durante la risposta immunitaria primaria ad un antigene sconosciuto e costituiscono fino al 10% della frazione immunoglobulinica. Sono le immunoglobuline più grandi (970 kDa).
- IgA sieriche Le IgA costituiscono il 15-20% della frazione immunoglobulinica totale, mentre nell'uomo l'80% delle molecole IgA sono presentate in forma monomerica. Le IgA secretorie si presentano in forma dimerica in un complesso con una componente secretoria, presente nelle secrezioni sierose-mucose (ad esempio, nella saliva, nel colostro, nel latte, secreti dalla mucosa del sistema genito-urinario e respiratorio).
- Le IgD costituiscono meno dell'1% della frazione immunoglobulinica plasmatica e si trovano principalmente sulla membrana di alcuni linfociti B. Le sue funzioni non sono del tutto chiare; si tratta presumibilmente di un recettore antigenico per i linfociti B che non si sono ancora presentati all'antigene.
- Le IgE- sono associate alle membrane dei basofili e dei mastociti e sono quasi assenti in forma libera nel plasma. Associato a reazioni allergiche.
Specificità degli anticorpi
Teoria della selezione clonale significa che ogni linfocita sintetizza anticorpi di una sola specificità specifica. E questi anticorpi si trovano sulla superficie di questo linfocita come recettori.
Come mostrano gli esperimenti, tutte le immunoglobuline della superficie cellulare hanno lo stesso idiottipo: quando un antigene solubile, simile alla flagellina polimerizzata, si lega a una cellula specifica, tutte le immunoglobuline della superficie cellulare si legano a questo antigene e hanno la stessa specificità, cioè la stessa idiottipo.
L'antigene si lega ai recettori, quindi attiva selettivamente la cellula per produrre grandi quantità di anticorpi. E poiché la cellula sintetizza anticorpi di una sola specificità, questa specificità deve coincidere con la specificità del recettore di superficie iniziale.
La specificità dell'interazione degli anticorpi con gli antigeni non è assoluta; possono reagire in modo crociato con altri antigeni a vari livelli. L'antisiero elevato a un antigene può reagire con un antigene correlato che trasporta uno o più determinanti uguali o simili. Pertanto ciascun anticorpo può reagire non solo con l'antigene che ne ha causato la formazione, ma anche con altre molecole, a volte del tutto indipendenti. La specificità degli anticorpi è determinata dalla sequenza aminoacidica delle regioni variabili delle Ig.
Teoria della selezione clonale:
- Anticorpi e linfociti con la specificità richiesta esistono già nell'organismo prima del primo contatto con l'antigene.
- I linfociti che partecipano alla risposta immunitaria hanno recettori antigene-specifici sulla superficie della loro membrana. I linfociti B hanno molecole recettoriali della stessa specificità degli anticorpi che i linfociti successivamente producono e secernono.
- Ogni linfocita porta sulla sua superficie recettori con una sola specificità.
- I linfociti che possiedono l'antigene subiscono una fase di proliferazione e formano un grande clone di plasmacellule. Le plasmacellule sintetizzano anticorpi solo con la specificità per la quale è stato programmato il linfocita precursore. I segnali per la proliferazione sono le citochine, che vengono rilasciate da altre cellule. I linfociti stessi possono secernere citochine.
Variabilità degli anticorpi
Gli anticorpi sono estremamente variabili (nel corpo di una persona possono esistere fino a 0,1 miliardi di varianti anticorpali). Tutta la diversità anticorpale deriva dalla variabilità sia delle catene pesanti che delle catene leggere. Gli anticorpi prodotti dall'uno o dall'altro organismo in risposta a determinati antigeni si distinguono:
- Isotipico variabilità - manifestata in presenza di classi di anticorpi (isotipi), che differiscono nella struttura delle catene pesanti e dell'oligomerità, prodotte da tutti gli organismi di una determinata specie;
- Allotipico la variabilità - si manifesta a livello individuale all'interno di una data specie sotto forma di variabilità degli alleli delle immunoglobuline - è una differenza geneticamente determinata tra un dato organismo e un altro;
- Idiotipico variabilità - si manifesta nelle differenze nella composizione aminoacidica del sito di legame dell'antigene. Ciò vale per i domini variabili e ipervariabili delle catene pesanti e leggere che sono a diretto contatto con l'antigene.
Controllo della proliferazione
Il meccanismo di controllo più efficace è che il prodotto della reazione funge contemporaneamente da inibitore. Questo tipo di feedback negativo si verifica durante la formazione degli anticorpi. L'effetto degli anticorpi non può essere spiegato semplicemente con la neutralizzazione dell'antigene, perché le molecole intere di IgG sopprimono la sintesi degli anticorpi in modo molto più efficace dei frammenti F(ab")2. Si presume che il blocco della fase produttiva del B-T-dipendente la risposta cellulare si verifica come risultato della formazione di legami incrociati tra i recettori dell'antigene, IgG e Fc sulla superficie delle cellule B. L'iniezione di IgM migliora la risposta immunitaria. Poiché gli anticorpi di questo particolare isotipo compaiono per primi dopo l'introduzione di un antigene , viene loro attribuito un ruolo potenziante nella fase iniziale della risposta immunitaria.
- A. Reuth, J. Brustoff, D. Meil. Immunologia - M.: Mir, 2000 - ISBN 5-03-003362-9
- Immunologia in 3 volumi / Sotto. ed. U. Paolo - M.: Mir, 1988
- V. G. Galaktionov. Immunologia - M.: Casa editrice. MSU, 1998 - ISBN 5-211-03717-0
Guarda anche
- Gli abzimi sono anticorpi cataliticamente attivi
| Sistema immunitario/Immunologia | |
|---|---|
| Sistemi | Sistema immunitario adattativo e Sistema immunitario innato Sistema immunitario umorale e Sistema immunitario cellulare Sistema complementare (Anafilotossine) Immunità intrinseca |
| Antigeni e anticorpi | Antigene (superantigene, allergene) Epitopo aptenico (epitopo lineare, epitopo conformazionale) Anticorpo (anticorpi monoclonali, anticorpi policlonali, autoanticorpi) Risposta policlonale delle cellule B Allotipi di anticorpi Isotipi di anticorpi Idiotipi di anticorpi Complesso immunitario |
| Cellule del sistema immunitario Leucociti |
Fagociti: Neutrofili, Macrofagi, Sistema reticoloendoteliale Cellule presentanti l'antigene: Cellule dendritiche Cellule B macrofagi |
| Immunità e tolleranza | azione: Immunità · Autoimmunità · Allergia · Infiammazione · Reattività crociata inazione: Tolleranza immunologica (anergia centrale, periferica, anergia clonale, delezione clonale) Immunodeficienza |
| Immunogenetica | Ipermutazione somatica Ricombinazione V(D)J Cambio di classe Complesso maggiore di istocompatibilità /HLA |
| Sostanze | Citochine Opsonina Citolisina |
| Altro | Immunologia diagnostica |
| Organi del sistema immunitario | Timo · Milza · Linfonodi · Sangue · Midollo osseo · Linfa · Malattie del sistema immunitario |
Fondazione Wikimedia. 2010.
Scopri cosa sono le “immunoglobuline” in altri dizionari:
Anticorpi, proteine complesse (glicoproteine) che si legano specificamente a sostanze estranee - antigeni; principali molecole effettrici dell’immunità umorale. Contenuto nella frazione globulinica del siero sanguigno, nella linfa, nella saliva e... ... Dizionario di microbiologia
Enciclopedia moderna
Proteine (glicoproteine) che hanno attività anticorpale. Contenuto principalmente nella frazione globulina del plasma (siero) del sangue dei vertebrati e dell'uomo. Sono sintetizzati dalle plasmacellule e partecipano alla creazione dell'immunità. Medicinali... Grande dizionario enciclopedico
Ig, anticorpi, proteine complesse (glicoproteine), che si legano specificamente a sostanze estranee; cap. molecole effettrici dell’immunità umorale. Contenuto nella frazione globulina del siero del sangue, nella linfa (anticorpi circolanti) ... Dizionario enciclopedico biologico
immunoglobuline- Preparazioni Ig per l'immunizzazione passiva contenenti anticorpi. Precedentemente note come gammaglobuline. [Glossario inglese-russo dei termini fondamentali della vaccinologia e dell'immunizzazione. Organizzazione Mondiale della Sanità, 2009] Argomenti: vaccinologia, ... ... Guida del traduttore tecnico
Immunoglobuline- (dal latino immunis, libero da qualsiasi cosa e palla globus), proteine globulari dei vertebrati e dell'uomo ad attività anticorpale; prodotto dai linfociti B. Contenuto principalmente nel plasma sanguigno e in altri fluidi corporei.… … Dizionario enciclopedico illustrato
- (Ig), un gruppo di quelli chimicamente correlati. la natura e le proprietà delle proteine globulari dei vertebrati e dell'uomo, che di solito possiedono anticorpi, cioè specifici. la capacità di legarsi ad un antigene, che ne stimola la formazione. I. sono prodotti in... ... Enciclopedia chimica
Ov; per favore (unità immunoglobulina, a; m.). Proteine contenute nel plasma sanguigno che hanno attività anticorpale e contribuiscono all'emergere dell'immunità nei vertebrati e nell'uomo. * * * proteine immunoglobuline (glicoproteine) con attività... ... Dizionario enciclopedico
immunoglobuline- (Ig, dal latino immunis libero da tutto e globus ball), proteine globulari dei vertebrati, prodotte dai linfociti e, di regola, dotate di attività anticorpale. Concetti "Io". e “gammaglobuline” non possono essere usati come sinonimi,... ... Agricoltura. Ampio dizionario enciclopedico
- (immuno+globuline; sinonimo: immunoglobuline) globuline umane e animali che svolgono la funzione di anticorpi... Ampio dizionario medico
Gli anticorpi o immunoglobuline sono glicoproteine solubili dell'uomo e degli animali a sangue caldo, presenti nel siero del sangue (che comprende circa il 30% di tutte le proteine sieriche), nei tessuti e in altri fluidi o sulla membrana di alcuni tipi di cellule (linfociti B) e sono coinvolti nel riconoscimento e nella neutralizzazione di oggetti estranei (antigeni), come batteri e virus. Le immunoglobuline riconoscono specificamente gli antigeni legandosi a un epitopo specifico, un frammento caratteristico della superficie o sequenza amminoacidica lineare dell'antigene. Furono scoperti per la prima volta nel 1890 da Bering e Kitasato. Esistono anticorpi policlonali (prodotti da cellule diverse) e monoclonali (discendenti di una cellula).
Le proprietà degli anticorpi includono:
- affinità - affinità per un antigene, la forza dell'interazione di un anticorpo con un antigene. Determinato tramite K A o K D . Gli anticorpi ad alta affinità hanno K D ≈ 10 9 -10 11 M -1
- specificità: interazione di un anticorpo con un epitopo specifico di un antigene
- bifunzionalità: riconoscimento e legame dell'antigene e prestazione delle funzioni effettrici
A questo proposito, gli anticorpi che eseguono il riconoscimento dell'antigene, il legame con l'antigene e una serie di funzioni effettrici sono il fattore più importante nell'immunità umorale specifica (Tabella 1).
Tabella 1. Classificazione degli anticorpi dei mammiferi in base alle loro funzioni effettrici, struttura e composizione aminoacidica delle catene pesanti.
Tipi di anticorpi e loro sintesi.
La sintesi delle molecole di immunoglobuline avviene nelle plasmacellule. Le catene pesanti e leggere della molecola sono sintetizzate su diversi cromosomi e sono codificate da diversi gruppi di geni. La dinamica della produzione di anticorpi in risposta a uno stimolo antigenico dipende dal fatto che l'organismo incontri questo antigene per la prima volta o ripetutamente. Durante la risposta immunitaria primaria, la comparsa degli anticorpi nel sangue è preceduta da un periodo di latenza di 3-4 giorni. Le prime immunoglobuline formate appartengono alle IgG. Quindi la quantità di anticorpi aumenta bruscamente e la sintesi passa dagli anticorpi IgG agli anticorpi IgG. Il livello massimo di anticorpi nel sangue si verifica nei giorni 7-11, dopodiché il loro numero diminuisce gradualmente. La risposta immunitaria secondaria è caratterizzata da un periodo di latenza più breve, un aumento più rapido dei titoli anticorpali e un valore massimo maggiore. È caratteristica la formazione immediata di anticorpi IgG. La capacità di produrre una risposta immunitaria secondaria persiste per molti anni ed è una manifestazione della memoria immunologica, un esempio della quale è l'immunità contro il morbillo e il vaiolo.
Isolamento e purificazione degli anticorpi.
Esistono metodi non specifici e specifici per isolare gli anticorpi. I metodi non specifici includono il frazionamento dei sieri immunitari, che si traduce in frazioni arricchite con anticorpi, molto spesso una frazione di anticorpi IgG. Questi includono la salatura delle immunoglobuline con solfato di ammonio o solfato di sodio, la precipitazione di immunoglobuline con alcol, metodi di elettroforesi preparativa e cromatografia a scambio ionico e cromatografia su gel. La purificazione specifica si basa sull'isolamento di anticorpi da un complesso con un antigene e porta alla produzione di immunoglobuline con la stessa specificità, ma eterogenee nelle proprietà fisico-chimiche. La procedura consiste nelle seguenti fasi: ottenere un precipitato specifico (complesso antigene-anticorpo) e lavarlo dai restanti componenti del siero; dissociazione precipitata; separazione degli anticorpi dall'antigene in base alle differenze nel loro peso molecolare, carica e altre proprietà fisico-chimiche. Per l'isolamento specifico degli anticorpi, sono ampiamente utilizzati gli immunoassorbenti: portatori insolubili su cui è fissato l'antigene. In questo caso, la procedura per ottenere immunoglobuline è molto semplificata e prevede il passaggio del siero immunitario attraverso una colonna con un immunoassorbente, il lavaggio dell'immunosorbente dalle proteine sieriche non legate, l'eluizione dell'anticorpo fissato sull'immunoassorbente a bassi valori di pH e la rimozione dell'agente dissociante mediante dialisi.
L'azienda Bialexa produce e vende prodotti altamente sensibili per la diagnostica in vitro e la ricerca scientifica. Nel nostro catalogo, che comprende più di 300 articoli, troverete una gamma completa di prodotti nei seguenti settori dell'immunodiagnostica: malattie cardiovascolari, medicina veterinaria, ormoni, immunologia, malattie infettive e virali, coagulazione del sangue, anemia, fertilità e riproduzione.
Le coppie di anticorpi consigliate vengono sottoposte a test preliminari con campioni clinici. Gli anticorpi e gli antigeni funzionano in modo affidabile in una gamma di metodi immunochimici, come i test immunologici diretti e indiretti (ELISA), i test immunologici sandwich, il Western blotting, l'immunoprecipitazione, l'immunocromatografia, l'immunofluorescenza e la colorazione immunocitochimica.
L'immunità è un modo per proteggere il corpo da sostanze geneticamente estranee - antigeni di origine esogena ed endogena, finalizzato a mantenere e preservare l'omeostasi, l'integrità strutturale e funzionale del corpo, l'individualità biologica (antigenica) di ciascun organismo e della specie come Totale.
Produzione di anticorpi mediante risposta immunitaria primaria e secondaria.
Esistono due opzioni per emettere una risposta immunitaria sotto forma di biosintesi degli anticorpi: una risposta primaria - dopo il primo incontro dell'organismo con un dato antigene, e una risposta secondaria - in seguito al contatto ripetuto con lo stesso antigene dopo 2-3 settimane.
Risposta immunitaria primaria. 1) La biosintesi degli anticorpi non inizia immediatamente dopo il contatto con l'antigene, ma dopo un certo periodo di latenza della durata di 3-5 giorni. Durante questo periodo avviene il processo di riconoscimento dell'antigene e la formazione di cellule in grado di sintetizzare anticorpi contro di esso; 2) la velocità di sintesi degli anticorpi è relativamente bassa; 3) i titoli degli anticorpi sintetizzati non raggiungono i valori massimi; 4) vengono sintetizzati prima gli anticorpi appartenenti alla classe delle immunoglobuline IgM e poi le IgG. Le IgA e le IgE compaiono più tardi rispetto a tutti gli altri, e anche in questo caso non in tutti i casi.
Risposta immunitaria secondaria.
1) Il periodo di latenza è molto breve, nell'arco di poche ore;
2) la curva che caratterizza il tasso di accumulo degli anticorpi sale in modo significativamente più ripido rispetto alla risposta primaria ed è di natura logaritmica;
3) i titoli anticorpali raggiungono i valori massimi;
4) gli anticorpi appartenenti alla classe IgG vengono immediatamente sintetizzati.
La risposta immunitaria secondaria è causata dalla formazione di cellule della memoria immunitaria.
La memoria immunitaria a livello cellulare è il risultato della generazione di speciali popolazioni antigene-specifiche di cellule di memoria T e B. Si manifesta sia in relazione alla produzione di anticorpi che in relazione ad altre forme di risposta immunitaria e può persistere a lungo.
Le cellule della memoria rappresentano quella parte di linfociti stimolati dagli antigeni T e B che, dopo 2-3 divisioni, entrano in uno stato di riposo e ricircolano nell'organismo per lungo tempo.
Teorie moderne che spiegano l'origine e la specificità degli anticorpi. Teoria clonale-selettiva e sue premesse. Caratteristiche del controllo genetico della biosintesi degli anticorpi.
Gli anticorpi sono proteine sieriche uniche - globuline, che vengono prodotte in risposta all'ingresso di un antigene nel corpo e sono in grado di interagire specificamente con esso. L'insieme delle proteine sieriche che hanno le proprietà degli anticorpi è chiamato immunoglobuline ed è indicato con il simbolo Ig
L'unicità degli anticorpi sta nel fatto che sono in grado di interagire solo con l'antigene che ne ha indotto la formazione.
Gli anticorpi sono proteine e la sintesi di ciascuna proteina è programmata dal gene corrispondente.
Schematicamente, il gene completo per la catena L delle immunoglobuline: L (la regione che codifica il peptide leader necessario per la secrezione di immunoglobuline dalla cellula) - introne - gene V - introne - gene J - introne - gene C.
Schematicamente il gene completo della catena H delle immunoglobuline: gene L - introne - gene V - introne - gene D - introne - gene J - introne - gene C.
I punti di associazione dei geni della linea germinale non sono strettamente fissi. Ciò aumenta il numero di possibili varianti delle catene polipeptidiche e, nel caso in cui siano coinvolte nella formazione di centri attivi, la loro diversità. Inoltre, durante la maturazione dei linfociti B, si verificano mutazioni somatiche puntiformi nei geni V, che alla fine adattano la struttura del centro attivo dell'anticorpo alla struttura del determinante dell'antigene. Si ritiene che il numero totale di varianti anticorpali aumenti di altre 100 volte a causa di splicing impreciso e mutazioni somatiche e ammonti a circa 2 miliardi:
Pertanto, l'immunità acquisita può essere fornita a qualsiasi agente patogeno, a qualsiasi possibile antigene estraneo. I seguenti meccanismi contribuiscono in modo decisivo a garantire la diversità delle immunoglobuline (specificità anticorpale):
1. la presenza di molti geni delle immunoglobuline germinali;
2. ricombinazioni intrageniche causate dalla struttura esone-introne dei geni V-, D-, J-, C;
3. associazione di diverse catene L con diverse catene H;
4. imprecisione di giunzione;
mutazioni somatiche dei geni V nei linfociti B maturi.
A. Monociti
B. Plasmociti
C. Microfagi
D. Linfociti
E. Macrofagi
347. Uno studente, rispondendo alla domanda di un insegnante sull'immunogenesi, ha definito una delle teorie sulla formazione degli anticorpi la più ragionevole e tempestiva. Quale teoria aveva in mente lo studente?
Teoria della selezione clonale di A. Burnet
B. Matrice diretta di Haurowitz-Pauling
S. Selezione naturale Erne
D. Strutture di rete di Heidelberg
E. Matrice indiretta di Burnet-Fenner
In uno degli organi centrali del sistema immunitario si formano cellule che sono i precursori delle cellule immunocompetenti. Alcuni di essi vengono poi trasformati in linfociti T o B. In quale organo si verifica questo?
A. Midollo osseo
B. Ghiandola del timo
S. Milza
D. Linfonodi
E. Tonsille palatine
In alcune infezioni nel corpo sono presenti contemporaneamente anticorpi e l'agente eziologico della malattia, cioè Questo è un tipo unico di immunità. Come si chiama?
R. Non sterile
B. Sterile
C. Ereditario
D. Passivo
E. Artificiale
È noto che i bambini non contraggono il morbillo e altre malattie infettive fino a 6 mesi. poiché ricevono gli anticorpi dalla madre per via transplacentare. Come si chiama questo tipo di immunità?
A. Passivo artificiale
B. Attivo artificiale
C. Attivo naturale
D. Passivo naturale
E. Specie congenite
351. Per condurre la microscopia in un sistema ad immersione, un batteriologo applica prima una sostanza sulla superficie di uno striscio preparato. Che cos'è?
S. alcali
D. Olio
E. acido
Quale dei seguenti metodi diagnostici di laboratorio consente di isolare e identificare l'agente eziologico della malattia?
R. Allergico
B. Biologico
C. batteriologico
Sierologico
E.Microscopico
La vaccinazione è oggi ampiamente utilizzata per la prevenzione specifica dell’epatite virale B. Quale metodo viene utilizzato per preparare il vaccino?
A. Dal virus dell'epatite ucciso dalla formaldeide
B. Dal fegato di pecore infette dal virus dell'epatite
C. Dall'antigene HBs isolato dal sangue dei portatori
D. Metodo di ingegneria genetica
E. Dal virus dell'epatite coltivato in coltura cellulare
Il dentista è stato vaccinato contro l'epatite B. Contro quali tipi di epatite virale è stata creata un'immunità attiva?
A. Epatite B e D
B. Epatite B, C D
C. Epatite B
D. Epatite B e A
E. Epatite B e C
Sulle labbra del paziente apparvero vescicole piene di un liquido giallastro. Il medico sospettava l'Herpes labiale. Quali virus possono causare questa malattia?
A. Herpesvirus 6
B. Virus dell'herpes simplex
C. Virus dell'herpes zoster
D. Citomegalovirus
Virus E. Epstein-Barr
Durante un’epidemia di influenza, a un paziente con febbre e debolezza fu diagnosticata da un medico l’”influenza”. Quale farmaco ha prescritto il medico al paziente?
A. Penicillina
B. Streptocidio
C. Streptomicina
D. Remantadina
E. Novarsenol
Il paziente è stato trattato per una polmonite cronica per molto tempo. Un esame microscopico dell'espettorato in uno striscio ha rivelato bastoncini rossi sottili, diritti e leggermente ricurvi, situati singolarmente. Lo striscio viene colorato utilizzando il complesso metodo Ziehl-Neelsen. Cosa impedisce loro di essere identificati con un semplice metodo di colorazione?
A. Elevato contenuto di acido micolico e lipidi
C. Presenza di contenziosi
D. Produzione di enzimi di aggressione
E. Formazione di capsule
Per valutare l'idoneità dell'acqua potabile è stato effettuato uno studio batteriologico. Quale indicatore caratterizza il numero di batteri coliformi contenuti in 1 litro?
Indice di A. Coli
Titolo di B. Coli.
C. Titolo colifagico.
Titolo D. Perfrangens.
E. Numero microbico
359. Durante una lezione pratica di microbiologia, agli studenti è stato chiesto di colorare una miscela di batteri utilizzando il metodo Gram e di spiegare il meccanismo della colorazione. Quali strutture morfologiche dei batteri determinano il colore gram-negativo e gram-positivo dei batteri?
A. Parete cellulare
C. Capsula
D. flagelli
E. citoplasma
Qual è il nome del metodo diagnostico microbiologico, che consiste nel determinare il titolo di anticorpi specifici nel siero del paziente?
R. Allergico
B. Biologico
C. Microbiologico
D. Sierologico
E. microscopico
Nel 2003 è comparsa una nuova malattia, denominata “polmonite atipica” o SARS (sindrome respiratoria acuta grave). A quale gruppo di microbi appartiene il suo agente eziologico?
R. Virus
B. Batteri
C. protozoi
Un paziente ha consultato un medico lamentando febbricola prolungata, ingrossamento dei linfonodi regionali e perdita di peso corporeo. Il medico sospettava che il paziente avesse l'AIDS. Qual è l'agente eziologico di questa malattia?
A. Poliovirus umano
B. Virus T-linfotropico umano-2
C. Virus T-linfotropico umano-1
Nonostante i diversi meccanismi non specifici della difesa immunitaria del corpo, non potrebbe essere protetto in modo affidabile dagli antigeni se non esistessero meccanismi di difesa immunitaria specifici, poiché gli antigeni si sono evoluti parallelamente all'evoluzione del sistema immunitario e hanno sviluppato una serie di meccanismi che consentono ad alcuni di loro
Ø evitare il contatto diretto con i fagociti (cambiando drasticamente la struttura spaziale dei loro recettori superficiali)
Ø evitare completamente l'attivazione del sistema del complemento attraverso la via alternativa
Ø o dopo l'attivazione del sistema del complemento lungo la via alternativa e la formazione del fattore C3b opsonizzante la fagocitosi sulla superficie dell'agente patogeno, questo non viene ancora fagocitato dai fagociti.
Gli antenati dell'evoluzione umana avevano bisogno di sviluppare meccanismi che servissero a proteggersi da ogni specifico microrganismo, indipendentemente dal numero di tali microrganismi. La formazione di tali meccanismi è stata assicurata grazie allo sviluppo di difese immunitarie specifiche. Tali difese immunitarie specifiche possono essere fornite da
Anticorpi(immunoglobuline) sono molecole proteiche, che interagiscono in modo strettamente specifico con determinati antigeni e
Ø oppure vengono direttamente neutralizzati,
Ø o facilitare la successiva fagocitosi degli antigeni da parte dei fagociti,
Ø oppure attivano il sistema del complemento lungo la via classica, provocando la formazione di un complesso di attacco alla membrana che provoca un danno all'antigene.
Nonostante l’ampia varietà di anticorpi, hanno tutti un piano strutturale comune. In particolare, si basano sugli anticorpi Molecola a forma di Y, consiste in quattro circuiti : due polmoni E due pesanti. Le catene pesanti sono più lunghe e occupano una posizione centrale nella molecola, mentre le catene leggere sono relativamente corte e si attaccano esternamente alle porzioni superiori (porzioni N-terminali) delle catene pesanti, mentre le porzioni inferiori delle catene pesanti (porzioni C-terminali) porzioni terminali) formano la “coda” della molecola. Le catene pesanti sono collegate tra loro e alle catene leggere tramite legami disolfuro (legami S-S). Le regioni di riconoscimento dell'antigene di un anticorpo sono la parte superiore delle spalle, formato dalle parti superiori (N-terminali) delle catene leggere e pesanti.
Riso. Struttura dell'immunoglobulina G
IN aree di riconoscimento dell'antigene Le catene pesanti e leggere della molecola anticorpale, a loro volta, si distinguono:
Ø 3 localizzati in sequenza regioni ipervariabili(regioni CDR, dall'inglese Complementarity Determining Regions), queste regioni determinano la specificità degli anticorpi, la loro composizione aminoacidica varia notevolmente tra i diversi anticorpi. Sono queste regioni delle catene pesanti e leggere che interagiscono specificamente (sulla base del principio della corrispondenza stereochimica) con determinati antigeni. Inoltre, risulta che l'antigene si trova all'interno del braccio di un determinato anticorpo, cioè circondato, da un lato, dalle regioni ipervariabili della catena leggera, e dall'altro, dalla catena pesante. Nelle regioni ipervariabili delle catene leggere si trovano un gran numero di residui di aminoacidi della glicina, che determinano la flessibilità di queste regioni della molecola polipeptidica. Si presuppone che la specificità dell'antigene sia fornita dalle regioni ipervariabili della catena pesante e la "regolazione fine" si ottiene grazie alla buona flessibilità conformazionale della catena leggera
Ø e connettere queste regioni ipervariabili sequenze peptidiche intermedie(la cui composizione aminoacidica differisce poco tra i diversi anticorpi), chiamato aree wireframe(aree quadro). Le regioni quadro forniscono non solo la comunicazione tra regioni ipervariabili all'interno di una catena, ma l'interazione con le regioni quadro di un dominio variabile di un'altra catena (tra i domini variabili della catena leggera e pesante).
La coda della molecola anticorpale, formata dalle parti inferiori (C-terminali) di due catene pesanti, non ha specificità (nelle molecole anticorpali appartenenti alla stessa classe, le parti terminali delle catene pesanti hanno una struttura simile) ed è responsabile del legame con i recettori delle cellule del corpo. Pertanto, ciascuna molecola anticorpale ha almeno:
ü due siti di riconoscimento dell'antigene e, di conseguenza, di legame dell'antigene corrispondenti ai bracci della molecola e chiamati Frammenti favolosi(dall'inglese frammento antigene vincolante)
ü e un frammento non specifico che garantisce l'interazione dell'anticorpo con i recettori delle cellule proprie dell'organismo e corrisponde alla coda della molecola anticorpale formata dalle parti distali delle catene pesanti (le cosiddette Frammento FC, che ha ricevuto il suo nome dagli inglesi. frammento cristallizzabile).
Le catene pesanti della molecola anticorpale alla giunzione dei bracci e della coda (cioè nella regione del “collo” della molecola) contengono un gran numero di residui di amminoacidi prolina, che forniscono flessibilità conformazionale alla molecola ed sono necessari per migliore interazione con i determinanti antigenici situati sulla superficie delle cellule. La regione delle catene pesanti che corrisponde alla transizione del braccio della catena pesante alla coda e presenta elevata flessibilità conformazionale è detta zona delle cerniere anticorpi.
A seconda delle caratteristiche strutturali (sequenza aminoacidica) Regioni costanti della catena pesante, le molecole di immunoglobuline (Ig) sono classificate in 5 classi(o isotipi):
ü UN(contengono catene pesanti di tipo A) ,
ü G( contengono catene pesanti di tipo G) ,
ü M(contengono catene pesanti di tipo m) ,
ü D ( contengono catene pesanti di tipo D) ,
ü E ( contengono catene pesanti di tipo E).
In base alle caratteristiche strutturali Regioni costanti delle catene leggere Esistono 2 tipi di immunoglobuline ( 2 isotipi) catene leggere: C E l, e una certa molecola di anticorpo contiene sempre catene leggere identiche (entrambe le catene C o entrambe le catene L). Pertanto, all'interno di ciascuna classe di immunoglobuline, a seconda di quali isotipi di catene leggere fanno parte della molecola anticorpale, si possono distinguere due tipi di anticorpi (ad esempio, le immunoglobuline di classe G sono rappresentate da due tipi di molecole: G c e G l, e classe M - M c e M l, ecc.).
Le catene pesanti e leggere degli anticorpi hanno una struttura spaziale complessa. In particolare sono costituiti da domini globulari disposti in sequenza, interconnessi da tratti lineari (costituiti da circa 20 residui amminoacidici). Ciascun dominio globulare ha la forma di un anello che combina fino a 60 amminoacidi e si forma come risultato della chiusura dei legami disolfuro tra alcuni residui di cisteina di amminoacidi all'interno di una delle catene anticorpali.

Riso. Il principio dell'organizzazione dei domini della molecola immunoglobulinica(usando l'esempio dell'immunoglobulina G). Ciascun dominio contiene circa 100-110 residui di amminoacidi; inoltre, circa 60 residui amminoacidici del dominio sono racchiusi in un'ansa da un legame disolfuro (legame S-S); circa 20 residui amminoacidici del dominio che non fanno parte dell'anello servono per connettersi ad altri domini. I numeri indicano la sequenza dei residui aminoacidici nelle catene polipeptidiche. V L e C L – domini variabili e costanti della catena leggera. V H – dominio variabile della catena pesante, C H 1 C H 2 C H 3 – domini costanti della catena pesante.

Riso. Modello computerizzato dell'immunogloblina G
All'interno dei domini, i frammenti peptidici che compongono il dominio formano una struttura b-sheet antiparallela compatta stabilizzata da legami idrogeno ( struttura secondaria delle proteine). La formazione di una struttura b-sheet all'interno del dominio è facilitata dai residui di amminoacidi della glicina. Pertanto, parti delle catene pesanti e leggere degli anticorpi all'interno dei domini formano strutture b-sheet ( struttura secondaria delle proteine), che a loro volta si piegano per formare domini a forma di ansa ( struttura terziaria delle proteine). Grazie alla struttura a strati del foglio B all'interno del dominio, le tre regioni ipervariabili in ciascuna catena anticorpale sono il più vicine possibile l'una all'altra.

Riso. Struttura dei domini globulari(variabile e costante) catena leggera(secondo l'analisi strutturale a raggi X delle proteine di Bence-Jones). Una superficie di ciascun dominio è costituita da 4 catene (frecce grigie) che formano una struttura b-sheet antiparallela stabilizzata da legami idrogeno intercatena (tra i gruppi CO e NH in tutta la struttura peptidica). L'altra superficie di ciascun dominio è formata da tre catene (frecce rosa). Le catene polipeptidiche che formano le due superfici del dominio sono collegate tra loro da un legame disolfuro intercatena (indicato dalla striscia più scura). La struttura descritta è caratteristica di tutti i domini immunoglobulinici. Di particolare interesse è la posizione delle regioni ipervariabili in tre anelli separati del dominio variabile (le regioni ipervariabili sono indicate da linee a strisce rosse e bianche, i numeri indicano alcuni residui amminoacidici nelle regioni ipervariabili). Queste regioni ipervariabili, sebbene situate a grande distanza l'una dall'altra nella struttura primaria della catena leggera, ma quando si forma la struttura spaziale, si trovano in stretta vicinanza l'una all'altra, prendendo parte alla formazione delle regioni leganti l'antigene centro dell'immunoglobulina.

Riso. Disposizione spaziale delle regioni ipervariabili all'interno del dominio variabile della catena pesante dell'immunoglobulina umana G. La caratteristica conformazionale del dominio variabile è che tutte e 3 le regioni ipervariabili, come risultato della formazione della struttura terziaria della catena polipeptidica, sono in stretta prossimità tra loro (aree nere della figura). Le regioni quadro (invarianti) forniscono l'interazione con le regioni quadro del dominio variabile della catena leggera. Come risultato dell'interazione dei domini variabili delle catene leggere e pesanti, si forma il centro di legame dell'antigene dell'immunoglobulina.

Riso. Rappresentazione bidimensionale semplificata del sito di legame dell'antigene di un anticorpo. Il centro di legame dell'antigene di un anticorpo è una cavità circondata da anse peptidiche delle regioni ipervariabili delle catene pesanti e leggere (i residui aminoacidici delle regioni ipervariabili delle catene sono numerati nella figura).

Riso. Significato funzionale dei diversi domini dell'immunoglobulina G(schema). I domini delle catene leggere sono indicati V L (dominio variabile) e CL (dominio costante); I domini della catena pesante di tipo g sono designati V H (dominio variabile della catena pesante) e Cg1 Cg2 e Cg3 (domini costanti della catena pesante)
Come accennato in precedenza, in base alle caratteristiche strutturali delle regioni costanti delle catene pesanti delle molecole di immunoglobuline, si distinguono 5 classi, ciascuna delle quali è caratterizzata da alcune caratteristiche dell'organizzazione dei frammenti Fc, che determinano i recettori di cui effettore cellule del corpo, come l'immunoglobulina e alcune delle sue altre, interagiranno con le caratteristiche funzionali. La classe predominante di immunoglobuline nei fluidi corporei interni(e principalmente nel fluido tissutale) sono anticorpi di classe G, che vengono prodotti in grandi quantità durante la risposta immunitaria secondaria e forniscono protezione al corpo da batteri, virus e tossine. In particolare, i complessi "IgG-antigene".
· potenziare la fagocitosi attraverso l'opsonizzazione (cioè i complessi “IgG-antigene” con frammenti Fc di IgG interagiscono con i recettori di membrana dei neutrofili e dei macrofagi, aumentando l'efficienza della fagocitosi degli antigeni),
stimolare la distruzione extracellulare degli antigeni attivando le cellule natural killer (le IgG associate agli antigeni, con i loro frammenti Fc, sono in grado di interagire non solo con i fagociti, ma anche con le cellule natural killer che danneggiano la membrana dell'antigene)
· avere la capacità di interagire con la componente C1 del sistema del complemento, attivandola lungo la via classica, che si accompagna alla comparsa
ü mediatori dell'infiammazione che hanno un effetto chemiotattico e attraggono fagociti e linfociti,
ü fattore opsonizzante della fagocitosi C3b
ü e, infine, la formazione di complessi di attacco alla membrana che distruggono gli agenti patogeni.
L'intensità della sintesi delle IgG dipende in gran parte dalla penetrazione degli antigeni nel corpo. L'IgG è l'unico anticorpo in grado di penetrare la barriera placentare, poiché sulla superficie delle cellule del trofoblasto placentare sono presenti recettori che legano i frammenti Fc delle molecole IgG materne. In questo caso, le molecole IgG associate ai recettori del trofoblasto vengono assorbite mediante endocitosi mediata dai recettori, dopo di che vengono trasportate nella cellula del trofoblasto come parte di vescicole delimitate, rimosse dalle cellule del trofoblasto e passano attraverso la sua membrana basale nel tessuto connettivo e capillari del feto. Il passaggio delle IgG attraverso la placenta garantisce il trasferimento dell'immunità passiva dalla madre al feto. Inoltre, grazie alla presenza di IgG nel latte, partecipa alla protezione immunitaria passiva specifica del bambino durante l'allattamento al seno.
Immunoglobuline di classe A rappresentano la principale classe di immunoglobuline secrezioni delle ghiandole esocrine(ghiandole mammarie, lacrimali, salivari, sudoripare, ghiandole della mucosa del tubo digerente e cellule caliciformi dei tubi respiratorio e genito-urinario). Le IgA vengono rilasciate sulla superficie delle mucose, dove interagiscono con gli antigeni. Di conseguenza, le IgA partecipano alla funzione protettiva del corpo, rafforzando la barriera nella mucosa del tratto digestivo, respiratorio e genito-urinario contro le infezioni. La molecola dell'immunoglobulina A contenuta nella secrezione di alcune ghiandole è un dimero stabilizzato da un'ulteriore catena J. Inoltre, le molecole dimeriche di IgA si formano nella plasmacellula stessa. Successivamente le molecole dimeriche di IgA interagiscono con alcuni recettori polipeptidici sulla superficie basale della cellula secretoria. I recettori delle IgA in complesso con il dimero delle IgA penetrano nella cellula secretoria mediante endocitosi e, insieme alla mediazione della fagocitosi da parte della cellula secretoria, forniscono protezione delle IgA dalla scissione sotto l'azione degli enzimi proteolitici delle secrezioni sintetizzate dalla cellula. Dopo la secrezione delle IgA attraverso la superficie apicale della cellula secretoria sulla superficie della membrana mucosa, il recettore per le IgA viene parzialmente scisso e la parte che rimane associata al dimero di IgA dopo tale scissione viene chiamata componente secretiva. Le IgA svolgono un ruolo importante nella protezione delle mucose dalle infezioni, grazie alla loro capacità di impedire la penetrazione dei microrganismi associati alle IgA attraverso lo strato epiteliale della mucosa nel tessuto. Nel plasma sanguigno, le molecole di IgA hanno una struttura prevalentemente monomerica.

Riso. Il meccanismo di secrezione dell'immunoglobulina A sulla superficie della mucosa. Le cellule epiteliali della mucosa sintetizzano un recettore immunoglobulinico (recettore Ig), che è incorporato nella membrana della superficie basale della cellula. Il dimero di Ig A si lega a questo recettore per endocitosi, penetra nella cellula, viene trasportato sulla sua superficie apicale, attraverso la cui membrana viene rilasciato sulla superficie della mucosa per esocitosi. Quando il recettore viene scisso sulla superficie della mucosa, vengono rilasciate le Ig A, che sono ancora associate a una parte del recettore, chiamata componente secretoria. Il trasporto delle Ig G attraverso la placenta avviene probabilmente in modo simile con l'aiuto dei recettori delle Ig G situati sulla superficie delle cellule del trofoblasto.
Immunoglobuline classe M sono molecole pentamericane (sono cioè costituite da cinque subunità a forma di Y, disposte radialmente e unite in un'unica molecola tramite un'unica catena J, che interagisce con le catene pesanti dei monomeri attraverso legami disolfuro). In questo caso, i frammenti Fc di ciascun monomero sono rivolti verso il centro della molecola e tra loro, mentre i frammenti Fab sono rivolti verso l'esterno. La catena J avvia l'assemblaggio della molecola IgM pentamericana. A causa della struttura pentamerica delle loro molecole, le IgM hanno il peso molecolare maggiore tra tutte le classi di anticorpi (950 kDa).
 Le immunoglobuline M sono la prima classe di anticorpi prodotti dallo sviluppo dei linfociti B al primo ingresso dell'antigene nell'organismo e si trovano in maggiori quantità nel sangue periferico (cioè le IgM costituiscono la prima linea di difesa durante la batteriemia). L'IgM, per le grandi dimensioni della sua molecola complessata con l'antigene, è in grado di attivare in un'unica quantità la componente C1 del sistema del complemento, avviando il processo di attivazione di questo sistema lungo la via classica, mentre di attivare la componente C1 componente dal complesso “IgG-antigene”, è necessario attaccare 5 complessi “IgG” alla sua molecola-antigene".
Le immunoglobuline M sono la prima classe di anticorpi prodotti dallo sviluppo dei linfociti B al primo ingresso dell'antigene nell'organismo e si trovano in maggiori quantità nel sangue periferico (cioè le IgM costituiscono la prima linea di difesa durante la batteriemia). L'IgM, per le grandi dimensioni della sua molecola complessata con l'antigene, è in grado di attivare in un'unica quantità la componente C1 del sistema del complemento, avviando il processo di attivazione di questo sistema lungo la via classica, mentre di attivare la componente C1 componente dal complesso “IgG-antigene”, è necessario attaccare 5 complessi “IgG” alla sua molecola-antigene".
Oltre ad attivare il sistema del complemento, le IgM hanno un effetto opsonizzante durante la fagocitosi. Inoltre, a causa della struttura pentamerica, le IgM sono in grado di provocare agglutinazione e la conseguente lisi degli antigeni. Teoricamente, una molecola IgM può legarsi a 10 antigeni, ma, di regola, interagisce efficacemente solo con 5, a causa di alcune restrizioni steriche derivanti dall'insufficiente flessibilità della molecola. Le molecole IgM monomeriche sono presentate sulla superficie dei linfociti B, formando recettori per l'interazione con l'antigene.
Riso. Struttura dell'immunoglobulina M
Immunoglobuline classe D sono presenti nel siero del sangue in quantità trascurabili, ma sono prevalentemente associati alla membrana dei linfociti e, ovviamente, agiscono come recettori per i linfociti, consentendo loro di interagire tra loro, garantendo così il controllo sull'attivazione e la soppressione dei linfociti.