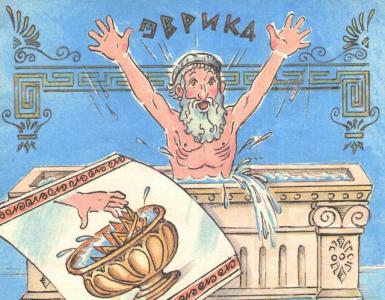Nervo trigemino su quale lato del viso. Nervo mandibolare (anatomia umana). Come alleviare l'infiammazione con i rimedi popolari
6 24 894 0
Il dolore alla mascella non è una malattia in quanto tale. E quando diciamo che la nostra mascella è “espulsa”, intendiamo principalmente un'infiammazione del nervo facciale.
Ma prima di iniziare a trattare un nervo "freddo", assicurati di avere davvero la neurite. Il dolore alla mascella può essere causato da molte altre malattie con sintomi simili, quindi assicurati di consultare un medico.
Conoscere le cause del dolore aiuterà solo a identificare la natura del problema e a determinare la scelta di uno specialista.
Definizione del problema
1. Infiammazione dell'articolazione della mascella.
Il dolore alla mascella nella zona dell'orecchio è un segno caratteristico di infiammazione dell'articolazione temporo-mandibolare.
In questo caso si osserva:
- Dolore doloroso, scricchiolio nella zona dell'orecchio durante la masticazione, l'apertura della bocca o la chiusura delle mascelle.
- Cambiamento costante dell'intensità del dolore da lieve disagio a sensazioni acute.
Questa malattia può essere confusa con l'otite media, che presenta sintomi simili. Pertanto, la diagnosi corretta può essere fatta da un medico ORL.
2. Malattie dentali.
Il dolore alla mascella, accompagnato dal dolore ai denti, è un sintomo di malattie come pulpite, carie, osteomielite, parodontite, trauma dentale e infiammazione delle gengive.
- Il dolore è pulsante.
- Si intensifica durante la masticazione di cibi duri.
- Con l'osteomielite può verificarsi gonfiore del viso e aumento della temperatura corporea.
In questo caso vale la pena contattare un dentista per la diagnosi e ricevere assistenza qualificata.
3. Nevralgia.
Se il nervo facciale, laringeo o il nodo dell'orecchio sono danneggiati, si osserva un dolore intenso nella mascella superiore, inferiore e nell'area vicino all'orecchio.
- Il dolore si intensifica con i movimenti della mascella.
- Può verificarsi una forte salivazione.
- Nell'orecchio compaiono rumori e ticchettii.
Se hai tali sintomi, dovresti contattare un neurologo.
 4. Infiammazione della parete dell'arteria facciale.
4. Infiammazione della parete dell'arteria facciale.
Con l'arterite, il dolore può colpire sia la zona del mento che la zona del labbro superiore, del naso, raggiungendo gli angoli degli occhi.
5. Altre patologie.
Il dolore alla mascella superiore può indicare sinusite o infiammazione delle ghiandole salivari parotidee. Il disagio sotto la mascella inferiore può indicare infiammazione dei linfonodi, faringite o mal di gola.
Primo soccorso
Se l'attacco si è verificato di sera, di notte o nel fine settimana, o al momento non hai la possibilità di visitare un medico, dovresti adottare le seguenti misure:
- Bevi antidolorifici ("Nurofen", "Efferalgan", "Analgin").
- Fornire riposo completo all'articolazione temporo-mandibolare. Non aprire troppo la bocca, masticare cibi duri o gomme da masticare.
- Se ti fanno male i denti, devi sciacquarti la bocca con una soluzione di soda:
- Soda 1 cucchiaino.
- Acqua 1 cucchiaio.
...o infusi di erbe (salvia, camomilla):
- Erba a scelta 1 cucchiaio. l.
- Acqua 1 cucchiaio.
- Se ti fa male l'orecchio, applica un impacco caldo (a condizione che la temperatura corporea sia normale). Un impacco di vodka e miele aiuta molto.
Sintomi e trattamento della neurite
La nevralgia facciale è una malattia molto grave, la cui automedicazione può portare a conseguenze disastrose, inclusa la paralisi facciale.
La malattia inizia, come la maggior parte delle malattie sopra descritte: dolore acuto, bruciante e lancinante nella zona della mascella vicino all'orecchio.
Dopo un giorno o due compaiono i sintomi caratteristici:
- Espressioni facciali difficili (incapacità di chiudere le palpebre, abbassamento dell'angolo della bocca, appianamento della piega naso-labiale).
- Asimmetria e intorpidimento su un lato del viso.
- Il dolore aumenta quando si mastica, si lava i denti, si ride o si parla.
Nei giorni 7-10 di malattia vengono prescritti fisioterapia (elettroforesi, radiazioni ultraviolette, bagni di paraffina) e massaggi.

Rimedi popolari
La medicina tradizionale integra la terapia generale e aiuta a recuperare più velocemente. Diamo un'occhiata alle ricette più popolari ed efficaci.
Per strofinare l'area dolorante avrai bisogno di:
- Fiori di acacia bianchi 4 cucchiai. l.
- Vodka o alcol 1 cucchiaio.
 Versare la vodka o l'alcol sui fiori bianchi di acacia. Lascia fermentare per una settimana. Strofina l'area problematica due volte al giorno per un mese.
Versare la vodka o l'alcol sui fiori bianchi di acacia. Lascia fermentare per una settimana. Strofina l'area problematica due volte al giorno per un mese.
Opzione alternativa:
- Soluzione per mummia al 10%. qualche goccia
- Diversi dischetti di cotone
Applicare una piccola quantità di soluzione di mummia al 10% su un batuffolo di cotone. Massaggiare la zona dolorante con movimenti leggeri per cinque minuti.
- Mumiyo 0,2 g
- Miele 1 cucchiaino.
- Latte caldo 1 cucchiaio.
Sciogliere 0,2 g della sostanza e un cucchiaino di miele in un bicchiere di latte tiepido. Bevi un bicchiere al giorno per due settimane.
Per l'impacco avrai bisogno di:
- Camomilla 3 cucchiaini.
- Acqua bollente 1 tazza
Ripida fiori di camomilla in una tazza di acqua bollita. Lasciare fermentare per 15 minuti. Posizionatelo sul viso e copritelo con un panno di lana. Applicare gli impacchi una volta al giorno.
La camomilla allevia perfettamente il gonfiore e i processi infiammatori.

Per riscaldarti avrai bisogno di:
- Sale 1 cucchiaio.
- borsa di stoffa 1 PC.
Scaldare il sale da cucina nel microonde o in una padella. Mettere in un sacchetto di stoffa e applicare sul punto dolente per un mese.
Tali procedure possono essere eseguite solo 7-10 giorni dopo l'inizio del trattamento tradizionale.
Ginnastica
Un complesso di esercizi terapeutici ti aiuterà perfettamente a tornare alla normalità. Per prima cosa, allunga i muscoli del collo e del cingolo scapolare. Siediti e rilassa completamente i muscoli facciali. Poi inizia a fare gli esercizi.
- Aggrotta le sopracciglia, poi alzale per la sorpresa.
- Strizza gli occhi e fai movimenti circolari.
- Sorridi con le labbra chiuse. Ripeti, ma questa volta esponendo i denti.
- Alza il labbro inferiore e mostra i denti. Ripeti lo stesso con quello in alto.
- Gonfia le guance, poi risucchiale.
- Spingi le labbra in un tubo.
Il nervo più grande correlato al cervello cranico è il nervo trigemino che, come suggerisce il nome, contiene tre rami principali e molti rami più piccoli. È responsabile della mobilità dei muscoli facciali, fornisce la capacità di eseguire movimenti di masticazione e mordere il cibo, oltre a donare sensibilità agli organi e alla pelle della zona anteriore della testa.
In questo articolo capiremo cos'è il nervo trigemino.
Diagramma di disposizione
Il nervo trigemino ramificato, che ha molti rami, ha origine nel cervelletto, proviene da una coppia di radici: motoria e sensoriale, e avvolge tutti i muscoli facciali e alcune parti del cervello in una rete di fibre nervose. La stretta connessione con il midollo spinale consente di controllare diversi riflessi, anche quelli legati al processo respiratorio, come sbadigliare, starnutire e sbattere le palpebre.
L'anatomia del nervo trigemino è la seguente: dal ramo principale, approssimativamente a livello della tempia, iniziano a separarsi quelli più sottili, che a loro volta si ramificano e si assottigliano ulteriormente e più in basso. Il punto in cui avviene la separazione è chiamato nodo Gasser, o trigemino. I processi del nervo trigemino attraversano tutto il viso: occhi, tempie, mucose della bocca e del naso, lingua, denti e gengive. Grazie agli impulsi inviati dalle terminazioni nervose al cervello, si verifica un feedback che fornisce sensazioni sensoriali.
Qui è dove si trova il nervo trigemino.
Le fibre nervose più fini, penetrando letteralmente in tutte le parti delle zone facciali e parietali, consentono a una persona di sentire il tatto, provare sensazioni piacevoli o spiacevoli, muovere le mascelle, i bulbi oculari, le labbra ed esprimere varie emozioni. La natura intelligente ha dotato la rete nervosa esattamente della sensibilità necessaria per un'esistenza tranquilla.
Rami principali
L'anatomia del nervo trigemino è unica. Il nervo trigemino ha solo tre rami; da essi si divide ulteriormente in fibre che portano agli organi e alla pelle. Diamo un'occhiata a loro in modo più dettagliato.
1 ramo del nervo trigemino è il nervo ottico o orbitale, che è solo sensoriale, cioè trasmette sensazioni, ma non è responsabile del lavoro dei muscoli motori. Con il suo aiuto, le informazioni vengono scambiate tra il sistema nervoso centrale e le cellule nervose degli occhi e delle orbite, dei seni e della mucosa del seno frontale, dei muscoli della fronte, delle ghiandole lacrimali e delle meningi.
Da quello ottico si diramano altri tre nervi più sottili:
- lacrimoso;
- frontale;
- nasociliare.
Poiché le parti che compongono l'occhio devono muoversi e il nervo orbitale non può fornirlo, accanto ad esso si trova uno speciale nodo autonomo chiamato nodo ciliare. Grazie alle fibre nervose di collegamento e al nucleo aggiuntivo, provoca la contrazione e il raddrizzamento dei muscoli pupillari.
Secondo ramo

Anche il nervo trigemino sul viso ha un secondo ramo. Il nervo mascellare, zigomatico o infraorbitario è il secondo ramo principale del trigemino ed è anch'esso destinato a trasmettere solo informazioni sensoriali. Attraverso di esso, le sensazioni vanno alle ali del naso, alle guance, agli zigomi, al labbro superiore, alle gengive e alle cellule nervose dentali della fila superiore.
Di conseguenza, da questo grosso nervo si dipartono un gran numero di rami medi e sottili, che attraversano diverse parti del viso e delle mucose e vengono combinati per comodità nei seguenti gruppi:
- principale mascellare;
- zigomatico;
- cranico;
- nasale;
- facciale;
- infraorbitale.
Anche qui è presente un ganglio vegetativo parasimpatico, chiamato ganglio pterigopalatino, che favorisce la salivazione e la secrezione di muco attraverso il naso e i seni mascellari.
Terzo ramo

Il terzo ramo del nervo trigemino è chiamato nervo mandibolare, che svolge sia la sensibilità a determinati organi e aree, sia la funzione di muovere i muscoli della cavità orale. È questo nervo che è responsabile della capacità di mordere, masticare e deglutire il cibo e favorisce il movimento dei muscoli necessari per parlare e localizzati in tutte le parti che compongono la zona della bocca.
Si distinguono i seguenti rami del nervo mandibolare:
- buccale;
- linguale;
- alveolare inferiore: il più grande, che emette una serie di sottili processi nervosi che formano il ganglio dentale inferiore;
- auricolotemporale;
- masticare;
- nervi pterigoidei laterali e mediali;
- maxilloioideo.
Il nervo mandibolare ha le formazioni più parasimpatiche che forniscono impulsi motori:
- orecchio;
- sottomandibolare;
- sublinguale.
Questo ramo del nervo trigemino trasmette la sensibilità alla fila inferiore dei denti e alla gengiva inferiore, al labbro e alla mascella nel suo insieme. Anche le guance ricevono sensazioni in parte con l'aiuto di questo nervo. La funzione motoria è svolta dai rami masticatorio, pterigoideo e temporale.
Questi sono i rami principali e i punti di uscita del nervo trigemino.
Cause della sconfitta
Processi infiammatori di varie eziologie che colpiscono i tessuti del nervo trigemino portano allo sviluppo di una malattia chiamata nevralgia. In base alla sua localizzazione viene chiamata anche “nevralgia facciale”. È caratterizzato da un improvviso parossismo di dolore acuto che penetra diverse parti del viso.
Ecco come viene danneggiato il nervo trigemino.
Le cause di questa patologia non sono completamente comprese, ma sono noti molti fattori che possono provocare lo sviluppo della nevralgia.
Il nervo trigemino o i suoi rami vengono compressi sotto l'influenza delle seguenti malattie:

- aneurisma cerebrale;
- aterosclerosi;
- colpo;
- osteocondrosi, che causa un aumento della pressione intracranica;
- difetti congeniti dei vasi sanguigni e delle ossa del cranio;
- neoplasie che insorgono nel cervello o sul viso dove passano i rami del nervo;
- lesioni e cicatrici sul viso o sulle articolazioni della mascella, sulle tempie;
- formazione di aderenze causate da infezioni.
Malattie di natura virale e batterica
- Herpes.
- Infezione da HIV
- Polio.
- Otite media cronica, parotite.
- Sinusite.
Malattie che colpiscono il sistema nervoso
- Meningiti di varia origine.
- Epilessia.
- Encefalopatia, ipossia cerebrale, che porta alla mancanza di apporto di sostanze necessarie per il pieno funzionamento.
- Sclerosi multipla.
Chirurgia
Il nervo trigemino sul viso può essere danneggiato a seguito di un intervento chirurgico nell'area del viso e della cavità orale:
- danni a mascelle e denti;
- conseguenze di un'anestesia errata;
- procedure odontoiatriche eseguite in modo errato.
L'anatomia del nervo trigemino è davvero unica e quindi questa zona è molto vulnerabile.
Caratteristiche della malattia
La sindrome dolorosa può essere avvertita solo da un lato o interessare tutto il viso (molto meno spesso), e può interessare solo le parti centrali o periferiche. In questo caso, le caratteristiche diventano spesso asimmetriche. Attacchi di varia intensità durano al massimo pochi minuti, ma possono causare sensazioni estremamente spiacevoli.
Questo è il disagio che può causare il nervo trigemino. Di seguito è riportato uno schema delle possibili aree interessate.

Il processo può coprire diverse parti del nervo trigemino: i rami singolarmente o alcuni insieme, la guaina del nervo o la sua interezza. Molto spesso sono colpite le donne di età compresa tra 30 e 40 anni. I parossismi del dolore nella nevralgia grave possono essere ripetuti più volte durante il giorno. I pazienti che soffrono di questa malattia descrivono gli attacchi come come scosse elettriche e il dolore può essere così forte che la persona diventa temporaneamente cieca e smette di percepire il mondo che la circonda.
I muscoli facciali possono diventare così sensibili che qualsiasi tocco o movimento provoca un nuovo attacco. Compaiono tic nervosi, contrazioni spontanee dei muscoli facciali, lievi convulsioni e rilascio di saliva, lacrime o muco dai passaggi nasali. Attacchi costanti complicano significativamente la vita dei pazienti, alcuni cercano di smettere di parlare e persino di mangiare per non danneggiare ulteriormente le terminazioni nervose.
Abbastanza spesso, la parestesia facciale si osserva per un certo tempo prima del parossismo. Questa sensazione ricorda il dolore alla gamba sedentaria: pelle d'oca, formicolio e intorpidimento della pelle.
Possibili complicazioni

I pazienti che ritardano la visita dal medico corrono il rischio di sviluppare molti problemi in pochi anni:
- debolezza o atrofia dei muscoli masticatori, molto spesso dalle zone trigger (aree la cui irritazione provoca attacchi dolorosi);
- asimmetria del viso e angolo rialzato della bocca, che ricorda un sorriso;
- problemi della pelle: desquamazione, rughe, distrofia;
- perdita di denti, capelli, ciglia, primi capelli grigi.
Metodi diagnostici
Prima di tutto, il medico raccoglie un'anamnesi completa, scoprendo quali malattie ha dovuto sopportare il paziente. Molti di loro possono provocare lo sviluppo della nevralgia del trigemino. Successivamente viene registrato il decorso della malattia, annotata la data del primo attacco e la sua durata e controllati attentamente i fattori associati.
È necessario chiarire se i parossismi hanno una certa periodicità o si verificano, a prima vista, in modo caotico, e se ci sono periodi di remissione. Successivamente il paziente mostra le zone trigger e spiega quali influenze e quale forza devono essere applicate per provocare una riacutizzazione. Qui viene presa in considerazione anche l'anatomia del nervo trigemino.
La posizione del dolore è importante: uno o entrambi i lati del viso sono colpiti dalla nevralgia, così come se gli antidolorifici, i farmaci antinfiammatori e antispastici aiutano durante un attacco. Inoltre vengono chiariti i sintomi che possono essere descritti dal paziente osservando il quadro della malattia.
L'esame dovrà essere effettuato sia durante un periodo tranquillo che durante l'inizio di un attacco - in questo modo il medico sarà in grado di determinare con maggiore precisione lo stato del nervo trigemino, quali parti di esso sono interessate, trarre una conclusione preliminare sullo stadio della malattia e sulla prognosi per il successo del trattamento.
Come viene diagnosticato il nervo trigemino?
Fattori importanti
Solitamente vengono valutati i seguenti fattori:
- Lo stato d'animo del paziente.
- Aspetto della pelle.
- La presenza di disturbi cardiovascolari, neurologici, digestivi e patologie dell'apparato respiratorio.
- La capacità di toccare le aree trigger sul viso del paziente.
- Il meccanismo di insorgenza e diffusione della sindrome del dolore.
- Il comportamento del paziente è intorpidimento o azioni attive, tentativi di massaggiare l'area nervosa e l'area dolorante, percezione inadeguata delle persone circostanti, assenza o difficoltà nel contatto verbale.
- La fronte si ricopre di sudore, l'area dolorante diventa rossa, si osserva una forte secrezione dagli occhi e dal naso e si deglutisce la saliva.
- Spasmi o tic dei muscoli facciali.
- Cambiamenti nel ritmo respiratorio, nel polso, nella pressione sanguigna.
Ecco come viene esaminato il nervo trigemino.
Un attacco può essere temporaneamente interrotto premendo su determinati punti nervosi o bloccandoli con iniezioni di novocaina.
Come metodi di certificazione vengono utilizzati la risonanza magnetica e la tomografia computerizzata, l'elettroneurogazia e l'elettroneuromiografia, nonché l'elettroencefalogramma. Inoltre, di solito viene prescritta una consultazione con uno specialista otorinolaringoiatra, un neurochirurgo e un dentista per identificare e trattare le malattie che possono provocare la comparsa della nevralgia facciale.
Trattamento

La terapia complessa mira sempre principalmente ad eliminare le cause della malattia, nonché ad alleviare i sintomi che causano dolore. Solitamente vengono utilizzati i seguenti farmaci:
- Anticonvulsivanti: "Finlepsin", "Difenin", "Lamotrigine", "Gabantine", "Stazepin".
- Rilassanti muscolari: "Baklosan", "Lioresal", "Mydocalm".
- Complessi vitaminici contenenti acidi grassi del gruppo B e omega-3.
- Antistaminici, principalmente Difenidramina e Pipalfen.
- Medicinali che hanno un effetto sedativo e antidepressivo: glicina, aminazina, amitriptilina.
In caso di gravi lesioni del nervo trigemino è necessario ricorrere ad interventi chirurgici mirati a:
- alleviare o eliminare malattie che provocano attacchi di nevralgia;
- diminuzione della sensibilità del nervo trigemino, diminuzione della sua capacità di trasmettere informazioni al cervello e al sistema nervoso centrale;
I seguenti tipi di fisioterapia vengono utilizzati come metodi aggiuntivi:
- irradiazione della zona del collo e del viso con radiazioni ultraviolette;
- esposizione all'irradiazione laser;
- trattamento utilizzando frequenze ultra-alte;
- elettroforesi con farmaci;
- Corrente diadinamica di Bernard;
- terapia manuale;
- agopuntura.
Tutti i metodi di trattamento, i farmaci, il decorso e la durata sono prescritti esclusivamente dal medico e vengono selezionati individualmente per ciascun paziente, tenendo conto delle sue caratteristiche e del quadro della malattia.
Abbiamo esaminato dove si trova il nervo trigemino, nonché le cause del suo danno e i metodi di trattamento.
Nervo mandibolare , N. mandibularis, - III ramo del nervo trigemino. È un nervo misto, formato da fibre nervose sensoriali provenienti dal ganglio trigemino e fibre motorie della radice motoria. Lo spessore del tronco nervoso varia da 3,5 a 7,5 mm e la lunghezza della parte extracranica del tronco da 0,5 a 2 cm Il nervo è costituito da 30-80 fasci, di cui da 50.000 a 120.000 fibre di polpa. Inoltre tra queste ci sono 2/3 di fibre piccole con un diametro fino a 5 micron e 1/3 di quelle grandi con un diametro superiore a 5 micron.
Il nervo mandibolare fornisce innervazione sensoriale alla dura madre, alla pelle del labbro inferiore, al mento, alla parte inferiore della guancia, alla parte anteriore del padiglione auricolare e al canale uditivo esterno, a parte della superficie esterna della membrana timpanica, alla mucosa della guancia , pavimento della bocca e due terzi anteriori della lingua, organi dentali e denti della mascella inferiore, nonché innervazione motoria dei muscoli masticatori (mm. massetere, temporale, pterygoidei medialis et lateralis e mm. tensore del timpano, m tensore del velo palatini, mylohyoideus et venter anteriore, m. digastrici).
Il nervo mandibolare esce dalla cavità cranica attraverso il forame ovale ed entra nella fossa infratemporale, dove si divide in prossimità del sito di uscita in una serie di rami. La ramificazione del nervo mandibolare può avvenire sia secondo il tipo sparso (più spesso nei dolicocefali), in cui il nervo si scompone in un numero maggiore di rami (8-11), oppure secondo il tipo principale (più spesso nei brachicefali) con ramificandosi in un piccolo numero di tronchi (4-5), comuni a più nervi.
Tre nodi del sistema nervoso autonomo sono associati ai rami del nervo mandibolare: auricolare, gangl. oticum, - con nervo pterigoideo interno, sottomandibolare, gangli. sottomandibolare, - con il nervo linguale, sublinguale, gangl. sublinguale, - con il nervo ipoglosso. Dai nodi postgangliari le fibre secretorie parasimpatiche vanno alle ghiandole salivari e le fibre gustative alle papille gustative della lingua. Dal nervo mandibolare partono i seguenti rami (Fig. 235 e 236):
1. Il ramo delle meningi, ramus meningeus, passa attraverso il forame spinoso insieme ad a. meningea media nella cavità cranica, dove è divisa in 2 rami: quello anteriore, che innerva la dura madre, e quello posteriore - alla mucosa delle cellule del processo mastoideo dell'osso temporale.
2. Nervo masticatorio, n. massetericus, prevalentemente motorio, abbastanza spesso (soprattutto nella forma principale di ramificazione del nervo mandibolare) ha un'origine comune con altri nervi dei muscoli masticatori. Passa verso l'esterno oltre il bordo superiore di m. pterygoideus lateralis attraverso l'incisura mandibolare e penetra in m. massetere Prima di entrare nel muscolo, invia un ramo sottile all'articolazione temporo-mandibolare, fornendo la sua innervazione sensibile.
3. Nervi temporali profondi, nn. temporales profundi, motore. Passano lungo la base esterna del cranio verso l'esterno, si piegano attorno alla cresta infratemporalis ed entrano nel muscolo temporale dalla sua superficie interna nelle sezioni anteriore (n. temporalis profundus anterior) e posteriore (n. temporalis profundus posterior), che innervano.
4. Nervo pterigoideo laterale, n. pterigoideo laterale, motore. Di solito lascia un tronco comune con il nervo buccale, si avvicina al muscolo con lo stesso nome, nel quale si ramifica.
5. Nervo pterigoideo mediale, n. pterygoideus medialis, prevalentemente motorio. Alla partenza passa attraverso il gangl. oticum o adiacente alla sua superficie e passa in avanti e in basso fino alla superficie interna del muscolo omonimo, nel quale penetra in prossimità del suo bordo superiore. Inoltre emette vicino al nodo auricolare n. tensoris timpano, n. tensoris veli palatini e il ramo di collegamento al nodo.

Riso. 236. Nervo mandibolare. 1 - nervo mascellare; 2 - nervo alveolare superiore; 3, 4 - nervo orbitale inferiore; 5 - nervo buccale; 6 - muscolo buccale; 7, 10 - nervo alveolare inferiore; 8 - muscolo masticatorio (tagliato e allontanato); 9 - nervo linguale; 11 - muscolo pterigoideo laterale; 12 - nervo masticatorio; 13 - nervo facciale; 14 - nervo auricolotemporale; 15 - muscolo temporale
6. Nervo buccale, n. buccale, sensibile. Penetra tra due teste m. pterygoideus lateralis, corre lungo la superficie interna di m. temporalis, diffondendosi insieme ai vasi buccali lungo la superficie esterna di m. buccinatore all'angolo della bocca. Nel suo percorso emette rami sottili che perforano il muscolo buccale, innervando la mucosa della guancia (fino alla gengiva del 2° premolare e del 1° molare) e si diramano fino alla pelle della guancia e all'angolo della bocca. Moduli di collegamento delle filiali con la filiale n. facciale e nodo auricolare.
7. Nervo auricolotemporale, n. auricolotemporalis, sensibile. Inizia dalla superficie posteriore del nervo mandibolare con due radici che coprono a. meningea media, che vengono poi collegate in un tronco comune. Ha un ramo di collegamento al gangl. otico. In prossimità del collo del processo articolare della mascella inferiore, il nervo auricolotemporale sale verso l'alto, penetra attraverso la ghiandola salivare parotide ed esce nella regione temporale, dove si ramifica in rami terminali. Nel suo percorso dà origine ai seguenti rami: a) articolare, rami articulares, fino all'articolazione temporo-mandibolare; b) rami della ghiandola salivare parotide, rami parotidei, che portano, oltre a quelle sensoriali, fibre secretorie parasimpatiche dal ganglio dell'orecchio; c) nervo del canale uditivo esterno, n. meato acustico esterno, alla pelle del canale uditivo esterno e del timpano; d) nervi auricolari anteriori, nn. auriculares anteriores, alla pelle della parte anteriore del padiglione auricolare e della parte mediana della regione temporale.
8. Nervo linguale, n. lingualis, sensibile. Ha origine dal nervo mandibolare vicino al forame ovale e si trova tra i muscoli pterigoidei anteriormente al nervo alveolare inferiore. Sul bordo superiore del muscolo pterigoideo mediale o leggermente più in basso, la corda timpanica, la corda timpanica, che è una continuazione del nervo intermedio, si unisce al nervo (vedi sezione VII - nervi parafacciali, questa edizione). Come parte della corda del timpano, il nervo linguale comprende fibre secretrici che vanno ai gangli nervosi sottomandibolari e sublinguali e fibre sensibili al gusto che raggiungono le papille della lingua. Successivamente, il nervo linguale passa tra la superficie interna della mascella inferiore e m. pterigoideo mediale sopra la ghiandola salivare sottomandibolare, lungo la superficie esterna del muscolo ioglosso nella piega della mucosa (plica n. lingualis) fino alla superficie laterale della lingua. Tra m. ioglosso e m. Il nervo genioglosso si divide in rami linguali terminali. Lungo il decorso del nervo si formano rami di collegamento: dal n. alveolare superiore; con n. ipoglosso; con gangli, sottomandibolare (rami multipli anteriori e posteriori corti). Nella cavità orale, il nervo linguale emette i seguenti rami.
a) Rami dell'istmo della faringe, rami isthmi faucium, che innervano la mucosa della faringe e la parte posteriore del pavimento della bocca.
b) Nervo ipoglosso, n. sublingualis, ha origine dal nervo linguale sul bordo posteriore del ganglio. sublinguale, da cui riceve un sottile ramo di collegamento, e si diffonde in avanti lungo la superficie laterale della ghiandola salivare sublinguale, innervando la mucosa del pavimento della bocca, delle gengive e della ghiandola salivare sublinguale.
c) I rami linguali, rami linguales, passano insieme a a. e vv. profundae linguae attraverso i muscoli della lingua in avanti e termina nella mucosa della punta della lingua e nel suo corpo fino alla linea terminalis. I rami linguali della corda del timpano comprendono fibre gustative che vanno alle papille della lingua.
Ganglio sottomandibolare, gangl. sub mandibolare, di dimensioni 3-3,5 mm, è situato sotto il tronco del nervo linguale sulla superficie superiore della ghiandola salivare sottomandibolare. Contiene cellule parasimpatiche multipolari. Presenta le seguenti radici: a) rami posteriori di collegamento tra il nodo e il nervo linguale, che portano fibre pregangliari sensoriali e parasimpatiche al nodo (che vanno al nervo linguale attraverso la corda del timpano); b) rami di collegamento dal plesso n. facialis, contenente fibre simpatiche postgangliari provenienti dai gangli cervicali. Dal nodo si dipartono rami di collegamento anteriori che portano al n. lingualis, fibre parasimpatiche e simpatiche postgangliari alla ghiandola salivare sottomandibolare.
9. Nervo alveolare inferiore, n. alveolare inferiore, misto, il ramo più grande del nervo mandibolare. Il tronco è compreso tra mm. pterygoidei dietro e lateralmente al nervo linguale, tra la mascella inferiore e lig. sphenomandibulare, entra, insieme ai vasi omonimi, nella morva mandibolare, dove emette molteplici rami che si anastomizzano tra loro e formano nella mascella inferiore o il plesso dentale inferiore, plesso dentale inferiore (50%), oppure direttamente i rami dentali e gengivali inferiori. Lascia il canale attraverso il forame mentale, dividendosi nel nervo mentale e nel ramo incisivo. Lungo la sua lunghezza, il nervo dà origine ai seguenti rami:
1. Nervo miloioideo, n. mylohyoideus, nasce in prossimità dell'ingresso del nervo alveolare inferiore nel forame mandibolare, è localizzato nel solco omonimo della branca della mandibola e va a mm. mylohyoideus et digastricus (ventre anteriore).
2. I rami dentali e gengivali inferiori, rami dentales et gingivales inferiores, originano dal nervo alveolare inferiore nel canale mandibolare, innervano le gengive, le alveoli del processo alveolare e i denti (premolari e molari). Abbastanza spesso (fino al 50%) i rami che si estendono dal nervo alveolare inferiore formano il plesso dentale inferiore, plesso dentale inferiore, da cui sono già formati i rami dentali e gengivali inferiori.
3. Nervo mentale, n. mentalis, è una continuazione del tronco del nervo alveolare inferiore in quanto esce attraverso il forame mentale dal canalis mandibularis, dove il nervo si diffonde a forma di ventaglio in 4-8 rami. Tra questi ci sono: a) mentali, rami mentali, alla pelle del mento; b) alla pelle e alla mucosa del labbro inferiore, rami labiales inferiores; c) il ramo incisivo, ramo incisivus, che passa attraverso lo spessore della mascella fino ai canini e agli incisivi, che, formando i rami gengivali e dentali, innerva.
Nodo auricolare, gangl. oticum, di forma rotonda, 3-5 mm di diametro. Situato nella fossa sottomandibolare direttamente sotto il forame ovale sulla superficie posteromediale del nervo mandibolare, anteriormente ad a. meningea media, adiacente alla superficie mediale di m. tensoris del velo palatino. Il nodo riceve rami dai nervi vicini, designati dalle sue radici: a) sensitivo - rami di collegamento dal tronco del nervo mandibolare; b) simpatico - rami del plesso a. meningea media, che trasporta le fibre simpatiche postgangliari dai gangli cervicali superiori; c) parasimpatico - nervo piccolo petroso, n. petrosus minor, continua n. timpanico, formato da fibre del nervo glossofaringeo (vedi sezione X nervi paravaghi, questa edizione).
Dal ganglio dell'orecchio partono numerosi rami di collegamento, lungo i quali le fibre sensoriali, postgangliari simpatiche e parasimpatiche agli organi entrano nei nervi vicini: a) rami di collegamento a n. auriculotemporalis, attraverso il quale entrano le fibre secretorie postgangliari parasimpatiche e simpatiche, che vanno poi, come parte dei rami parotidei, alla ghiandola salivare parotide; b) un ramo di collegamento al ramo meningeo, che invia fibre simpatiche che alimentano i vasi durae matris; c) ramo di collegamento con la corda del timpano; d) collegare i rami al gangl. pterigopalatinum (n. sphenoideus internus) e gangl. trigeminale (n. sphenoideus externus).
VI coppia - nervi abducenti (anatomia umana)
Nucleo nervo abducente, N. abducens, si trova nella parte anteriore del fondo del ventricolo IV, direttamente adiacente alla parte posteriore dei nuclei dei nervi oculomotore e trocleare. Il tronco nervoso lascia il cervello sul bordo posteriore del ponte, tra questo e la piramide del midollo allungato, e presto entra nel seno cavernoso dalla parte posteriore della sella turcica, dove si trova lungo la superficie esterna della carotide interna. arteria. Quindi penetra attraverso la fessura orbitaria superiore nell'orbita e prosegue lungo il nervo oculomotore. Nel seno cavernoso, i rami di collegamento del plesso carotico interno, contenenti fibre nervose simpatiche, si avvicinano al nervo. Innerva il muscolo retto esterno dell'occhio.
VII coppia - nervi facciali (anatomia umana)
Nervo facciale , N. facialis, si sviluppa in connessione con la formazione del secondo arco del caber. Innerva quindi tutti i muscoli facciali e parzialmente i muscoli del pavimento della bocca. Il nervo è misto e comprende fibre motorie dal suo nucleo midollare efferente, nonché fibre sensoriali e autonome (gustose e secretorie) appartenenti al nervo intermedio, n. intermedio. Il nervo intermedio decorre parzialmente insieme al nervo facciale (fig. 237).

Riso. 237. Schema della struttura del nervo facciale. 1 - fondo del ventricolo IV; 2 - nucleo del nervo facciale; 3 - foro stilomastoideo; 4 - muscolo dell'orecchio posteriore; 5 - vena occipitale"; 6 - ventre posteriore del muscolo digastrico; 7 - muscolo stiloioideo; 8 - rami del nervo facciale ai muscoli facciali e al platisma; 9 - muscolo che deprime l'angolo dell'oride; 10 - muscolo mentale; 11 - muscolo che deprime il labbro inferiore; 12 - muscolo buccale; 13 - muscolo orbicularis oris; 14 - muscolo elevatore del labbro superiore; 15 - muscolo canino; 16 - muscolo zigomatico; 17 - muscolo orbicularis oculi; 18 - muscolo corrugatore; 19 - muscolo frontale ; 20 - corda del timpano; 21 - nervo linguale; 22 - ganglio pterigopalatino; 23 - ganglio trigemino; 24 - arteria carotide interna; 25 - nervo intermedio; 26 - nervo facciale; 27 - nervo vestibolococleare
Nucleo motore del nervo facciale, nucleo n. facialis, si trova nella parte inferiore del IV ventricolo cerebrale nella regione laterale della formazione reticolare (vedi sezione Bridge, questa edizione). La radice del nervo facciale lascia il cervello insieme alla radice del nervo intermedio davanti al nervo vestibolococleare tra il bordo posteriore del ponte e l'oliva del midollo allungato. Successivamente, i nervi facciali e intermedi entrano nell'apertura uditiva interna ed entrano nel canale facciale.
Nel canale facciale i nervi facciali e quelli intermedi formano un tronco comune, compiendo due giri secondo le anse del canale (Fig. 238).

Riso. 238. Nervi dei canali dell'osso temporale. 1 - nervo stapedio; 2 - corda di tamburo; 3 - plesso timpanico; 4 - ramo di collegamento del nervo facciale con il plesso timpanico; 5 - montaggio del gomito; 6 - nervo facciale; 7 - nervo intermedio; 8 - nervo vestibolococleare; 9, 19 - ramo di collegamento dal ganglio al plesso dell'arteria media delle meningi; 10 - nervo petroso maggiore; 11 - nervo carotideo-timpanico; 12 - nervo petroso minore; 13 - plesso nervoso carotideo interno; 14 - nervo petroso profondo; 15 - nervo del canale pterigoideo; 16 - nervi pterigopalatini; 17 - nervo mascellare; 18 - nodo pterigopalatino; 20 - plesso nervoso attorno all'arteria media delle meningi; 21 - nodo auricolare; 22 - rami del ganglio dell'orecchio al nervo auricolotemporale; 23 - ramo di collegamento tra il nodo dell'orecchio e la corda del tamburo; 24 - nervo masticatorio; 25 - nervo mandibolare; 26 - nervo linguale; 27 - nervo alveolare inferiore; 28 - nervo auricolotemporale; 29 - nervo timpanico; 30 - nervo glossofaringeo; 31 - nodo superiore del nervo vago; 32 - ramo auricolare del nervo vago; 33 - ramo di collegamento del nervo facciale con il ramo auricolare del vago; 34 - rami del nervo facciale al muscolo stiloioideo; 35 - rami del nervo facciale al ventre posteriore del muscolo digastrico; 36 - nervo auricolare posteriore; 37 - processo mastoideo
Inizialmente, il nervo si trova orizzontalmente, correndo anteriormente e lateralmente sopra la cavità timpanica. Quindi, in corrispondenza del ginocchio del canale facciale, il nervo ritorna ad angolo retto, formando il genicolo n. facialis e il nodo del ginocchio, gangl. geniculi, appartenente al nervo intermedio. Passando sopra la cavità timpanica, il nervo facciale fa una seconda svolta - verso il basso, situata dietro la cavità dell'orecchio medio, ed esce dal canale attraverso il forame stilomastoideo, entrando presto nella ghiandola salivare parotide. La lunghezza del tronco della parte extracranica del nervo facciale varia da 0,8 a 2,3 cm (di solito 1,5 cm) e lo spessore da 0,7 a 1,4 mm. Il nervo contiene 3500-9500 fibre nervose molli, tra le quali predominano quelle spesse.
Nella ghiandola salivare parotide, ad una profondità di 0,5-1 cm dalla sua superficie esterna, il nervo facciale è diviso in 2-5 rami primari, che a loro volta sono divisi in secondari, formando il plesso nervoso parotideo, plesso parotideo.
Esistono due forme della struttura esterna del plesso parotideo: reticolare e principale (Fig. 239). Nella forma reticolare il tronco del nervo facciale è corto (0,8-1,5 cm); nello spessore della ghiandola è diviso in molti rami che hanno più connessioni tra loro, a seguito delle quali si forma un plesso ad ansa stretta. Nella forma principale il tronco nervoso è relativamente lungo (1,5-2,3 cm); è diviso in due rami (superiore ed inferiore), che danno origine a diversi rami secondari; ci sono poche connessioni tra i rami secondari, il plesso è ampiamente ad ansa. Nella forma reticolare del plesso si osservano molteplici connessioni con i rami del nervo trigemino. Nel suo percorso, il nervo facciale emette rami lungo il canale, così come all'uscita da esso.

Riso. 239. Differenze nella struttura del nervo facciale. a - struttura a rete del nervo facciale; b - struttura principale del nervo facciale. 1 - nervo facciale; 2 - muscoli masticatori
Nel canalis facialis, il nervo facciale dà origine ai seguenti rami:
1. Nervo petroso maggiore, n. petrosus major, origina da gangl. geniculi, lascia il canale del nervo facciale attraverso lo iato canalis n. petrosi major e corre lungo il solco omonimo fino al forame lacerum, penetrando attraverso la cartilagine fino alla base esterna del cranio. Qui si collega al n. petrosus profundus e forma il nervo del canale pterigoideo, n. canalis pterygoidei, entrando nel canale pterigoideo e raggiungendo i gangli. pterigopalatino. Il nervo trasporta le fibre parasimpatiche pregangliari al ganglio pterigopalatino, nonché le fibre sensoriali delle cellule gangliari. genicoli. Alcune delle fibre sensoriali del nervo grande petroso provengono dai gangli. pterigopalatino nel nervo facciale.
2. Nervo stapediale, n. stapedius, un fusto sottile, si dirama nel canale facciale al secondo giro, penetra nella cavità timpanica, dove innerva m. stapedius (vedi sezione Orecchio medio, questa edizione).
3. La corda del timpano è una continuazione del nervo intermedio. Si separa dal nervo facciale nella parte inferiore del canale sopra il foro stilomastoideo ed entra attraverso il canalicolo corda del timpano nella cavità timpanica, dove si trova sotto la mucosa tra la gamba lunga dell'incudine e il manico del martello. . Attraverso la fessura petrotimpanica, la corda del timpano esce alla base esterna del cranio e si fonde con il nervo linguale (vedi sezione Nervo mandibolare, questa edizione). Nel punto di intersezione con il nervo alveolare inferiore, la corda del timpano emette un ramo di collegamento con il ganglio dell'orecchio, ramus communicans cum ganglio oticum, in cui le fibre motorie passano dal nervo facciale al m. elevatore del velo palatino.
4. Il ramo di collegamento con il plesso timpanico, ramus communicans cum plexu tympanico, è un ramo sottile che nasce dal gangl. geniculi o n. petrosus major, passa attraverso il tetto della cavità timpanica fino al plesso timpanico.
All'uscita dal canale, dal tronco principale del nervo facciale si diramano i rami successivi.
1. Nervo auricolare posteriore, n. auricularis posteriore, origina dal nervo facciale immediatamente dopo l'uscita dal foro stilomastoideo. Va avanti e indietro lungo la superficie anteriore del processo mastoideo, dividendosi in due rami: l'auricolare, ramus auricularis, che innerva il lungo muscolo posteriore, e l'occipitale, ramus occipitalis, il ventre occipitale del muscolo pericranico.
2. Il ramo digastrico, ramo digastricus, parte leggermente al di sotto del nervo auricolare posteriore e, scendendo, innerva l'addome posteriore del m. digastrico e m. stylohyoidus.
3. Ramo di connessione con il nervo glossofaringeo, ramo comunicante cum n. glossopharyngeo, si ramifica vicino al foro stilomastoideo e si diffonde anteriormente e verso il basso lungo m. stylopharyngeus, che si collega ai rami del n. glossofaringeo.
I rami del plesso parotideo sono i seguenti.
1. I rami temporali, rami temporalis, nella quantità di 2-4 salgono e sono divisi in tre gruppi di rami: quelli anteriori, che innervano la parte superiore del muscolo orbicularis oculi e m. corrufator supercilii, medio, che innerva il muscolo frontale, posteriore, che innerva la parte anteriore del m. epicranius temporoparietalis e muscoli vestigiali del padiglione auricolare.
2. Rami zigomatici, rami zygomatici, in quantità di 3-5, si diffondono in avanti e verso l'alto fino alle parti inferiore ed esterna del muscolo orbicularis oculi e del muscolo zigomatico, che innervano.
3. Rami buccali, rami buccali, in quantità di 3-5, corrono orizzontalmente anteriormente lungo la superficie esterna del muscolo masticatorio e forniscono rami ai muscoli intorno al naso e alla bocca.
4. Il ramo marginale della mascella inferiore, ramo marginale mandibulae, si estende lungo il bordo della mascella inferiore, innerva mm. risorius, depressore labii inferioris, mentalis.
5. Il ramo cervicale, ramo colli, scende al collo e si collega con n. colli trasversali.
Nervo intermedio , N. intermedine, costituite da fibre motorie pregangliari, parasimpatiche e sensoriali. Le cellule unipolari sensibili si trovano nei gangli. geniculi. I processi centrali delle cellule salgono come parte della radice nervosa e terminano nel nucleo del tratto solitario. I processi periferici delle cellule sensoriali passano attraverso la corda del timpano e n. petroso maggiore.
Le fibre parasimpatiche secretive hanno origine nel nucleo salivatorio superiore nella parte dorsale del ponte. La radice del nervo intermedio lascia il cervello tra i nervi facciale e vestibolococleare, quindi si unisce al nervo facciale e scorre nel canale facciale. Le fibre del nervo intermedio lasciano il tronco facciale nella corda del timpano e n. petrosus major e raggiungono le ghiandole salivari sottomandibolari e sublinguali, le ghiandole della mucosa della cavità nasale, il palato, la ghiandola lacrimale, nonché gli organi del gusto della lingua.
VIII coppia - nervi vestibolococleari (anatomia umana)
nervo vestibolococleare , N. vestibulocochlearis (o nervo VIII, n. octavus) è sensibile, composto da due parti funzionalmente diverse: la vestibolare, pars vestibularis, e la cocleare, pars cochlearis. La parte vestibolare conduce gli impulsi dall'apparato statico del vestibolo e dai canali semicircolari del labirinto dell'orecchio interno. La parte cocleare assicura la trasmissione degli stimoli sonori provenienti dall'organo Corti della coclea. Ogni parte del nervo ha i propri nodi sensoriali contenenti cellule nervose bipolari: pars vestibularis - nodo vestibolare, gangl. vestibolare, situato nella parte inferiore del canale uditivo interno, pars cochlearis - nodo spirale, gangl. spirale - nella lumaca. Il nodo vestibolare è allungato, ha due parti: quella superiore, pars superior, e quella inferiore, pars inferior. I processi periferici delle cellule della parte superiore formano i seguenti nervi: a) nervo sacculare ellittico, n. utricularis, va alle cellule della sacca ellittica del vestibolo della coclea; b) nervo ampollare anteriore, n. ampollare anteriore, va alle cellule delle strisce sensibili dell'ampolla membranosa anteriore del canale semicircolare anteriore; c) nervo ampollare laterale, n. ampullaris lateralis, va all'ampolla membranosa laterale. Dalla parte inferiore del ganglio vestibolare, i processi cellulari periferici provengono come parte di: a) nervo sferico-sacculare, n. saccularis, alla macula uditiva del sacco; b) verme ampollare posteriore, n. ampollare posteriore, all'ampolla membranosa posteriore (vedere la sezione Orecchio interno, questa edizione).
I processi centrali delle cellule del ganglio vestibolare formano la radice superiore (vestibolare), radice superiore (vestibularis), che esce attraverso l'apertura uditiva interna dietro i nervi facciali e intermedi ed entra nel cervello vicino all'uscita n. facialis, raggiungendo i quattro nuclei vestibolari (mediale, laterale, superiore, inferiore) nel ponte (vedi sezione Midollo allungato, questa edizione).
Dall'angolo della spirale, gangl. spirale, i processi periferici delle sue cellule nervose bipolari vanno alle cellule epiteliali sensibili dell'organo spirale della coclea, formando collettivamente la pars cochlearis del nervo. I processi centrali delle cellule del ganglio spirale formano la radice inferiore (cocleare), radice inferiore (cochlearis), che insieme alla radice superiore va nel cervello fino ai nuclei cocleari dorsale e ventrale (vedi sezione Midollo allungato, questa edizione) .
IX paio - nervi glossofaringei (anatomia umana)
Nervo glossofaringeo , N. glossofaringeo, nervo III dell'arco branchiale, misto. Innerva la mucosa del terzo posteriore della lingua, le arcate palatine, la faringe, la cavità timpanica, la ghiandola parotide e m. stilofaringeo (Fig. 240, 242).

Riso. 240. Schema della struttura del nervo glossofaringeo. 2 - nervo facciale; 2 - nervo timpanico; 3 - nodo inferiore del nervo glossofaringeo; 4 - nervo glossofaringeo; 5 - nodo auricolare; 6 - nodo pterigopalatino; 7 - nodo trigemino; 8 - nervo petroso minore; 9 - nervo petroso maggiore
Il nervo contiene tre tipi di fibre nervose: a) sensoriali, b) motorie, c) parasimpatiche. Le fibre sensibili sono processi di cellule afferenti dei gangli nervosi superiori e inferiori, gangli. superius et inferius. I processi periferici seguono come parte del nervo agli organi dove formano i recettori, quelli centrali vanno al midollo allungato, dividendosi in due rami - uno corto discendente - al nucleo dorsale sensibile, nucleo dorsale, e uno più lungo ascendente - al nucleo sensibile del tratto solitario, nucleus tractus solitarii. Le fibre motorie derivano dalle cellule nervose del doppio nucleo, nucleo ambiguo, comune al nervo vago, e da esso passano come parte del nervo al m. stilofaringeo. Le fibre parasimpatiche hanno origine nel nucleo salivare inferiore del parasimpatico autonomo, nucleo salivatorius inferiore, che si trova nel midollo allungato.
La radice del nervo glossofaringeo emerge dal midollo allungato dietro il sito di uscita del nervo vestibolococleare e, insieme al nervo vago, lascia il cranio attraverso il foro giugulare. Nel foro giugulare si trova il primo ispessimento del nervo: il ganglio nervoso superiore, gangl. superius, e all'uscita dal foro - una seconda estensione - il nodo inferiore, gangl. inferiore. All'esterno del cranio, il nervo glossofaringeo si trova dapprima tra l'arteria carotide interna e la vena giugulare interna, quindi si piega in un arco delicato dietro e all'esterno del m. stilofaringeo e si avvicina dall'interno del muscolo ipoglosso alla radice della lingua, dividendosi in rami terminali. Il nervo glossofaringeo dà origine ai seguenti rami (Fig. 240).
1. Nervo timpanico, n. tympanicus, si dirama dal nodo inferiore e passa attraverso il canaliculus tympanicus nella cavità timpanica, dove si forma insieme ai rami simpatici del plesso caroticus internus - nn. caroticotympanici: plesso nervoso timpanico, plesso timpanico. Il plesso timpanico innerva la mucosa della cavità timpanica e la tuba uditiva. Il nervo lascia la cavità timpanica attraverso la sua parete superiore chiamata n. petrosus minor, che va al gangl. otico. Fibre secretorie parasimpatiche pregangliari passanti attraverso n. petrosus minor, vengono interrotti nel nodo auricolare e le fibre secretorie postgangliari entrano n. auriculotemporalis e raggiungere in esso la ghiandola salivare parotide (vedi sezione Nervo mandibolare, questa edizione).
2. Ramo del muscolo stilofaringeo, ramo m. stylo pharyngei, al muscolo omonimo e alla mucosa della faringe.
3. Ramo del seno carotideo, ramo del seno carotideo, sensibile, che si ramifica nel seno carotico e nel glomo carotico.
4. Rami della tonsilla, rami tonsillaris, alla mucosa della tonsilla palatina e degli archi.
5. Rami faringei, rami faringei, in quantità di 3-4, passano alla faringe e, insieme ai rami faringei del nervo vago e del tronco simpatico, formano il plesso nervoso faringeo, plesso faringeo, sulla superficie esterna del faringe, che contiene anche 1-2 piccoli gangli nervosi. Da esso si dipartono i rami dei muscoli della faringe e della mucosa, che a loro volta formano i plessi nervosi intramurali.
6. I rami linguali, rami linguales, i rami terminali del nervo glossofaringeo, contengono fibre sensoriali e gustative nella mucosa del terzo posteriore della lingua.
Coppia X - nervi vaghi (anatomia umana)
Nervo vago , N. vago, misto, si sviluppa dalle arcate branchiali IV-V e ha un areale ampio, da qui il nome. Innerva gli organi respiratori, gli organi
L'apparato digerente (fino al colon sigmoideo), la tiroide e le paratiroidi, le ghiandole surrenali, i reni, sono coinvolti nell'innervazione del cuore e dei vasi sanguigni.
Il nervo vago contiene conduttori parasimpatici e simpatici sensoriali, motori e autonomi, nonché piccoli nodi nervosi intratroncali (Fig. 241). Le fibre nervose sensibili del nervo vago provengono da cellule nervose afferenti pseudounipolari, i cui gruppi formano due gangli nervosi sensoriali: il ganglio superiore. superius, situato nel foro giugulare, e inferiore, gangl. inferius, giacente all'uscita del foro. I processi centrali delle cellule vanno nel midollo allungato al nucleo sensibile, nucleo del tratto solitario (sui nuclei nervosi, vedere la sezione midollo allungato, questa edizione), e quelli periferici - come parte del nervo ai vasi, cuore e organi interni, dove terminano nell'apparato recettore. Le fibre motorie per i muscoli volontari del palato molle, della faringe e della laringe provengono dalle cellule nervose del nucleo motore, nucleo ambiguo. Le fibre parasimpatiche autonome provengono dal nucleo dorsale vegetativo, nucleo dorsale e si diffondono come parte del nervo al muscolo striato del cuore, al tessuto muscolare liscio dei vasi sanguigni e agli organi interni. Allo stesso tempo, gli impulsi che viaggiano lungo le fibre parasimpatiche rallentano il battito cardiaco, dilatano i vasi sanguigni, restringono i bronchi e aumentano la peristalsi degli organi tubolari del tratto digestivo. Le fibre simpatiche postgangliari autonome entrano nel nervo vago lungo i suoi rami di collegamento con il tronco simpatico dalle cellule dei gangli simpatici paravertebrali e si diffondono lungo i rami del nervo vago al cuore, ai vasi sanguigni e agli organi interni.

Riso. 241. Schema della struttura del vago e dei nervi accessori. 1 - ramo di collegamento del nervo vago con il nervo facciale; 2 - nervo glossofaringeo; 3 - nervo accessorio; 4 - ramo di collegamento del nervo vago con il nervo ipoglosso; 5 - ramo di collegamento del nervo vago con il tronco simpatico; 6 - lingua; 7 - osso ioide; 8 - laringe; 9 - trachea; 10 - nervo laringeo ricorrente destro; 11 - nervo laringeo ricorrente sinistro; 12 - nervo vago sinistro; 13 - arco aortico; 14 - polmone sinistro; 15 - cuore; 16 - diaframma; 17 - stomaco; 18 - fegato; 19 - nodo semilunare destro del plesso nervoso celiaco; 20 - nodo nervoso sull'aorta ascendente; 21 - polmone destro; 22 - esofago; 23 - rami del nervo laringeo inferiore destro; 24 - nervo laringeo superiore; 25 - muscolo trapezio; 26 - muscolo sternocleidomastoideo; 27 - nervo accessorio; 28 - nuclei del vago e dei nervi accessori; 29 - nucleo del nervo vago; 30 - nervo facciale
Come già notato, il nervo vago durante lo sviluppo distingue per differenziazione i nervi glossofaringei e accessori. Pertanto, mantiene le connessioni con questi nervi, così come con i nervi ipoglosso e simpatico attraverso rami di collegamento.
Il nervo vago lascia il midollo allungato attraverso numerose radici, fondendosi nel solco laterale posteriore in un tronco comune, che lascia la cavità cranica attraverso il foro giugulare. Successivamente, il nervo vago scende verso il basso come parte del fascio neurovascolare cervicale tra la vena giugulare interna e l'arteria carotide interna, e sotto il livello del bordo superiore della cartilagine tiroidea tra la stessa vena e l'arteria carotide comune. Attraverso l'apertura superiore del torace, il nervo vago penetra tra la vena e l'arteria succlavia (a destra) e davanti all'arco aortico (a sinistra) nel mediastino posteriore. Qui si forma davanti all'esofago (nervo sinistro) e dietro di esso (nervo destro) mediante ramificazioni e connessioni tra i rami, un plesso nervoso, che, in prossimità dell'apertura esofagea del diaframma, forma due tronchi vaghi, quello anteriore, tronco vagalis anteriore e quello posteriore, truncus vagalis posteriore, corrispondente al nervo vago sinistro e destro. Entrambi i tronchi escono dalla cavità toracica attraverso l'apertura esofagea, danno rami allo stomaco e terminano in una serie di rami terminali nel plesso nervoso celiaco, plesso celiaco.
Da esso nascono rami lungo l'intera lunghezza del nervo vago (Fig. 242).

Riso. 242. Nervi vago e glossofaringei e tronco simpatico. 1 - rami cardiaci inferiori del nervo vago; 2 - nervo laringeo inferiore; 3 - rami cardiaci superiori; 4 - plesso faringeo; 5 - nervo ipoglosso; 6 - nervo laringeo superiore; 7 - nervo linguale; 8 - rami faringei del nervo vago; 9 - nervo glossofaringeo; 10-11 - rami del nervo accessorio; 12, 15, 17, 19 - II, III, IV, V nervi spinali cervicali; 13 - nodo cervicale superiore del tronco simpatico; 14, 16 - nervo vago; 18 - nervo frenico; 20 - nodo cervicale medio del tronco simpatico; 21 - plesso brachiale; 22 - nodo cervicale inferiore del tronco simpatico; 23, 24, 26, 28 - II, III, IV, V nodi toracici del tronco simpatico; 25 - nervo laringeo ricorrente; 27 - plesso polmonare
Rami del nervo vago intracranico. 1. Il ramo delle meningi, ramus meningeus, nasce da gangl. superius e attraverso il foro giugulare raggiunge la dura madre della fossa posteriore del cranio.
2. Il ramo auricolare, ramus auricularis, va dal nodo superiore lungo la superficie anterolaterale del bulbo della vena giugulare fino all'ingresso del canaliculus mastoideus e ulteriormente lungo esso fino alla parete posteriore del canale uditivo esterno e parte della pelle del padiglione auricolare. Nel suo percorso forma rami di collegamento con il nervo glossofaringeo, ramo comunicante cum n. glossopharyngeo, e con il nervo facciale, ramus communicans cum. N. facciale.
Rami del nervo vago cervicale. 1. I rami faringei, rami pharyngei, originano o dal nodo inferiore, o immediatamente sotto di esso, dal tronco stesso, ricevono rami sottili dal nodo cervicale superiore del tronco simpatico e, tra le arterie carotidi esterna ed interna, penetrano alla parete laterale della faringe, sulla quale, insieme al faringeo. I rami del nervo glossofaringeo e il tronco simpatico formano il plesso faringeo.
2. Nervo laringeo superiore, n. laringeo superiore, si dirama dal nodo inferiore e scende e avanza lungo la parete laterale della faringe medialmente dall'arteria carotide interna, dividendosi in corrispondenza del grande corno dell'osso ioide in due rami: quello esterno, ramo esterno, e quello interno, ramo interno. Il ramo esterno si collega con piccoli rami dal ganglio cervicale superiore del tronco simpatico e corre lungo il bordo posteriore della cartilagine tiroidea fino a m. cricothyreoideus e il costrittore inferiore della faringe, e dà anche incoerentemente rami a mm. arythenoidei trasverso e obliquo, cricoarythenoideus lateralis. Inoltre, dà rami alla mucosa della faringe e alla ghiandola tiroidea. Il ramo interno, più spesso e sensibile, perfora la membrana tireoidea e si ramifica nella mucosa del recessus piriformis (sopra la glottide), nonché nella mucosa dell'epiglottide e nella parete anteriore della faringe nasale. Forma un ramo di collegamento con il nervo laringeo inferiore, ramo comunicante cum n. laringeo inferiore.
3. I rami cardiaci cervicali superiori, rami cardiaci cervicales superiores, variabili per spessore e livello di branca, generalmente sottili, hanno origine tra i nervi laringei superiori e ricorrenti e scendono al plesso nervoso cervicotoracico (vedi sezione Plessi autonomici cervicali e toracici, presenti pubblicazioni).
4. I rami cardiaci cervicali inferiori, rami cardiaci cervicales inferiores, originano dal nervo laringeo ricorrente e dal tronco del nervo vago e partecipano alla formazione del plesso nervoso cervicotoracico.
Rami del nervo vago toracico. 1. Nervo laringeo ricorrente, n. laringeo ricorrente, lascia il nervo vago immediatamente entrando nella cavità toracica, e il nervo ricorrente destro si piega attorno all'arteria succlavia destra da sotto e dietro, e quello sinistro attorno all'arco aortico. Entrambi i nervi salgono lungo i solchi tra l'esofago e la trachea, emettendo rami verso gli organi. Il ramo terminale è il nervo laringeo inferiore, n. laringeo inferiore, si avvicina alla laringe e innerva tutti i muscoli della laringe, ad eccezione di m. cricothyreoideus e la mucosa della laringe sotto le corde vocali. Forma un ramo di collegamento con il nervo laringeo superiore.
Il nervo laringeo ricorrente dà origine ai seguenti rami: a) rami tracheali, rami tracheali, al plesso nervoso della trachea; b) rami esofagei, rami esofagei, verso l'esofago; c) rami della tiroide, rami tireoidei, alla tiroide e alle ghiandole paratiroidi; d) nervo laringeo inferiore.
2. I rami cardiaci toracici, rami cardiaci thoracici, originano dai nervi ricorrenti vago e laringeo sinistro e partecipano alla formazione del plesso cervicotoracico.
3. Rami tracheali, rami tracheali, - alla trachea toracica.
4. Rami bronchiali, rami bronchioli, - ai bronchi.
5. Rami esofagei, rami esofagei, - all'esofago toracico.
6. Rami pericardici, rami pericardiaci, - alla parete posteriore del pericardio.
All'interno delle cavità del collo e del torace, i rami del vago, dei nervi ricorrenti e dei tronchi simpatici formano un potente plesso cervicotoracico, plesso cervicotoracico, in cui si distinguono i plessi degli organi: tiroide, plesso tireoideo, tracheale, plesso tracheale, esofageo, plesso esofageo , polmonare, plesso polmonare, cardiaco, plesso cardiaco, ecc. (vedi sezione Plessi autonomici cervicali e toracici, questa edizione).
Rami del tronco vago (parte ventrale).
1. I rami gastrici anteriori, rami gastrici anteriores, derivano dal tronco anteriore e formano il plesso gastrico anteriore, plesso gastrico anteriore, sulla superficie anteriore dello stomaco.
2. I rami gastrici posteriori, rami gastrici posteriores, si estendono dal tronco posteriore e formano il plesso gastrico posteriore, plesso gastrico posteriore.
3. I rami celiaci, rami celiaci, si avvicinano maggiormente al plesso celiaco dal tronco posteriore, mentre dal tronco anteriore seguono il decorso di a. gastrica sinistra. I rami celiaci partecipano alla formazione del plesso celiaco, plesso celiaco (vedi sezione Plessi addominali autonomi, questa edizione).
4. Rami epatici, rami epatici, - al plesso nervoso epatico, plesso epatico (vedere la sezione Plessi autonomici addominali, questa edizione).
5. Rami renali, rami renali, - al plesso nervoso renale, plesso renale.
Dal plesso celiaco, le fibre del nervo vago si diffondono attraverso i plessi perivascolari fino agli organi.
XI paio - nervi accessori (anatomia umana)
Nervo accessorio , N. accessori, principalmente motori, separati durante lo sviluppo dal nervo vago. Inizia in due parti: craniale e spinale dai corrispondenti nuclei motori nel midollo allungato e nel midollo spinale. Le fibre afferenti entrano nel tronco attraverso la parte spinale dalle cellule dei gangli intervertebrali (vedi Fig. 241 e 242).
La parte cranica emerge dalle radici craniche, radices craniales, dal midollo allungato sotto l'uscita n. vago La parte spinale è formata dalle radici spinali, radices fuselli, che emergono dal midollo spinale tra le radici dorsale e ventrale da un numero variabile di segmenti cervicali da CII a CVII. La parte spinale del nervo sale al forame magno, entra attraverso di esso nella cavità cranica, dove si collega con la parte cranica e forma il tronco comune del nervo.
Nella cavità cranica il nervo accessorio è diviso in due rami: interno ed esterno.
1. Il ramo interno, ramo interno, si avvicina al nervo vago. Attraverso questa diramazione al n. vago sono collegati da fibre nervose motorie che lo lasciano attraverso i nervi laringei. Si può presumere che le fibre sensoriali passino in transito anche al nervo vago e successivamente al nervo laringeo.
2. Il ramo esterno, ramo esterno, lascia la cavità cranica attraverso il foro giugulare fino al collo e si trova prima dietro l'addome posteriore di m. digastricus, e poi dall'interno del muscolo sternocleidomastoideo. Perforando quest'ultimo, il ramo scende e termina nel muscolo trapezio. Si osserva la formazione di rami di collegamento tra i nervi accessori e cervicali.
Il ramo innerva i muscoli sternocleidomastoideo e trapezio.
XII coppia - nervi ipoglossi (anatomia umana)
Nervo ipoglosso , N. l'ipoglosso, prevalentemente motorio, si sviluppa come risultato della fusione di diversi nervi segmentali spinali primari che innervano i muscoli ipoglossi. Tuttavia, attraverso di esso passano anche altri tipi di fibre. Le fibre nervose sensoriali provengono dalle cellule del ganglio inferiore del nervo vago e, eventualmente, dalle cellule dei gangli intervertebrali lungo i rami di collegamento tra i nervi ipoglosso, vago e cervicale. Le fibre simpatiche entrano nel nervo ipoglosso lungo il suo ramo di collegamento con il ganglio cervicale superiore del tronco simpatico (Fig. 243). Le fibre nervose motorie che compongono il nervo ipoglosso nascono dalle cellule del suo nucleo motore, situato nel midollo allungato (vedi sezione Midollo allungato, questa edizione). Da esso emerge il nervo tra la piramide e l'olivo con numerose radici. Il tronco nervoso formato passa attraverso i canali ipoglossi fino al collo, dove si trova prima tra le arterie carotidi esterna ed interna, e poi scende sotto l'addome posteriore del m. digastricus a forma di arco aperto verso l'alto lungo la superficie laterale di m. hyoglossus, che costituisce il lato superiore del triangolo Pirogov. Sul bordo anteriore, il nervo si ramifica nei rami linguali terminali, rami lunguales, che innervano i muscoli della lingua.

Riso. 243. Schema della struttura del nervo ipoglosso. 1 - fossa a forma di diamante; 2 - canale del nervo ipoglosso; 3 - collega i rami del nervo ipoglosso con il nodo cervicale superiore del tronco simpatico e il nodo inferiore del nervo vago; 4 - nervo ipoglosso; 5, 6 - rami del nervo ipoglosso ai muscoli della lingua; 7 - rami del nervo ipoglosso al muscolo genioioideo; 8 - osso ioide; 9 - ramo del nervo ipoglosso al muscolo tiroioideo; 10 - rami del nervo ipoglosso al muscolo sternoioideo; 11 - rami del nervo ipoglosso al muscolo sternotiroideo; 12 - ramo del muscolo omoioideo; 13 - vena giugulare interna; 14 - radice inferiore dell'anello ioide; 15 - radice superiore dell'anello ioide; 16 - vena giugulare interna; 17 - arteria carotide interna; 18 - I, II nervi spinali cervicali; 19 - nucleo del nervo ipoglosso
Dal centro dell'arco nervoso lungo a. carotis communis, si diparte un ramo: la radice superiore dell'ansa cervicale, radix superior ansae cervicalis, che si collega con la sua radice inferiore, radix inferior, dando luogo alla formazione dell'ansa cervicale, ansa cervicalis. Diversi rami si estendono dall'ansa cervicale ai muscoli del collo (vedi sezione Plesso brachiale, questa edizione).
La posizione del nervo ipoglosso nel collo può variare. Nelle persone con il collo lungo l'arco formato dal nervo è relativamente basso, mentre nelle persone con il collo corto è alto, il che è importante da considerare quando si opera sul nervo.
Interrogare il paziente. Da quanto sopra è chiaro che il territorio di innervazione del nervo trigemino è molto ampio; al nervo trigemino è associato un folto gruppo di nodi autonomici. Il dolore in faccia può essere causato dalla sconfitta di ciascuno di essi. La diagnosi topica della sindrome del dolore in ciascun caso specifico viene stabilita praticamente solo sulla base di un'analisi del carattere di Poly; sulla base di ciò, quando si intervistano i pazienti, è particolarmente importante stabilire se il dolore ha un temperamento lancinante o se è pressante, scoppiante; compaiono inaspettatamente e durano pochi secondi o aumentano lentamente, e sullo sfondo di questo aumento appare un parossismo doloroso. quanto durano (secondi, ore, giorni, ecc.), dove si localizzano inizialmente e dove si irradiano, da cosa sono accompagnati e cosa li provoca. A quali tecniche ricorre il paziente per ridurre il dolore, quali farmaci specifici apportano sollievo. Qual è la dinamica della sindrome dolorosa (prima gli attacchi erano rari, ma arrivavano sporadicamente, ora sono diventati più frequenti fino a tante volte al giorno). Quali nuovi sintomi specifici sono stati aggiunti al dolore (ad esempio, intorpidimento).
Esame del pazienteè di grande importanza, soprattutto durante il periodo di parossismo doloroso. L'attenzione viene prestata al comportamento del paziente, alla presenza di una smorfia di dolore, all'ipercinesia del viso e alla reazione autonomica.
Palpazione dei punti di uscita dei rami del nervo trigemino (punti Balle). Il punto d'uscita del primo ramo del nervo trigemino si palpa nell'incisura sopraorbitaria. Per fare ciò, l'esaminatore fa scorrere il suo enorme dito lungo l'arco sopraciliare e il dito, per così dire, urta in una tacca che corrisponde al punto di uscita del nervo frontale (n. frontalis).
II ramo del nervo trigemino palpato nel punto medio della fossa canina (fossa canina). Corrisponde al punto di uscita del nervo infraorbitario.

III ramo- nel punto medio della fossa mentoniera, corrisponde al punto in cui il nervo mentoniero (n. mentalis) esce dal canale mandibolare sulla superficie del cranio. Tutti e tre i punti sono approssimativamente sulla stessa linea. In questi punti si determina la presenza del dolore e l'entità del dolore.
Successivamente vengono esaminati il dolore, la temperatura, la sensibilità tattile e la sensazione muscolo-articolare profonda di tipo radicolare. La sensibilità al dolore viene testata applicando iniezioni su aree simmetriche del viso nelle aree di innervazione di alcuni rami del nervo trigemino, la sensibilità tattile toccando con l'estremità appuntita di un pezzo di carta. Il paziente deve anche contare ad alta voce il numero di tocchi. La sensibilità muscolo-articolare profonda viene testata muovendo la plica cutanea. Il paziente deve scoprire la direzione del suo spostamento.

Prova di sensibilità a seconda della tipologia segmentale, si effettua mediante iniezioni lungo la linea mediana del viso dall'orecchio al naso. Sottolineiamo che in molte persone sane la sensibilità nella zona nasale è migliore che in altre parti del viso, il che dà l'impressione della presenza di ipoalgesia nei territori esterni e medi di Zelder. In questi casi, per accertarsi che non vi siano disturbi della sensibilità, è consigliabile studiare la sensibilità al dolore lungo la linea mediana della fronte da tempia a tempia. Non dobbiamo dimenticare che le sezioni laterali delle guance nella regione dell'angolo della mascella inferiore sono innervate dalla seconda radice cervicale C2.
Controllo della funzione della porzione motoria del nervo trigemino. Si richiama l'attenzione sulla simmetria della posizione della mascella inferiore. Viene controllato il numero dei suoi movimenti. Per fare ciò, al paziente viene chiesto di aprire e chiudere la bocca, muovere la mascella verso destra (viene controllata la funzione del muscolo pterigoideo sinistro) e verso sinistra (viene controllata la funzione del muscolo opposto). Insieme a questo, il numero di movimenti creati deve essere elevato. Vengono palpati i muscoli masticatori, durante i quali si determina la presenza di atrofia e il tono muscolare. Al paziente viene inoltre chiesto di stringere e aprire bene i denti ed eseguire movimenti di masticazione.

Quando si controlla la forza dei muscoli masticatori, è necessario immaginare con precisione la loro funzione: muscolo temporale - la contrazione di tutti i suoi fasci solleva la mascella inferiore cadente; i fasci posteriori tirano indietro la mascella inferiore sporgente.
I muscoli masticatori sollevano la mascella inferiore abbassata; la parte superficiale del muscolo la spinge in avanti.
Il ventre anteriore del muscolo digastrico abbassa la mascella inferiore e solleva l'osso ioide verso l'alto e anteriormente.
Stato di forza dei muscoli temporali e masticatori viene esaminato come segue: al paziente viene chiesto di aprire la bocca, quindi chiuderla; Il medico, appoggiando il pollice sul mento, resiste a questo movimento.

La forza del muscolo digastrico viene determinata come segue: il medico mette la mano sotto il mento del paziente, il paziente cerca di aprire la bocca, il medico resiste.
Muscoli pterigoidi: il medico posiziona il palmo della mano sul lato della guancia del paziente; il paziente cerca di muovere la mano esaminante con la mascella.
Sfortunatamente, molto spesso qualsiasi carico aggiuntivo può provocare un attacco di nevralgia. Uno dei tipi più comuni è la nevralgia del trigemino.
Affrontare questa diagnosi provoca un dolore atroce per le persone. Le cause e i sintomi della malattia compaiono immediatamente, è necessario un ciclo di trattamento sotto la supervisione di un medico.
Il nervo trigemino è uno dei dodici nervi cranici, che conferisce sensibilità alla zona facciale, grazie a tre rami che si estendono da esso:
- Oftalmico;
- Mascellare;
- Mandibolare.
Poiché da ciascun ramo nascono piccoli vasi, il nervo trigemino copre quasi l'intera area del viso.
Le donne di età superiore ai 45-50 anni hanno maggiori probabilità di sviluppare la malattia; tuttavia, la nevralgia può svilupparsi in pazienti di qualsiasi sesso ed età. Per molti pazienti, la nevralgia del trigemino è una malattia dolorosa. 
Cosa può portare all'infiammazione
La nevralgia del trigemino può manifestarsi da sola o come conseguenza di una malattia. Vari fattori contribuiscono allo sviluppo della malattia; in medicina non è stata identificata alcuna causa specifica.
I fattori che influenzano lo sviluppo del processo infiammatorio sono i seguenti:
- Ipotermia dell'area del viso;
- Malattie virali passate: herpes, herpes zoster e altre;
- Sistema immunitario indebolito;
- Qualsiasi trauma al viso o alla testa;
- La presenza di un tumore o di un aneurisma dei vasi sanguigni che può comprimere il nervo, compromettendone il funzionamento;
- Varie malattie o processi infiammatori nel cavo orale;
- Stress emotivo e psicologico;
- Placche di colesterolo sulle pareti dei vasi sanguigni.
Quanto è pericoloso?
Oltre alla comparsa di dolori lancinanti, i pazienti corrono il rischio di sviluppare paralisi facciale completa o incompleta, nonché perdita di sensibilità.
 Poiché le persone con questa diagnosi cercano di utilizzare la metà non affetta del viso e della bocca quando masticano il cibo, possono formarsi noduli muscolari sul lato opposto.
Poiché le persone con questa diagnosi cercano di utilizzare la metà non affetta del viso e della bocca quando masticano il cibo, possono formarsi noduli muscolari sul lato opposto.
Se la malattia è protratta, sono possibili gravi conseguenze e complicazioni sotto forma di sviluppo di cambiamenti distrofici nei muscoli masticatori e ridotta sensibilità nella zona interessata del viso.
La nevralgia è molto difficile da trattare. In alcuni casi è necessario un trattamento ospedaliero.
Una forma avanzata della malattia e un trattamento ritardato possono portare a una forma cronica della malattia.
Sintomi della lesione
È abbastanza difficile non notare la presenza della nevralgia del trigemino. I sintomi e i segni primari di infiammazione si presentano come segue:
- Spasmo muscolare improvviso. La contrazione muscolare provoca un'asimmetria facciale anomala;
- Manifestazione di attacchi di dolore di vario tipo. Il dolore severo dura, di regola, per due o tre minuti, poi si indebolisce e diventa doloroso. La localizzazione degli attacchi di dolore dipende da quale ramo del nervo è interessato. Raramente sono colpiti entrambi i lati del viso; di regola, la nevralgia facciale è unilaterale.
Nella fase iniziale della malattia, il dolore è solitamente di breve durata e non pronunciato. A poco a poco il dolore diventa più intenso. Con il progredire della malattia, la durata degli attacchi di dolore facciale è più lunga e più dolorosa.
Ulteriori segni dello sviluppo della nevralgia: 
- La presenza costante di una forma cronica di dolore;
- Manifestazione di costante asimmetria facciale;
- C'è intorpidimento della pelle, perdita di sensibilità nella zona interessata;
- Brevi attacchi ripetuti che si verificano in qualsiasi situazione: mentre si mangia, si parla, si lavano i denti o a riposo;
- Stato di debolezza generale;
- C'è dolore muscolare in tutto il corpo;
- Sono possibili eruzioni cutanee.
Di norma, il dolore costante provoca lo sviluppo di insonnia, affaticamento, irritabilità e comparsa di mal di testa.
Con la nevralgia del trigemino si distinguono i seguenti tipi di dolore:
- Il dolore tipico è caratterizzato da fluttuazioni di calma o di nuovo intensificazione. Di norma, il dolore aumenta quando si tocca l'area interessata del viso. Hanno un carattere di tiro, che ricorda una scossa elettrica;
- Il dolore atipico è costante e colpisce un'ampia area del viso. Non ci sono periodi in cui il dolore diminuisce.
Ci sono periodi di esacerbazione degli attacchi di dolore, soprattutto nella stagione fredda.
Il dolore può essere così forte che una persona non riesce a concentrarsi su nient'altro. Di norma, in questi momenti i pazienti sono in costante tensione e aspettano un nuovo attacco o un'esacerbazione della malattia.
Come trattare il nervo trigemino
È molto difficile riprendersi da un danno al nervo trigemino. Di norma, i moderni metodi terapeutici possono alleviare la sofferenza del paziente solo riducendo il dolore. Per trattare l'infiammazione vengono utilizzati sia metodi conservativi che interventi chirurgici.

Prima di tutto, è necessario determinare correttamente la diagnosi. Ciò richiede un esame da parte di un neurologo. Per chiarire la diagnosi e l'area interessata, è prescritto quanto segue:
- Risonanza magnetica;
- Elettroneurografia.
Molto spesso, i pazienti con tale dolore si rivolgono al dentista, credendo che si tratti di mal di denti e richieda l'estrazione o il trattamento del dente.
È necessario riconoscere la neurite e iniziare un ciclo di trattamento il prima possibile. Qualsiasi trattamento deve essere prescritto dal medico curante, poiché molti farmaci presentano controindicazioni ed effetti collaterali.
Di norma, il complesso delle misure terapeutiche comprende farmaci con i seguenti effetti sul corpo:
- Antivirale;
- Antidolorifici;
- Antinfiammatorio;
- Ridurre gli spasmi muscolari;
- Complessi vitaminici;
- Ridurre l'infiammazione e il gonfiore;
- Procedure fisioterapeutiche.
 Un corso di massaggio aiuterà ad alleviare l'aumento della tensione muscolare. Il massaggio aiuterà a migliorare la microcircolazione e l'afflusso di sangue nel nervo infiammato, così come nei tessuti adiacenti. Un corretto massaggio nella zona del viso ha un effetto positivo sulle zone riflesse nei punti di uscita dei rami del nervo trigemino.
Un corso di massaggio aiuterà ad alleviare l'aumento della tensione muscolare. Il massaggio aiuterà a migliorare la microcircolazione e l'afflusso di sangue nel nervo infiammato, così come nei tessuti adiacenti. Un corretto massaggio nella zona del viso ha un effetto positivo sulle zone riflesse nei punti di uscita dei rami del nervo trigemino.
Il massaggio per questa diagnosi deve essere eseguito in posizione seduta, la testa deve essere inclinata all'indietro sul poggiatesta in modo che i muscoli del collo siano rilassati.
È possibile evitare l'uso costante di antidolorifici eliminando la fonte che irrita il nervo, causando dolore. Nei casi in cui la malattia progredisce, i farmaci sono inefficaci e non alleviano gli attacchi di dolore e si ricorre all'intervento chirurgico.
L'efficacia del trattamento dipende dallo stadio della malattia, dall'età del paziente e dalla presenza di malattie concomitanti. Sono importanti anche una diagnosi chiara e un rigoroso controllo medico.
Il trattamento con metodi tradizionali è molto comune. Nella medicina popolare esistono molti rimedi più efficaci per l'infiammazione del nervo trigemino. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il trattamento con i metodi tradizionali è inefficace. Sono solo mezzi ausiliari al trattamento principale.
Conclusione
 La nevralgia del trigemino è una vera prova di resistenza per una persona. Non tutti sono in grado di sopportare a lungo e spesso il dolore, che a volte è insopportabile e spesso ripetuto.
La nevralgia del trigemino è una vera prova di resistenza per una persona. Non tutti sono in grado di sopportare a lungo e spesso il dolore, che a volte è insopportabile e spesso ripetuto.
Una visita tempestiva dal medico e un ciclo di trattamento tempestivo contribuiranno a ridurre significativamente la durata del dolore lancinante. Purtroppo non è sempre possibile curare completamente la patologia. Nella maggior parte dei casi, viene ridotto solo il dolore associato a questa malattia.
Nelle situazioni in cui il trattamento farmacologico non produce risultati, il dolore non diminuisce, si osserva un peggioramento o complicazioni, viene utilizzato l'intervento chirurgico.
Come ogni altra malattia, è meglio evitare che curare. Per prevenire lo sviluppo del processo infiammatorio, l'infiammazione dei seni deve essere trattata tempestivamente e i denti devono essere mantenuti in buone condizioni. Inoltre, come misura preventiva, dovresti monitorare la tua salute e mantenere la tua immunità. Cerca di evitare varie lesioni, infezioni, ipotermia.
Puoi ottenere ulteriori informazioni sulle malattie del nervo trigemino dal seguente video.