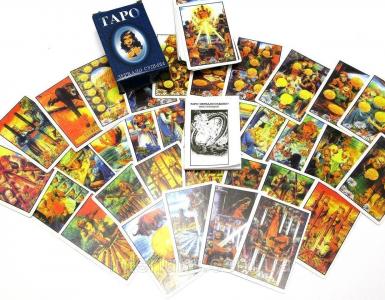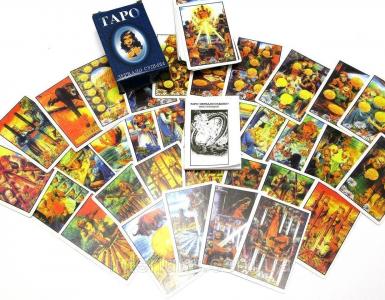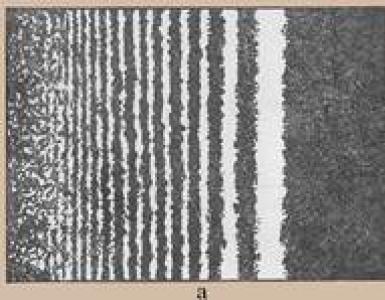Cosa significa aumento dell'aggregazione nel sangue? Parliamo dell'aggregazione piastrinica. Scopriamo di cosa si tratta e qual è la norma? Sintomi di deviazioni dagli indicatori
L'aggregazione piastrinica è il processo di intasamento di una ferita con cellule del sangue molto piccole che si trovano vicino alle pareti dei vasi sanguigni e sono impegnate nel loro mantenimento.
Se l'integrità dei capillari viene violata, vengono diretti verso la lesione, chiudendola e prevenendo così il sanguinamento. Come ridurre quali farmaci assumere?
Descrizione
Quando le placche si precipitano nel sito della lesione, sovrapponendosi l'una sull'altra, formano un coagulo di sangue: questo fenomeno è chiamato adesione e aggregazione, un processo (aggregatio accession), che si fonde in un unico sistema, dura fino alla chiusura della ferita. Grazie a ciò, una persona non perde molto sangue.
Lo studio dell'aggregazione piastrinica viene effettuato analizzando il plasma. In un uomo sano, queste cellule proteggono il corpo dal sanguinamento; possono verificarsi deviazioni che provocano varie malattie. Può essere aumentato/diminuito.
Indicatori per età
Analisi
Un test di aggregazione piastrinica viene prelevato da una vena. È necessario per alcuni disturbi del cuore, dei vasi sanguigni e del sangue.
Prima dell'invio, è necessario soddisfare alcune condizioni per l'accuratezza dell'analisi:
- Seguire la dieta prescritta dal medico per 3 giorni.
- Smettere di assumere farmaci per 24 ore.
- Non bere alcolici, caffeina o fumare per 24 ore.
Se vengono seguite tutte le raccomandazioni, l'analisi sarà veritiera, non ci sono sostanze che influenzano il processo di coagulazione del sangue. In laboratorio, per ottenere il risultato, al plasma vengono aggiunti induttori (stimolatori) che imitano le cellule umane.
Viene effettuata l'analisi:
- Adenosina difosfato (ADP).
- Con ristomicina (ristomicina; sinonimo ristoceina) antibiotico.
- L'adrenalina (epinefrina) (L-1 (3,4-diossifenil)-2-metilamminoetanolo) è il principale ormone della midollare del surrene.
- Acido arachidonico (acido grasso polinsaturo omega-6).
- Il collagene è una proteina fibrillare.
- Serotonina – 5-idrossitriptamina, neurotrasmettitore, ormone della felicità.
L'aggregazione indotta viene utilizzata per diagnosticare alcune malattie. A questo scopo viene utilizzato un analizzatore laser. Al suo interno vengono introdotti plasma e un induttore, dopodiché il dispositivo calcola la coagulabilità delle placche.
I più comuni sono:
- Con l'ADF.
- Con acido arachidonico.
- Con adrenalina (epinefrina).
- E anche con la ristocetina.
I primi tre stimolatori consentono di valutare la cellula da tutti i lati, il quarto - patologia (sanguinamento).
Indicatori di aggregazione: decifrare l'analisi in base all'induttore
Tipi
- Aggregazione spontanea, quando viene prelevato il plasma, posto in un apposito dispositivo, riscaldato ad una certa temperatura per rivelare l'azione della cellula del sangue.
- Indotto, che viene effettuato da un analizzatore di aggregazione piastrinica utilizzando induttori, per identificare alcune malattie.
- Moderato – causato dalla circolazione del sangue nella placenta durante la gravidanza.
- L’aumento della pressione sanguigna porta alla formazione di coaguli di sangue e gonfiore.
Analisi
Prescritto quando:
- Trombosi troppo veloce.
- Tromboflebiti, trombocitopenia.
- Predisposizione al sanguinamento (uterino, nasale).
- Scarsa guarigione della ferita.
- Gengive sanguinanti.
- Uso a lungo termine di anticoagulanti (acido salicilico).
- Flebeurismo.
- Malattie del cuore e dei vasi sanguigni.
- Complicazioni durante la gravidanza.
- Prima dell'intervento chirurgico.
Declino
L'aggregazione è bassa in alcune malattie, forse ereditarie. Una scarsa adesione della cellula inibisce (sopprime) il processo di arresto del sangue e possono verificarsi gravi emorragie. Questo succede:
- Carenza o eccesso di ormone tiroideo.
- Gravi danni al fegato (cirrosi, epatite).
- Infettive, virali (morbillo, rosolia).
- Avvelenamento da tossine.
Una forte diminuzione delle placche può verificarsi durante una malattia grave, l'uso di trattamenti chimici o l'uso a lungo termine di inibitori.
- Lesioni cancerose del midollo osseo, leucemia.
- L'irradiazione dei malati di cancro modifica notevolmente la composizione del sangue.
- Medicinali con effetti collaterali (acido acetilsalicilico, reopirina, antibiotici).
In caso di malattie gravi che portano alla perdita di cellule, viene eseguita un'ulteriore analisi del coagulogramma (coagulazione del sangue). Si consiglia di farlo:
- Prima dell'intervento chirurgico.
- Pianificazione della gravidanza.
- Per patologie cardiache, infarti.
- Ipertensione.
- Inibitori utilizzati nel trattamento da molto tempo.
È necessario un coagulogramma per evitare gravi emorragie, gravi conseguenze di malattie e per identificare patologie congenite al momento dell'intervento. Una scarsa coagulazione è rara.
Aumento
L'iperaggregazione favorisce la viscosità del sangue e la rapida formazione di coaguli di sangue. Questo fenomeno si verifica quando:
- Livelli elevati di zucchero (diabete).
- Ipertensione.
- Oncologia nei reni, nello stomaco, nella leucemia.
- Sindrome emorragica che porta ad un'emostasi compromessa.
- Aterosclerosi dei vasi sanguigni del cuore e del cervello.
La formazione di coaguli (trombi) all'interno dei capillari porta a gravi conseguenze. L'adesione delle placche alle pareti delle arterie porta ad una diminuzione del lume, che influisce negativamente sulla circolazione sanguigna.
Un aumento del contenuto di coaguli di sangue può corrispondere alle seguenti malattie che portano alla disabilità:
- A causa di disturbi circolatori, il muscolo cardiaco soffre e si verifica un infarto.
- La formazione di coaguli di sangue nella testa porta a ictus.
- I coaguli si depositano sulle vene delle gambe, formando tromboflebiti.
Quando il lume dei vasi sanguigni si chiude, si tratta di una patologia grave che porta alla morte e richiede cure mediche. Per questi scopi, esiste un inibitore (inibitore - per sopprimere, ritardare) l'aggregazione piastrinica.
In questo caso, ha un effetto deprimente sul processo di incollaggio cellulare e sulla formazione della patologia. Di seguito sono riportati i farmaci utilizzati per trattare le malattie cardiovascolari e l'insufficienza renale.
I farmaci inibitori Enazil, Lisinopril, Hartil, Diroton utilizzati non riducono la pressione sanguigna. Eventuali esami possono essere sostenuti in laboratorio, dove urgenza e rapidità sono garantite.
Ottieni esami preventivi e prenditi cura della tua salute. Quasi tutte le malattie possono essere curate in una fase precoce. Visitate il nostro sito web per nuove informazioni.
Contenuto
Il corpo è protetto dalla perdita di sangue dalle piastrine, globuli incolori. Corrono sempre sul luogo del danno per bloccarlo attraverso la coagulazione del sangue. Si verifica quando le piastrine si uniscono. Di conseguenza, si forma un tappo che chiude la ferita. Il processo con cui le piastrine si uniscono è chiamato aggregazione. In un organismo sano svolge un ruolo protettivo. Alcune persone hanno una capacità di aggregazione troppo bassa o, al contrario, alta. Entrambi i casi sono deviazioni e quindi richiedono un trattamento.
Cos'è l'aggregazione piastrinica
Questo concetto riflette il processo di connessione delle piastrine tra loro. In altre parole, l’aggregazione riflette la capacità del sangue di coagulare. Le piastrine sono cellule del sangue (cellule). Il loro ruolo principale nel corpo è la protezione contro la perdita di sangue, che si realizza durante l'aggregazione:
- dopo l'infortunio, le piastrine si attaccano alle pareti dell'arteria danneggiata, aderendo tra loro e formando aggregati piastrinici;
- il coagulo di sangue formato cresce;
- Di conseguenza, la nave si chiude e l’emorragia si ferma.
L'aggregazione è uno dei meccanismi dell'emostasi. È un sistema biologico che mantiene il sangue allo stato liquido e smette di sanguinare. L'emostasi ha due tipi:
- Vascolare-piastrinico. Arresta il sanguinamento dai piccoli vasi. Questo tipo include l'aggregazione o l'agglutinazione delle piastrine.
- Coagulazione. Questo meccanismo garantisce l'arresto del sanguinamento nei grandi vasi quando l'emostasi primaria non è più sufficiente. Qui il trombo piastrinico diventa il tappo emostatico finale. Chiude il difetto vascolare.
La velocità della coagulazione è importante perché in alcune situazioni la vita di una persona dipende da essa. Il processo di aggregazione è considerato vantaggioso solo per le navi danneggiate. L’aumento dell’attività piastrinica può portare ad infarto o ictus. L'aumento dell'adesione di tali cellule impedisce anche l'apporto delle sostanze necessarie agli organi. Questa è la fase iniziale della formazione del coagulo di sangue. Se il livello delle cellule del sangue incolori, al contrario, è ridotto, una persona potrebbe perdere molto sangue. Con frequenti sanguinamenti, il corpo è esausto, causando anemia (anemia).
Tipi
La classificazione principale divide l'aggregazione in tipologie a seconda delle malattie o condizioni che la innescano. Ogni tipo ha le sue caratteristiche e i suoi rischi. Si distinguono quindi le seguenti tipologie di aggregazione:
- Indotto. Si osserva durante l'esame del fluido sanguigno per alcune patologie. Per eseguire la diagnostica, gli induttori vengono introdotti nel plasma. Qui, l'aggregazione piastrinica avviene con adrenalina, collagene e adenosina difosfato (ADP).
- Spontaneo. Questo tipo è determinato senza induttore. Per rilevare l'attività di aggregazione, il sangue viene versato in una provetta, che viene poi inserita in un dispositivo che riscalda il fluido biologico a 37 gradi.
- Moderare. Si osserva durante la gravidanza e si sviluppa a causa della circolazione placentare.
- Basso. Associato a disturbi del sistema circolatorio. Il sanguinamento si verifica a causa dei bassi livelli di piastrine. Questo tipo di aggregazione si osserva nelle donne durante le mestruazioni.
- È aumentato. Provoca la formazione di coaguli di sangue. Sono caratterizzati da intorpidimento e gonfiore.
Esame del sangue per l'aggregazione piastrinica
Sia l'aumento che la diminuzione dell'aggregazione sono ugualmente pericolosi per la salute umana. Secondo le statistiche, ogni anno muore di trombosi 1 persona su 250. Per questo motivo il livello delle piastrine nel sangue deve essere costantemente monitorato. Per questo c'è un esame del sangue speciale. Le indicazioni per la sua attuazione sono:
- sanguinamento frequente - dal naso, uterino;
- ferite che guariscono male;
- la formazione di lividi al minimo infortunio;
- gonfiore dei tessuti.
Per queste indicazioni, la funzionalità piastrinica viene testata utilizzando un test di aggregazione indotta. Il risultato è un diagramma di aggregazione. Riflette graficamente quanto le piastrine si uniscono. Lo studio viene effettuato al microscopio o su un aggregometro automatico. Lo specialista preleva un campione di sangue e lo inietta in un induttore, un dispositivo che innesca una reazione naturale di coagulazione. I suoi stimolanti sono sostanze speciali. Sono chiamati anche induttori e sono:
- debole - adrenalina, ADP a piccole dosi;
- forte - ADP in grandi quantità, trombina, collagene.
Preparazione per l'analisi
Affinché i risultati della ricerca siano affidabili, è necessario seguire una serie di regole prima dell'analisi. Prima della procedura stessa, non puoi mangiare nulla, perché il sangue viene prelevato a stomaco vuoto. È consentito bere solo acqua pulita non gassata. È inoltre importante escludere tutte le sostanze che influenzano l'attività di aggregazione piastrinica:
- beta-bloccanti;
- diuretici e beta-lattamici ad alte dosi;
- bloccanti dei canali del calcio;
- farmaci a base di aspirina;
- antimalarici;
- citostatici;
- vasodilatatori;
- farmaci antifungini.
Dovrebbero essere abbandonati una settimana prima della procedura. Alcuni prodotti influenzano anche l'attività di aggregazione. Per questo motivo, per 1-3 giorni prima dell'analisi, è necessario seguire una dieta, escludendo:
- aglio;
- alcol;
- caffè;
- grasso di pesce;
- curcuma;
- zenzero.

Indicatori normali
Gli standard possono variare da laboratorio a laboratorio. Nell'analisi si riflettono come percentuali. In media, a seconda del tipo di induttore utilizzato, è considerata normale una variazione dell'aggregazione dal 25 al 75%. La tabella descrive i risultati in modo più dettagliato:
I risultati dell'analisi mostrano molti altri indicatori ottenuti sulla base della ricerca condotta dall'assistente di laboratorio. Il loro elenco e valori normali:
- tempo di sanguinamento – 2-3 minuti dopo la puntura;
- adesione – 20-50%;
- il tempo di coagulazione nell'analisi è di 5-10 minuti per il sangue venoso;
- tempo di trombina – 15-18 secondi;
- tempo di tromboplastina parziale attivata – 30-40 secondi;
- fibrinogeno – 2-4 g/l;
- indice di protrombina – 93-107%.
Aggregazione piastrinica in gravidanza
Una delle ragioni per la deviazione degli indicatori di aggregazione dalla norma è la gravidanza. Durante questo periodo, la donna avverte una produzione insufficiente di piastrine, che riduce la capacità del sangue di coagulare. Inoltre, la composizione qualitativa di queste cellule del sangue potrebbe essere alterata. Questa condizione è indicata da lividi e sanguinamento, lividi sul corpo. Durante e dopo il parto, l’ipoaggregazione può causare sanguinamenti massicci. Una diminuzione dei livelli piastrinici durante la gravidanza è associata a:
- assumere antibiotici o diuretici;
- allergie;
- tossicosi grave;
- dieta malsana;
- patologie endocrine;
- mancanza di vitamine C e B12.
L'aumento dell'aggregazione è associato a una grande perdita di liquidi a causa di diarrea o vomito durante la tossicosi. Di conseguenza, la concentrazione nel sangue aumenta, il che aumenta il rischio di coaguli di sangue. Questa condizione è pericolosa a causa dell'aborto precoce. Un'aggregazione moderata è considerata normale durante la gravidanza. Si sviluppa come risultato della formazione della circolazione sanguigna placentare. La norma è un'aggregazione piastrinica del 30-60% con ADP o qualsiasi altro induttore. L’analisi viene effettuata nei seguenti casi:
- nel trattamento dell'infertilità;
- prima di pianificare una gravidanza;
- prima e durante l'assunzione di contraccettivi;
- in caso di aborto spontaneo.
Caratteristiche nei bambini
Il numero di piastrine nel sangue dei bambini è normale o aumentato. Anche il tasso di incollaggio dei globuli incolori al loro interno è leggermente più forte rispetto agli indicatori standard. La durata dell'aggregazione nell'adolescenza è considerata normale se non supera 1 minuto. La conta piastrinica normale viene calcolata tenendo conto dell'età e del peso del bambino e dell'ora del test. Gli indicatori standard sono mostrati nella tabella:
Nei bambini di età inferiore a 1 anno, l'iperaggregazione è spesso associata a disidratazione o anemia. Questa condizione è tipica degli adolescenti sotto stress. La loro aggregazione è influenzata anche dalla crescita fisiologica dell'organismo. L'ipoaggregazione nell'infanzia si manifesta:
- sangue dal naso;
- mestruazioni abbondanti;
- gengive sanguinanti;
- individuare eruzioni cutanee sulla pelle.
Iperaggregazione
Lo stato di iperaggregazione è accompagnato da una mobilità del sangue troppo lenta, ma da una rapida coagulazione. Se questo è stato scoperto durante l'analisi, la causa potrebbe essere:
- diabete mellito di tipo 1 o 2;
- cancro ai reni, allo stomaco o al sangue;
- linfogranulomatosi;
- sepsi;
- aumento costante della pressione sanguigna - ipertensione;
- aterosclerosi vascolare.
Il pericolo di iperaggregazione è elevato se il paziente non controlla questo processo e non segue le istruzioni del medico riguardo al trattamento farmacologico. In questo caso, il rischio di sviluppare:
- infarto miocardico - una malattia acuta che si sviluppa a causa di un insufficiente afflusso di sangue al cuore;
- ictus - incidente cerebrovascolare;
- trombosi: blocco delle vene degli arti inferiori.

Ipoaggregazione
In uno stato di ipoaggregazione, la formazione di coaguli di sangue è difficile. Questo è pericoloso a causa dello sviluppo di gravi emorragie. Le malattie accompagnate da una ridotta coagulazione del sangue includono:
- uremia, insufficienza renale;
- leucemia cronica;
- mieloma multiplo;
- diminuzione della funzionalità tiroidea;
- anemia.
Con queste malattie si formano trombocitopatie secondarie. I chirurghi li incontrano anche durante l'intervento chirurgico. L'ipoaggregazione può essere innescata da malattie virali e infettive. I livelli piastrinici sono influenzati anche dai farmaci assunti durante la chemioterapia o dal trattamento con farmaci antipiastrinici, come l’aspirina. Una diminuzione dell'aggregazione può essere non solo acquisita a causa di eventuali condizioni patologiche, ma anche congenita. Ciò è osservato nei pazienti con trombofilia ereditaria.
Valori normalizzanti
Il corso del trattamento è determinato in base al risultato dei test di aggregazione. Se i livelli sono inferiori al normale, è possibile un sanguinamento prolungato. I vasi diventano fragili, il che si manifesta esternamente con lividi che si verificano senza colpi. Per questo motivo è importante che le persone con bassi livelli di piastrine evitino lesioni. Questo consiglio non vale solo per i graffi. Quando viene colpito, anche senza danneggiare la pelle, si sviluppa un'emorragia interna. Dovresti anche evitare i farmaci che fluidificano il sangue e compromettono la coagulazione del sangue. Questi includono:
- farmaci a base di aspirina;
- Dipiridamolo;
- Indometacina;
- Ibuprofene;
- Eufillin;
- Troxevasin.
Terapia farmacologica
La prescrizione dei farmaci dipende anche dai risultati dell'analisi. Per aumentare il numero delle piastrine, è necessario assumere farmaci che aumentano la coagulazione del sangue. Vengono utilizzati i seguenti farmaci:
- Dicynone, Emosint e Acido Tranexamico per somministrazione orale;
- Soluzione al 5% di acido aminocaproico per iniezione endovenosa;
- Sodio adenosina trifosfato per iniezioni intramuscolari.
Se si sviluppa un sanguinamento massiccio a causa della scarsa coagulazione, viene interrotto mediante trasfusione della massa piastrinica del donatore. Il regime di trattamento per l’iperaggregazione è l’opposto. In questa condizione si osservano formazione attiva di trombi e elevata viscosità del sangue. Per questo motivo è necessario assumere anticoagulanti - farmaci dimagranti. La loro base è l'aspirina. Facilita il processo di passaggio del sangue attraverso i vasi e previene la formazione di nuovi coaguli di sangue. Oltre all’aspirina possono essere prescritti:
- blocco della novocaina: allevia l'irritazione nel focus patologico;
- antidolorifici – alleviano il dolore;
- farmaci che dilatano i vasi sanguigni - facilitano il flusso del sangue.
Dieta
Per eventuali deviazioni dell'aggregazione dalla norma, è importante considerare attentamente la propria dieta. Sullo sfondo di una diminuzione del numero delle piastrine, è necessario mangiare cibi che migliorano l'ematopoiesi. In questo caso sono utili prodotti con grandi quantità di vitamine B e C:
- grano saraceno;
- rosa canina;
- banane;
- verde;
- fegato di manzo;
- uova;
- pescare;
- carne rossa;
- barbabietola;
- carota;
- granate;
- ribes nero;
- aronia.

Dovrebbero essere esclusi dalla dieta gli alimenti che riducono la coagulazione del sangue: aglio, agrumi, zenzero, frutti di mare, verdure rosse e verdi. Al contrario, devono essere aggiunti al menu durante l'iperaggregazione. Tali prodotti aiuteranno a ridurre la viscosità del sangue. Inoltre, a questo scopo, si consiglia di bere circa 2-2,5 litri di acqua al giorno. Bere una quantità eccessiva di liquidi restringe i vasi sanguigni, facendo addensare ulteriormente il sangue. In caso di iperaggregazione, dovrebbero essere esclusi dalla dieta gli alimenti che favoriscono l'emopoiesi:
- grano saraceno;
- aronia;
- Melograno.
Metodi di trattamento non tradizionali possono essere utilizzati in aggiunta al trattamento principale, ma prima di utilizzare le erbe è necessario consultare un medico. Alcune piante sono vietate per la trombocitosi. Per aumentare l'aggregazione, puoi utilizzare le seguenti ricette:
- Prendi 1 cucchiaio. l. erba di trifoglio dolce macinata. Versare un bicchiere di acqua bollente sulla materia prima e lasciare fermentare per mezz'ora. Successivamente, dividere il prodotto in 3-4 parti approssimativamente uguali. Bere tutte le porzioni durante la giornata. Ripeti la procedura ogni giorno per un mese.
- Macina la radice di peonia, aggiungi il 70% di alcol in un rapporto di 250 ml per 1 cucchiaio. l. materie prime. Posizionare il prodotto in un luogo buio per 21 giorni. Agitare periodicamente la bottiglia. Dopo il periodo specificato, puoi iniziare a prendere la tintura 30 gocce 3 volte al giorno per 2 settimane. Successivamente dovrebbe esserci una settimana di pausa, dopo di che il corso viene ripetuto.
- Per 50 ml di acqua bollente, prendi 1 cucchiaino. radice di zenzero tritata e tè verde. Aggiungi la cannella sulla punta di un coltello. Lascia riposare il tè per circa 15 minuti. Se lo si desidera, è possibile aggiungere il limone. Bere il prodotto durante la giornata.
- Bere ogni giorno 100 ml di succo d'arancia appena spremuto. Per varietà, puoi mescolarlo con la zucca in un rapporto 1:1.
Altre erbe e prodotti riducono l'aggregazione: ortica, olio di sesamo, succo di barbabietola. Dovrebbero essere utilizzati anche previa consultazione di un medico e solo come terapia ausiliaria. I prodotti sono preparati secondo le seguenti ricette:
- Versare 250 ml di acqua bollente 1 cucchiaio. l. ortica secca. Riscaldare il prodotto a fuoco basso per circa 10 minuti. Può essere assunto dopo il raffreddamento. Bere prima dei pasti 1 volta al giorno per un mese.
- Prendi 1 cucchiaino di olio di sesamo ogni giorno dopo i pasti.
- Macinare le barbabietole di medie dimensioni su una grattugia, aggiungere un po 'di zucchero. Lasciare la verdura durante la notte. Al mattino spremere il succo e bere a stomaco vuoto. Ripeti l'operazione ogni giorno per 2-3 settimane. Articoli popolari

L'aggregazione piastrinica è necessaria affinché quando la pelle è danneggiata, quando i vasi sanguigni si rompono e il sangue inizia a essere rilasciato nell'ambiente esterno, avviene il processo di coagulazione - smettere di sanguinare e oltre guarigione delle ferite.
Senza l’aggregazione piastrinica, le ferite non guarirebbero perché il sangue scorrerebbe dall’area danneggiata senza fermarsi. E anche una piccola ferita, se questo processo viene interrotto, può causare molti problemi.
Come già notato, senza aggregazione piastrinica, il sangue non si coagula nei siti di lesione. Come avviene questo processo? All'inizio si verifica una rottura del vaso.
Il corpo capisce che è tempo di agire. Le piastrine si precipitano in gran numero nel sito della lesione e si uniscono.
Quando ci sono più coaguli, vengono aggiunte nuove piastrine, che si attaccano alle pareti dei vasi. Tau e una crosta si formano sul graffio e sulla ferita.
Cioè, il ruolo dell'aggregazione è quello di “rattoppare” una nave danneggiata, fermando l'emorragia e garantendo condizioni tese per l'ambiente interno del corpo. Grazie a questo processo le ferite guariscono e la persona successivamente non le ricorda nemmeno.
Tasso di piastrine
Affinché l'aggregazione piastrinica sia normale, è necessario garantire che l'organismo ne riceva una quantità sufficiente vitamine, microelementi, macroelementi.
Ciò manterrà i normali livelli di emoglobina nel sangue quando i livelli di ferro sono conformi allo standard e il sangue è in grado di trasportare ossigeno agli organi e ai tessuti.
Quando si esaminano i campioni di sangue, è necessario tenere conto del tempo impiegato dalle piastrine per formare i coaguli. L'assistente di laboratorio valuta in tempo reale velocità di movimento delle cellule e la loro trasformazione. La norma va da 10 secondi a un minuto.
Test piastrinico
Quando prestare attenzione all’aggregazione piastrinica?
- Se noti lividi sul corpo, anche se non vi sono stati impatti significativi. In questo caso, vi è il sospetto di una funzione piastrinica difettosa.
- Se le ferite non guariscono bene. Ciò significa che le piastrine hanno difficoltà a far fronte al compito loro assegnato: restare unite nei punti danneggiati. Il risultato sono ferite costantemente sanguinanti che lentamente si chiudono e guariscono.
- Se va spesso sangue dal naso. Un altro segno di scarsa coagulazione.
- Se ci rigonfiamento dei tessuti. Ciò significa che il tasso di aggregazione è sovrastimato, il che comporta il rischio di problemi vascolari.
Che aspetto ha l'analisi? Innanzitutto, l'assistente di laboratorio preleva un campione di sangue. Successivamente, in condizioni di laboratorio, viene introdotto nel sangue un induttore (un mezzo che consente di innescare la naturale reazione di coagulazione del sangue). In questa fase avviene l'osservazione e la misurazione degli indicatori della cintura.
Come prepararsi al test?
- Non assumere farmaci senza consultare il medico. Soggetto a divieto farmaci a base di aspirina, poiché influiscono sulle piastrine, fluidificano il sangue e complicano la coagulazione. Il risultato dell'analisi non corrisponderà alla realtà.
- Un giorno prima della prova non mangiare niente di grasso. I cibi grassi influenzano anche la coagulazione del sangue.
- Non mangiare nulla 12 ore prima del test.. Puoi bere normale acqua pulita. È meglio fare il test al mattino a stomaco vuoto.
- Stai calmo. Ricordare qualsiasi ansia può avere il suo pedaggio sugli indicatori fisici.
- Non fare sport allenamento nelle ultime 24 ore prima di fare l'analisi.
- È vietato un giorno prima della visita in laboratorio fumare, bere alcolici, è vietato bere caffè o mangiare aglio.
- Se si verificano processi infiammatori, il risultato dell'analisi potrebbe essere errato. Se hai tosse (mal di gola), ascesso cutaneo, dolori articolari e la causa è un'infiammazione, è meglio fare il test più tardi.
Donne durante ciclo mestrualeÈ meglio non sottoporsi al test, poiché in questo periodo le piastrine sono meno attive per motivi naturali.
Cambiamenti durante la gravidanza
Durante la gravidanza, le donne non cambiano solo i loro livelli ormonali, ma anche il corso generale della maggior parte dei processi. Può anche verificarsi una scarsa coagulazione del sangue.
Sintomi di scarsa aggregazione durante la gravidanza:
- si osserva sanguinamento dal naso;
- compaiono lividi sul corpo;
- le gengive sanguinano;
- si verifica un gonfiore dei tessuti molli;
- appare una rete vascolare (rischio di sviluppare coaguli di sangue).
Peculiarità
È importante capire che le deviazioni moderate dalla norma sono considerate naturali durante la gravidanza. Inoltre, si possono osservare deviazioni in entrambe le direzioni: aumento della formazione di coaguli di sangue o, al contrario, diminuzione.
Perché la gravidanza influisce sulla composizione del sangue e sulla funzione piastrinica? Ciò è dovuto alla circolazione placentare e alle caratteristiche dell'afflusso di sangue alle estremità, quando in generale la circolazione sanguigna diventa più difficile.
Cosa fare se l’aggregazione piastrinica è ridotta?
 Con una ridotta aggregazione, si osserva un sanguinamento prolungato e la fragilità dei vasi sanguigni diventa il fattore principale nella formazione di emorragie interne, che si manifestano esternamente come lividi che si verificano senza precedenti colpi.
Con una ridotta aggregazione, si osserva un sanguinamento prolungato e la fragilità dei vasi sanguigni diventa il fattore principale nella formazione di emorragie interne, che si manifestano esternamente come lividi che si verificano senza precedenti colpi.
In primo luogo, hai bisogno evitare lesioni. Inoltre, le lesioni non sono solo abrasioni e graffi, ma anche colpi, poiché quando si verificano senza danneggiare la pelle, la struttura dei vasi sanguigni viene interrotta, si rompono e si formano emorragie interne.
In secondo luogo, devi ricordartene alcuni i farmaci influenzano l'aggregazione naturale.
Ad esempio, i farmaci a base di aspirina come l'indometacina e il dipiridamolo dovrebbero essere assunti in piccole quantità e solo quando veramente necessario. In alcuni casi possono essere sostituiti con un’alternativa più delicata, a seconda del caso specifico. In genere, i farmaci a base di aspirina fluidificano il sangue, causando una scarsa coagulazione.
Terzo, Non è consigliabile bere alcolici in grandi quantità o con alta frequenza. Anche l’alcol fluidifica il sangue.
Inoltre, evitare di mangiare cibi troppo salati o troppo piccanti. Normalmente, tale cibo viene digerito abbastanza normalmente e non nuoce alla salute, ma l'assunzione sistematica di quantità eccessive della norma fluidifica anche il sangue e peggiora l'aggregazione.
La dieta dovrebbe includere prodotti naturali– frutta, verdura, latte. Mele, barbabietole, grano saraceno, carne, pesce e noci, che hanno un alto contenuto di ferro, aiutano soprattutto a normalizzare la formazione e il funzionamento delle piastrine.
Ragioni per una maggiore aggregazione
L'aumento dell'aggregazione è un fenomeno pericoloso che può verificarsi nel corpo in condizioni favorevoli.
 Prima a rischio pazienti ipertesi– persone con malattie del sistema cardiovascolare.
Prima a rischio pazienti ipertesi– persone con malattie del sistema cardiovascolare.
Poche persone tengono conto del fatto che con le malattie dei reni e dello stomaco sorgono problemi con la pervietà dei vasi sanguigni e il sangue si addensa.
È inoltre necessario prestare attenzione alla nutrizione: l'alto contenuto di pectina, la mancanza di ferro, il consumo costante di cibi grassi sono fattori di rischio.
Aumento dell'aggregazione piastrinica diventa una conseguenza della rimozione della milza, della sepsi.
Sintomi della malattia
Il sangue denso che si muove lentamente attraverso i vasi diventa il sintomo principale. Come determinare La circolazione sanguigna è buona?? Questo fattore negativo è determinato principalmente dalle condizioni della pelle. Se cedimenti, cellulite e pelle pallida compaiono in luoghi insoliti, il sangue potrebbe essere troppo denso e stagnante.
Con una maggiore aggregazione appare una sensazione di intorpidimento (soprattutto alle dita) e gonfiore.
Perché è pericoloso?
Una maggiore aggregazione è pericolosa il fatto che quando si verifica aumenta il rischio di sviluppare trombosi, infarto e ictus.
Normale per un bambino
Le piastrine nel sangue dei bambini sono solitamente entro i limiti normali o elevate. Lo stesso si può dire della loro aggregazione: la velocità di "fusione" delle cellule può essere più significativa, superando i limiti normali.
I medici contano livelli normali delle piastrine a seconda dell’età del bambino, del peso e dell’ora in cui è stata effettuata l’analisi.
Per un neonato, la norma è 100-420 mila. Nell'adolescenza, nelle ragazze sono considerate normali 75-220mila piastrine. La velocità di aggregazione da 10 a 40 secondi è la norma. Per l'adolescenza, l'aggregazione fino a un minuto è considerata la norma.
Le piastrine sono cellule del sangue formate che aiutano a normalizzare il processo di coagulazione del sangue. Ciò accade come segue. In caso di violazione dell'integrità delle pareti vascolari, le piastrine, attraverso una catena di reazioni biochimiche, ricevono un determinato segnale, si riuniscono nel sito di sfondamento e, unendosi insieme, assicurano il processo di blocco. Ecco come avviene il processo di aggregazione.
Tuttavia, un processo di aggregazione eccessivamente intenso è patologico. L'iperaggregazione piastrinica porta ad un aumento della formazione di trombi, che aumenta significativamente il rischio di sviluppare malattie come ictus e infarto del miocardio.
I bassi tassi di aggregazione non sono meno pericolosi e rappresentano una potenziale minaccia non solo per la salute, ma anche per la vita del paziente. Un'adesione piastrinica insufficiente porta alla formazione di una malattia come la trombocitopenia (ridotta coagulazione del sangue). Allo stesso tempo, esiste un'alta probabilità di sviluppare emorragie interne ed esterne, che non solo contribuiscono allo sviluppo di forme gravi di anemia, ma possono anche causare la morte.
Pertanto, è estremamente importante monitorare il contenuto delle piastrine nel sangue e la loro capacità di aggregarsi.
L’aggregazione piastrinica è particolarmente importante durante la gravidanza. Il fatto è che le violazioni di questo processo possono portare a una serie di conseguenze piuttosto gravi. L'ipoaggregazione (ridotta aggregazione piastrinica) può provocare sanguinamento uterino durante il parto o dopo il parto. Un'aggregazione eccessivamente attiva è pericolosa anche per la futura mamma e il suo bambino, poiché può portare alla formazione di coaguli di sangue, che è una delle cause più comuni di aborti spontanei e di interruzione spontanea della gravidanza nelle fasi iniziali.
Per evitare tali conseguenze negative e ridurre al minimo i rischi, gli esperti raccomandano di condurre uno studio sul livello delle piastrine nel sangue e di identificare la loro capacità di rigenerarsi prima del concepimento, quando si pianifica una gravidanza.
Studi per il controllo dell'aggregazione
L'analisi di laboratorio delle piastrine viene effettuata utilizzando una tecnica diagnostica chiamata aggregazione indotta. Per effettuare questa procedura, al sangue venoso prelevato dal paziente vengono aggiunte specifiche sostanze, la cui composizione chimica è simile a quella delle cellule del corpo umano, favorendo il processo di formazione di trombi, con conseguente agglutinazione piastrinica. Le sostanze che compongono le pareti dei vasi sanguigni vengono solitamente utilizzate come induttori. Questi includono:
Per l'analisi viene utilizzato un dispositivo speciale: un analizzatore di aggregazione piastrinica. Durante lo studio, le onde luminose vengono fatte passare attraverso il plasma sanguigno pieno di piastrine. L’analisi viene effettuata in due fasi. Gli indicatori del grado di aggregazione rappresentano la differenza nella densità della luce del plasma prima dell'inizio del processo di coagulazione e dopo il suo completamento. Inoltre, gli esperti prestano attenzione a fattori quali la forma, la natura e la specificità dell'onda luminosa.
L'aggregazione piastrinica indotta è un metodo di analisi del sangue caratterizzato da un'elevata precisione ed è quindi ampiamente utilizzato nella diagnostica moderna quando si sospettano determinate malattie.
Non tutte le cliniche dispongono delle attrezzature necessarie per effettuare questo tipo di procedura diagnostica. Ad oggi, gli studi sull'aggregazione piastrinica sono stati condotti con successo nei laboratori Invitro.
Perché viene condotta la ricerca?
Un esame del sangue per lo studio delle piastrine consente allo specialista di determinare la capacità di aggregazione di queste cellule del sangue e permette di identificare alcuni disturbi dell'emostasi, che possono essere sia congeniti che acquisiti. Inoltre, studiando l'aggregazione piastrinica, è possibile diagnosticare non solo patologie del sistema emopoietico, ma anche malattie del sistema cardiovascolare. Questa procedura è necessaria per monitorare la dinamica di una serie di alcune malattie, determinare le tecniche terapeutiche necessarie e controllare il processo di trattamento.
Indicazioni per lo studio
L'aggregazione indotta può essere prescritta da uno specialista nei seguenti casi:
- Trombocitopenia.
- Aumento della coagulazione del sangue.
- Tendenza alla trombosi.
- Gengive sanguinanti.
- Aumento del gonfiore.
- Tendenza al sanguinamento, sanguinamento uterino.
- Ferite che guariscono male.
- Trattamento a lungo termine con preparati di acido acetilsalicilico.
- Malattie di Von Willebrand e Glanzmann.
- Trombofilia.
- Gravidanza complicata.
- Accidente cerebrovascolare, malattia coronarica.
- Trombocitopenia di natura congenita o acquisita.
- Vene varicose.
- Monitoraggio della dinamica del trattamento con farmaci antipiastrinici.
- Malattie autoimmuni.
- Studio della funzionalità delle cellule piastriniche prima dell'intervento chirurgico.
- Infertilità.
- Diversi tentativi di fecondazione in vitro consecutivi senza successo.
- Gravidanza congelata.
- Determinazione del grado di sensibilità del paziente agli effetti degli agenti antipiastrinici.
- Trombastenia di Glanzmann.
- Malattia di Bernard-Soulier.
- Prima e durante l'assunzione di contraccettivi ormonali.
Come prepararsi alla ricerca?
Un esame del sangue per verificare la capacità delle piastrine di subire il processo di aggregazione richiede il rigoroso rispetto delle regole di preparazione. Affinché lo studio sia estremamente corretto ed efficace, i pazienti devono seguire le seguenti raccomandazioni:
- Una settimana prima del prelievo di sangue per il test, è necessario interrompere l'assunzione di farmaci che sopprimono la formazione di trombi. Questi includono i seguenti farmaci: preparati di acido acetilsalicilico, antidepressivi, sulfapiridazina, dipiridamolo, indometacina, agenti antipiastrinici, farmaci ormonali, contraccettivi.
- Il giorno prima dello studio è necessario astenersi dal bere bevande contenenti caffeina e alcoliche.
- Elimina cibi grassi, piccanti, piccanti, spezie e aglio dalla tua dieta.
- È vietato fumare il giorno della procedura.
- Limitare estremamente lo stress fisico e psico-emotivo.
- L'ultimo pasto deve essere consumato entro e non oltre 12 ore prima del prelievo di sangue per l'analisi.
Una controindicazione all'aggregazione piastrinica indotta è considerata la presenza di processi infiammatori acuti o cronici nell'organismo.
Il rispetto delle regole di cui sopra è necessario per ottenere i risultati più accurati e oggettivi dello studio!
Effettuare analisi
Un esame del sangue per determinare la capacità delle cellule piastriniche di rigenerarsi viene effettuato esclusivamente al mattino. L'orario ideale per il prelievo del sangue è considerato dalle 7:00 alle 10:00.
Lo studio viene effettuato a stomaco vuoto; in questo giorno il paziente non deve bere altro che acqua pura e naturale.
Il sangue venoso viene utilizzato per condurre un test per determinare il grado di aggregazione piastrinica. Viene raccolto dalla vena ulnare del paziente utilizzando una siringa monouso. Successivamente, il materiale viene posto in una provetta con una soluzione di citrato di sodio al 4%. Successivamente, il contenitore viene capovolto più volte in modo che il sangue sia completamente miscelato con questo principio attivo. Nella fase successiva, la provetta con il sangue raccolto viene inviata al laboratorio per ulteriori ricerche.
Aggregazione piastrinica: concetto, negli esami del sangue, deviazioni dalla norma, sfumature
L'aggregazione piastrinica è il desiderio delle piastrine del sangue, frammenti di megacariociti detti piastrine o placche di Bizzocero, “percependo” una situazione di emergenza accompagnata da perdita di sangue, di riunirsi per, con l'aiuto di altri “liquidatori” (presenti o formatisi nel processo ), chiudere il danno nella nave.
Una piccola lesione con violazione dell'integrità dei piccoli vasi, di regola (se tutto è in ordine con il sistema emostatico), non minaccia grossi problemi. Il sangue che scorre dalla ferita dopo un po 'si ferma e in questi casi le persone, negando la loro partecipazione, dicono: "Si è fermato da solo". E, probabilmente, non tutti conoscono un processo come l'aggregazione piastrinica, che svolge un ruolo importante nell'arrestare il sanguinamento e prevenire la perdita di liquidi preziosi per il corpo.
L'aggregazione piastrinica è una delle fasi dell'arresto del sanguinamento
Dietro una cosa apparentemente insignificante come fermare il sanguinamento dai vasi del sistema microvascolare (arteriole, venule, capillari) si nascondono processi complessi e sequenziali:
- In risposta al danno, i vasi microcircolatori si spasmano e quindi impediscono parzialmente il libero flusso del sangue;
- Piastrine nel sangue - le piastrine, che si attaccano all'area danneggiata, si precipitano sul luogo dell'incidente, cercando di colmare il “gap” (adesione piastrinica);
- Il numero di piastrine nel sito della lesione aumenta rapidamente (accumulo), iniziano ad ammucchiarsi e formare conglomerati: si verifica l'aggregazione piastrinica, che è lo stadio iniziale, ma molto importante, della formazione del trombo;
- Come risultato dell'aggregazione delle piastrine del sangue, si forma un tappo piastrinico allentato (aggregazione piastrinica irreversibile), questo tappo, sebbene impenetrabile al plasma, non è molto stabile e affidabile: basta toccarlo e il sangue scorrerà di nuovo;
- Il coagulo di sangue si contrae sotto l'influenza della proteina contrattile delle piastrine (tromboplastina), i fili di fibrina rendono denso il coagulo di sangue, che smette di sanguinare (retrazione del trombo trombinico).
fasi della formazione del coagulo sanguigno
Ovviamente l'aggregazione piastrinica non è la fase finale dell'arresto del sanguinamento, è solo una delle fasi del processo, ma ciò non la rende meno importante. Come si svolge questa reazione, quali componenti vi sono coinvolti verranno descritti nei paragrafi successivi, ma innanzitutto occorre informare il lettore che l'aggregazione piastrinica, pur svolgendo una funzione protettiva nelle persone sane, può avere anche un effetto negativo . Le piastrine non si comportano sempre in questo modo: sedute per il momento in silenzio e con calma, si attivano rapidamente, si attaccano alle pareti dei vasi sanguigni e si uniscono se necessario (se il vaso sanguigno da cui scorre il sangue è danneggiato).
L'aumento dell'aggregazione piastrinica implica un'eccessiva intensità dell'azione di queste piastrine, quando vengono attivate inutilmente (in assenza di sanguinamento), si uniscono tra loro e contribuiscono così alla formazione di coaguli di sangue non necessari per l'organismo, che successivamente, spostandosi attraverso il flusso sanguigno, chiudere i vasi sanguigni e interrompere la nutrizione dei tessuti degli organi vitali. Ciò può accadere ovunque: nei vasi che forniscono sangue al cuore (infarto miocardico), ai polmoni (infarto polmonare), al cervello (ictus ischemico), ecc., motivo per cui le forme medicinali di agenti antipiastrinici sono così ampiamente prescritte per la prevenzione e il trattamento di queste condizioni patologiche.
La tromboembolia delle arterie principali ha spesso un esito triste, ma tutto è iniziato con una piccola cosa - con l'aggregazione piastrinica spontanea, ma, sfortunatamente, quando una funzione (di aggregazione) così importante per qualche motivo ha già subito cambiamenti patologici...
Aggregazione piastrinica negli esami del sangue
Per studiare la capacità di aggregazione delle piastrine, per le cellule vengono create condizioni vicine a quelle naturali (circolazione nel sangue). I test vengono effettuati sul vetro utilizzando sostanze induttrici assunte in determinate concentrazioni (aggregazione piastrinica indotta), che, in generale, partecipano a questo processo in un organismo vivente (in vivo) con aggregazione piastrinica stimolata dal sanguinamento (ADP, collagene, trombina, adrenalina). In alcuni laboratori per l'analisi vengono utilizzate sostanze che non sono presenti nell'organismo ma che hanno la capacità di provocare aggregazione, ad esempio la ristomicina (ristocetina). Va notato che ogni induttore ha i propri limiti di valori normali, che possono essere trovati guardando la tabella. Ma basta informarsi, poiché la norma è data solo in via provvisoria, può espandere o restringere la sua portata in diversi laboratori - questo dipende dai valori di riferimento di ciascun CDL.
Tabella: normale capacità di aggregazione piastrinica in funzione della sostanza induttrice
Di particolare importanza per la diagnosi di condizioni patologiche (soprattutto malattie cardiovascolari) è l'aggregazione piastrinica spontanea (SAT), quando un numero eccessivo di piastrine incollate tra loro circola liberamente nei vasi sanguigni, causando una serie di disturbi, e ciò si verifica, in primo luogo, tutto, nella zona del microcircolo:
- L'aggregazione piastrinica spontanea per un lungo periodo di tempo minaccia di portare a cambiamenti nelle pareti dei vasi sanguigni (specialmente per i vasi microvascolari);
- Il SAT crea le condizioni per aumentare la capacità delle piastrine di formare aggregati, aumentando così il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, la sua progressione e il verificarsi di gravi complicazioni e conseguenze in questo contesto.
Molto spesso, l'aggregazione piastrinica spontanea in condizioni di laboratorio è determinata da:
- Misurazione della densità ottica di una sospensione piastrinica;
- Attraverso la valutazione morfologica (visiva) delle piastrine del sangue aggregate.
Per diagnosticare e determinare la forma nosologica delle trombocitopatie, è senza dubbio meglio utilizzare speciali attrezzature moderne - aggregometri (ottico, che registra l'aggregazione delle piastrine nel plasma arricchito con esse, o conduttometrico, che misura questo indicatore nel sangue intero). Questi dispositivi registrano continuamente tutto ciò che accade alle piastrine del sangue e poi mostrano graficamente i loro valori (curva - aggregogramma). Tali metodi diagnostici sono abbastanza affidabili, tuttavia richiedono molto lavoro e richiedono grandi quantità di plasma per la ricerca.
Le deviazioni dalla norma creano problemi durante la gravidanza
Sia la bassa che l’alta capacità di aggregazione sono ugualmente negative. A questo proposito, in circostanze specifiche, quando l'aggregazione piastrinica può essere aumentata o diminuita rispetto alla norma, diventa obbligatorio un esame del sangue che calcoli questo indicatore.
Una di queste circostanze è l'esame delle donne in gravidanza, perché in ostetricia le deviazioni della capacità di aggregazione piastrinica dalla norma hanno spesso conseguenze negative. Durante il periodo di gestazione, il corpo di una donna inizia molto tempo fa a prepararsi per l'imminente perdita di sangue, quindi i tassi di coagulazione aumentano leggermente, ma si nota un aumento moderato, che non dovrebbe indicare un'iperaggregazione.
Un aumento dell'aggregazione piastrinica può causare trombosi, ma se diminuisce c'è il rischio di sanguinamento. Per una gravidanza favorevole, hai bisogno di una via di mezzo...
La norma durante la gravidanza per la capacità di aggregazione piastrinica varia solitamente dal 30 al 60% (indipendentemente dalla sostanza induttrice utilizzata) e ancora: tutto è approssimativo - i risultati dovrebbero essere trovati nel laboratorio che ha eseguito l'analisi, dove gli specialisti li confronteranno con valori di riferimento e segnalerà eventuali deviazioni. Solo in questi casi ci si può aspettare di non andare incontro né a ipo- né a iperaggregazioni ed evitare trombosi e sanguinamenti.
Aggregazione piastrinica con induttori
Un esame del sangue che determina la capacità di aggregazione dei rappresentanti del legame piastrinico dovrebbe essere effettuato con più induttori contemporaneamente (devono essercene almeno quattro) per sapere a quale livello del processo si verifica il fallimento.
Aggregazione delle piastrine con ADP
Lo studio della capacità di aggregazione piastrinica con ADP viene effettuato al fine di identificare l'aggregazione piastrinica spontanea o diagnosticare condizioni trombotiche che si verificano in una determinata patologia:
- Processo aterosclerotico;
- Ipertensione arteriosa;
- IHD, infarto del miocardio;
- Disturbi della circolazione cerebrale;
- Diabete mellito;
- Iperlipoproteinemia (cambiamenti nello spettro lipidico, aumento delle lipoproteine a bassa densità, aumento del coefficiente di aterogenicità);
- Trombopatia ereditaria;
- Trombocitopatie che accompagnano l'emoblastosi;
- Quando si assumono alcuni farmaci che possono inibire l'attività delle cellule piastriniche.
Lo scostamento verso il basso è dato da:
- Trombastenia di Glanzmann (patologia ereditaria causata dall'assenza o dal difetto del recettore di membrana per il fibrinogeno e le glicoproteine IIb-IIIa);
- Atrombia essenziale (differisce dalla tromboastenia per compromissione incompleta delle capacità funzionali delle piastrine;
- Sindrome di Wiskott-Aldrich (una rara malattia recessiva legata al sesso caratterizzata da cambiamenti nella forma e diminuzione delle dimensioni delle cellule);
- Sindrome simile all'aspirina (patologia associata a una violazione della "reazione di rilascio" e della 2a fase di aggregazione);
- Trombocitopatia nella sindrome uremica;
- Trombocitopatie secondarie (con neoplasie ematologiche, ipotiroidismo, trattamento con agenti antipiastrinici, FANS - farmaci antinfiammatori non steroidei, antibiotici, diuretici e farmaci che abbassano la pressione sanguigna).
Un aumento degli indicatori si osserva quando:
- Sindrome piastrinica viscosa (tendenza all'adesione, aumento dell'aggregazione piastrinica);
- Attivazione delle cellule della parte piastrinica del sistema di coagulazione, causata da vari fattori: stress psico-emotivo, farmaci, formazione di complessi immunitari per determinati motivi, ecc.;
- Resistenza all'acido acetilsalicilico.
Aggregazione indotta con collagene
Una deviazione dalla norma quando si utilizza una reazione con il collagene può indicare che si verificano già disturbi a livello di adesione. Gli indicatori tendono a diminuire, in linea di principio, con la stessa patologia dei campioni con ADP. Un aumento dell'aggregazione piastrinica si osserva nella sindrome piastrinica viscosa e nelle vasculiti di varia origine.
Determinazione della capacità di aggregazione piastrinica in un test con adrenalina
Studio dell'attività del cofattore della ristocetina
I valori di questo indicatore riflettono l'attività del fattore von Willebrand; il test viene utilizzato principalmente per diagnosticare una malattia con lo stesso nome.
Va notato che l'esecuzione di questo test utilizzando induttori è utile non solo per determinare la capacità di aggregazione delle piastrine del sangue. Questi test permettono di valutare l'efficacia dei farmaci antipiastrinici durante il trattamento e permettono di selezionare le dosi corrette dei farmaci.
Informazioni per i curiosi
Nel frattempo, il lettore può giustamente rimproverare che, avendo iniziato la descrizione dell'argomento con test, varianti della loro norma e cambiamenti patologici, l'autore abbia detto troppo poco sulle piastre del sangue stesse, sulle loro funzioni e sul comportamento durante l'aggregazione stimolata dal sanguinamento. Il testo non evidenzia i meccanismi di attivazione piastrinica, né spiega l'essenza di tutte le reazioni che stanno dietro l'incollaggio cellulare e la formazione del tappo emostatico.
Tutto ciò può essere facilmente corretto consentendo alle persone con maggiore interesse di seguire l'intero processo descritto nelle sezioni seguenti, dall'inizio alla fine, comprendere autonomamente le singole sottigliezze e indicare l'importanza di ciascuno dei componenti della reazione.
L'importante ruolo delle piastrine
Le piastrine sono molto importanti nell'implementazione dell'emostasi vascolare-piastrinica, il che si riflette nel nome del processo. In generale, le loro funzioni consistono nel risolvere i seguenti compiti:
- Le piastre del sangue, svolgendo una funzione angiotrofica, mantengono la normale struttura e le capacità funzionali delle pareti dei vasi di piccolo calibro;
- Avendo capacità di aggregazione adesiva, che consistono nel fatto che le cellule si riuniscono in “mucchi” e si attaccano alle aree danneggiate dei vasi sanguigni (adesione), formando rapidamente un tappo emostatico (aggregazione piastrinica), possono arrestare piccole emorragie in 1 – 2 minuti ;
- I compiti delle piastre del sangue includono il mantenimento dello spasmo degli emocapillari feriti al giusto livello: queste cellule non consentono ai vasi di rilassarsi, perché ciò causerà un aumento del sanguinamento;
- Le piastrine non solo sono presenti, ma prendono anche parte attiva ai processi di coagulazione e, inoltre, influenzano la reazione di fibrinolisi.
Le funzioni di adesione e aggregazione piastrinica sono indissolubilmente legate e combinate in una sola: aggregazione adesiva (questa capacità delle cellule del sangue è stata scoperta alla fine del penultimo anno - IX secolo). Il fatto è che il tappo piastrinico inizia a formarsi anche prima del momento in cui le piastrine arrivano al loro posto e iniziano ad aderire alla membrana basale delle pareti vascolari.
Sebbene l'adesione delle piastrine alle pareti dei capillari sia facilitata da vari componenti del tessuto connettivo, il collagene è riconosciuto come il principale stimolatore del primo stadio dell'emostasi vascolare-piastrinica.
Cambiando “look” acquisiscono nuove opportunità
È interessante notare che le piastrine del sangue, dopo aver "imparato" una situazione di emergenza nel corpo, iniziano a prepararsi intensamente prima di arrivare sul luogo dell'incidente:
- In una frazione di secondo cambiano aspetto: da cellule piatte a forma di disco si trasformano in forme sferiche, espellendo pseudopodi (lunghi processi che prima non c'erano e che diventavano urgentemente necessari per aggrapparsi ai tessuti e comunicare tra loro);
- Le piastrine arrivano nel vaso danneggiato completamente equipaggiate, cioè ben preparate sia per l'adesione che per l'aggregazione, quindi impiegano fino a 5 secondi per attaccarsi.
- Allo stesso tempo, le piastrine che circolano nel sangue “non restano inattive”, cercano e trovano rapidamente i loro “fratelli”, si riuniscono in gruppi (da 3 a 20 cellule) e si uniscono formando conglomerati;
- I conglomerati vengono inviati nell'area danneggiata per connettersi con le piastrine che sono state le prime (principalmente aderenti) ad arrivare sulla scena e ad aderire alla membrana basale esposta del vaso sanguigno.
Tutte queste azioni vengono svolte dalle piastrine al fine di aumentare molto rapidamente le dimensioni del tappo emostatico, che in breve tempo (da 1 a 3 minuti) sarà in grado di chiudere qualsiasi varco nel vaso sanguigno del microcircolo in modo da smettere di sanguinare.
Dietro l'aggregazione c'è un processo biochimico complesso
L'adesione e l'aggregazione delle piastrine non è una reazione così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Si tratta di un complesso processo biochimico a più fasi che avviene con la partecipazione di vari fattori esogeni (esterni) ed endogeni (interni, emanati dalle stesse piastre del sangue): stimolanti della reazione, consumo di energia, ristrutturazione significativa delle placche di Bizzocero. Ad esempio, per il pieno funzionamento, le piastrine necessitano del fattore von Willebrand (una glicoproteina, un cofattore plasmatico per l'adesione delle piastrine al collagene), la sua produzione avviene nelle pareti vascolari. Quindi le piastrine, muovendosi attraverso i vasi sanguigni, fanno scorta di questa glicoproteina per un uso futuro, immagazzinandola nei loro granuli in modo che, se necessario (quando attivata), la rilasciano nell'ambiente.
L'aggregazione piastrinica è impossibile senza la partecipazione di una serie di stimolanti, che vengono attivati contemporaneamente quando inizia la reazione:
- Il collagene è il principale stimolatore dell'adesione piastrinica;
- ADP - questo componente assume un ruolo di primo piano nella prima fase di aggregazione: in primo luogo, l'ADP viene rilasciato in piccole quantità dalla parete del vaso danneggiato e dai globuli rossi (eritrociti), presenti anche sul luogo dell'incidente. Successivamente la zona emostatica viene rifornita di tale stimolatore dalle stesse placche di Bizzocero (ATP → ADP), che sono riuscite inizialmente ad aderire e ad attivarsi (la “reazione di rilascio” caratteristica delle piastrine);
- Parallelamente all'ADP, altri agonisti dell'aggregazione - adrenalina e serotonina - provengono dai granuli piastrinici; gli enzimi di membrana vengono attivati nelle piastre del sangue, promuovendo la formazione di potenti stimolanti della reazione - l'acido arachidonico (C 20 H 32 O 2) e i suoi derivati, tra qual è la sostanza aggregante più attiva: il trombossano;
- Un collegamento significativo nella regolazione della capacità di aggregazione piastrinica è il sistema delle prostaglandine: nella modalità attiva, nell'endotelio e nelle cellule muscolari lisce si formano endoperossidi delle prostaglandine, che possono anche essere convertiti in trombossano. Tuttavia, nell’ultima fase dell’aggregazione, quando non è più necessaria, queste sostanze cambiano direzione e iniziano a garantire il rilascio nel sangue della prostaciclina vasodilatatrice (PGI 2), che dilata i vasi sanguigni e sopprime in gran parte l’aggregazione piastrinica;
- La “reazione di rilascio” dei fattori intrapiastrinici, rafforzando e aumentando la forza del tappo emostatico con la fibrina, è completata da un agente aggregante molto potente, la trombina, che è in grado di provocare aggregazione in dosi minuscole rispetto a quelle necessarie affinché il sangue possa coagularsi.
Naturalmente, i meccanismi elencati sono nell'area di attenzione dei medici di un certo profilo, tuttavia, forse interesseranno anche i lettori particolarmente curiosi che si sono prefissati l'obiettivo di comprendere a fondo le complesse reazioni dell'emostasi piastrinica. Inoltre, tale conoscenza aiuterà a comprendere l'origine di una serie di malattie associate ai disturbi della coagulazione del sangue in questa fase.
Vulnerabilità
I disturbi in alcune parti dell'emostasi piastrinica formano una serie di condizioni patologiche (ereditarie e acquisite).
La più vulnerabile nel meccanismo di aggregazione piastrinica si è rivelata una "reazione di rilascio" molto significativa - senza di essa, il processo di affollamento e incollaggio delle cellule termina non appena inizia. Naturalmente in questi casi non si forma un tappo emostatico.
Inoltre, per una coagulazione del sangue di alta qualità nella zona del microcircolo, è necessaria la presenza di varie sostanze non proteiche (Ca 2+, Mg 2+, fattore fosfolipidico), nonché proteiche (albumina, fibrinogeno, singoli componenti della frazione gamma, ecc.).
Le proteine sono necessarie alle piastrine per creare condizioni confortevoli per loro, la cosiddetta “atmosfera plasmatica”, e solo allora le piastrine del sangue svolgeranno in modo efficiente i compiti loro assegnati. Tuttavia, molti prodotti della degradazione proteica (in particolare quelli ottenuti dalla degradazione del fibrinogeno e della fibrina) interferiscono con l'aggregazione piastrinica e la inibiscono significativamente.
Nel frattempo, a condizione che tutti i partecipanti all'emostasi piastrinica funzionino normalmente, l'aggregazione piastrinica è abbastanza in grado di fermare il sanguinamento nella zona del microcircolo, ma nei vasi di grandi dimensioni, dove la pressione sulle pareti è maggiore, un tappo non rinforzato con fibrina sarà insostenibile e , in poche parole, “volerà via” riprendendo il sanguinamento.
Tutto sul processo di aggregazione piastrinica
Le piastrine sono uno dei tipi di cellule del sangue responsabili della coagulazione dei fluidi biologici, partecipano al processo di emostasi (arresto del sanguinamento) e nutrono le pareti dei vasi sanguigni. L'aggregazione piastrinica è un processo di adesione, che dà luogo a un tappo che si forma per chiudere la ferita. In un corpo sano, ha una natura protettiva, ma c'è anche una capacità anormalmente elevata delle piastrine di aderire - iperaggregazione, che minaccia una maggiore formazione di trombi nei vasi.
Ruolo nella coagulazione del sangue
La capacità del sangue di coagulare dipende da molti fattori, uno dei quali è l'aggregazione piastrinica, che in una persona sana svolge una funzione protettiva. Se l'incollaggio avviene in un vaso sanguinante, il processo gioca un ruolo positivo. Ma quando l'attività di aggregazione cambia oltre i livelli normali, si verificano condizioni patologiche pericolose per la salute e la vita umana.
Per prevenirli, esistono metodi per determinare l'aggregazione che consentono di vedere il grado di deviazione.
Tipi di aggregazione
In medicina è consuetudine distinguere i seguenti tipi di aggregazione piastrinica:
- Spontaneo, che è determinato senza induttore. Per fare ciò, il sangue venoso viene versato in una provetta e riscaldato ad una temperatura di 37 o C.
- Indotto, durante lo studio di quali induttori vengono aggiunti al plasma, che sono collagene, ADP, ristomicina o adrenalina. Il metodo viene utilizzato nella diagnosi di alcune malattie del sangue.
- Moderare. Causato dalla circolazione del sangue nella placenta durante la gravidanza.
- Basso. Si osserva in presenza di malattie del sistema circolatorio e può causare sanguinamento.
- Aumento, che porta ad un aumento del rischio di coaguli di sangue.
Iperaggregazione piastrinica
Un aumento della capacità di aggregazione del sangue porta ad un aumento della sua viscosità e ad un caratteristico movimento lento del sangue con una maggiore capacità di coagulazione (a una velocità normale fino a 2 minuti). La patologia si manifesta quando:
- Aumento della pressione sanguigna.
- Diabete mellito.
- Oncologia del sangue, dei reni e dello stomaco.
- Trombocitopatie.
- Cambiamenti aterosclerotici nei vasi sanguigni.
L’iperaggregazione porta alle seguenti patologie:
- Infarto miocardico dovuto a insufficiente apporto di sangue.
- Ictus dovuto ad accidente cerebrovascolare.
- Trombosi venosa alle gambe.
Valori normali
Il tasso di aggregazione in una persona sana è compreso tra il 25 e il 75%, il che indica un'emopoiesi normale e l'assenza di mancanza di ossigeno nei tessuti e negli organi. Il tasso di indicatore per i vari induttori è il seguente:
Con quale analisi viene determinato?
L'esame del sangue generale comprende anche una valutazione della sua coagulabilità. Ma ci sono studi più accurati condotti utilizzando una tecnica speciale: l'aggregazione indotta. Per fare ciò, al sangue venoso vengono aggiunti componenti simili nella composizione alle sostanze presenti nel corpo umano che causano la formazione di trombi. Sono componenti delle pareti dei vasi sanguigni e sono chiamati induttori.
La diagnosi dei disturbi della coagulazione è inclusa nell'elenco delle fasi obbligatorie nel processo di preparazione del paziente all'imminente intervento chirurgico. Permette di identificare la capacità del corpo di superare il sanguinamento durante l’intervento chirurgico.
Preparazione per l'analisi
L'analisi della capacità di aggregazione viene effettuata dopo una certa preparazione. Per ottenere risultati accurati, non devono essere presenti sostanze nel sangue che possano avere un effetto negativo su di esso. Il processo di preparazione è il seguente:
- 7 giorni prima della data della donazione, interrompere l'assunzione di farmaci a base di aspirina, poiché sopprimono la formazione di trombi. Se tale cancellazione non è possibile informare l'assistente di laboratorio che seleziona l'analisi.
- Non mangiare per 12 ore, poiché il cibo, soprattutto i cibi grassi, può influenzare il risultato.
- Il paziente deve mantenere la calma e astenersi dall'attività fisica.
- Il giorno prima del test evita alcol, caffè, aglio e non fumare.
- L'analisi non viene eseguita in presenza di un processo infiammatorio attivo.
Effettuare analisi
Il prelievo di sangue per l'analisi viene effettuato solo al mattino tra le 7 e le 10. L'analisi della coagulabilità è un metodo di ricerca semplice e accessibile. A tale scopo, esistono i seguenti metodi per determinare l'aggregazione:
- Secondo Lee-white. Determina la velocità di coagulazione del sangue prelevato da una vena in una provetta, nella quale vengono lasciati 3 ml di materiale e inclinata di un angolo di 50 o, dopodiché viene misurato il tempo di completa coagulazione con un cronometro, quando il liquido si ferma fluente. Quindi, a circa 37, questa volta è di 4-7 minuti.
- Secondo Sukharev. Per lo studio viene prelevato il sangue capillare, che viene posto in una provetta speciale - un capillare, e inclinato agli angoli richiesti, annotando il tempo di coagulazione. Pertanto, la formazione di fibrina inizia dopo 0,5-2 minuti e termina dopo 3-5 minuti.
- Coagulogramma. L'analisi viene eseguita con un dispositivo speciale: un analizzatore di aggregazione. Lo studio valuta il processo di coagulazione e molti altri indicatori.
L'aggregazione indotta è molto accurata e viene spesso utilizzata nei casi in cui si sospetta la presenza di patologie individuali. Gli indicatori di analisi dipendono dall'uso dell'induttore. Quella più comunemente eseguita è l'aggregazione piastrinica indotta con ADP, il cui tasso varia dal 30 al 70%.
Risultati, trascrizione
Per ottenere risultati, un medico di laboratorio conduce una serie di studi che richiedono 1-2 giorni lavorativi. La ripartizione dell’analisi evidenzia i seguenti indicatori:
- Tempo di sanguinamento (normale – 2-3 minuti dopo la puntura).
- Aggregazione (tasso spontaneo 0-20%).
- Adesione (indice normativo 20-50%).
- Tempo di coagulazione nell'analisi (la norma per il sangue venoso è 5-10 minuti).
- Indice di protrombina (normale%).
- Tempo di trombina (normasek).
- Fibrinogeno (normale 2-4 g/l).
- Tempo di tromboplastina parziale attivata (normasek).
L'interpretazione indipendente di un test di coagulazione del sangue è possibile se una persona ha informazioni su cos'è l'aggregazione piastrinica e conosce i valori normali degli indicatori.
Il ruolo della trombocitopatia
Le trombocitopatie possono essere ereditarie o acquisite per patologie concomitanti. Secondo le statistiche ne soffre fino al 10% degli abitanti del mondo. La maggior parte dei casi della malattia sono associati all'influenza di alcuni composti sul normale funzionamento delle piastrine, che provoca una scarsa coagulazione del sangue, portando a una significativa perdita di sangue anche con ferite minori ed emorragie interne.
La patologia si fa sentire a partire dall'età scolare, sotto forma di sangue dal naso regolare, un gran numero di contusioni, gonfiore articolare dopo un livido e gengive sanguinanti. Durante la pubertà, le ragazze adolescenti sperimentano periodi lunghi e pesanti, che portano all'anemia.
Una bassa aggregazione piastrinica è facilmente provocata da agenti patogeni batterici e virali, da alcuni farmaci e da procedure di fisioterapia.
Disturbi dell'aggregazione in gravidanza
L'aggregazione piastrinica durante la gravidanza può discostarsi dalla norma, che durante questo periodo è compresa tra il 30 e il 60%, indipendentemente dall'induttore. La disaggregazione si verifica quando c'è una formazione insufficiente o cambiamenti nella composizione qualitativa, che si manifestano con la comparsa di lividi e sanguinamento. Durante il parto è necessario tenere in considerazione la possibilità di un sanguinamento massiccio.
L'aumento dell'aggregazione piastrinica durante la gravidanza si verifica, di regola, durante il periodo di tossicosi, quando si perde liquido a causa di diarrea e vomito. L'ispessimento del sangue porta ad un aumento della formazione di trombi, che può causare un aborto spontaneo nelle fasi iniziali.
L'iperaggregazione moderata è la norma e si verifica a causa dello sviluppo della circolazione sanguigna nella placenta.
Valori normalizzanti
Il trattamento dei disturbi emorragici richiede spesso misure urgenti, poiché se aumenta c'è il rischio di coaguli di sangue e se diminuisce c'è il rischio di sanguinamenti pericolosi. Il trattamento dei disturbi acquisiti della coagulazione si riduce al trattamento eziologico delle malattie che li hanno causati e alla lotta contro i fattori provocatori.
Caratteristiche del trattamento dell'iperaggregazione:
Farmaco. Nelle prime fasi vengono utilizzati farmaci per fluidificare il sangue. A questo scopo è adatta l'aspirina regolare. Dopo una serie di studi aggiuntivi, può essere prescritto quanto segue:
- Anticoagulanti (prevengono una rapida coagulazione del sangue);
- Blocco della novocaina e analgesici;
- Vasodilatatori.
Etnoscienza. In alcuni casi porta buoni risultati, ma prima di usarlo è necessario consultare un medico, poiché è vietato utilizzare alcuni componenti vegetali per la trombocitosi. Le ricette popolari più efficaci per l'iperaggregazione sono le seguenti:
- Trifoglio dolce. 1 cucchiaio. l. le materie prime vengono versate con un bicchiere di acqua bollente, infuse per 30 minuti e bevute in 3-4 dosi al giorno. Il trattamento dura 1 mese;
- Peonia. La radice schiacciata (1 cucchiaio) viene versata con 250 ml di alcol al 70% e lasciata al buio per 3 settimane. Assumere 30 gocce prima dei pasti tre volte al giorno per 2 settimane;
- Succo d'arancia appena spremuto, o mescolato in parti uguali con succo di zucca, assumerne 100 g al giorno;
- Il tè verde e la radice di zenzero (1 cucchiaino ciascuno) vengono versati con 0,5 litri di acqua bollente e un pizzico di cannella, lasciati in infusione per 15 minuti e bevuti durante il giorno.
Dieta. Quando si compila una dieta, l'enfasi è sul consumo di latticini e alimenti vegetali, ed esclude anche gli alimenti che attivano l'emopoiesi: grano saraceno, sorbo e melograno. La dieta deve includere:
- Frutti di mare;
- Verdure verdi e rosse, erbe aromatiche;
- Aglio, zenzero;
- Agrumi.
Quando si tratta l'iperaggregazione, è importante aderire al corretto regime di consumo, poiché la mancanza di liquidi porta alla vasocostrizione e all'ulteriore ispessimento del sangue. Dovresti consumare più di 2-2,5 litri al giorno. acqua.
Caratteristiche del trattamento per l'ipoaggregazione:
Farmaco. È escluso l'uso di farmaci anticoagulanti e nelle forme avanzate della malattia il trattamento viene effettuato in ambiente ospedaliero e viene prescritto quanto segue:
- Introduzione dell'acido aminocaproico;
- Iniezione di ATP;
- Acido tranexamico, Emosint, Dicynone.
Etnoscienza. Viene utilizzato come coadiuvante insieme al trattamento tradizionale. Per questo uso:
- Infuso di ortica. 1 cucchiaio. l. le materie prime vengono versate con 250 ml di acqua bollente e riscaldate per 10 minuti. Assumere prima dei pasti per 1 mese;
- Olio di sesamo. Assumere dopo i pasti;
- Succo di barbabietola. Si prepara macinando la radice su una grattugia con l'aggiunta di zucchero e lasciando il composto in infusione per una notte. Il succo spremuto viene assunto prima di colazione.
Dieta. La dieta deve includere alimenti che stimolano l'emopoiesi: carne rossa, fegato di manzo, pesce, grano saraceno, uova, formaggio, carote, barbabietole, melograni, sorbo, rosa canina.
La prevenzione è possibile?
A seconda che l'aggregazione del sangue umano sia aumentata o diminuita, vengono adottate misure preventive appropriate per correggere questo indicatore. In caso di iperaggregazione, monitorare l'assunzione di liquidi (almeno 2 litri al giorno) e adeguare la dieta, eliminando gli alimenti che addensano il sangue. In caso di coagulazione insufficiente, la prevenzione passa anche dall'adeguamento della dieta, e in entrambi i casi è necessario sottoporsi regolarmente ad esami sotto controllo medico.
L'aggregazione piastrinica è la capacità di mutua adesione, che è di natura adattiva e protettiva. Ma ci sono deviazioni in questo indicatore che portano a gravi interruzioni nel funzionamento del corpo.
La ricerca di aggregazione è un'importante procedura diagnostica che ci consente di identificare una serie di patologie nelle prime fasi di sviluppo, e quindi prevenire possibili complicazioni e prescrivere il trattamento necessario.
Cause dei disturbi dell'aggregazione piastrinica
La determinazione dell'aggregazione piastrinica con vari induttori di aggregazione svolge un ruolo fondamentale nella diagnosi differenziale delle trombocitopatie.
Disturbi dell'aggregazione piastrinica in varie malattie
Stimolatore dell'aggregazione e disturbo dell'aggregazione
malattia di von Willebrand
(+,-) - non ha valore diagnostico.
A seconda delle caratteristiche funzionali e morfologiche delle piastrine, si distinguono i seguenti gruppi di trombocitopatie.
- Trombocitopatie ereditarie da disaggregazione senza interruzione della reazione di rilascio (ondata secondaria). Questo gruppo include:
- Trombastenia di Glyantzmann, che è caratterizzata da una violazione dell'aggregazione ADP-dipendente, con normale aggregazione della ristocetina;
- atrombia essenziale: quando esposta a piccole quantità di ADP, l'aggregazione non viene indotta e quando la quantità di ADP viene raddoppiata, si avvicina alla normalità;
- Anomalia di May-Hegglin: l'aggregazione collagene-dipendente è compromessa, la reazione di rilascio dopo stimolazione con ADP e ristocetina è preservata.
- Trombocitopatie a disaggregazione parziale. Questo gruppo comprende malattie con un difetto congenito di aggregazione con l'uno o l'altro aggregato o con l'inibizione della reazione di rilascio.
- Reazione di rilascio compromessa. Questo gruppo di malattie è caratterizzato dall'assenza di una seconda ondata di aggregazione quando stimolate con una piccola quantità di ADP e adrenalina. Nei casi più gravi, l’aggregazione ADP e adrenalina-dipendente è assente. L'aggregazione collagene-dipendente non viene rilevata.
- Malattie e sindromi con un pool insufficiente di accumulo e stoccaggio di mediatori di aggregazione. Questo gruppo comprende malattie caratterizzate da una ridotta capacità delle piastrine di accumulare e rilasciare serotonina, adrenalina, ADP e altri fattori piastrinici. I test di laboratorio per questo gruppo sono caratterizzati da una diminuzione di tutti i tipi di aggregazione e dall'assenza di una seconda ondata di aggregazione.
Una diminuzione dell'aggregazione piastrinica in risposta alla somministrazione di ADP è stata osservata nell'anemia perniciosa, nella leucemia acuta e cronica e nel mieloma. Nei pazienti con uremia, quando stimolati con collagene, adrenalina e ADP, l'aggregazione è ridotta. L'ipotiroidismo è caratterizzato da una diminuzione dell'aggregazione piastrinica quando stimolata dall'ADP. L'acido acetilsalicilico, la penicillina, l'indometacina, la clorochina, i diuretici (in particolare la furosemide se usata ad alte dosi) aiutano a ridurre l'aggregazione piastrinica, di cui bisogna tenere conto nel trattamento con questi farmaci.
Durante gli interventi chirurgici complicati dal sanguinamento, i disturbi nel sistema di emostasi vascolare-piastrinica nella maggior parte dei casi non sono causati da una violazione dell'aggregazione e di altre proprietà funzionali delle piastrine, ma dalla presenza di trombocitopenia di vario grado.
Cos'è l'aggregazione piastrinica, le ragioni della diminuzione e dell'aumento dell'aggregazione
Una funzione particolarmente importante del sistema della coagulazione è l'aggregazione piastrinica. Che cos'è? Si forma un tappo che impedisce al sangue di fuoriuscire dai vasi danneggiati. Tale “aiuto” per gli infortuni aiuta a preservare la vita di una persona e previene una grave perdita di sangue. Esami del sangue regolari per il contenuto e il volume medio delle piastrine, nonché il livello di aggregazione, sono un'esigenza importante per ogni persona.
Aggregazione, sue forme, tipologie e ruolo nel corpo
Il processo di aggregazione è una delle fasi finali del meccanismo di coagulazione del sangue. In questo caso si verifica l'affollamento o l'adesione delle piastrine. Quando l'integrità di un vaso sanguigno viene danneggiata, dai suoi tessuti viene rilasciata una sostanza speciale: l'adenosina difosfato (ADP). È lo stimolatore più importante dell'aggregazione piastrinica nel sito della lesione. L'ADP viene prodotto e rilasciato anche dalle cellule del sangue come i globuli rossi e le piastrine.
L'aggregazione piastrinica segue sempre l'adesione, quando le singole cellule aderiscono al sito della lesione vascolare. L'ulteriore adesione delle piastrine è chiamata aggregazione: la formazione di un coagulo stabile e denso, un tappo che può ostruire l'area danneggiata.
A seconda del tipo di coagulo formatosi durante il processo di affollamento si distinguono due forme di aggregazione:
- Reversibile. La spina è allentata e consente il passaggio del plasma.
- Irreversibile. Si forma con la partecipazione della trombostenina, una proteina che contribuisce alla compattazione e al fissaggio del tappo nel vaso.
L’aggregazione piastrinica consente l’arresto del sanguinamento entro 15 secondi.
Esistono diversi tipi di affollamento piastrinico:
- diminuito - ipoaggregazione;
- aumentato - iperaggregazione;
- moderatamente elevato. Questo tipo è tipico delle donne incinte;
- normale indotto. Si sviluppa secondo un meccanismo standard con la partecipazione di attivatori - ADP e altre sostanze;
- normale spontaneo. Si verifica senza la partecipazione di stimolanti sotto l'influenza di fattori esterni, in particolare il riscaldamento al di sopra della temperatura corporea. Spesso utilizzato nel processo di esecuzione di un esame del sangue.
Ruolo dell’affollamento piastrinico:
- intasamento della ferita;
- fermare qualsiasi tipo di sanguinamento;
- protezione contro l'anemia causata dalla perdita di sangue;
- prevenendo lo sviluppo di un eccessivo sanguinamento fisiologico. Un esempio sono le mestruazioni nelle donne.
Studio di aggregazione, valori normali
I motivi per consultare un medico ed esaminare le condizioni del sistema di coagulazione sono:
- sanguinamento frequente, anche lieve, aumento del sanguinamento delle gengive, sangue dal naso periodico;
- mestruazioni abbondanti;
- ematomi da colpi minori;
- ferite non cicatrizzate a lungo termine;
- rigonfiamento;
- Malattie autoimmuni;
- patologie del midollo osseo;
- malattie oncologiche;
- malattie della milza;
- problemi circolatori e cardiaci;
- interventi chirurgici frequenti;
- la necessità di selezionare una dose di anticoagulante;
- prima dell'intervento chirurgico.
Quando si esegue un esame del sangue per l'aggregazione piastrinica, è importante capire che si tratta di un test che richiede una preparazione preliminare obbligatoria.
- seguire una dieta speciale il giorno prima del prelievo di sangue. È importante evitare di mangiare cibi grassi;
- 6-8 ore prima di rinunciare a caffè e alcol;
- non fumare 4 ore prima;
- non mangiare cibi piccanti, cipolle e aglio 6 ore prima;
- Se possibile, evitare di assumere farmaci per 5-7 giorni, soprattutto quelli che influenzano il processo di coagulazione del sangue. Se lo studio viene effettuato su persone con patologie croniche, allora è importante informare il medico sui farmaci che si assumono;
- escludere la presenza di infiammazione acuta nel corpo;
- in un giorno, elimina i carichi pesanti e il lavoro estenuante, rilassati e dormi a sufficienza.
Per l'analisi viene utilizzato sangue venoso prelevato a stomaco vuoto, preferibilmente entro tre ore dal risveglio. Gli stimolanti di aggregazione vengono aggiunti al campione risultante nel volume richiesto. Diversi laboratori utilizzano tali sostanze tra cui scegliere: ADP, adrenalina, collagene, serotonina. Un'ulteriore analisi consiste nello studiare i cambiamenti nella lunghezza d'onda della luce passata attraverso il campione di sangue prima e dopo la coagulazione.
La norma degli indicatori di affollamento piastrinico dipende da quale sostanza stimolante viene presa per l'analisi:
- ADP - aggregazione piastrinica dal 31 al 78%;
- collagene - norma dal 46,5 al 93%;
- adrenalina - 35-92%.
Aumento dell'aggregazione: cause, complicanze e trattamento
Questa condizione è chiamata iperaggregazione. Consiste in un aumento della coagulazione del sangue nei vasi, che può portare ad un aumento del rischio di coaguli di sangue, nonché alla morte.
Cause e malattie accompagnate da iperaggregazione:
- malattie oncologiche del sangue;
- cancro allo stomaco;
- cancro al rene;
- malattia ipertonica;
- disturbi circolatori;
- aritmia;
- bradicardia.
- colpi;
- infarti;
- morte improvvisa dovuta al blocco dei grandi vasi sanguigni da parte di un trombo;
- apporto di sangue insufficiente agli organi a causa del restringimento del lume dei vasi sanguigni, principalmente del cervello;
- trombosi venosa degli arti inferiori.
Principi del trattamento farmacologico dell'iperaggregazione:
- Assunzione di farmaci a base di acido acetilsalicilico (Cardiomagnyl). L'assunzione di tali farmaci è giustificata dall'età di 40 anni per mantenere la normale consistenza del sangue e ridurre il rischio di coaguli di sangue.
- Assunzione di agenti antipiastrinici (Clopidogrel), che riducono l'aggregazione piastrinica e normalizzano la viscosità del sangue.
- Assunzione di anticoagulanti (eparina, fraxiparina, streptochinasi) per prevenire la formazione di coaguli di sangue.
- L'uso di agenti che dilatano il lume dei vasi sanguigni - vasodilatatori e antispastici.
- Trattamento della patologia sottostante che causa l'iperaggregazione.
Principi del trattamento non farmacologico dell'iperaggregazione:
- Una dieta ricca di cibi vegetali: verdure, agrumi, verdure. Per i prodotti proteici, dare la preferenza ai latticini. I frutti di mare aiuteranno anche a mantenere le normali proprietà del sangue. Limitare il consumo di grano saraceno, melograni e aronia.
- Rispetto del regime di consumo di alcol. La mancanza di liquidi nel corpo è spesso accompagnata da iperaggregazione e formazione di trombi. Dovresti bere almeno 2 litri di acqua pulita al giorno.
- La medicina tradizionale non può essere considerata un’alternativa al trattamento farmacologico. Le principali piante medicinali che riducono la coagulazione del sangue sono il meliloto, la radice di peonia e il tè verde.
Aggregazione ridotta: cause, complicanze e trattamento
Questa condizione è chiamata ipoaggregazione in medicina. Questo è un disturbo pericoloso che porta a una scarsa coagulazione del sangue, alla minaccia di gravi perdite di sangue e alla possibile morte del paziente.
- malattie infettive;
- insufficienza renale;
- leucemia;
- ipotiroidismo;
- anemia;
- uso irrazionale di farmaci anticoagulanti;
- intossicazione;
- trombocitopenia;
- disidratazione;
- chemioterapia.
- sanguinamento;
- morte per perdita di sangue;
- anemia;
- morte di una donna in travaglio durante il parto.
Il trattamento farmacologico si basa sull'uso di farmaci con proprietà emostatiche, nonché sul trattamento della malattia di base:
Nei casi più gravi, il paziente viene trasfuso con il sangue di un donatore.
Metodi non farmacologici per aiutare il paziente:
- Dieta. Arricchisci la dieta con alimenti che stimolano l'ematopoiesi: grano saraceno, fegato, carne, melograni, pesce rosso.
- Fitoterapia con foglie di ortica, succo di barbabietola, aronia, semi di sesamo.
Aggregazione nei bambini e nelle donne in gravidanza: caratteristiche principali
I disturbi emorragici sono rari durante l’infanzia. Possono essere ereditari e anche essere il risultato di infezioni virali e batteriche, anemia e grave disidratazione. La principale misura di assistenza è la normalizzazione della nutrizione, del regime di consumo di alcol e del trattamento di malattie che hanno causato disturbi della coagulazione. Durante l’adolescenza aumenta il ruolo dello stress nello sviluppo dei disturbi dell’aggregazione piastrinica.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai problemi di coagulazione del sangue nelle donne in gravidanza. Questo è importante sia per il processo di gestazione che per il normale corso del travaglio.
Nelle future mamme, l'aggregazione piastrinica è leggermente aumentata, causata da un aumento fisiologico del volume sanguigno circolante.
- cattiva amministrazione;
- inizio prematuro del travaglio;
- cattiva amministrazione.
- sanguinamento durante la gravidanza;
- sanguinamento pesante e pericoloso durante il parto;
- morte per massiccia perdita di sangue.
La fornitura tempestiva di assistenza e la prescrizione di farmaci efficaci aiuteranno a prevenire complicazioni potenzialmente letali per la madre e il bambino.
27.1. Farmaci che riducono l’aggregazione piastrinica (agenti antipiastrinici)
Le piastrine sono piccoli elementi del sangue a forma di disco che si formano come frammenti di megacariociti del midollo osseo. Le piastrine circolano nel sangue per 6-12 giorni e vengono poi assorbite dai macrofagi dei tessuti.
L'endotelio vascolare influenza l'attività funzionale delle piastrine. Le cellule endoteliali rilasciano nel flusso sanguigno la prostaciclina (prostaglandina I 2) e il fattore rilassante endoteliale, identificato con l'ossido nitrico - NO. Queste sostanze prevengono l'aggregazione piastrinica. Inoltre, le cellule endoteliali secernono sostanze che riducono la coagulazione del sangue e favoriscono la lisi del coagulo. Tutto ciò garantisce le proprietà antitrombogeniche dell'endotelio vascolare intatto.
Quando l'endotelio vascolare viene danneggiato, cosa che può essere causata da vari fattori (traumi meccanici, infezioni, alterazioni aterosclerotiche nella parete vascolare, aumento della pressione sanguigna, ecc.), le proprietà antitrombogeniche dell'endotelio si riducono, creando le condizioni per la formazione di un coagulo di sangue. La sintesi della prostaciclina e del fattore rilassante endoteliale viene interrotta e questo facilita il contatto
piastrine con superficie endoteliale danneggiata. Le piastrine si accumulano nella sede del danno e interagiscono con il subendotelio vascolare: direttamente o attraverso il fattore di von Willebrand (secreto dalle piastrine attivate e dalle cellule endoteliali), si legano al collagene e ad altre proteine del subendotelio con la partecipazione di glicoproteine specifiche localizzate nella piastrina membrana. Il fattore di Von Willebrand si lega alla glicoproteina Ib e il collagene si lega alla glicoproteina Ia della membrana piastrinica (vedi Fig. 27-1). L'effetto del collagene (così come della trombina, che si forma localmente in piccole quantità già nella fase iniziale della formazione del trombo) sulle piastrine provoca un cambiamento nel loro stato: l'attivazione. Le piastrine cambiano forma (da disco si diffondono con numerosi processi - pseudopodi) e ricoprono la superficie danneggiata del vaso.
Quando attivate, le piastrine rilasciano varie sostanze biologicamente attive, che nelle piastrine non attivate si trovano in granuli (α-granuli, granuli densi). I granuli densi sono un deposito di sostanze che stimolano l'aggregazione piastrinica: ADP e serotonina. Il rilascio di queste sostanze dai granuli piastrinici avviene a seguito di un aumento della concentrazione intracellulare di Ca 2+ dovuto all'azione del collagene, della trombina e di altri induttori di aggregazione, tra cui lo stesso ADP, sulle piastrine. L'ADP rilasciato nel flusso sanguigno stimola specifici recettori (purinergici) localizzati nella membrana piastrinica. Attraverso i recettori accoppiati alle proteine G (recettori purinergici P2Y 12), l'ADP provoca l'inibizione dell'adenilato ciclasi e una diminuzione dei livelli di cAMP, che porta ad un aumento dei livelli di Ca 2 nel citoplasma delle piastrine (Fig. 27-2).
Inoltre, quando le piastrine vengono attivate, aumenta l’attività della fosfolipasi A2 di membrana piastrinica, un enzima coinvolto nella formazione dell’acido arachidonico dai fosfolipidi di membrana. Nelle piastrine, gli endoperossidi ciclici (prostaglandine G2/H2) vengono prima sintetizzati dall'acido arachidonico sotto l'influenza della cicloossigenasi, e da essi, con la partecipazione della trombossanesina-
La tetasi produce trombossano A 2, uno stimolatore attivo dell'aggregazione piastrinica e un vasocostrittore. Una volta rilasciato nel flusso sanguigno, il trombossano A 2 stimola i recettori del trombossano sulle membrane piastriniche. Di conseguenza, la fosfolipasi C viene attivata attraverso le proteine Cq associate a questi recettori e la formazione di
Riso. 27-1. Adesione e aggregazione delle piastrine durante il danno alla parete vascolare: EC - cellula endoteliale; VW - fattore von Willebrand; TxA 2 - trombossano A 2; IGP 2 - prostaciclina; NO - fattore rilassante endoteliale; GP - glicoproteine; GP llb/llla - glicoproteine llb/llla (Da: Katzung B.G. Bazic and Clinical Pharmacology - NY, 2001, come modificato)
inositolo-1,4,5-trifosfato, che promuove il rilascio di Ca 2+ dal deposito intracellulare delle piastrine (il ruolo del deposito di calcio nelle piastrine è svolto da un sistema di tubuli densi). Ciò porta ad un aumento della concentrazione citoplasmatica di Ca 2+ (Fig. 27-2). Il trombossano A 2 provoca un aumento della concentrazione di Ca 2+ nelle cellule muscolari lisce vascolari, che porta alla vasocostrizione.

Riso. 27-2. Meccanismi d'azione degli agenti antipiastrinici (acido acetilsalicilico, ticlopidina ed epoprostenolo): EC - cellula endoteliale; PL - fosfolipidi delle membrane cellulari; AA - acido archidonico; PLA2 - fosfolipasi A2; COX - cicloossigenasi; TS - trombossano sintetasi; PS - prostaciclina sintetasi; PGG 2 /H 2 - endoperossidi ciclici; TxA 2 - trombossano A 2; IGP 2 - prostaciclina; AC - adenilato ciclasi; PLS - fosfolipasi C; IP 3 - inositolo-1, 4, 5-trifosfato
Pertanto, l'ADP e il trombossano A 2 aumentano il livello di Ca 2+ nel citoplasma delle piastrine. Il Ca 2+ citoplasmatico provoca un cambiamento nella conformazione delle glicoproteine IIb/IIIa nella membrana piastrinica, in conseguenza della quale acquisiscono la capacità di legare il fibrinogeno. Una molecola di fibrinogeno ha due siti di legame per le glicoproteine IIb/IIIa e quindi può unire due piastrine (Fig. 27-3). L'unione di molte piastrine mediante ponti fibrinogeni porta alla formazione di aggregati piastrinici.
La prostaciclina (prostaglandina I 2) ha l'effetto opposto sull'aggregazione piastrinica. Come il trombossano, la prostaciclina
è formato da endoperossidi ciclici, ma sotto l'azione di un altro enzima: la prostaciclina sintetasi. La prostaciclina viene sintetizzata dalle cellule endoteliali e rilasciata nel flusso sanguigno, dove stimola i recettori della prostaciclina nella membrana piastrinica e l'adenilato ciclasi ad essi associato attraverso la proteina G s. Di conseguenza, il livello di cAMP nelle piastrine aumenta e la concentrazione di Ca 2+ citoplasmatico diminuisce (vedi Fig. 27-2). Ciò impedisce il cambiamento della conformazione delle glicoproteine IIb/IIIa e queste perdono la capacità di legare il fibrinogeno. Pertanto, la prostaciclina previene l'aggregazione piastrinica. Sotto l'influenza della prostaciclina, la concentrazione di Ca 2+ nelle cellule muscolari lisce vascolari diminuisce, il che porta alla vasodilatazione.

Si può distinguere la seguente sequenza di eventi principali che portano all'aggregazione piastrinica (vedi Diagramma 27-1).
Il focus principale dell'azione degli agenti antipiastrinici, attualmente utilizzati nella pratica clinica, è associato all'eliminazione dell'azione del trombossano A 2 e dell'ADP, nonché al blocco delle glicoproteine IIb/IIIa delle membrane piastriniche. Vengono utilizzate anche sostanze con un diverso meccanismo d'azione, che aumentano la concentrazione di cAMP nelle piastrine e, quindi, riducono la concentrazione di Ca 2+ in esse.
Si distinguono i seguenti gruppi di agenti che riducono l'aggregazione piastrinica.
2 . - Inibitori della ciclossigenasi:
acido acetilsalicilico.

Schema 27.1. Meccanismo di aggregazione piastrinica
Inibitori della cicloossigenasi e della trombossano sintetasi: indobufene.
Agenti che stimolano i recettori della prostaciclina:
epoprostenolo**.
Agenti che interferiscono con l'effetto dell'ADP sulle piastrine:
ticlopidina; clopidogrel.
Agenti che inibiscono la fosfodiesterasi piastrinica:
dipiridamolo
Agenti che bloccano le glicoproteine IIb/IIIa delle membrane piastriniche.
Anticorpi monoclonali: abciximab.
Bloccanti sintetici delle glicoproteine IIb/IIIa: eptifibatide; tirofiban.
Farmaci che inibiscono la sintesi del trombossano A 2
L'acido acetilsalicilico (aspirina*) è un noto agente antinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Attualmente ampiamente utilizzato come agente antipiastrinico. L'effetto antipiastrinico dell'acido acetilsalicilico è associato al suo effetto inibitorio sulla sintesi del trombossano A 2 nelle piastrine.
L'acido acetilsalicilico inibisce irreversibilmente la cicloossigenasi (provoca l'acetilazione irreversibile dell'enzima) e quindi interrompe la formazione di endoperossidi ciclici, precursori del trombossano A2 e delle prostaglandine dall'acido arachidonico. Pertanto, sotto l'influenza dell'acido acetilsalicilico, diminuisce non solo la sintesi del trombossano A 2 nelle piastrine, ma anche la sintesi della prostaciclina nelle cellule endoteliali vascolari (vedi Fig. 27-2). Tuttavia, selezionando le dosi e il regime appropriati, è possibile ottenere un effetto preferenziale dell'acido acetilsalicilico sulla sintesi del trombossano A 2 . Ciò è dovuto alle differenze significative tra piastrine e cellule endoteliali.
Le piastrine - cellule anucleate - non hanno un sistema di risintesi proteica e, quindi, non sono in grado di sintetizzare la cicloossigenasi. Pertanto, con l'inibizione irreversibile di questo enzima, l'interruzione della sintesi del trombossano A2 persiste per tutta la vita della piastrina, cioè entro 7-10 giorni. A causa della formazione di nuove piastrine, l'effetto antipiastrinico dell'acido acetilsalicilico dura per un periodo di tempo più breve e pertanto, per ottenere un effetto stabile del farmaco (cioè una diminuzione stabile dei livelli di trombossano), si raccomanda di prescriverlo una volta al giorno.
La ciclossigenasi viene sintetizzata nelle cellule endoteliali vascolari e l'attività di questo enzima viene ripristinata entro poche ore dall'assunzione di acido acetilsalicilico. Pertanto, quando il farmaco viene prescritto una volta al giorno, non si verifica una riduzione significativa della sintesi della prostaciclina.

Inoltre, circa il 30% dell'acido acetilsalicilico subisce un metabolismo di primo passaggio nel fegato, quindi la sua concentrazione nella circolazione sistemica è inferiore a quella nel sangue portale. Di conseguenza, l'acido acetilsalicilico agisce sulle piastrine circolanti nel flusso sanguigno portale in concentrazioni più elevate rispetto alle cellule endoteliali dei vasi sistemici. Pertanto, per sopprimere la sintesi del trombossano A2 nelle piastrine, sono necessarie dosi di acido acetilsalicilico inferiori rispetto a quelle necessarie per sopprimere la sintesi della prostaciclina nelle cellule endoteliali.
Per questi motivi, con l'aumento della dose e della frequenza di somministrazione dell'acido acetilsalicilico, il suo effetto inibitorio sulla sintesi della prostaciclina diventa più pronunciato, il che può portare ad una diminuzione dell'effetto antipiastrinico. In relazione a queste caratteristiche, si consiglia di prescrivere l'acido acetilsalicilico come agente antipiastrinico in piccole dosi (in media 100 mg) una volta al giorno.
Come agente antipiastrinico, l'acido acetilsalicilico viene utilizzato per l'angina instabile, per la prevenzione dell'infarto miocardico, dell'ictus ischemico e della trombosi vascolare periferica, per prevenire la formazione di coaguli di sangue durante l'intervento di bypass coronarico e l'angioplastica coronarica. L'acido acetilsalicilico viene prescritto per via orale in dosi di 75-160 mg (per alcune indicazioni - nell'intervallo di dose da 50 a 325 mg) 1 volta al giorno per un lungo periodo. Attualmente, i medici hanno a disposizione preparati di acido acetilsalicilico destinati alla prevenzione della trombosi, che contengono 50-325 mg del principio attivo, comprese compresse con rivestimento enterico - Acecardol *, Aspicor *, Cardiopyrin *, Aspirin Cardio *, Novandol *, Trombo ACC*, ecc. L'effetto antipiastrinico dell'acido acetilsalicilico si manifesta rapidamente (entro 20-30 minuti). Le forme di dosaggio con rivestimento enterico iniziano ad agire più lentamente, ma con l'uso a lungo termine la loro efficacia non è praticamente diversa da quella delle compresse convenzionali. Per ottenere un effetto più rapido, le compresse di acido acetilsalicilico devono essere masticate.
I principali effetti collaterali dell'acido acetilsalicilico sono associati all'inibizione della cicloossigenasi. Ciò interrompe la formazione delle prostaglandine E 2 e I 2, che hanno un effetto antisecretorio e gastroprotettivo (riducono la secrezione di acido cloridrico da parte delle cellule parietali dello stomaco, aumentano la secrezione di muco e bicarbonati). Di conseguenza, anche con un uso a breve termine, l'acido acetilsalicilico può causare danni all'epitelio dello stomaco e del duodeno (effetto ulcerogeno). L'effetto sulla mucosa gastrica è meno pronunciato quando si utilizzano forme farmaceutiche con rivestimento enterico. Quando si utilizza l'acido acetilsalicilico, sono possibili sanguinamento gastrointestinale e altre complicazioni emorragiche. Il rischio di tali complicazioni è inferiore quando l’acido acetilsalicilico viene prescritto a una dose pari o inferiore a 100 mg/die. L'inibizione selettiva della COX porta all'attivazione della via della lipossigenasi per la conversione dell'acido arachidonico e la formazione di leucotrieni, che hanno proprietà broncocostrittrici. Nei pazienti con asma bronchiale, l'acido acetilsalicilico può provocare l'insorgenza di un attacco (“asma da aspirina”). Sono possibili reazioni allergiche.
Per ridurre l'effetto ulcerogeno dell'acido acetilsalicilico, è stata proposta una combinazione di farmaci Cardiomagnyl * contenente idrossido di magnesio. L'idrossido di magnesio neutralizza l'acido cloridrico nello stomaco (effetto antiacido), riducendone l'effetto dannoso sulla mucosa. Il farmaco viene utilizzato per le stesse indicazioni dell'acido acetilsalicilico, inclusa la prevenzione secondaria dell'ictus ischemico.
L'indobufene (ibustrina *) riduce la sintesi del trombossano A 2, inibendo contemporaneamente la cicloossigenasi e la trombossano sintetasi. A differenza dell'acido acetilsalicilico, l'indobufene provoca un'inibizione reversibile della cicloossigenasi. Quando si assume questo farmaco, si verifica un aumento relativo della quantità di prostaciclina (il rapporto prostaciclina/trombossano A 2 aumenta). L'indobufene inibisce l'adesione e l'aggregazione piastrinica. Le indicazioni per l'uso e gli effetti collaterali sono gli stessi dell'acido acetilsalicilico.
Agenti che stimolano i recettori della prostaciclina
Un altro modo per ridurre l’aggregazione piastrinica è la stimolazione dei recettori della prostaciclina. A questo scopo usano
preparato prostaciclina e p o pro s t e n o l* . L'effetto della prostaciclina è opposto all'effetto del trombossano A 2 non solo sulle piastrine, ma anche sul tono vascolare. Provoca vasodilatazione e diminuzione della pressione sanguigna. Questo effetto della prostaciclina viene utilizzato nell'ipertensione polmonare. Poiché la prostaciclina viene distrutta rapidamente nel sangue (t 1/2 circa 2 minuti) e quindi non agisce a lungo, il farmaco viene somministrato per infusione. A causa della sua breve azione, l’epoprostenolo* non ha trovato un uso diffuso come agente antipiastrinico. Un possibile ambito di utilizzo dell’effetto antipiastrinico dell’epoprostenolo è la prevenzione dell’aggregazione piastrinica durante la circolazione extracorporea.
Agenti che interferiscono con l'azione dell'ADP sulle piastrine
La ticlopidina (ticlid*), un derivato della tienopiridina, inibisce l'aggregazione piastrinica causata dall'ADP. La ticlopidina è un profarmaco; il suo effetto antipiastrinico è associato alla formazione di un metabolita attivo con la partecipazione degli enzimi epatici microsomiali. Il metabolita ticlopidina contiene gruppi tiolici, attraverso i quali si lega irreversibilmente ai recettori purinergici P2Y 12 nella membrana piastrinica. Ciò porta all'eliminazione dell'effetto stimolante dell'ADP sulle piastrine e ad una diminuzione della concentrazione di Ca 2+ citoplasmatico in esse. Di conseguenza diminuisce l'espressione delle glicoproteine IIb/IIIa nella membrana piastrinica e il loro legame con il fibrinogeno (vedi Fig. 27-2). Per la natura irreversibile della sua azione, la ticlopidina ha un effetto antiaggregante piastrinico di lunga durata.
L'effetto massimo con l'uso costante della ticlopidina si ottiene dopo 7-11 giorni (tempo necessario per la formazione e lo sviluppo dell'azione del metabolita attivo) e dopo la sospensione del farmaco persiste per tutta la vita delle piastrine (7-10 giorni).
La ticlopidina è prescritta per la prevenzione secondaria dell'ictus ischemico, per prevenire la trombosi nelle malattie obliteranti degli arti inferiori, durante l'innesto di bypass coronarico e lo stent delle arterie coronarie. Il farmaco è efficace se assunto per via orale, prescritto 2 volte al giorno durante i pasti.
L'uso della ticlopidina è limitato a causa dei suoi effetti collaterali. Possibile perdita di appetito, nausea, vomito, diarrea (20%), dolore addominale, eruzioni cutanee (11-14%). Notato
aumento del livello plasmatico delle lipoproteine aterogene. Il sanguinamento è una complicanza comune quando si utilizzano agenti antipiastrinici. Una complicanza pericolosa è la neutropenia, che si manifesta durante i primi tre mesi di trattamento nell'1-2,4% dei pazienti. Sono possibili trombocitopenia, agranulocitosi e, molto raramente, anemia aplastica. A questo proposito, durante i primi mesi di trattamento, è necessario il monitoraggio sistematico del quadro ematico.
Clopidogrel (Plavix*, Zilt*) è simile alla ticlopidina nella struttura chimica, negli effetti principali e nel meccanismo d'azione. Come la ticlopidina, è un profarmaco e subisce la conversione nel fegato per formare un metabolita attivo. Una significativa inibizione dell'aggregazione piastrinica è stata osservata dal secondo giorno di trattamento, l'effetto massimo si ottiene dopo 4-7 giorni. Dopo la sospensione del farmaco, il suo effetto dura 7-10 giorni. Clopidogrel ha un'attività superiore alla ticlopidina: alla dose giornaliera di 75 mg provoca la stessa diminuzione dell'aggregazione piastrinica e il prolungamento del tempo di sanguinamento della ticlopidina alla dose giornaliera di 500 mg.

Clopidogrel viene utilizzato per le stesse indicazioni dell'acido acetilsalicilico, in caso di intolleranza. Assumere per via orale 1 volta al giorno, indipendentemente dai pasti. Clopidogrel può essere combinato con l'acido acetilsalicilico, poiché i farmaci inibiscono diversi meccanismi di aggregazione piastrinica e quindi potenziano l'effetto reciproco (tuttavia, con questa combinazione esiste un rischio maggiore di complicanze emorragiche).
Rispetto alla ticlopidina, gli effetti collaterali del clopidogrel sono meno pronunciati (diarrea - 4,5%, eruzione cutanea - 6%). L'uso di clopidogrel è associato a un minor rischio di una complicanza grave come la neutropenia (0,1%) e la trombocitopenia si verifica meno frequentemente. Come complicanza rara, come con la ticlopidina, può svilupparsi porpora trombotica trombocitopenica.
Inibitori della fosfodiesterasi piastrinica
Il dipiridamolo (curantil*, persantine*) è stato inizialmente proposto come dilatatore coronarico. Successivamente è stata rivelata la sua capacità di inibire l'aggregazione piastrinica. Attualmente il dipiridamolo viene utilizzato principalmente come agente antipiastrinico per la prevenzione della trombosi. L'effetto antipiastrinico del dipiridamolo è associato ad un aumento del livello di cAMP nelle piastrine, a seguito del quale diminuisce la concentrazione di Ca 2+ citoplasmatico in esse. Ciò accade per diversi motivi. Innanzitutto, il dipiridamolo inibisce la fosfodiesterasi, che inattiva il cAMP. Inoltre, il dipiridamolo inibisce l'assorbimento dell'adenosina da parte delle cellule endoteliali e degli eritrociti e il suo metabolismo (inibisce l'adenosina deaminasi), aumentando così il livello di adenosina nel sangue (Fig. 27-4). L'adenosina stimola i recettori piastrinici A 2 e aumenta l'attività dell'adenilato ciclasi associata a questi recettori, di conseguenza aumenta la formazione di cAMP nelle piastrine e diminuisce il livello di Ca 2+ citoplasmatico. Il dipiridamolo aumenta anche i livelli di cAMP nelle cellule muscolari lisce vascolari, provocando vasorilassamento.

Il dipiridamolo viene utilizzato per prevenire l'ictus ischemico, nonché per le malattie delle arterie periferiche (principalmente in combinazione con l'acido acetilsalicilico, poiché il dipiridamolo stesso ha un debole effetto antipiastrinico). Prescritto per via orale 3-4 volte al giorno 1 ora prima dei pasti. In combinazione con anticoagulanti orali, il dipiridamolo viene prescritto per prevenire la formazione di coaguli di sangue nella cardiopatia mitralica.
Quando si utilizza dipiridamolo, mal di testa, vertigini, ipotensione arteriosa, sintomi dispeptici,
eruzioni cutanee. Il rischio di sanguinamento è inferiore rispetto all'uso dell'acido acetilsalicilico. Il dipiridamolo è controindicato nei casi di angina pectoris (possibile “sindrome da furto”).

Riso. 27-4. Meccanismo d'azione antipiastrinica del dipiridamolo: EC - cellula endoteliale; A 2 -P - recettore dell'adenosina A 2; PDE - fosfodiesterasi del cAMP; AC - adenilato ciclasi; GP IIb/IIIa - glicoproteine IIb/IIIa
La pentossifillina (agapurina*, trental*), come il dipiridamolo, inibisce la fosfodiesterasi e aumenta i livelli di cAMP. Di conseguenza, il livello di Ca 2 + citoplasmatico nelle piastrine diminuisce, il che porta ad una diminuzione della loro aggregazione. La pentossifillina ha anche altre proprietà: aumenta la deformabilità dei globuli rossi, riduce la viscosità del sangue, ha un effetto vasodilatatore, migliorando la microcircolazione.
La pentossifillina viene utilizzata per gli accidenti cerebrovascolari, i disturbi circolatori periferici di varia origine e le patologie vascolari degli occhi (vedere il capitolo “Farmaci utilizzati per gli accidenti cerebrovascolari”). Possibili effetti collaterali: sintomi dispeptici, vertigini, arrossamento del viso, nonché diminuzione della pressione sanguigna, tachicardia, reazioni allergiche, sanguinamento. Come il dipiridamolo, può provocare attacchi durante l'angina pectoris.
Agenti bloccanti le glicoproteine IIb/IIIa delle membrane piastriniche
Questo gruppo di agenti antipiastrinici, che interagiscono direttamente con le glicoproteine IIb/IIIa delle membrane piastriniche e interrompono il loro legame con il fibrinogeno, è apparso relativamente di recente.
Abciximab (reopro*) - il primo farmaco di questo gruppo è un anticorpo monoclonale “chimerico” murino/umano (frammento Fab di anticorpi murini contro le glicoproteine IIb/IIIa combinato con il frammento Fc di Ig umane). L'abciximab inibisce in modo non competitivo il legame del fibrinogeno con le glicoproteine IIb/IIIa sulla membrana piastrinica, interrompendone l'aggregazione (vedere Fig. 27-3). L'aggregazione piastrinica si normalizza 48 ore dopo una singola dose. Il farmaco viene somministrato per via endovenosa (come infusione) per prevenire la trombosi durante l'angioplastica delle arterie coronarie. Quando si utilizza abciximab, è possibile il sanguinamento, incluso quello interno (gastrointestinale, intracranico, sanguinamento dal tratto genito-urinario), nausea, vomito, ipotensione, bradicardia, reazioni allergiche fino allo shock anafilattico, trombocitopenia.
La ricerca di farmaci meno allergenici con lo stesso meccanismo d'azione ha portato alla creazione di bloccanti sintetici delle glicoproteine IIb/IIIa. A partire dalla barborina (un peptide isolato dal veleno del serpente a sonagli pigmeo), è stato ottenuto il farmaco e p t i f i b a t i d (integrilina *), un ettapeptide ciclico che imita la sequenza aminoacidica della catena del fibrinogeno, che si lega direttamente alle glicoproteine IIb/IIIa. L’eptifibatide spiazza competitivamente il fibrinogeno dal legame ai recettori, causando un disturbo reversibile dell’aggregazione piastrinica. Il farmaco viene somministrato per via endovenosa come infusione; l'effetto antipiastrinico si manifesta entro 5 minuti e scompare 6-12 ore dopo la cessazione della somministrazione. Il farmaco è raccomandato per la prevenzione della formazione di trombi durante l'angioplastica coronarica percutanea, per l'angina instabile e per la prevenzione dell'infarto del miocardio. Una complicanza pericolosa quando si usa l'eptifibatide è il sanguinamento; è possibile la trombocitopenia.
Tirofiban (agrastat*) è un bloccante non peptidico delle glicoproteine IIb/IIIa, un analogo della tirosina. Come l’eptifibatide, il tirofiban blocca in modo competitivo i recettori della glicoproteina IIb/IIIa. Il farmaco viene somministrato per via endovenosa (infusione). La velocità di insorgenza dell'effetto, la durata dell'azione e le indicazioni per l'uso sono le stesse dell'eptifibatide. Effetti collaterali: sanguinamento, trombocitopenia.
Per ampliare le possibilità di utilizzo dei farmaci di questo gruppo, sono stati creati bloccanti delle glicoproteine IIb/IIIa efficaci se somministrati per via orale: xemilofiban *, sibrafiban *, ecc. Tuttavia, i test di questi farmaci hanno rivelato la loro insufficiente efficacia e un effetto collaterale nel forma di trombocitopenia grave.