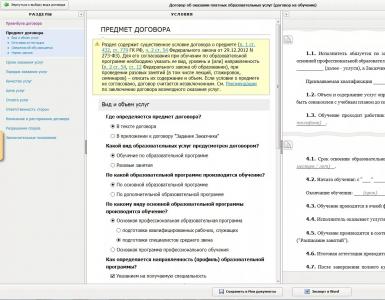Leptospirosi. Cause, sintomi, diagnosi e trattamento della patologia. Clinica, diagnosi, trattamento della leptospirosi Sintomo caratteristico della leptospirosi
Clinica. Il periodo di incubazione è di 4-14 giorni. Si osservano forme itteriche e anitteriche della malattia, con decorso lieve, moderato e grave. La forma tipica della malattia inizia in modo acuto ed è caratterizzata da un aumento della temperatura corporea fino a 39-40 ° C nell'arco di diverse ore, mal di testa e forti dolori muscolari, soprattutto al polpaccio. La mialgia si intensifica con il movimento e può essere così grave che il paziente non riesce ad alzarsi in piedi. La sindrome del dolore muscolare è considerata tipica della leptospirosi, ma non si verifica in tutti i pazienti. Nei giorni successivi l'intossicazione aumenta: i pazienti vengono inibiti, il mal di testa si intensifica, compaiono nausea e vomito.
L'aspetto della palla è caratteristico: il viso è gonfio, iperemico, i vasi della sclera e della congiuntiva sono nettamente iniettati. A volte compaiono eruzioni erpetiche sulle labbra e sulle ali del naso. In alcuni pazienti, al 3-5o giorno di malattia, si osserva un'eruzione roseolo-papulare o eritematosa, meno spesso petecchiale, situata simmetricamente sulla pelle delle estremità e del busto. Nella maggior parte dei casi si verifica micropolilinfoadenite.
Si osservano sordità dei suoni cardiaci, ipotensione e tachicardia. Sopra i polmoni: respiro affannoso, respiro sibilante secco intermittente. Nei casi più gravi della malattia e nelle persone che soffrono di alcolismo cronico, spesso si sviluppa la polmonite. Dal 2-3o giorno di malattia, il fegato si ingrandisce, nel 12-20% dei pazienti compaiono ittero di varia intensità e coluria. L'acolia fecale di solito non si osserva. Studi biochimici rivelano iperbilirubinemia (con un aumento del livello di bilirubina legata e libera), un moderato aumento dell'attività di ALT e AST. Alcuni pazienti sviluppano una meningite sierosa al 5-7° giorno di malattia. Quando si esamina il sangue periferico, si osservano leucocitosi neutrofila e aumento della VES.
Fin dai primi giorni di malattia vengono colpiti i reni: inizialmente si manifestano oliguria e moderata proteinuria, nelle urine compaiono leucociti, eritrociti, cilindri ialini e cellule epiteliali renali. Segni di progresso del danno renale, che è accompagnato da anuria, aumento dei livelli di urea e creatinina nel siero del sangue. L’insufficienza renale acuta che porta all’uremia è la causa più comune di morte nei pazienti.
Nei casi più gravi della malattia, la condizione peggiora notevolmente dal 7 al 10° giorno, a volte anche prima. Un segno prognostico sfavorevole è la sindrome vemorraica: eruzione petecchiale, emorragie nella sclera, nella congiuntiva e nei siti di iniezione, ematuria, sangue dal naso, emorragie negli organi interni.
Per la maggior parte dei pazienti la prognosi è favorevole. La durata della febbre è di 5-12 giorni, quindi la temperatura scende alla normalità. Alcuni pazienti manifestano febbre di basso grado prolungata. Nelle persone che non hanno ricevuto terapia antibatterica, dopo 3-9 giorni di apiressia, si verifica una seconda ondata febbrile, di durata più breve, con manifestazioni cliniche più lievi.
A volte il decorso della malattia comprende 2-3 ricadute simili.
Di solito, entro la fine della 2a settimana, la salute migliora, la diuresi viene ripristinata, i sintomi di intossicazione e ittero regrediscono. La durata totale della malattia è di 3-4 settimane.
Le complicanze più comuni sono lo shock infettivo-tossico, la sindrome emorragica, l'insufficienza renale acuta o epatica, nonché lesioni oculari - uveite, irite, iridociclite, ecc., che persistono per diverse settimane durante il periodo di convalescenza. Alcuni pazienti sperimentano ricadute.
Esistono forme cancellabili della malattia che si manifestano facilmente senza danni ai reni o al fegato e sono simili alle manifestazioni cliniche dell'influenza. Queste forme di leptospirosi possono essere diagnosticate solo sulla base di specifici test di laboratorio e sembrano essere molto più comuni di quanto riportato.
Diagnostica. La diagnosi clinica nei casi tipici può essere fatta sulla base dei dati clinici (esordio acuto, febbre alta, brividi, mialgia, aspetto caratteristico del paziente; sindrome epatolienale, sintomi meningei, eruzioni cutanee eritematose ed emorragiche, segni di danno renale) ed epidemiologici ( fattore professionale: lavoratori della carne che lavorano nell'industria, allevamenti di bestiame, persone che entrano in contatto con roditori sinantropici durante le loro attività, soggiorno in un focolaio endemico - caccia, pesca, nuoto e acqua potabile da bacini aperti, contatto con animali malati o trasportatori - cani, topo muschiato, nutria, ecc.).
Per confermare la diagnosi vengono utilizzati metodi batteriologici e sierologici. Il materiale per la ricerca batteriologica può essere sangue, urina, liquido cerebrospinale.
La ricerca viene effettuata in laboratori speciali. Dal 1° al 5° giorno di malattia vengono eseguite emocolture, microscopia in campo oscuro del sangue citrato e infezione degli animali da laboratorio. Le colture di urina possono essere eseguite durante tutto il periodo febbrile. I metodi sierologici più utilizzati sono la reazione di microagglutinazione (RMA), RSK, RNIF. Lo studio richiede sieri accoppiati prelevati prima del 5-7° giorno di malattia e una settimana dopo. I titoli PMA sono considerati positivi - 1:100, RSC - 1:10 o più, un aumento significativo dei titoli anticorpali di 4 volte.
La leptospirosi si differenzia dall'epatite virale, dall'HFRS, dalla pseudotubercolosi, dall'influenza, ecc.
Trattamento. I pazienti sono ricoverati in ospedali per malattie infettive e, se necessario, in unità e reparti di terapia intensiva (vedere “Febbre emorragica con sindrome renale”). Nella cura dei pazienti, l'attenzione principale è rivolta all'identificazione dei primi segni di insufficienza renale e shock tossico-infettivo, pertanto è necessario monitorare attentamente la diuresi e l'attività cardiovascolare.
Nelle forme gravi della malattia, l'immunoglobulina anti-leptospirosi viene somministrata 10 ml per via intramuscolare (dopo un test cutaneo) per 3 giorni.
Ai pazienti viene prescritta penicillina in una dose a seconda della gravità dell'infezione - da 6.000.000 a 12.000.000 di unità/giorno. Nei casi gravi della malattia, accompagnati da sintomi meningei, la dose di penicillina viene aumentata a 18.000.000 di unità/giorno.
Dopo la dimissione dall'ospedale, il paziente viene osservato in regime ambulatoriale: in presenza di effetti oftalmologici residui - da un oculista; per effetti neurologici residui - consultare un neurologo; in caso di danno renale sotto forma di nefrite consultare un nefrologo; in assenza di questi fenomeni consultare uno specialista in malattie infettive.
I tempi di dimissione dei pazienti dall'ospedale dipendono dalla gravità dell'infezione e dalla natura delle complicanze.
Dopo la dimissione dall'ospedale, i convalescenti devono essere liberati dal lavoro fisico pesante, dalle competizioni sportive e dal lavoro associato a rischi industriali per 3-6 mesi. Per 2-3 mesi è necessario seguire una dieta che escluda alcol, cibi piccanti, fritti e grassi.
L'osservazione del dispensario viene effettuata da uno specialista in malattie infettive o da un terapista per 6 mesi e comprende test di controllo del sangue periferico, delle urine (una volta ogni 2 mesi), esame da parte di un oculista e un neurologo. Se la leptospirosi è accompagnata dallo sviluppo di nefrite, osservazione di follow-up e trattamento di follow-up con un nefrologo per almeno 2 anni.
Prevenzione. L'importanza principale nella prevenzione della leptospirosi è la protezione dei serbatoi naturali e artificiali dalla contaminazione con l'urina di animali selvatici e domestici. L’educazione sanitaria gioca un ruolo importante. I lavoratori degli allevamenti affetti da leptospirosi, degli impianti di lavorazione della carne e dei sistemi fognari sono soggetti a vaccinazione di routine. Ogni anno i cani vengono vaccinati anche contro la leptospirosi.
La leptospirosi è una malattia infettiva zoonotica causata da batteri del genere Leptospira. Questi microrganismi si trovano ovunque tranne che in Antartide. Più comune nei paesi con climi tropicali. Le leptospire sono stabili nell'ambiente. Pertanto, i batteri possono sopravvivere nei serbatoi per circa trenta giorni e nel terreno umido fino a nove mesi.
Sommario:Cause
La fonte dell'infezione sono principalmente roditori, ricci, nonché animali da fattoria (maiali, bovini), cani. Le Leptospire vengono escrete nei rifiuti animali, inquinando l'acqua, il suolo, le verdure e le piante. È impossibile contrarre la leptospirosi da una persona malata. 
La malattia ha molti meccanismi di trasmissione:
- Nutrizionale: l'infezione si verifica quando si beve acqua da serbatoi aperti, nonché cibo contaminato dall'urina di un animale malato;
- Contatto: l'infezione si verifica quando la pelle o le mucose danneggiate entrano in contatto con acqua o suolo contaminati.
 Una persona corre il rischio di contrarre la leptospirosi quando nuota in specchi d'acqua stagnanti. L'acqua può essere contaminata da urina e feci di animali malati. Pertanto, la Listeria può penetrare non solo attraverso la pelle danneggiata, ma anche attraverso la mucosa della bocca, del naso e anche attraverso la congiuntiva degli occhi. Puoi contrarre la leptospirosi anche camminando a piedi nudi su un terreno contaminato.
Una persona corre il rischio di contrarre la leptospirosi quando nuota in specchi d'acqua stagnanti. L'acqua può essere contaminata da urina e feci di animali malati. Pertanto, la Listeria può penetrare non solo attraverso la pelle danneggiata, ma anche attraverso la mucosa della bocca, del naso e anche attraverso la congiuntiva degli occhi. Puoi contrarre la leptospirosi anche camminando a piedi nudi su un terreno contaminato.
Le persone che lavorano negli allevamenti di bestiame, negli impianti di lavorazione della carne e coloro che lavorano nelle zone umide sono ad alto rischio di contrarre la malattia. Non dovresti escludere i veterinari, i lavoratori dei rifugi per animali e i lavoratori dei servizi pubblici che possono essere infettati da cani malati.
La suscettibilità umana alle infezioni è molto elevata. Quindi, quando si nuota in uno stagno, una persona può ammalarsi anche se c'è una piccola area di pelle danneggiata e una piccola quantità di batteri nell'acqua.

Il periodo di incubazione varia da tre a trenta giorni, ma in media è da sei a quattordici giorni. La gamma delle manifestazioni cliniche è molto ampia. La malattia può manifestarsi nelle forme itterica e anitterica, con quadro clinico chiaro oppure sfumato. La leptospirosi è caratterizzata da un polimorfismo dei sintomi clinici osservati in altre malattie. Pertanto, la malattia richiede un'attenta diagnosi differenziale. Nel corso della malattia si distinguono i seguenti periodi:
- Elementare;
- Convalescenza.
Periodo iniziale
La malattia si sviluppa in modo acuto, la temperatura sale improvvisamente a 39-40 gradi, la persona soffre di brividi, debolezza, nausea, vomito e dolore nella regione lombare. La febbre può durare una settimana ed essere persistente o ricorrente. Un segno patognomonico della malattia è il dolore muscolare, soprattutto ai polpacci. Il dolore si intensifica con la palpazione dei muscoli. Pertanto, la comparsa di dolore durante la palpazione della parete addominale anteriore può essere erroneamente percepita dal medico come un sintomo di un addome acuto.

L’aspetto della persona è sorprendente: la pelle del viso e della parte superiore del corpo diventa rossa, gonfia (sintomo del cappuccio), viene iniettata la sclera. La lingua è secca, ricoperta da una patina grigia e successivamente marrone. Possono comparire eruzioni erpetiche nell'area delle labbra e delle ali del naso.
 Dal terzo al sesto giorno di malattia, sulla pelle appare un'eruzione cutanea: punteggiata, rosea, orticarioide. Questo sintomo è osservato in circa il 30-40% dei pazienti. La Leptospira secerne un'endotossina, che distrugge i globuli rossi. Ciò porta a emorragie nella sclera e nella congiuntiva, nonché sangue dal naso. Da un punto di vista prognostico, quanto prima il paziente sviluppa la sindrome emorragica, tanto più grave è il decorso della malattia.
Dal terzo al sesto giorno di malattia, sulla pelle appare un'eruzione cutanea: punteggiata, rosea, orticarioide. Questo sintomo è osservato in circa il 30-40% dei pazienti. La Leptospira secerne un'endotossina, che distrugge i globuli rossi. Ciò porta a emorragie nella sclera e nella congiuntiva, nonché sangue dal naso. Da un punto di vista prognostico, quanto prima il paziente sviluppa la sindrome emorragica, tanto più grave è il decorso della malattia.
 C'è un aumento delle dimensioni del fegato e della milza. Possono comparire segni di danno renale: dolore lombare, diminuzione della minzione, l'urina diventa rossastra.
C'è un aumento delle dimensioni del fegato e della milza. Possono comparire segni di danno renale: dolore lombare, diminuzione della minzione, l'urina diventa rossastra.
Le leptospire sono in grado di penetrare la barriera ematoencefalica, raggiungendo il cervello. Circa il 20% dei pazienti sviluppa la sindrome meningea: il mal di testa si intensifica, non viene eliminato dagli antidolorifici, compaiono vomito e sintomi meningei.
La durata del periodo iniziale è di sette giorni.
 Approssimativamente nella seconda settimana di malattia, la temperatura e l'intossicazione iniziano a diminuire. Ma le condizioni del paziente non migliorano. L'ittero, apparso alla fine del periodo iniziale, diventa sempre più pronunciato. Con l'aumento dell'ittero si osserva anche un ingrossamento del fegato e della milza. Vale la pena notare che le forme anitteriche di leptospirosi non sono affatto rare.
Approssimativamente nella seconda settimana di malattia, la temperatura e l'intossicazione iniziano a diminuire. Ma le condizioni del paziente non migliorano. L'ittero, apparso alla fine del periodo iniziale, diventa sempre più pronunciato. Con l'aumento dell'ittero si osserva anche un ingrossamento del fegato e della milza. Vale la pena notare che le forme anitteriche di leptospirosi non sono affatto rare.
I gruppi di persone ad alto rischio di infezione (veterinari, allevatori, addetti agli impianti di lavorazione della carne, disinfettanti) devono indossare indumenti protettivi durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. Inoltre, queste persone sono soggette a vaccinazione con il vaccino contro la leptospirosi ucciso, che viene somministrato per via sottocutanea in dosi da 2 ml due volte, con un intervallo di dieci giorni. Dopo un anno è opportuno effettuare la rivaccinazione.
Dopo una sospetta infezione, la doxiciclina può essere prescritta come profilassi di emergenza.
Grigorova Valeria, osservatore medico
La leptospirosi è una malattia infettiva focale naturale zoonotica acuta con trasmissione patogena prevalentemente per via idrica, caratterizzata da intossicazione generale, febbre, danni ai reni, al fegato, al sistema nervoso centrale, diatesi emorragica ed elevata mortalità.
Eziologia della leptospirosi
Le leptospire sono microrganismi sottili e mobili a forma di spirale con una lunghezza da diversi a 40 nm o più e un diametro da 0,3 a 0,5 nm. Entrambe le estremità della leptospira sono, di regola, piegate a forma di uncini, ma si trovano anche forme senza uncini. Le leptospire hanno tre elementi strutturali principali: un guscio esterno, un filamento assiale e un cilindro citoplasmatico, che è attorcigliato elicoidale attorno all'asse longitudinale. Si riproducono per divisione trasversale.
Le leptospire sono Gram-negativi. Sono aerobi stretti; vengono coltivati su terreni nutritivi contenenti siero sanguigno. La crescita ottimale è tra 27 e 30 °C, tuttavia anche in tali condizioni crescono molto lentamente. I fattori di patogenicità della Leptospira sono sostanze simili alle esotossine, endotossine, enzimi (fibrinolisina, coagulasi, lipasi, ecc.), nonché capacità invasiva e adesiva.
Le leptospire sono sensibili alle alte temperature: l'ebollizione le uccide all'istante, il riscaldamento a 56–60 °C le uccide entro 20 minuti. Le Leptospira sono più resistenti alle basse temperature. Pertanto, a –30–70 °C e negli organi congelati, rimangono vitali e virulenti per molti mesi. La bile, il succo gastrico e l'urina umana acida hanno un effetto dannoso sulla leptospira e nell'urina leggermente alcalina degli erbivori rimangono vitali per diversi giorni. Nell'acqua di bacini aperti con una reazione leggermente alcalina o neutra, le leptospire persistono per 1 mese e nel terreno umido e impregnato d'acqua non perdono la loro patogenicità fino a 9 mesi. La Leptospira sopravvive sui prodotti alimentari fino a 1-2 giorni e, se esposta alla luce ultravioletta e una volta essiccata, muore entro 2 ore.La Leptospira è sensibile alla penicillina, al cloramfenicolo, alla tetraciclina ed è estremamente sensibile all'azione dei disinfettanti convenzionali, bollendo , salatura e marinatura. Allo stesso tempo, le basse temperature non hanno effetti dannosi sulla Leptospira. Ciò spiega la loro capacità di svernare in bacini aperti e terreni umidi, mantenendo pienamente la virulenza.
Epidemiologia della leptospirosi
La leptospirosi è una delle malattie infettive focali naturali più comuni. La fonte dell'agente infettivo sono gli animali selvatici, da fattoria e domestici. Il ruolo di alcune specie animali come fonte
L'infezione da leptospirosi è tutt'altro che la stessa a causa dei diversi gradi di sensibilità a questi microrganismi e della natura della risposta all'infezione. Gli animali in cui, a seguito dell'infezione, si verifica un processo cronico e, in alcuni casi, asintomatico, accompagnato da una prolungata escrezione di leptospira nelle urine, hanno il maggiore significato epidemiologico ed epizootologico. Sono questi animali che garantiscono la conservazione della Leptospira come specie biologica. La massima importanza nei focolai naturali di leptospirosi è assegnata ai rappresentanti dell'ordine dei roditori, nonché agli insettivori (ricci, toporagni). La trasmissione della Leptospira è stata dimostrata in quasi 60 specie di roditori, di cui 53 appartengono alla famiglia dei topi e dei criceti.
La plasticità biologica delle Leptospire consente di adattarle agli animali agricoli e domestici (bovini, maiali, cavalli, cani), nonché ai roditori sinantropici (ratti grigi, topi),
che costituiscono focolai di infezione antropourgica, rappresentando il principale pericolo per l'uomo (Fig. 17-3).
Da un punto di vista epidemiologico, l'incidenza delle malattie nei bovini grandi e piccoli, nonché nei suini, è importante. Sono colpiti animali di qualsiasi età, ma negli adulti la leptospirosi si manifesta più spesso in forma latente e negli animali giovani in una forma più pronunciata.
nuovi sintomi.
Gli esseri umani non sono importanti come fonte di infezione.
Il fattore principale nella trasmissione dell'agente eziologico della leptospirosi è l'acqua contaminata con secrezioni (urina) di animali infetti. Le cause immediate dell'infezione nelle persone sono bere acqua non depurata, lavarsi da specchi d'acqua aperti, nuotare in piccoli stagni a basso flusso o guadarli.
Anche i prodotti alimentari contaminati con secrezioni di roditori svolgono un ruolo nella trasmissione dell’infezione. La trasmissione dell'infezione avviene nella maggior parte dei casi attraverso il contatto, ma è possibile anche la via alimentare. I fattori di trasmissione includono
terreno umido, erba da pascolo, contaminata da escrementi di animali malati. L'infezione può verificarsi durante la macellazione del bestiame, il taglio delle carcasse, nonché attraverso il consumo di latte e carne non riscaldata. La leptospirosi colpisce spesso le persone che hanno contatti professionali con animali malati: veterinari, specialisti della disinfestazione e lavoratori agricoli.
Perché la Leptospira possa penetrare è sufficiente la minima violazione dell'integrità della pelle.
Le epidemie di leptospirosi sono solitamente limitate al periodo estivo-autunnale. Il picco di incidenza si verifica nel mese di agosto. Esistono tre tipi principali di epidemie: acquatiche, agricole e zootecniche.
La leptospirosi si manifesta anche in casi sporadici, che possono essere registrati durante tutto l'anno.
Le leptospira sono idrofile, quindi la leptospirosi è caratterizzata da un'elevata prevalenza nelle aree dove sono presenti molte pianure paludose e fortemente umide.
Nella Federazione Russa, la leptospirosi è considerata una delle zoonosi più comuni, l'incidenza è di 0,9–1,5 ogni 100mila abitanti. L'incidenza è più alta nel Caucaso nordoccidentale, centrale e, soprattutto, settentrionale
regioni. Negli ultimi anni è stata notata una chiara tendenza all'urbanizzazione della morbilità - distribuzione nelle megalopoli (Mosca, San Pietroburgo).
La predisposizione naturale degli esseri umani all’infezione da leptospirosi è significativa. L'immunità post-infettiva è forte, ma specifica per tipo, quindi sono possibili malattie ricorrenti causate da altri sierotipi dell'agente patogeno.
Misure per prevenire la leptospirosi
Non specifico
La prevenzione viene effettuata congiuntamente dagli organi di Rospotrebnadzor e dal servizio veterinario. Identificano e curano gli animali di valore, effettuano regolarmente il controllo dei roditori nelle aree popolate, proteggono i corpi idrici dalla contaminazione da escrementi animali, vietano il nuoto in corpi idrici stagnanti, disinfettano l'acqua da fonti d'acqua libere e combattono i cani randagi.
Specifica
Viene effettuata la vaccinazione degli animali da allevamento e dei cani, nonché la vaccinazione di routine delle persone il cui lavoro è associato al rischio di contrarre la leptospirosi: lavoratori di allevamenti di bestiame, zoo, negozi di animali, canili,
allevamenti di animali da pelliccia, imprese per la lavorazione di materie prime zootecniche, dipendenti di laboratorio che lavorano con colture di Leptospira. Il vaccino per la prevenzione della leptospirosi viene somministrato dall'età di 7 anni alla dose di 0,5 ml per via sottocutanea una volta, rivaccinazione dopo un anno.
Patogenesi della leptospirosi
L'agente patogeno penetra nel corpo umano grazie alla sua mobilità.
Le porte d'ingresso sono microdanni alla pelle e alle mucose del cavo orale, dell'esofago, della congiuntiva degli occhi, ecc. Sono noti casi di infezione di laboratorio attraverso la pelle danneggiata. Con la penetrazione intradermica in un esperimento su animali da laboratorio, la leptospira penetra nel sangue entro 5-60 minuti, apparentemente aggirando i linfonodi, che non svolgono una funzione di barriera nella leptospirosi. Nel sito di introduzione dell'agente patogeno non si verifica alcun effetto primario. Un'ulteriore diffusione della Leptospira avviene per via ematogena, mentre rimangono intatti anche i vasi linfatici e i linfonodi regionali. Con il flusso sanguigno, le leptospire entrano in vari organi e tessuti: fegato, milza, reni, polmoni, sistema nervoso centrale, dove si moltiplicano e si accumulano. Sviluppando prima fase infezioni che durano da 3 a 8 giorni, che corrisponde al periodo di incubazione.
Seconda fase La patogenesi della leptospirosi è la batteriemia secondaria, quando il numero di leptospire nel sangue raggiunge il massimo e continuano a moltiplicarsi nel fegato e nella milza, nelle ghiandole surrenali, causando l'insorgenza clinica della malattia. Con il flusso sanguigno, le leptospire si distribuiscono nuovamente in tutto il corpo, rompendo anche la BBB. Durante questo periodo, insieme alla riproduzione delle leptospira, inizia la loro distruzione a seguito della comparsa di anticorpi che si agglutinano entro il quarto giorno della malattia e liscono la leptospira. L'accumulo di prodotti metabolici e la disgregazione della leptospira nel corpo sono accompagnati da febbre e intossicazione, che aumentano la sensibilizzazione del corpo e provocano reazioni iperergiche.
Questa fase dura 1 settimana, ma può essere ridotta a diversi giorni. La concentrazione massima di leptospira verso la fine della fase di leptospiremia si osserva nel fegato. La Leptospira produce emolisina che, influenzando la membrana dei globuli rossi, provoca la loro emolisi e il rilascio di bilirubina libera. Inoltre, nel fegato si sviluppano cambiamenti distruttivi con la formazione di infiammazione ed edema tissutale. Nei casi gravi della malattia, il fattore principale nel processo patologico nel fegato è il danno alle membrane dei capillari sanguigni, che spiega la presenza di emorragie ed edema sieroso.
La patogenesi dell'ittero nella leptospirosi è duplice: da un lato, la rottura dei globuli rossi a causa dell'effetto tossico dell'emolisina e dell'antigene emolitico sulle membrane, nonché a seguito dell'eritrofagia da parte delle cellule del sistema reticoloendoteliale in la milza, il fegato e altri organi, invece, a causa dello sviluppo di un'infiammazione parenchimale con interruzione della formazione della bile e della funzione escretoria del fegato.
Terza fase patogenesi della leptospirosi - tossico. Le leptospira muoiono a causa dell'effetto battericida del sangue e dell'accumulo di anticorpi, scompaiono dal sangue e si accumulano nei tubuli contorti dei reni. La tossina accumulata a causa della morte della Leptospira ha un effetto tossico su vari organi e sistemi. In alcuni pazienti, la Leptospira si moltiplica nei tubuli contorti e viene escreta dal corpo attraverso le urine. In questo caso, viene alla ribalta il danno renale. Il danno renale più caratteristico della leptospirosi è un processo degenerativo nell'epitelio dell'apparato tubulare, quindi è più corretto considerarlo come una nefrosi tubulare distale diffusa. I pazienti sviluppano segni di insufficienza renale acuta con oligoanuria e coma uremico. Un grave danno renale è una delle cause di morte più comuni nella leptospirosi.
Nella fase di tossiemia, il danno agli organi e ai tessuti è causato dall'azione non solo delle tossine e dei prodotti di scarto della Leptospira, ma anche degli autoanticorpi formati a seguito della rottura dei tessuti e delle cellule colpite del macroorganismo. Questo periodo coincide con la seconda settimana di malattia, ma può essere leggermente ritardato. La tossina ha un effetto dannoso sull'endotelio dei capillari, che aumenta la loro permeabilità con la formazione di coaguli di sangue e lo sviluppo della sindrome da coagulazione intravascolare disseminata.
Il sistema nervoso centrale è interessato a causa della penetrazione della BBB da parte della leptospira. Alcuni pazienti sviluppano meningite sierosa o purulenta, meno comunemente meningoencefalite.
In alcuni casi si verifica una miocardite specifica da leptospirosi.
Il sintomo patognomonico della leptospirosi è lo sviluppo della miosite con danni allo scheletro, in particolare ai muscoli del polpaccio. Sono spesso colpiti i polmoni (polmonite da leptospirosi), gli occhi (irite, iridociclite) e, meno spesso, altri organi.
Quadro clinico della leptospirosi
Il periodo di incubazione dura da 3 a 30 (solitamente 7-10) giorni.
Classificazione
Non esiste una classificazione generalmente accettata della leptospirosi.
Secondo il decorso clinico, esistono forme lievi, moderate e gravi di leptospirosi. Una forma lieve può manifestarsi con febbre, ma senza danni significativi agli organi interni. La forma moderata è caratterizzata da febbre grave e un quadro clinico dettagliato di leptospirosi, mentre la forma grave è caratterizzata dallo sviluppo di ittero, comparsa di segni di sindrome tromboemorragica, meningite e insufficienza renale acuta. Secondo le manifestazioni cliniche si distinguono le forme itterica, emorragica, renale, meningea e mista. La leptospirosi può essere complicata o non complicata.
Principali sintomi e dinamiche del loro sviluppo
La malattia esordisce in modo acuto, senza periodo prodromico, con forti brividi e un aumento della temperatura corporea fino a valori elevati (39-40 °C) entro 1-2 giorni.
La temperatura rimane elevata per 6-10 giorni, poi diminuisce in modo critico o per lisi abbreviata. Nei pazienti che non hanno ricevuto antibiotici si può osservare una seconda ondata febbrile. Si verificano anche altri sintomi di intossicazione, come forte mal di testa, lombalgia, debolezza, mancanza di appetito, sete, nausea e talvolta vomito. Durante questo periodo può svilupparsi anche la congiuntivite.
Un segno caratteristico della leptospirosi è il dolore ai muscoli, principalmente ai muscoli del polpaccio, ma può verificarsi dolore ai muscoli della coscia e della regione lombare. Nelle forme gravi, il dolore è così forte da rendere difficile il movimento del paziente. Alla palpazione si nota un forte dolore muscolare. L'intensità della mialgia corrisponde spesso alla gravità della malattia. La miolisi porta allo sviluppo della mioglobinemia, che è una delle cause dell'insufficienza renale acuta. In alcuni pazienti, la mialgia è accompagnata da iperestesia cutanea. Degni di nota sono l'iperemia della pelle del viso e del collo e l'iniezione dei vasi sclerali. All'esame, viene rivelato un "sintomo del cappuccio": gonfiore del viso e iperemia della pelle del viso, del collo e della metà superiore del torace, iniezione di vasi sclerali.__
Nei casi gravi di leptospirosi, a partire dal 4°-5° giorno di malattia, si manifestano ittero della sclera e ittero della pelle. Il decorso clinico può essere schematicamente suddiviso in tre periodi:
- elementare;
- altezza;
- recupero.
Nel 30% dei pazienti l'esantema si verifica nella fase iniziale e talvolta nel culmine della malattia. L'eruzione cutanea è costituita da elementi polimorfici localizzati sulla pelle del tronco e degli arti. La natura dell'eruzione cutanea può essere simile al morbillo, alla rosolia o, meno spesso, alla scarlatta. Possono verificarsi anche elementi orticarioidi.
L'eruzione maculare tende a fondere i singoli elementi. In questi casi si formano campi eritematosi. L'esantema eritematoso è il più comune; l'eruzione cutanea scompare dopo 1-2 giorni. Dopo la scomparsa dell'eruzione cutanea, è possibile la desquamazione della pelle simile alla pitiriasi. Spesso compaiono eruzioni erpetiche (sulle labbra, sulle ali del naso). La sindrome tromboemorragica si manifesta, oltre all'eruzione petecchiale, con emorragie cutanee nei siti di iniezione, sangue dal naso,
emorragie nella sclera.
Durante questo periodo sono possibili un leggero mal di gola e tosse. Un esame obiettivo rivela spesso una moderata iperemia delle arcate, delle tonsille e del palato molle, su cui si possono osservare enantemi ed emorragie.
In alcuni pazienti, i linfonodi sottomandibolari e cervicali posteriori sono ingranditi.
Dal sistema cardiovascolare, la relativa bradicardia e una diminuzione della pressione sanguigna attirano l'attenzione. I suoni cardiaci sono ovattati e l'ECG può rilevare segni di danno miocardico diffuso. È possibile lo sviluppo di polmonite o bronchite specifica da leptospirosi. Quando si verifica, si osserva ottusità del suono polmonare e dolore al petto. Il fegato è ingrossato, moderatamente doloroso alla palpazione e in quasi la metà dei pazienti è palpabile la milza.
I segni di danno al sistema nervoso centrale nella leptospirosi sono la sindrome meningea: vertigini, delirio, insonnia, mal di testa e sintomi meningei positivi (torcicollo; sintomo di Kernig; sintomi di Brudzinski superiore, medio e inferiore). Quando si esamina il liquido cerebrospinale, si notano segni di meningite sierosa: citosi con predominanza di neutrofili.
Dal sistema urinario si possono osservare segni di insufficienza renale acuta: diminuzione della diuresi fino allo sviluppo di oligoanuria, comparsa di cilindri proteici, ialini e granulari e di epitelio renale nelle urine. Il contenuto ematico di potassio, urea e creatinina aumenta. Quando si esamina il sangue periferico, si determina un aumento della VES e della leucocitosi neutrofila con uno spostamento della formula a sinistra, spesso verso i mielociti e l'aneosinofilia.
Al culmine della malattia, dal 5° al 6° giorno nei casi più gravi, l'intossicazione aumenta, il mal di testa e la debolezza muscolare si intensificano, appare l'avversione al cibo, il vomito diventa più frequente, anche se la temperatura corporea diminuisce. Alcuni pazienti manifestano ittero, la cui intensità corrisponde alla gravità della malattia e dura da alcuni giorni a diverse settimane. Durante questo periodo si osservano le manifestazioni più gravi della sindrome emorragica: emorragie nella pelle e nelle mucose, sanguinamento dalle gengive, sanguinamento gastrointestinale, emottisi, emorragie nelle membrane e nella sostanza del cervello. Più spesso, la sindrome emorragica si osserva nella forma itterica della malattia. Compaiono segni clinici ed ECG di danno al cuore e alle meningi. Il danno renale merita un'attenzione speciale: aumento dell'azotemia, proteinuria.
A causa di emolisi e alterazione dell'eritropoiesi, anemia iporigenerativa, trombocitopenia, leucocitosi, aumento della linfopenia, compromissione della capacità di aggregazione piastrinica, la VES raggiunge 40–60 mm/h. Un esame del sangue biochimico rivela una moderata iperbilirubinemia con un aumento del contenuto di bilirubina sia legata che libera con un leggero aumento dell'attività della transferasi. Allo stesso tempo, a causa del danno muscolare, l'attività della creatina fosfochinasi aumenta notevolmente, la funzione sintetica proteica del fegato viene interrotta e il livello di albumina diminuisce.
La condizione comincia a migliorare dalla fine della seconda settimana, il periodo di convalescenza va dal 20 al 25 giorno di malattia. Durante questo periodo è possibile una ricaduta della malattia, che di solito procede più facilmente dell'ondata principale. In altri casi, la temperatura corporea
si normalizza persistentemente, ma la sindrome astenica persiste a lungo ed è possibile una crisi poliurica. Le funzioni del fegato e soprattutto dei reni vengono ripristinate lentamente; l'insufficienza della funzione tubulare persiste per lungo tempo, che si manifesta con isoipostenuria e proteinuria; Sono possibili disturbi trofici e un aumento dell'anemia.
In diverse regioni, il decorso può differire nella frequenza delle forme itteriche, nel danno al sistema nervoso centrale e nello sviluppo di insufficienza renale acuta. La forma più grave di leptospirosi è causata da l. interroganti itteroemorragie. Sono comuni le forme abortive e cancellate della malattia, che si verificano con febbre a breve termine (2-3 giorni) senza patologia d'organo tipica.
Complicanze della leptospirosi
ITS, insufficienza renale acuta, insufficienza renale acuta, insufficienza renale acuta (RDS), sanguinamento massiccio, emorragia, miocardite, polmonite, negli stadi successivi - uveite, irite, iridociclite.
Mortalità e cause di morte
La mortalità varia dall'1 al 3%. Le cause della morte sono le complicazioni sopra menzionate, molto spesso l'insufficienza renale acuta.
Diagnosi di leptospirosi
Clinico
L'anamnesi epidemiologica gioca un ruolo importante nella diagnosi della leptospirosi. Dovrebbe essere presa in considerazione la professione del paziente (lavoratore agricolo, cacciatore, veterinario, disinfestatore), nonché il contatto con animali selvatici e domestici. Si dovrebbe prestare attenzione al fatto che il paziente abbia nuotato in acque libere, poiché la contaminazione dell'acqua da parte della leptospira in alcune regioni è estremamente elevata.
La diagnosi di leptospirosi viene stabilita sulla base di sintomi clinici caratteristici: esordio acuto, ipertermia, mialgia, rossore al viso, danno combinato al fegato e ai reni, sindrome emorragica, alterazioni infiammatorie acute nel sangue.
Diagnostica di laboratorio specifica e non specifica
La conferma di laboratorio della diagnosi si ottiene attraverso studi batterioscopici, batteriologici, biologici e sierologici. Nei primi giorni della malattia, le leptospire vengono rilevate nel sangue mediante microscopia a campo oscuro e successivamente nel sedimento urinario o nel liquido cerebrospinale.
Quando si coltiva sangue, urina o liquido cerebrospinale su terreni di coltura contenenti siero sanguigno, è possibile ottenere risultati più affidabili, anche se questo metodo richiede tempo, poiché, come già accennato, la leptospira cresce piuttosto lentamente.
Si consiglia di conservare le colture primarie di sangue, urina e tessuti di organi sospettati di contenere leptospira per i primi 5–6 giorni a una temperatura di 37 °C, quindi a 28–30 °C.__ Il metodo biologico consiste nell'infettare gli animali : topi, criceti e porcellini d'India, però recentemente questo metodo ha avuto molti oppositori che lo considerano disumano.
I più informativi sono i metodi sierologici, in particolare il test di microagglutinazione raccomandato dall'OMS. Un aumento del titolo anticorpale pari o superiore a 1:100 è considerato positivo. Viene utilizzato anche RAL Leptospira nella modifica olandese. Gli anticorpi compaiono tardivamente, non prima dell'8°-10° giorno di malattia, per cui è consigliabile esaminare sieri accoppiati prelevati ad intervalli di 7-10 giorni.
Trattamento della leptospirosi
Modalità. Dieta
Il trattamento viene effettuato in ambiente ospedaliero. Il ricovero viene effettuato secondo indicazioni epidemiologiche. Nel periodo acuto, riposo a letto. La dieta è determinata dalle caratteristiche cliniche della malattia. Se la sindrome renale è dominante - tabella n. 7, epatica - tabella n. 5, con lesioni combinate - tabella n. 5 con restrizione di sale o tabella n. 7 con restrizione di grasso.
Terapia farmacologica
Il principale metodo di trattamento è la terapia antibatterica, che spesso viene effettuata con penicillina alla dose di 4-6 milioni di unità/giorno o ampicillina alla dose di 4 g/giorno. Se si è intolleranti alla penicillina, si prescrive la doxiciclina alla dose di 0,1 g due volte al giorno, il cloramfenicolo alla dose di 50 mg/kg al giorno. Se è interessato il sistema nervoso centrale, la dose di penicillina viene aumentata a 12-18 milioni di unità/die, la dose di ampicillina viene aumentata a 12 g/die e il cloramfenicolo viene aumentato a 80-100 mg/kg al giorno.
La durata della terapia antibiotica è di 5-10 giorni.
In caso di insufficienza renale acuta nella fase iniziale, quando la quantità giornaliera di urina diminuisce, vengono somministrati per via endovenosa diuretici osmotici (300 ml di soluzione di mannitolo al 15%, 500 ml di soluzione di glucosio al 20%), 200 ml di soluzione di bicarbonato di sodio al 4% al giorno in due dosi. Nello stadio anurico vengono somministrate grandi dosi di saluretici (fino a 800-1000 mg/die di furosemide), steroidi anabolizzanti (methandienone 0,005 g 2-3 volte/die), 0,1 g/die di testosterone.
Per la ITS, al paziente viene somministrato per via endovenosa prednisolone a una dose massima di 10 mg/kg al giorno, dopamina secondo un regime individuale, quindi in sequenza per via endovenosa 2–2,5 l di una soluzione come Trisol♠ o Quintasol♠, 1–1,5 l di una miscela polarizzante (soluzione di glucosio al 5%, 12–15 g di cloruro di potassio, 10–12 unità di insulina). Le soluzioni saline vengono prima somministrate in un flusso, quindi passano alla somministrazione a goccia (quando compaiono polso e pressione sanguigna). Quando si sviluppa DIC, vengono utilizzati plasma fresco congelato, pentossifillina, eparina sodica e inibitori della proteasi.
Indicazioni per l'emodialisi
- Anuria di due o tre giorni.
- Azotemia
Viene utilizzata l'ossigenoterapia iperbarica. Per la sindrome emorragica grave vengono prescritti 40-60 mg/die di prednisolone per via orale o 180-240 mg/die per via endovenosa. Vengono prescritti anche un trattamento sintomatico e un complesso di vitamine.
LEPTOSPIROSI
La leptospirosi è una malattia infettiva acuta del gruppo zoonotico, causata dalla Leptospira, con danni predominanti ai reni e al fegato, al sistema cardiovascolare e nervoso. Le malattie precedentemente identificate isolatamente a seconda del sierotipo della Leptospira sono considerate varianti cliniche di una forma nosologica
Eziologia. La leptospira è una cellula allungata, a forma di cavatappi, poco resistente alle condizioni ambientali sfavorevoli e l'agente patogeno presenta diverse forme. La maggior parte delle epidemie sono associate a leptospira icterohemorrhagica, canicola, pomona, influenpotyphos, hebdomadis e, meno spesso, ad altre numerose forme di leptospira. Le fonti più comuni di infezione nell’uomo sono il bestiame, i roditori, i cani e l’acqua. Il principale serbatoio dell'agente patogeno, soprattutto nelle città, sono i ratti, che con le loro secrezioni inquinano l'ambiente e le acque. La circolazione dell'agente patogeno tra i ratti è possibile quando le acque reflue o le fonti d'acqua sono contaminate. I prodotti alimentari possono diventare un fattore di trasmissione di agenti infettivi solo se sono intensamente infestati da ratti.
Negli ultimi decenni sono stati osservati cambiamenti nella struttura eziologica della leptospirosi. Se negli anni del dopoguerra nella SSR ucraina prevalevano agenti patogeni come l’influenza potifoide e la pomona, associati a focolai idrici causati da infezioni di origine agricola e selvaggio animali, poi negli ultimi anni il fattore principale è diventato la leptospirosi itteroemorragica, che ha portato ad un notevole aumento delle forme cliniche gravi con elevata mortalità.
Epidemiologia. La leptospirosi è comune in tutti i continenti. La maggior parte delle malattie sono legate al fattore acqua: nuoto nei fiumi, stagni, laghi e pesca. Questo spiega la stagionalità estiva, particolarmente pronunciata durante le giornate calde. Ma anche in inverno si verificano casi di infezione umana a seguito del contatto con roditori negli allevamenti di bestiame, nelle fabbriche alimentari, nei negozi di alimentari e nelle case abitate da roditori. L'infezione può verificarsi durante la caccia al topo muschiato o durante la cura della nutria in condizioni di allevamento domestico. L’incidenza rimane elevata tra alcuni gruppi coinvolti nella cura di animali malati (veterinari, specialisti del bestiame, mungitrici, allevatori di suini), nella macellazione del bestiame negli impianti di lavorazione della carne e nel lavoro nelle miniere dove sono presenti roditori.
Particolarmente convincenti sono i casi di malattia in persone in cui, in presenza di abrasioni cutanee, graffi, tagli, abrasioni, i primi sintomi di leptospirosi sono comparsi pochi giorni dopo aver nuotato in un fiume o in un bacino con acqua stagnante. Il fattore idrico dell'infezione, che può essere considerato il principale, ci consente di considerare la leptospirosi come una malattia dell'acqua sporca. Le malattie collettive, in particolare le forme anitteriche, sono spesso associate al lavoro agricolo nei campi. Da qui i nomi di tali febbri: "prato", "acqua", "falciatura".
Patogenesi. La Leptospira penetra nel corpo umano attraverso le mucose dell'apparato digerente, della congiuntiva e della pelle, senza lasciare alterazioni infiammatorie nel sito di penetrazione. Anche danni invisibili. graffi e abrasioni possono diventare porte di infezione. Una volta nel corpo, le leptospire vengono trasportate dal sangue e dalla linfa negli organi ricchi di tessuto reticoloendoteliale, principalmente fegato, reni e milza. Qui si moltiplicano rapidamente. La leptospiremia raggiunge il suo pieno sviluppo entro il 3-5° giorno di malattia. Durante questo periodo di generalizzazione dei sintomi clinici, le leptospire possono essere rilevate nel sangue, così come nel liquido cerebrospinale, dove entrano dopo aver rotto la barriera ematoencefalica. L'accumulo dei prodotti di degradazione della Leptospira nel sangue porta alla sensibilizzazione del corpo e alla comparsa di reazioni iperergiche. Il fattore patogenetico più importante è il danno ai capillari sanguigni. Un aumento della loro permeabilità si manifesta clinicamente con la sindrome emorragica. Viene alla ribalta nel quadro delle alterazioni patologiche degli organi interni sotto forma di estese emorragie nei reni, nel fegato, nella milza, nelle ghiandole surrenali e nell'apparato digerente. All'origine delle emorragie sono di grande importanza la trombocitopenia e la diminuzione della coagulazione del sangue. Il processo infiammatorio negli epatociti è spesso accompagnato da ittero. I processi autoimmuni prendono parte allo sviluppo della malattia.
Sotto l'influenza di anticorpi specifici, la leptospira scompare dal sangue entro la fine della 1a settimana di malattia. Il loro ulteriore accumulo intensivo avviene nei reni. Il danno ai tubuli contorti porta a disturbi della minzione, inclusa l'uremia, la principale causa di morte. Dopo una malattia si forma un'immunità attiva forte e duratura.
Clinica differisce in una diversità significativa: da uno stato febbrile a breve termine a forme estremamente gravi che terminano con la morte. La durata del periodo di incubazione va dai 3 ai 14 giorni, in alcuni casi questo periodo può essere ridotto a 2 giorni. A volte, ad esempio, quando si nuota una volta in uno stagno, il periodo di incubazione può essere determinato con la massima precisione. Solo raramente si verifica uno sviluppo graduale sotto forma di malessere e debolezza. Nella maggior parte dei casi la malattia inizia in modo acuto con brividi e febbre. La temperatura sale fino a 39-40 °C, è di natura remittente, dura 5-8 giorni e poi diminuisce in modo critico o come lisi accelerata e successivamente può verificarsi una seconda ondata febbrile più breve: la malattia recidiva. Man mano che si sviluppa la leptospiremia, l'intossicazione aumenta: l'appetito scompare, compaiono nausea, vomito, mal di testa, talvolta delirio e perdita di coscienza. I pazienti possono rimanere immobili. Il minimo sforzo è associato a una mialgaia diffusa. Particolarmente preoccupante è il dolore ai muscoli del polpaccio, talvolta espresso a tal punto che i pazienti hanno difficoltà a muoversi e a restare in piedi. A volte può non esserci dolore ed è possibile la sindrome addominale associata a danni ai muscoli addominali.
L'aspetto del paziente è caratteristico: iperemia e gonfiore del viso, iniezione pronunciata dei vasi sclerali, fino alle emorragie sotto la congiuntiva. Può comparire precocemente un rash effimero roseolo-papuloso che, nei casi più gravi, assume carattere petecchiale. Non sono rari gli eruzioni cutanee erpetiche sulle labbra, sulle ali del naso e l'enantema della mucosa della faringe. Le manifestazioni emorragiche sono tipiche: sangue dal naso, vomito sotto forma di fondi di caffè, ematuria. Nei siti delle iniezioni endovenose rimangono estesi lividi. I cambiamenti nei polmoni vanno da lievi sintomi catarrali alla polmonite emorragica. Si notano suoni cardiaci ovattati e sordi e soffio sistolico all'apice. Il polso è lento, sono possibili tachicardia e aritmie, si determina una tendenza all'ipotensione a causa della diminuzione principalmente della pressione diastolica. Sono possibili collassi protratti, shock tossico-infettivo e dispnea. Elettrocardiograficamente si notano cambiamenti nel muscolo cardiaco, una diminuzione della contrattilità funzionale, il fenomeno della miocardite acuta tossico-infettiva, disturbi del ritmo e della conduzione. L'ECG determina alterazioni della parte finale del complesso ventricolare: spostamento verso il basso e deformazione dei segmenti S - T, appiattimento e inversione dell'onda T. Il 3-5o giorno appare un ittero in rapido aumento. La dimensione del fegato aumenta. La milza di solito non può essere palpata. Fin dai primi giorni della malattia compaiono sintomi di danno al sistema nervoso centrale: forte mal di testa, insonnia, letargia o maggiore eccitabilità. Spesso i sintomi neurologici si limitano alla meningite, nei casi più gravi si può sviluppare una meningite sierosa, il liquido cerebrospinale esce in gocce frequenti, trasparenti, talvolta xantocromiche, opalescenti, la malattia procede come una meningite linfocitaria con dissociazione delle cellule proteiche.
Con lo sviluppo della malattia emergono i sintomi del danno renale. La diuresi diminuisce notevolmente, nelle urine compaiono proteine e cilindri, l'azotemia aumenta. La violazione della filtrazione glomerulare e del riassorbimento tubulare porta ad anuria. Un aumento graduale della diuresi indica l'attenuazione della L'oliguria viene sostituita dalla poliuria, la quantità giornaliera di urina escreta può raggiungere 3-4 l, mentre elevati livelli di azoto residuo rimangono per lungo tempo, il che può essere spiegato dall'aumento del flusso di prodotti di azoto dai tessuti nel flusso sanguigno sotto condizioni di un processo infettivo ciclico.La durata totale della malattia è di 3-4 settimane.
In base al principale segno di danno ai singoli organi e sistemi, si possono distinguere le seguenti forme cliniche di leptospirosi: epatorenale, cardiovascolare, polmonare, meningea, addominale
Epatorenale - una delle forme tipiche più comuni: si manifesta l'ittero con sintomi di epatargia e sintomi di insufficienza renale acuta.
Cardiovascolare la forma si manifesta con tachicardia, aritmia e spesso si sviluppa ipotensione, causata da una diminuzione principalmente della pressione diastolica fino allo sviluppo del collasso. Si notano arresto cardiaco improvviso, suoni cardiaci ovattati, soffio sistolico nell'area del cuore e espansione dei suoi confini, labilità del polso, disturbi del ritmo caratteristici della miocardite, disturbi della conduzione
Polmonare la forma è caratterizzata da sintomi catarrali quali dolore respiratorio, talvolta polmonite emorragica, dolore toracico, tachipnea, sangue nell'espettorato, calo della pressione arteriosa.Questa opzione, solitamente estremamente grave, ha un tasso di mortalità particolarmente elevato
Meningeo la forma è accompagnata da un forte mal di testa, rigidità dei muscoli del collo, sintomi positivi di Kernig e Brudzinsky.Quando si esegue una puntura spinale si nota una citosi moderata, reazioni positive di Pandi e Nonne-Apelt
La leptospirosi può essere mascherata dai sintomi di un addome acuto Addominale la forma è caratterizzata da un dolore acuto nella parte superiore dell'addome. La sindrome del dolore ricorda il quadro della colecistite, della colecistopancreatite. La comparsa di ittero e iperleucocitosi in questi casi può portare a una laparotomia non necessaria
La classificazione clinica data è condizionata, poiché le singole opzioni non possono essere considerate isolatamente, non ci sono confini chiari tra loro.Gli stessi segni clinici (ipertermia, mal di testa, ittero, emorragia, insufficienza renale) possono ripetersi in forme separate, ma i principali , il segno principale consente di navigare nella diagnosi differenziale della malattia
Uno studio di laboratorio rivela iperleucocitosi con spostamento dei neutrofili, a volte fino a giovani e mielociti. Il numero di granulociti eosinofili diminuisce quasi sempre, compaiono plasmacellule. La VES per un breve periodo sale a 40-60 mm / h e supera addirittura questi indicatori. si sviluppa anemia. Il contenuto di emoglobina diminuisce notevolmente. , la coagulazione del sangue rallenta, il che è confermato da un coagulogramma. Con lo sviluppo dell'ittero, il contenuto di bilirubina nel sangue raggiunge un livello elevato a causa della frazione diretta e, in misura minore, indiretta. L'attività degli enzimi, in particolare delle aminotransferasi, è moderatamente aumentata o rimane nell'intervallo normale, il che indica più la presenza di un processo infiammatorio che necrotico nel fegato. Un segno diagnosticamente importante è un aumento significativo del livello di azoto residuo, urea, creatinina.Le proteine vengono rilevate nelle urine, compaiono globuli rossi, cellule epiteliali renali e compaiono cilindri.
La leptospirosi grave è caratterizzata da 3 segni principali: anuria, epatargia ed emorragia. Tuttavia, questi sintomi non sono sempre espressi. La malattia può essere di moderata gravità e forma lieve con febbre a breve termine, intossicazione moderata, leggero dolore muscolare. In questi casi , l'ingrossamento del fegato non è accompagnato da ittero, i cambiamenti renali si riducono ad albuminuria e cilindruria a passaggio rapido, i test funzionali del fegato e dei reni sono leggermente disturbati, la diuresi rimane normale.Sono possibili complicazioni: miocardite, endocardite, pancreatite acuta, polineurite, irite, iridociclite, uveite, danno muscolare generalizzato come la polimiosite a lungo termine
Diagnosi differenziale Per riconoscere la leptospirosi è importante l'anamnesi epidemiologica, particolarmente convincenti sono i casi della malattia di persone nelle quali, in presenza di abrasioni, graffi, tagli, i primi sintomi della leptospirosi compaiono 7-12 giorni dopo aver nuotato in un fiume o in un bacino. con acqua stagnante. Le malattie di gruppo sono spesso associate a condizioni professionali, lavoro agricolo. Negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento dell'incidenza della leptospirosi non solo nel periodo estivo, ma anche nel periodo autunno-invernale, che richiede in- una ricerca ambientale approfondita e le necessarie misure preventive.
A volte, in presenza di un quadro clinico tipico, una reazione positiva alla lisi della Leptospira, l'interrogatorio più approfondito del malato non rivela la fonte dell'infezione e in questi casi si pensa alla possibilità di contaminazione del cibo da parte di roditori.
L'elenco diagnostico differenziale, che conta decine di forme nosologiche - epatite virale, sepsi, influenza, polmonite, meningite, colecistopancreatite, febbre emorragica con sindrome renale, trichinosi, malaria, colica epatica e renale, ittero infettivo secondario e altre malattie e condizioni, indica la diversità dei sintomi che un professionista può incontrare nel riconoscere la leptospirosi.
Nonostante il quadro clinico tipico di questa malattia, la sua diagnosi, soprattutto nelle prime fasi, può presentare notevoli difficoltà a causa del polimorfismo dell'infezione, le cui “maschere” frequenti sono la gravità dell'esordio con un forte aumento della temperatura, come nella sepsi o nell'influenza, ittero in rapido aumento, sindrome addominale, che fa pensare alla colecistopancreatite, all'appendicite, ai sintomi meningei - segni che sono ugualmente inerenti a molte malattie infettive e non infettive.
La comparsa relativamente rara di leptospirosi può essere interpretata erroneamente come Epatite virale. L'esordio acuto, l'ipertermia e l'ittero precoce avvicinano la leptospirosi all'epatite virale A. Ma la dinamica successiva dei dati clinici e di laboratorio, la storia epidemiologica (stagionalità autunno-inverno dell'epatite A) rendono relativamente facile distinguerli.
La leptospirosi itteroemorragica è simile nei sintomi all'epatite virale B, che presenta anche ittero e sindrome emorragica. Contrariamente alla leptospirosi a rapido sviluppo con aumento dell'insufficienza renale, aumentano l'albuminuria, l'azotemia e l'iperleucocitosi. L'epatite virale B da VES nella maggior parte dei casi si sviluppa gradualmente, gradualmente, accompagnata da dolore alle articolazioni, aumento delle dimensioni del fegato e della milza, lievi alterazioni dei reni, leucopenia, attività pronunciata degli enzimi sierici, in particolare delle aminotransferasi, e un brusco VES rallentata. A questo dobbiamo aggiungere i dati epidemiologici: manipolazioni parenterali e trasfusioni di sangue nel periodo premorboso, che non è del tutto tipico della leptospirosi.
Le principali caratteristiche diagnostiche differenziali sono riportate nella tabella. 10.
Con un esordio improvviso con febbre alta, mal di testa, stanchezza generale, debolezza, fotofobia, iniezione dei vasi sclerali, malessere, si può sospettare influenza O ORZ. Di grande importanza sono l'anamnesi epidemiologica e l'utilizzo sul campo di acqua proveniente da fonti dubbie. È inoltre necessario tenere conto della stagionalità delle infezioni respiratorie acute; si osservano relativamente raramente in estate e non si limitano a colpire singoli gruppi. Con l'influenza, non c'è dolore severo ai muscoli del polpaccio, di solito non c'è eruzione cutanea, non c'è ittero, manifestazioni emorragiche o segni evidenti di insufficienza renale. La leucocitosi non è tipica, la VES rimane normale
È necessario ricordare meningite sierosa, non così raramente si verificano nelle malattie infettive di varie eziologie. Forte mal di testa, vertigini, rigidità del collo, segno di Kernig positivo, aumento della citosi del liquido cerebrospinale Tutto questi segni possono essere osservati nella leptospirosi, la cui diagnosi finale viene stabilita sulla base dell'anamnesi, della dinamica dei dati clinici di laboratorio e dei risultati di uno studio sierologico
Ci sono casi in cui la leptospirosi, accompagnata da sindrome addominale, ittero e diarrea, è stata erroneamente scambiata per colecistite, colecistopancreatite, salmonellosi
Tabella 10 Criteri diagnostici differenziali per la leptospirosi e l'epatite virale
|
Leptospiroe |
Epatite virale |
|
|
Insorgenza della malattia |
L'acuto è spesso improvviso, senza |
Acuto, soprattutto con l'epatite A, |
|
prodromico pronunciato ne |
lento nell'epatite B |
|
|
Temperatura |
Elevato nel periodo iniziale, |
Ipertermia iniziale con hepa |
|
a volte a due onde |
Tite A, normale con epatite |
|
|
Iniezione sclerale con iperemia facciale |
Espresso chiaramente |
Nessuno |
|
Mialgia, dolore nella necrosi |
I segni sono tipici, ma non necessariamente |
Assente, dolori articolari durante |
|
interessante |
epatite B |
|
|
Emorragico |
Spesso trovato |
Si verifica nei casi gravi di epatite B |
|
Segno precoce |
Appare dopo il periodo prodromico |
|
|
Sindrome epatolienale |
Moderato ingrossamento del fegato, la milza è raramente palpabile |
periodo Nella maggior parte dei casi è chiaramente determinato |
|
Danno renale Attività cardiaca VES |
Oliguria anuria Tachicardia, collassi Aumenta rapidamente dal primo |
Meno tipica Bradicardia, ipotensione Normale o lenta |
|
giorni di malattia |
||
|
Leucocitosi |
Espresso con neutrofili |
Leucopenia, neutropenia |
|
Attività residua dell'azoto aminotransferasi nel sangue |
Aumentato Normale o leggermente più debole |
Indicatori normali Notevolmente aumentato dai primi giorni |
|
Albuminuria, qi |
Tipicamente osservato |
Di solito assente |
|
Lindruria |
||
|
Reazione di microagglutinazione |
Positivo in crescita |
Negativo |
|
nazioni con leptospira |
||
|
Antigenemia |
Assente |
Rilevato nell'epatite B |
Uno stato febbrile come una delle manifestazioni della leptospirosi può essere confuso malattia tifo-paratifo. La leptospirosi inizia in modo acuto, la febbre tifoide e la febbre paratifoide gradualmente. I pazienti affetti da tifo sono apatici, sonnolenti, hanno il viso pallido, un'eruzione cutanea rosea e una milza ingrossata. I pazienti affetti da leptospirosi sono generalmente eccitati, il viso è iperemico, gonfio, l'iniezione dei vasi sclerali è pronunciata, predominano i sintomi di danno renale, azotemia, albuminuria.I test sierologici (emocoltura, test di Widal, reazione di microagglutinazione) aiutano nel riconoscimento.Insorgenza acuta, l'ipertermia può diventare una ragione per la diagnosi differenziale della leptospirosi nel tifo di massa, in cui i pazienti lamentano un forte mal di testa e insonnia; si osservano iperemia e gonfiore del viso, l'iniezione cancella tremori alle mani, appare un'eruzione cutanea roseola, che si trasforma gradualmente in petecchiale. Di grande importanza sono l’anamnesi epidemiologica e i risultati degli studi sierologici.
La leptospirosi è stata ripetutamente diagnosticata febbre emorragica con sindrome renale a causa di somiglianze come insorgenza improvvisa con brividi e ipertermia, mialgia diffusa, danni renali, manifestazioni emorragiche, iniezione di vasi sclerali, emorragie sotto la congiuntiva. Ma con la leptospirosi non c'è dolore acuto nella parte bassa della schiena, il sintomo di Pasternatsky è negativo, la densità relativa dell'urina è normale e con la nefrosonefrite emorragica diminuisce bruscamente a 1002-1003, e talvolta alla densità relativa dell'acqua.
La leptospirosi deve essere differenziata dalla sepsi, che è caratterizzata da esordio acuto, ipertermia, emorragie, sindrome epatorenale, ittero secondario, iperleucocitosi e aumento della VES. Tutti questi segni sono possibili con la leptospirosi. La diagnosi finale viene stabilita tenendo conto dei fattori ambientali, dei prerequisiti epidemiologici, della fonte di possibile infezione endogena (tromboflebite, polmonite, endocardite, stafiloderma), della dinamica dei sintomi clinici e dei risultati di laboratorio.
Numerosi segni clinici e di laboratorio avvicinano la leptospirosi meningococcemia, nella forma fulminante si osservano un'insorgenza improvvisa e un rapido sviluppo della malattia, mialgia diffusa, insufficienza renale acuta, sindrome emorragica, iperleucocitosi e aumento della VES. Ma a differenza della leptospirosi, la meningococcemia è caratterizzata da un'abbondante eruzione cutanea a forma di stella con necrosi superficiale dell'epitelio, manifestazioni meningee, talvolta perdita di memoria, perdita di coscienza e assenza di ittero; l'esame microscopico di uno striscio e di una spessa goccia di sangue rivela il meningococco. Una diagnosi corretta tempestiva e immediata determina in gran parte l'esito della malattia.
Molto spesso, con la leptospirosi, l'eruzione cutanea diventa maculare ( macchiato) carattere. L'elemento di tale eruzione cutanea è la macula, un punto che è a filo con la pelle, cioè non sporge sopra la sua superficie. La dimensione delle macchie varia da 1 a 5 centimetri. Questi punti tendono a fondersi. Quando si uniscono, formano grandi campi eritematosi. Con la sindrome emorragica grave si osserva un'eruzione petecchiale. Un elemento di tale eruzione cutanea sono le petecchie: una piccola emorragia nella pelle. Molto spesso l'eruzione cutanea è accompagnata da eruzioni erpetiche sulle ali del naso e delle labbra.
Lo sviluppo di eruzioni cutanee ed emorragie nella leptospirosi è spiegato dal danno vascolare. I fattori di patogenicità della Leptospira sono diretti principalmente alla rete di vasi sanguigni. Pertanto, l'endotossina della Leptospira ha un effetto distruttivo diretto sull'epitelio vascolare. Allo stesso tempo, fattori come l’emolisina e la fibrinolisina fluidificano il sangue. Pertanto, attraverso i difetti della parete vascolare, si verifica sanguinamento e si formano piccole emorragie. Quanto più grandi sono i difetti nei vasi, tanto maggiori sono le emorragie.
Emorragie congiuntivali, sangue dal naso
Le emorragie nella congiuntiva, nella sclera e in altre mucose compaiono al 5°-6° giorno della malattia. Il loro aspetto è anche associato a una violazione dell'integrità dei vasi sanguigni. Le tossine della Leptospira colpiscono principalmente i piccoli vasi dell'occhio, vale a dire la congiuntiva. Il sangue dal naso si osserva nelle forme più gravi. Sono associati non solo ad una maggiore permeabilità vascolare, ma anche alla fluidificazione del sangue.
Le emorragie si verificano non solo nella congiuntiva o nella sclera, ma anche in numerosi organi interni. Tuttavia, tali emorragie non sono visibili e si manifestano solo con l'interruzione del funzionamento di questi organi. La loro presenza è confermata anche dall'autopsia patomorfologica. Le statistiche delle autopsie di pazienti morti di leptospirosi indicano che le emorragie si osservano più spesso nei reni, nel cuore e nel fegato.
Ittero
L'ittero è una colorazione giallastra della pelle e delle mucose. La tonalità del giallo può essere molto varia: dal giallo brillante al marrone scuro. La colorazione itterica della pelle è accompagnata da ingrossamento e dolorabilità del fegato, nonché da altri sintomi associati al danno al tessuto epatico.A seconda della presenza di questo sintomo, si distinguono due forme di leptospirosi: itterica e anicterica. Nella forma itterica si verificano gravi danni al fegato. Lo sviluppo dell'ittero è causato sia da processi distruttivi nel tessuto epatico sia da una maggiore distruzione ( emolisi) globuli rossi. Lo sviluppo di un colore caratteristico è dovuto ad un'aumentata concentrazione di bilirubina nel sangue. La bilirubina è un pigmento biliare il cui colore dipende dalla sua forma. Normalmente si trova in una certa quantità nel sangue. Quando la sua concentrazione aumenta, i tessuti diventano gialli. L’aumento della concentrazione di bilirubina è causato dal danno agli epatociti ( cellule del fegato) e il rilascio di bile da essi. Questo sintomo si sviluppa anche a causa di una maggiore degradazione dei globuli rossi. I globuli rossi contengono molecole di eme ( complesso di ferro), che sono i precursori della bilirubina. Pertanto, quando i globuli rossi vengono distrutti ( globuli rossi) da essi fuoriescono componenti della bilirubina che provocano anche una colorazione itterica della pelle.
Tipicamente, l’ittero si sviluppa durante la prima settimana di malattia e progredisce molto rapidamente. Il colore della pelle diventa rapidamente giallo, a volte acquisendo una tinta zafferano. Vale la pena notare che l’intensità del colore dipende dalla carnagione iniziale del paziente. Più chiara è la pelle del paziente, più luminoso risulterà il colore giallo. L'ittero si sviluppa spesso con una grave sindrome emorragica. In questo caso, sullo sfondo della pelle giallastra, compaiono emorragie inizialmente piccole e poi sempre più grandi.
Nei giorni 10-15, il dolore al fegato aumenta e il paziente avverte dolore nell'ipocondrio destro. Il dolore è causato da un aumento del volume del fegato ( a causa della degenerazione grassa) e stiramento della capsula epatica. La capsula epatica è rappresentata da una densa membrana fibrosa, nella quale sono penetrate numerose terminazioni nervose. Quando si sviluppa l’ittero, il fegato si ingrandisce ed esercita pressione sulla capsula, provocando dolore.
L'ittero è accompagnato dallo sviluppo non solo di sintomi oggettivi, ma anche di una serie di segni di laboratorio. Pertanto, è accompagnato da un aumento del livello di bilirubina, enzimi epatici e altri indicatori.
Danni agli organi interni
Quando le leptospire entrano nel corpo umano, vengono trasportate attraverso il flusso sanguigno e linfatico a tutti gli organi e sistemi.La leptospirosi colpisce più spesso:
- reni;
- fegato;
- cuore;
- cervello e le sue membrane.
Il danno al sistema cardiovascolare si manifesta con una diminuzione della pressione sanguigna, polso aritmico e sviluppo di blocchi. L'elettrocardiogramma mostra segni di distrofia cardiaca, disturbi del ritmo e della conduzione.
Il danno al cervello e alle sue membrane si manifesta con lo sviluppo di meningite e meningoencefalite. Questi sintomi si verificano nel 20-30% dei pazienti e sono associati alla penetrazione della Leptospira attraverso la barriera ematoencefalica. In questo caso, il paziente soffre di un forte mal di testa e di vomito incontrollabile. La coscienza di questi pazienti è solitamente confusa e talvolta si sviluppano stati precomatosi. La meningite da leptospirosi può svilupparsi sia all'inizio che alla fine della malattia. In quest’ultimo caso può causare la morte.
Clinicamente, ci sono tre periodi principali durante questa malattia. Il periodo iniziale è preceduto da una fase prodromica. Questa fase non è caratterizzata da alcun sintomo. Durante il prodromo della leptospirosi, l'agente patogeno entra nel corpo e avviene la sua diffusione primaria. Questa volta ci vogliono dai 3 ai 30 giorni. Successivamente, la leptospira entra nuovamente nel sangue dagli organi interni. Da questo momento inizia il periodo febbrile della malattia.
Si distinguono i seguenti periodi clinici di leptospirosi:
- periodo febbrile della malattia;
- periodo di picco;
- periodo di recupero.
Il periodo di picco è anche chiamato periodo di danno d'organo. Questo nome riflette l'essenza di questo periodo, poiché in questo momento si verificano gravi danni al fegato, ai reni e al cervello. Questo periodo è caratterizzato da un aumento della mortalità. Il periodo di recupero corrisponde al ripristino delle funzioni vitali, quali quelle respiratorie, cardiovascolari e urinarie.
Diagnosi di leptospirosi

Esame da parte di un medico
L'esame da parte di un medico consiste nell'esaminare e intervistare il paziente. Sulla base delle informazioni ricevute, il medico fa una conclusione preliminare sulla probabilità della leptospirosi. Per confutare o confermare una diagnosi preliminare, il medico prescrive una serie di test.Intervista al paziente
Lo scopo dell'indagine è determinare le possibili vie di infezione umana da leptospirosi. Il metodo di infezione più comune è l'acqua, quindi il medico è interessato a sapere se il paziente ha visitato corpi idrici naturali. La leptospirosi può essere contratta anche attraverso l'ingestione di alimenti contaminati. Esiste un’alta probabilità di infezione da contatto, soprattutto se sono presenti anche piccoli tagli, graffi o abrasioni sulla pelle del paziente. Spesso questa malattia è di natura professionale, quindi il medico è interessato anche al campo di attività del paziente.
Le domande che il medico potrebbe porre sono:
- se il paziente ha nuotato in acque libere;
- se il paziente ha utilizzato l'acqua proveniente da serbatoi aperti per lavare i piatti o altri oggetti domestici;
- se il paziente ha avuto contatto con il terreno bagnato;
- se la persona venuta al ricevimento era impegnata nel tagliare la carne cruda;
- se il paziente è un dipendente di una clinica veterinaria, di un allevamento di bestiame o di un negozio di animali;
- se il paziente ha un cane o altri animali domestici.
La leptospirosi è caratterizzata da un'esordio acuto e improvviso della malattia, in cui il paziente è disturbato da dolori muscolari, temperatura corporea elevata, brividi e debolezza. Molto spesso, il dolore si manifesta nei muscoli del polpaccio, nell'addome, nel torace e nella schiena. Quando senti le parti del corpo che disturbano, il dolore si intensifica. Il paziente può anche avvertire mal di testa, vertigini e insonnia. Nei giorni 3-6 dopo l’infezione, tutti i sintomi si intensificano, nel 50% dei pazienti ( soprattutto bambini) sul corpo appare un'eruzione cutanea localizzata simmetricamente. Alcuni pazienti sono disturbati da sangue dal naso ed emorragie sulle mucose e sulla pelle. Alcuni pazienti lamentano vomito, aumento del tono dei muscoli del collo e aumento.
I reclami dei pazienti specifici per la leptospirosi sono:
- temperatura 39 – 40 gradi;
- lingua secca;
- dolore agli occhi;
- letargia;
- dolori muscolari;
- andatura pesante;
- problemi di sonno;
- diminuzione della quantità di urina escreta;
- scolorimento delle feci.
Esame esterno del paziente
I pazienti affetti da questa malattia sono caratterizzati da un aspetto tipico e da una serie di sintomi che il medico identifica esaminando la pelle e la gola del paziente, ascoltando il cuore e i polmoni.
I segni diagnostici esterni della leptospirosi includono:
- viso gonfio;
- colorazione gialla della sclera;
- arrossamento della pelle del viso o colorazione itterica del viso;
- linfonodi ingrossati situati sotto la mascella inferiore e dietro il collo;
- paura della luce.
Oltre all'esame, il medico palpa l'addome, durante il quale si palpa la milza. Il fegato è ingrossato e moderatamente doloroso alla palpazione.
Le patologie che un medico può rilevare durante l'esame della gola e della bocca di un paziente includono:
- rivestimento marrone sulla lingua;
- moderato arrossamento delle tonsille;
- eruzione cutanea sul palato molle;
- emorragie sulle arcate, sulle tonsille, sul palato.
In alcuni pazienti può comparire un'eruzione erpetica nell'area dei seni e delle labbra.
Ricerca di laboratorio
I metodi diagnostici di laboratorio sono fondamentali per formulare la diagnosi di leptospirosi.I metodi diagnostici di laboratorio per la leptospirosi sono:
- analisi del sangue cliniche e biochimiche;
- metodo microscopico;
- metodo batteriologico;
- metodo biologico;
- metodi diagnostici sierologici;
Esame del sangue clinico e biochimico
Un esame del sangue è uno dei primi esami a cui viene sottoposto un paziente se si sospetta una malattia infettiva. Un esame del sangue generale non è un metodo specifico, poiché non determina il tipo di agente patogeno. Tuttavia, indica la presenza di un processo infettivo nel corpo. Ciò è supportato da parametri quali il numero totale di leucociti e la velocità di sedimentazione degli eritrociti. Un aumento di questi due indicatori indica un processo infettivo nel corpo.
Anche un esame del sangue biochimico non è specifico per la leptospirosi. Tuttavia, le deviazioni in esso indicano danni agli organi interessati. Pertanto, un aumento del livello delle transaminasi epatiche, come l'alanina aminotransferasi ( ALAT) e aspartato aminotransferasi ( AL), indica un danno al fegato. Con lo sviluppo dell'ittero, un esame del sangue biochimico rivela un'aumentata concentrazione di bilirubina ( più di 20 millimoli per litro).
Con la leptospirosi, cambiano i seguenti parametri di un esame del sangue biochimico:
- alanina aminotransferasi - più di 41 unità per litro;
- aspartato aminotransferasi – più di 40 unità per litro;
- bilirubina – più di 17,1 micromoli per litro;
- fosfatasi alcalina - più di 270 unità per litro;
- 5-nucleotidasi – più di 17 unità per litro.
Metodo microscopico
Questo metodo consente di identificare l'agente eziologico della leptospirosi ( Interogans di Leptospirra), direttamente nel materiale nativo ed esaminarlo al microscopio. Lo striscio viene precolorato utilizzando vari metodi. Per la leptospirosi, questo metodo è la colorazione Romanovsky-Giemsa, che colora la leptospira di rosa. Oltre al metodo Romanovsky, viene utilizzato il metodo dell'argentatura. Questo metodo colora i batteri di marrone.
Il metodo al microscopio è un metodo rapido che consente di identificare l'agente patogeno in modo rapido ed economico. Consiste in due fasi: raccolta del materiale e preparazione del farmaco. Per la prima fase vengono utilizzati il sangue, l'urina o il liquido cerebrospinale del paziente. Il materiale prelevato viene applicato su un vetrino, fissato e colorato. Il materiale colorato viene esaminato da un tecnico di laboratorio al microscopio. A questo scopo viene utilizzato il metodo della microscopia diretta in campo scuro.
La Leptospira può essere rilevata nel materiale studiato già nei primi giorni della malattia. Nelle urine e nel liquido spinale nei giorni 7-10 della malattia. Nonostante la sua facilità e accessibilità, il metodo presenta i suoi svantaggi. Dà risultati negativi più spesso di altri.
Metodo batteriologico
Il metodo batteriologico consiste nello studio dei batteri patogeni inoculando materiale su terreni nutritivi. Permette di identificare l'agente patogeno nella sua forma pura e studiarne le proprietà. La Leptospira cresce su terreni contenenti siero, quindi per la loro coltivazione vengono utilizzati terreni nutritivi con l'aggiunta di siero di sangue di coniglio. Dopo aver inoculato il materiale di prova ( sangue, urina) la coltura viene posta in un termostato, dove si creano le condizioni ottimali per la crescita della Leptospira. Tali condizioni per Leptospira sono elevata umidità, temperatura di 30 gradi Celsius e acidità compresa tra 7,0 e 7,4. La Leptospira cresce molto lentamente e la sua crescita viene rilevata solo nei giorni 7-10, il che rappresenta uno svantaggio significativo di questo metodo.
Metodo biologico
Questo metodo prevede l'isolamento dell'agente eziologico della malattia infettando animali da laboratorio che ne sono sensibili. Per la leptospirosi, tali animali sono criceti, porcellini d'India e ratti. Il metodo non è diffuso ed è più storico.
Metodi diagnostici sierologici
Questi metodi sono fondamentali nella diagnosi della leptospirosi. Si basano sull’identificazione di anticorpi specifici nel sangue del paziente. Questi anticorpi sono sintetizzati dal sistema immunitario umano in risposta all'ingresso di Leptospira nel corpo. Per la leptospirosi si utilizzano reazioni di microagglutinazione ( RMA) e complementare l'associazione ( RSK).
La reazione di microagglutinazione consiste nel rilevare il titolo degli anticorpi nel sangue ( o meglio, nel siero) paziente. L'agglutinazione è l'adesione e, di conseguenza, la precipitazione dei batteri. A questo scopo vengono utilizzati ceppi speciali di Leptospira al 10° – 12° giorno di crescita e il siero del paziente. Le colture di Leptospira vengono diluite a determinate concentrazioni. La reazione viene effettuata in provette o in speciali piastre a pozzetti, che vengono poste in un termostato per 2 ore ad una temperatura di 30 - 37 gradi Celsius. L'agglutinazione delle leptospira, cioè il loro incollaggio, assomiglia alla formazione di palline. La più alta diluizione del siero che farà sì che la leptospira si unisca è chiamata titolo. La reazione è considerata positiva con un titolo di 1 su 100. Se la diagnosi viene effettuata nella seconda e terza settimana di malattia, il titolo diagnostico può raggiungere 1:100.000. Ciò significa che le leptospire sono presenti nel siero diluito al massimo.
La reazione di legame del complemento comporta la formazione di un complesso antigene-anticorpo e l'aggiunta di un complemento ad esso. Se il complesso antigene-anticorpo non si forma il complemento rimane libero. La prima fase della reazione prevede la miscelazione del siero del paziente, che contiene anticorpi contro la Leptospira, e antigeni standard. Se non ci sono anticorpi nel siero, non si verificherà la formazione del complesso e il complemento rimarrà libero. Se una persona è malata di leptospirosi e ci sono anticorpi nel suo siero, si legheranno specificamente agli antigeni e si attribuiranno un complimento.
Per scoprire se il complemento è rimasto legato o era attaccato, nella provetta viene aggiunta una miscela di eritrociti di pecora e anticorpi ad esso sensibilizzati. Se il complimento è associato, non accadrà nulla alla miscela di globuli rossi e anticorpi. Quando il complimento è libero, si attacca ai globuli rossi e li distrugge. Si verifica una reazione chiamata “emolisi eritrocitaria”. Visivamente, ciò si manifesta nella formazione di un coagulo sul fondo della provetta.
Reazione a catena della polimerasi ( PCR)
Il metodo diagnostico PCR è il metodo più accurato. La sua specificità raggiunge il 95-99% e la durata della sua attuazione non richiede più di un giorno. Il metodo prevede l'identificazione di frammenti di materiale genetico di Leptospira nel materiale biologico. Qualsiasi fluido corporeo può essere utilizzato come materiale ( sangue, urina, liquido spinale), pennellate, pezzi di tessuto. La reazione viene condotta in un apparecchio chiamato termociclatore, con l'aggiunta di numerosi reagenti speciali. L'essenza del metodo è la sintesi di un gran numero di filamenti di acido desossiribonucleico ( DNA) basato su piccoli pezzi di esso. Pertanto, anche se nel materiale da testare sono presenti frammenti minori di DNA, è possibile identificare l'agente patogeno.
Nelle prime fasi, questi frammenti vengono identificati. Quindi, sulla base di essi, un filamento di DNA viene completato utilizzando enzimi. Quindi il numero di thread viene moltiplicato per diverse migliaia di copie. Nella fase finale, il DNA trovato viene identificato. Poiché la molecola del DNA è unica e inimitabile per ogni batterio o virus, la specificità del metodo e la sua sensibilità raggiungono il 99%. La PCR molto raramente dà risultati falsi positivi. Uno svantaggio significativo di questo metodo è il suo costo.
Trattamento della leptospirosi
Disintossicazione del corpo
 La disintossicazione dalla leptospirosi è necessaria per rimuovere la leptospira e le sue tossine dal corpo. A questo scopo vengono utilizzate varie soluzioni saline e sostitutive del plasma. Allo stesso tempo, il volume del sangue circolante viene reintegrato, poiché a causa dello sviluppo della sindrome emorragica nella leptospirosi si verifica la perdita di sangue e liquidi corporei.
La disintossicazione dalla leptospirosi è necessaria per rimuovere la leptospira e le sue tossine dal corpo. A questo scopo vengono utilizzate varie soluzioni saline e sostitutive del plasma. Allo stesso tempo, il volume del sangue circolante viene reintegrato, poiché a causa dello sviluppo della sindrome emorragica nella leptospirosi si verifica la perdita di sangue e liquidi corporei. Farmaci utilizzati per disintossicare il corpo
| Una droga | Meccanismo di azione | Come viene prescritto? |
| Hemodez | Grazie al potassio, calcio, magnesio e sodio contenuti nel farmaco, ripristina l'equilibrio acido-base e regola l'equilibrio idroelettrolitico. Ripristina il volume plasmatico. | Si consiglia la somministrazione per via endovenosa, 50 gocce al minuto. Il volume giornaliero viene calcolato in base alle condizioni e all'età del paziente. Una singola dose non deve superare i 500 ml. |
| Enterodesi | Il principio attivo del farmaco è un composto ad alto peso molecolare: povidone. Lega ed elimina le tossine, fornendo così un effetto disintossicante. | Il farmaco viene assunto per via orale, due ore dopo aver mangiato. La bustina con il farmaco viene diluita in 100 ml di acqua fredda. Si consiglia l'assunzione di 2-3 bustine del farmaco al giorno. |
| Mannitolo | Ha un effetto diuretico e antiedematoso. L'effetto diuretico viene utilizzato per rimuovere rapidamente le tossine della Leptospira dal corpo. Il principio d'azione è quello di aumentare la pressione osmotica del plasma e ripristinare il volume del sangue circolante. A causa di ciò, la diuresi aumenta ( volume dell'urina), che si riduce nella leptospirosi. Le tossine, la leptospira e i prodotti metabolici del corpo vengono escreti insieme all'urina. Più dell'80% del farmaco somministrato viene escreto dai reni entro 3 ore. | In ragione di 0,5 grammi per 1 kg di peso, il farmaco viene somministrato per via endovenosa mediante flebo o flusso ( a seconda del volume di liquido perso). Vengono introdotte soluzioni al 10, 15 e 20%. Prima dell'uso, si consiglia di riscaldare il farmaco a 30 gradi per evitare la sedimentazione. |
| Soluzione di glucosio al 20 e 40% + furosemide | La combinazione di questi farmaci fornisce un aumento artificiale della minzione. Il glucosio stimola la transizione del fluido nel flusso sanguigno, ripristinando così il volume del sangue circolante. La furosemide ha un rapido effetto diuretico. | La dose massima di glucosio al 40% è di 250 ml al giorno; 20% glucosio – 500 ml al giorno. Le soluzioni vengono somministrate per via endovenosa, 30 gocce ( per il 20% di glucosio) e 20 gocce ( per il 40% di glucosio) in un minuto. Al termine della somministrazione endovenosa vengono somministrati 20-40 mg di furosemide. |
| Polisorb | Assorbe tossine, sostanze simili alle tossine e batteri dal tratto gastrointestinale. Assorbe anche ( assorbe sulla sua superficie) prodotti metabolici come la bilirubina. Pertanto, riduce l'aumento della concentrazione di bilirubina nel sangue. Particolarmente efficace per la forma itterica della leptospirosi. | Assunto esclusivamente per via orale, un'ora prima dei pasti. Da uno a due cucchiai del farmaco ( 3 – 6 grammi) viene agitato in 150 ml ( mezzo bicchiere) acqua fredda. La dose media giornaliera è di 12 grammi ( 4 cucchiai). |
Trattamento con antibiotici
La terapia antibiotica insieme all'introduzione di siero specifico è il trattamento di base della leptospirosi. Vengono utilizzati principalmente preparati a base di penicillina e, in caso di intolleranza, antibiotici del gruppo dei macrolidi.Antibiotici utilizzati nel trattamento della leptospirosi
| Una droga | Meccanismo di azione | Come viene prescritto? |
| Penicillina | Interrompe la formazione dei componenti della parete cellulare della Leptospira, provocandone così la distruzione. | La dose dipende dalla gravità della malattia. Per la gravità moderata, la dose giornaliera è di 10.000.000 – 12.000.000 di unità ( unità di azione); nelle forme gravi che si verificano con lo sviluppo della meningite - 24.000.000 di unità. La dose scelta dal medico viene suddivisa in 4-6 dosi e somministrata per via intramuscolare rigorosamente secondo l'orologio. |
| Eritromicina | Si lega ai ribosomi ( organelli cellulari), bloccando la sintesi delle proteine necessarie alla vita dei batteri. | 500 mg vengono somministrati per via endovenosa ogni 6 ore. La dose massima è di 4 grammi. |
| Doxiciclina | Ha un ampio spettro d'azione. Interrompe la sintesi proteica, inibendo la crescita della Leptospira. | Preso per via orale 100 mg due volte al giorno. In casi eccezionali, la dose arriva fino a 200 mg due volte al giorno. |
Plasmaferesi
Plasmaferesi – extracorporea ( fuori del corpo) una procedura volta a rimuovere i componenti tossici del sangue. Nella leptospirosi, tali componenti sono tossine e prodotti metabolici del corpo. Questa procedura viene utilizzata per lo sviluppo di insufficienza renale ed epatica. Consiste nel prelevare parte del sangue del paziente e purificarlo. La pulizia avviene eliminando la parte liquida del sangue - plasma, che contiene tutte le tossine. Gli elementi formati del sangue (leucociti, piastrine, globuli rossi) vengono restituiti al flusso sanguigno del paziente e il volume del plasma raccolto viene reintegrato con soluzioni fisiologiche e sostituti del sangue. Pertanto, la pulizia del sangue dalle tossine avviene come risultato della rimozione del plasma, che contiene queste tossine. Gli elementi del sangue rimangono intatti.A seconda della tecnica di questa procedura, esistono diverse opzioni per la plasmaferesi.
Si distinguono i seguenti metodi di plasmaferesi:
- Metodo di filtrazione. Il principio si basa sulla filtrazione del plasma attraverso speciali filtri al plasma. Il filtro è una membrana fibrosa con molte fibre porose. Le cellule del sangue non passano attraverso questi pori.
- Metodo della gravità. Questo metodo si basa sul principio della centrifugazione, che consiste nel separare parti eterogenee in singoli componenti in base alla densità utilizzando le forze centrifughe.
- Metodo a cascata. Consiste nella filtrazione ripetuta del plasma attraverso uno speciale filtro che lascia passare solo l'albumina del sangue.
Introduzione di siero specifico
Per il trattamento e la prevenzione della leptospirosi si utilizza siero specifico o gammaglobuline. Il trattamento della leptospirosi con questi farmaci è più diffuso nei paesi post-sovietici.Quando viene nominato?
Viene prescritto un siero specifico per compensare rapidamente il deficit immunologico del corpo del paziente. Molto spesso, l'insufficienza della difesa immunitaria si osserva nelle fasi iniziali della malattia, quando il corpo non ha ancora avuto il tempo di produrre la quantità necessaria di anticorpi contro Leptospira. Ciò si verifica anche quando le risorse immunitarie del corpo si esauriscono rapidamente nelle persone con immunodeficienza, malattie croniche gravi e negli anziani.
Il siero antileptospirosi e le gammaglobuline hanno indicazioni rigorose per l'uso.
Le principali fasi della malattia in cui vengono prescritti sieri e globuline specifiche sono:
- periodo acuto di manifestazioni cliniche;
- forme gravi di leptospirosi con gravi danni a organi e apparati;
- insufficienza d'organo acuta ( renale, cardiaco);
- infezioni batteriche secondarie ( meningite, encefalite, miocardite).
Cosa contiene il siero?
Il siero antileptospirosi contiene titoli elevati ( concentrazioni) anticorpi contro le principali specie di Leptospira che causano malattie nell'uomo.
Questi sieri sono creati a base di sangue animale ( cavalli) o persone infettate artificialmente da Leptospira patogena. Per ottenere titoli anticorpali elevati, grandi dosi di antigeni della leptospirosi vengono gradualmente introdotte nel corpo animale/umano. In risposta agli antigeni estranei, il corpo produce un gran numero di anticorpi che li neutralizzano. I sieri eterologhi vengono creati sulla base del sangue animale contenente i titoli anticorpali più elevati. I sieri ottenuti dal sangue umano sono detti omologhi.
Elaborando il siero anti-leptospirosi e facendo precipitare le sue frazioni proteiche contenenti anticorpi, si ottiene la gamma globulina. In altre parole, la gammaglobulina è un “siero di latte concentrato” altamente purificato.
Sieri specifici e gammaglobuline sono disponibili in fiale da 5 e 10 millilitri. I farmaci vengono somministrati per via intramuscolare per tre giorni consecutivi, 5 millilitri. Nelle forme gravi di leptospirosi e complicanze secondarie, la dose viene aumentata a 10 millilitri.
Qual è l'efficacia per la malattia?
L’efficacia dei sieri anti-leptospirosi e delle gammaglobuline è piuttosto elevata. Grazie ad una grande dose di anticorpi specifici, viene creata un'immunizzazione passiva, che garantisce una lotta attiva contro le infezioni. Tuttavia, l’immunità “artificiale” creata non è permanente. L'effetto degli anticorpi sierici dura in media 5-6 settimane, dopodiché vengono distrutti.
Prevenzione della leptospirosi
 L'infezione da leptospirosi può essere prevenuta limitando il contatto con i portatori della malattia, che sono roditori infetti, animali da fattoria e domestici. Le misure preventive per combattere questa malattia possono essere divise in due gruppi. La prima categoria comprende le norme di cui la persona stessa è responsabile. Il secondo gruppo comprende attività la cui organizzazione e controllo spetta alle autorità di controllo sanitario ed epidemiologico e alle istituzioni sanitarie.
L'infezione da leptospirosi può essere prevenuta limitando il contatto con i portatori della malattia, che sono roditori infetti, animali da fattoria e domestici. Le misure preventive per combattere questa malattia possono essere divise in due gruppi. La prima categoria comprende le norme di cui la persona stessa è responsabile. Il secondo gruppo comprende attività la cui organizzazione e controllo spetta alle autorità di controllo sanitario ed epidemiologico e alle istituzioni sanitarie. Le regole per la prevenzione personale della leptospirosi sono:
- vaccinazione tempestiva degli animali;
- rilevamento e trattamento di malattie negli animali domestici;
- sterminio dei roditori e prevenzione del loro aspetto;
- attuazione di norme preventive durante il lavoro agricolo;
- rispetto delle norme di sicurezza durante il relax nella natura;
- rispetto dei requisiti igienico-sanitari sul luogo di lavoro in caso di professionista appartenente a un gruppo a rischio;
- immunizzazione contro la leptospirosi.
Vaccinazione degli animali contro la leptospirosi
L'immunizzazione degli animali contro la leptospirosi è una misura efficace che proteggerà gli esseri umani e gli animali da questa malattia. I metodi di vaccinazione dipendono dalle condizioni in cui l'animale è stato acquisito. Se il proprietario sa con certezza che l'animale non è infetto da Leptospira ( se acquistato da un vivaio o da un allevatore), viene eseguita una procedura di vaccinazione standard. Se l'animale è stato acquistato a mano o raccolto per strada, viene effettuata l'immunizzazione passiva, nella quale prima del vaccino viene posto uno speciale siero iperimmune.Individuazione e trattamento della leptospirosi negli animali domestici
I proprietari di animali domestici sono a rischio di leptospirosi, poiché la fonte dell’infezione è spesso un animale malato. Le principali vie di infezione sono il contatto della pelle con l'acqua contaminata da secrezioni, saliva o urina di un animale malato. L'identificazione tempestiva dei sintomi della malattia in un animale e un trattamento adeguato consentiranno a una persona di evitare l'infezione da Leptospira.Distruzione e protezione dai roditori
Ratti e topi possono causare la leptospirosi negli esseri umani. Molto spesso, le persone si ammalano a causa dei morsi di ratto. La fonte dell'infezione può essere cibo o bevande che contengono urina, saliva o secrezioni di roditori. I cani che li cacciano possono anche causare l’infezione da leptospira negli esseri umani. Pertanto, a scopo preventivo, è necessario effettuare il controllo dei roditori, distruggendo quelli esistenti e prevenendo la comparsa di nuovi ratti e topi.Le misure per prevenire i roditori includono:
- pulizia locali tecnici, soffitte e scantinati;
- rimozione tempestiva dei rifiuti;
- sigillare fessure e aperture attraverso le quali gli animali possono entrare nella stanza;
- uso di ultrasuoni e altri dispositivi per respingere i roditori.
Una casa di campagna o una dacia è una potenziale fonte di infezione da Leptospira. L'infezione può verificarsi quando si lavora con terreno che contiene secrezioni di animali portatori. Puoi anche contrarre l'infezione utilizzando piatti o oggetti domestici contaminati da roditori infetti. La probabilità di infezione aumenta se in casa o negli edifici annessi vengono trovati escrementi di ratto o topo. Per prevenire la leptospirosi, prima dell'inizio della stagione estiva, è necessario effettuare la pulizia con acqua utilizzando soluzioni alcaline.
Le aree che necessitano di essere pulite e trattate sono:
- scantinati;
- soffitte;
- capannoni;
- garage;
- edifici residenziali;
- edifici di servizio;
- area non edificata adiacente alla casa.
Le misure preventive sugli appezzamenti personali includono:
- distruzione di tutti i prodotti deteriorati da topi o ratti;
- rifiuto di bere acqua non depurata;
- conservare cibo e acqua in contenitori ermeticamente chiusi;
- eseguire lavori di scavo indossando guanti;
- prevenire la formazione di discariche in un cottage estivo e nelle sue immediate vicinanze.
Regole per trascorrere il tempo in aree aperte
Durante la ricreazione attiva nella natura, una persona può incontrare focolai naturali di leptospirosi, dove gli agenti patogeni circolano nella popolazione di animali selvatici. Le zone di potenziale infezione da Leptospira si trovano principalmente sui bassi rilievi delle foreste e delle valli fluviali. Pericolosi sono anche i bacini con acqua stagnante e le aree adiacenti.I luoghi in cui esiste un'alta probabilità di infezione da leptospirosi sono:
- aree erbose bagnate;
- boschetti di carici, tife, canne;
- prati umidi delle pianure alluvionali;
- paludi;
- margini delle foreste e deforestazione umida.
Adottare precauzioni sul posto di lavoro
Oltre ai focolai naturali, ci sono zone economiche in cui aumenta la probabilità di infezione da leptospirosi. La formazione di tali condizioni è facilitata dal trattamento, dall'allevamento e dal mantenimento degli animali portatori di Leptospira. Gli animali espellono gli agenti patogeni insieme alle loro urine, contaminando il suolo, l'acqua, i pascoli, i mangimi e altri oggetti ambientali attraverso i quali le persone si infettano. È possibile infettarsi da Leptospira attraverso il contatto con animali, la riparazione e la pulizia dei locali in cui sono tenuti, oppure mangiando o bevendo nei luoghi di lavoro, con i quali può entrare in contatto materiale infetto. L’incidenza della leptospirosi nelle epidemie economiche non ha stagionalità. La probabilità di infezione è maggiore negli allevamenti in cui sono presenti ratti e roditori. Il pericolo aumenta anche nelle strutture che si trovano in condizioni igieniche insoddisfacenti.Il gruppo ad alto rischio comprende rappresentanti delle seguenti professioni:
- dipendenti di cliniche veterinarie;
- allevatori di cani;
- allevatori di suini, mungitrici, lavoratrici di vitelli;
- dipendenti di impianti di lavorazione della carne e di allevamenti di bestiame;
- persone che trasportano animali;
- lavoratori di circhi, zoo, sezioni equestri.
Le misure per prevenire l’infezione da leptospirosi sul posto di lavoro sono:
- indossare scarpe e guanti di gomma, tute o camici speciali, grembiuli gommati, cappelli;
- trattare gli indumenti da lavoro alla fine della giornata lavorativa con appositi disinfettanti;
- deposito degli indumenti e delle scarpe da lavoro in locali appositamente attrezzati;
- rifiuto di assumere cibo e acqua sul posto di lavoro;
- conservare l'acqua potabile e gli alimenti in contenitori chiusi;
- disinfezione e lavaggio delle mani con sapone prima dei pasti e alla fine della giornata lavorativa;
- mangiare cibo in aree appositamente designate.
Immunizzazione contro la leptospirosi
Per formare un'immunità attiva in una persona a rischio di infezione da Leptospira, viene effettuata la vaccinazione. Per la vaccinazione viene utilizzato un farmaco costituito da alcuni dei tipi più comuni di agenti patogeni della leptospirosi. Il vaccino viene iniettato due volte nella regione sottoscapolare. Il volume della prima dose è di 2 millilitri, la seconda ( effettuato dopo 7 – 10 giorni) – 2,5 millilitri. L'immunità delle persone che ricevono il vaccino non dura più di un anno. Pertanto, le persone che si trovano costantemente nel territorio di focolai naturali o economici con un rischio elevato di infezione devono essere vaccinate ogni anno. L’intervallo tra la vaccinazione contro la leptospirosi e i vaccini contro altre malattie dovrebbe essere di almeno 30 giorni per gli adulti e di almeno 60 giorni per i bambini. 24 ore prima della vaccinazione, devi rinunciare all'alcol e sottoporti a un esame da parte di un medico, che trarrà una conclusione sull'ammissione alla vaccinazione.Misure preventive controllate dallo Stato contro la leptospirosi
La sorveglianza sanitaria ed epidemiologica della leptospirosi, regolata dalle agenzie governative, è una serie di attività volte a ridurre il tasso di incidenza nel Paese. L'attuazione delle misure preventive è affidata alle istituzioni mediche e preventive, alle organizzazioni sanitarie ed epidemiologiche e alle autorità di controllo veterinario.Il ruolo delle imprese mediche e preventive nella prevenzione della leptospirosi
I funzionari della sanità pubblica sono responsabili dell’identificazione precoce dei casi umani per prevenire epidemie di leptospirosi.
Le misure per prevenire l'infezione di massa da leptospira, eseguite dai medici, sono:
- diagnosi tempestiva dei casi di morbilità tra le persone;
- ricovero immediato di persone con sospetta leptospirosi;
- registrazione, registrazione e mantenimento delle statistiche dei casi di infezione da leptospirosi;
- notifica dei casi registrati alle autorità competenti;
- attuazione della supervisione dispensaria per sei mesi per le persone che hanno avuto questa infezione.
Organismi di controllo sanitario-epidemiologico e veterinario
Ricevendo informazioni su casi di leptospirosi di gruppo o professionali, i dipendenti delle autorità di sorveglianza sanitaria-epidemiologica e veterinaria organizzano una serie di attività al fine di determinare la fonte dell'infezione e prevenire lo scoppio dell'infezione.
Le misure per prevenire la leptospirosi, di cui sono responsabili i rappresentanti di questi organismi, sono:
- condurre un'indagine speciale in caso di malattie professionali o collettive;
- indagine sulle persone che lavorano o vivono in prossimità dei siti di infezione;
- rimozione di campioni dall'ambiente per ricerche di laboratorio;
- introdurre un divieto sui prodotti legati alla fonte dell'infezione;
- limitazione del lavoro e della permanenza delle persone in aree potenzialmente pericolose;
- effettuare disinfezione e derattizzazione;
- organizzazione di eventi sulla prevenzione della leptospirosi tra la popolazione;
- organizzazione della vaccinazione delle persone a rischio.