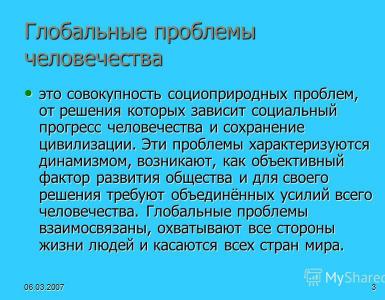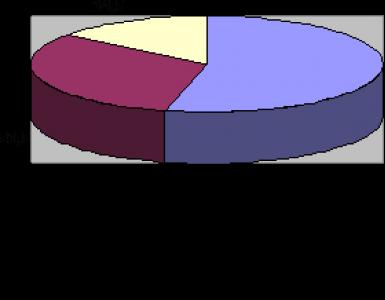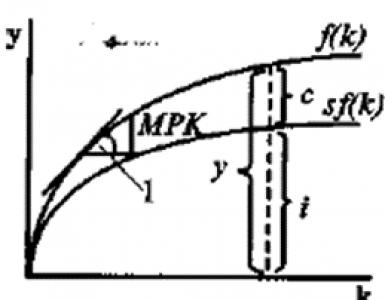Concetti antropologici. Teoria antropologica. Antropologia in Russia
5.1 Storia dello sviluppo delle opinioni sull'antropogenesi
Evoluzione umana, oantropogenesi (dal greco anthropos - uomo, genesi - sviluppo) -questo è il processo storico della formazione evolutiva umana . La scienza che studia le origini dell'uomo si chiamaantropologia.
L'evoluzione umana è qualitativamente diversa dall'evoluzione degli organismi di altre specie. Perché in esso non erano in gioco solo fattori biologici, ma anche sociali. La complessità dei problemi dell'antropogenesi è aggravata dal fatto che l'uomo stesso ha due facce. Con una faccia è rivolto al mondo animale, da cui proviene e con il quale rimane anatomicamente e fisiologicamente connesso, e con la seconda - al mondo delle conquiste scientifiche e tecniche create dal lavoro collettivo, dalla cultura, ecc. L'uomo, da un lato, è un essere biologico, dall'altro- sociale.
La costituzione ereditaria dell'uomo si è formata come risultato di un processo di evoluzione graduale e lungo. Nel processo di evoluzione sulla base del programma genetico, gli immediati predecessori dell'uomo incontrarono continuamente contraddizioni tra la loro organizzazione morfofisiologica e i metodi elementari emergenti dell'attività del "lavoro istintivo". La risoluzione di questa contraddizione attraverso la selezione naturale portò prima a cambiamenti negli arti anteriori, poi allo sviluppo della corteccia cerebrale e, infine, all'emergere della coscienza. Possiamo dire che questo è stato il primo ma decisivo atto per completare la specializzazione dei geni in geni strutturali e regolatori. Inoltre, la coscienza assicurava non solo la formazione, ma anche l'ulteriore sviluppo dell'uomo.
Successivamente, il ritmo dello sviluppo biologico umano iniziò a diminuire. Dall'emergere della coscienza sono state fornite nuove forme e possibilità di adattamento all'ambiente. Ciò ha portato a deviazioni dall'azione della selezione naturale, a seguito della quale lo sviluppo biologico ha lasciato il posto allo sviluppo e al miglioramento sociale.
Esistono diverse teorie che si riferiscono in modo diverso al problema dell'antropogenesi. DIconcetti di base dell'apparizione dell'uomo sulla Terra.
Come nella questione dell'origine dell'Universo, c'è un'ideasulla creazione divina dell'uomo. “E Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza... E Dio creò l'uomo a sua immagine” (Genesi 1,26, 27). Le opinioni dei sostenitori dell'origine soprannaturale dell'uomo si sono fuse da tempo con il concetto biblico, che afferma l'improvvisa creazione dell'uomo nel sesto giorno della Creazione, avvenuta 10.000 anni fa. Nell'ultimo quarto del XX secolo, sotto la pressione dei fatti scientifici, Papa Giovanni Paolo II nel 1986 fu costretto a riconoscere l'origine del corpo umano nel quadro della teoria dell'evoluzione, ma non dell'anima umana. Nell'ottobre 1996 ha ripetuto le sue dichiarazioni sull'evoluzione umana. Data l'autorità del capo della Chiesa cattolica romana, si può concludere che le sue dichiarazioni significano la fine delle visioni antievolutive sulla natura umana.
In molte tribù primitive era diffusa la convinzione che il lorogli antenati discendevano da animali e persino da piante (su questo si basa l’idea dei totem). Tali credenze si trovano ancora tra i cosiddetti popoli arretrati. Il concetto di origini umane da esseri extraterrestri che hanno visitato la Terra. Una variante del concetto: l'uomo è venuto dall'incrocio di alieni spaziali con scimmie. Dalla fine del XIX secolo dominail concetto di origine umana dagli antenati altamente sviluppati delle scimmie moderne.
Tuttavia, già nell'antichità si esprimeva l'idea dell'origine animale dell'uomo. Pertanto, Anassimandro e Aristotele, definendo il posto dell'uomo nella natura, lo riconobbero come gli antenati degli animali. Dividendo gli animali in “a sangue” e non a sangue, Aristotele classificò gli esseri umani nel gruppo degli animali “a sangue” e collocò le scimmie tra gli esseri umani e gli animali nel gruppo “a sangue”. È stato riconosciuto anche il fatto che l'uomo è vicino agli animaliK. Galeno (130-200), che formulò una conclusione sull'anatomia umana basata sui risultati dell'autopsia delle scimmie inferiori.
K. Linneo, rispetto ai suoi predecessori, andò molto oltre, evidenziando l'ordine dei primati, includendovi le proscimmie, le scimmie e il genere delle persone della stessa specie - Homo sapiens) e sottolineando le somiglianze tra uomo e scimmia. Non tutti i contemporanei di K. Linneo riconobbero il suo sistema, in particolare l’appartenenza dell’uomo all’ordine dei primati. Furono proposte anche altre versioni del sistema, in cui il rango dell'uomo era notevolmente sopravvalutato, poiché l'uomo era riconosciuto come un regno della natura separato. Questo essenzialmente separava l’uomo dagli animali.
Nonostante la soluzione corretta alla questione del rapporto tra uomo e animali, la questione dell'origine dell'uomo è rimasta aperta per molto tempo nel lavoro degli scienziati. Si ritiene che la prima ipotesi dell'antropogenesi sia stata formulata da J.-B. Lamarck. Credendo che l'uomo avesse antenati simili a scimmie, Lamarck fu il primo a nominare la sequenza di risultati evolutivi nella trasformazione di un antenato simile a una scimmia in un uomo. Inoltre, attribuiva la massima importanza al passaggio dei quadrupedi arboricoli alla locomozione bipede e alla vita sulla terra. Lamarck descrisse i cambiamenti nello scheletro e nei muscoli degli antenati umani in connessione con il passaggio alla deambulazione eretta. Ma, avendo sopravvalutato il ruolo dell'ambiente, come nel caso di altri organismi, ha comunque travisato le forze trainanti dell'evoluzione umana.
A. Wallace (1823-1913) suggerì che nell'evoluzione dell'uomo avevano grande importanza le forme che si muovevano su due arti, e che dopo la camminata eretta si verificava un aumento del cervello. Ha suggerito che la storia dell'emergere dell'uomo fosse molto lunga nel tempo. Non c'è dubbio che queste e altre affermazioni simili siano state solo un significativo passo avanti nella comprensione della questione dell'emergere dell'uomo, ma non erano esaustive e non hanno portato alla formazione di una teoria scientifica sull'origine dell'uomo. Una teoria veramente scientifica sull'origine dell'uomo iniziò a essere formulata quando apparve l'insegnamento evoluzionistico di Charles Darwin, che divenne la base di questa teoria.
L'uomo è stato tradizionalmente al centro dell'attenzione dei pensatori europei; i sofisti - Protagora, Socrate, Aurelio Agostino, Spinoza e Cartesio, Rousseau e Holbach, Schopenhauer e Nietzsche - gli hanno prestato attenzione. Ma se all'inizio del XX secolo. i problemi legati alla filosofia umana furono risolti nel contesto di altre questioni, poi dalla fine degli anni '20 del secolo scorso iniziò una copertura completa dell'essenza della vita spirituale umana.
Il rappresentante più famoso dell'antropologia filosofica fu il filosofo tedesco Max Scheler (1874-1928). Nelle sue opere rivela a fondo il contenuto dell'antropologia filosofica, nata come reazione all'opposizione tra natura e cultura.
L'uomo, scrive Scheler, appare in due forme: come un "uomo naturale" e un "cercatore di Dio". L'“uomo naturale” è un animale altamente sviluppato, che successivamente compensa con l'intelligenza le sue debolezze nei primi anni di vita. “L’uomo cercatore di Dio” è qualcosa di completamente diverso. Questa ipostasi lo distingue dall'ipostasi dell '"uomo naturale" non solo per l'intelletto, ma anche per la capacità di creare strumenti, linguaggio ed è un collegamento transitorio dalla natura nel suo significato assoluto a Dio. Lasciare la sfera dell '"uomo naturale" è molto difficile e doloroso, poiché i tratti naturali sono stati formati dall'evoluzione nel corso di milioni di anni.
Una delle prime è stata la questione dell'uomo nella filosofia del XIX secolo. Detto in modo nuovo da Kerkegaard (1813-1855), i filosofi, a suo avviso, mettono la materia, lo spirito, la verità, Dio, il progresso al primo posto nella loro teoria e subordinano l'uomo a queste astrazioni filosofia veramente rivolta all'uomo “Yerkegaard la vedeva come entrare nel sentimento della vita umana, nella sofferenza umana (una persona deve scoprire una verità per la quale vorrebbe vivere e morire).
Quindi, nel 19 ° secolo. Appare una tendenza filosofica antropologica, che cerca di sostituire la filosofia classica delle essenze con la filosofia dell'esistenza umana. È così che è apparsa la filosofia dell'esistenzialismo.
Il problema centrale della ricerca posto dall’esistenzialismo è l’alienazione. Il compito della filosofia in questa situazione è trovare un'opportunità per l'uomo; se non superi la paura e l'alienazione (questo non è sempre possibile), allora in ogni caso cerca e trova il tuo “io”, il contenuto della tua vita in situazioni tragiche, “assurde”.
Una persona crea se stessa, comprende la sua essenza, già esistente: questa è l'essenza del primo principio dell'esistenzialismo. Da ciò derivano alcune importanti conseguenze; non esiste una natura umana data; nessuna forza esterna, nessun altro oltre a questo individuo, può operare la sua trasformazione in persona. È lui il responsabile se la sua trasformazione in persona non si è mai materializzata.
La coscienza di una persona orientata esistenzialmente è libertà, volontà, alla quale una persona è condannata. La libera scelta di un individuo è il suo destino, la sua responsabilità e la sua tragedia. Per questo A. Camus afferma: “...mi ribello, il che significa che esisto”. E questo accade in ogni situazione in cui una persona lotta per il proprio “io” (la sua esistenza).
La filosofia esistenziale si oppone fondamentalmente all'isolamento dell'uomo dal mondo che lo circonda. Così, la filosofia esistenziale pone l’uomo, la sua coscienza, la sua volontà, la sua capacità di scelta, al centro della riflessione.
Sviluppando problemi antropologici, la maggior parte dei filosofi della metà del XX secolo. si allontanò da una biologizzazione semplificata dell'essenza dell'uomo. Questo approccio rappresenta chiaramente il personalismo.
Il problema dell'uomo è sempre stato al centro dell'attenzione di diversi movimenti e scuole filosofiche, tuttavia, alcuni pensatori lo hanno interpretato come qualcosa di aggiuntivo nella risoluzione di vari problemi di ontologia, mentre altri gli hanno prestato un'attenzione più significativa. Questi ultimi possono essere definiti in tutto e per tutto personalisti. È vero, bisogna fare una certa cautela: il “vero” personalismo non pone semplicemente la persona al centro della sua attenzione, ma sottolinea il fatto che è l'uomo la base fondamentale di tutte le cose. Al giorno d'oggi, il personalismo come direzione moderna nella filosofia sociale dell'Occidente si sta sviluppando principalmente in linea con la filosofia cristiana, in particolare cattolica. Il filosofo più influente nel personalismo è il pensatore francese Emmanuel Mounié (1905-1950).
Analizzando i processi sociali moderni, Munier giunge alla conclusione che l'attenzione principale dello stato, della società, delle istituzioni educative, delle organizzazioni pubbliche, ecc. dovrebbe essere focalizzato sulla formazione delle basi spirituali di una persona.
Nel personalismo moderno si sono formati quattro massimi, in cui, secondo i personalisti, si riflettono i principali problemi dell'uomo.
- 1. Il garante dei valori umani è la fede in Dio. Nella sua attività, una persona fluttua costantemente lungo una linea predeterminata. Tutti vogliono in qualche modo realizzare il proprio “io” interiore, che è unico, unico. Una persona deve controllare di tanto in tanto le sue azioni, i suoi pensieri, ecc. con le tradizioni della Chiesa cattolica, che si sono formate sotto l'influenza della fede nell'assoluto, perfetto, onnipotente, onnipotente.
- 2. L'uomo moderno è minacciato da due forme della sua esistenza: da un lato, l'attività attiva nella società e, dall'altro, la ricerca dentro di sé. È necessario trovare la “media aurea” proclamata da Aristotele e Seneca.
L'uomo, credono i personalisti, è primario rispetto alla società. La società è un principio attivo per un certo periodo della vita di una persona. Questo periodo è determinato dal confine di 14-17 anni, quando una persona diventa un individuo. Il sistema “persona” si sta trasformando radicalmente nel sistema “persona-società”, cioè l'elemento dominante diventa l'individuo.
- 3. L'essenza di una persona non può essere determinata con mezzi razionali. Oggi è una, domani è diversa. Ma questa essenza esiste. È determinato dal livello di fede religiosa. L'essenza si sente, non si definisce.
- 4. La società si forma quando ciascuno di noi, senza rinunciare alla propria libertà, sente il bisogno dell'altro. La libertà è la capacità di rispettare gli altri. Quella persona che, nel profondo della sua anima, è intrisa di fede in Dio, di regola, con la sua visione dei percorsi da scegliere, è al di sopra di coloro che ignorano questa fede, ma non dovrebbe mai opporsi alla libertà di opinioni e azioni di altri.
- 10 Genesi delle idee metodologiche moderne (dettagli sul positivismo, filosofia storico-culturale della scienza, ermeneutica - facoltativo)
Il positivismo (positivo) è un movimento ampiamente ramificato nella filosofia borghese. I positivisti dichiarano che tutti i problemi più importanti con cui la filosofia si è occupata per secoli (la questione del rapporto tra pensiero ed essere) sono inverosimili e privi di significato. Secondo loro, la filosofia non dovrebbe andare oltre il quadro della conoscenza “positiva”, positiva, ad es. dati sperimentali della scienza. Ma la scienza, l'esperienza umana, dal loro punto di vista, non ha accesso all'essenza delle cose. La scienza può solo descrivere gli aspetti esterni dei fenomeni, chiarirne la somiglianza esterna, la sequenza, ma non le leggi che ne governano il cambiamento e lo sviluppo. Quindi, un tratto caratteristico del positivismo/agnosticismo. La natura idealistica delle opinioni dei positivisti si manifesta nella loro interpretazione del concetto di esperienza, uno dei concetti principali della filosofia positivista. Nell'esperienza, sostengono i positivisti, una persona non può stabilire la natura oggettiva di oggetti e fenomeni, penetrare nella loro essenza, perché non si occupa solo del suo mondo interiore, non va oltre i limiti delle sue percezioni ed esperienze. Il positivismo cerca di racchiudere tutta la conoscenza scientifica nel quadro dell'esperienza soggettiva umana. Il positivismo nacque nel secondo terzo del XIX secolo. Il suo fondatore fu Comte (Francia). Anche Miles e Spencer (Inghilterra) giocarono un ruolo importante nello sviluppo delle visioni positiviste durante questo periodo. Cercando di dimostrare la “giustizia” del punto di vista positivista, Comte propone uno schema idealistico secondo il quale la conoscenza nel suo sviluppo storico attraversa tre fasi. Nella prima fase (teologica), una persona vede la causa dei fenomeni osservati nell'azione delle forze soprannaturali; nella seconda fase (metafisica), considera alcune entità astratte (ad esempio la natura) alla base di questi fenomeni. e solo al terzo stadio (positivo) riconosce le conoscenze sperimentali, pratiche, utili. Comte pone questo schema alla base dell'intero processo storico. Secondo lui, il progresso della società è il semplice sviluppo delle capacità spirituali dell'umanità. Spencer ha proposto il cosiddetto. teoria organica della società. Paragonando la società a un organismo biologico, ha affermato che la vita sociale tende all'equilibrio delle forze, all'armonia degli interessi di classe. Su questa base, le rivoluzioni sociali furono da lui dichiarate “dannose”. L'ulteriore sviluppo del positivismo è associato ai nomi di Mach e Avenarius (fine XIX secolo) - i fondatori dell'empiriocriticismo (positivismo “secondo”). La terza fase nella storia del positivismo è il neopositivismo, sorto negli anni '20 e '30. 20 ° secolo
L'ermeneutica (esplicativa, interpretativa) è un insieme di metodi e regole per l'interpretazione, la traduzione e la spiegazione del significato, del contenuto e del significato delle opere della cultura e della scienza (principalmente testi antichi). Inizialmente, i metodi dell'ermeneutica furono sviluppati in teologia, dove per ermeneutica si intendeva la dottrina della corretta interpretazione e traduzione dei testi biblici. All'inizio del XIX secolo. Schleiermacher ha tentato di creare l'ermeneutica come metodologia per l'interpretazione storica delle opere culturali, come l'arte di tradurre testi filosofici (in particolare Platone). Lo distinse dalla dialettica, che rivela il contenuto sostanziale delle opere, e dalla grammatica, associata all'analisi della loro lingua, e la ridusse alla rivelazione della maniera stilistica individuale di un particolare scrittore, rivelando il suo mondo spirituale. Nelle opere di numerosi filosofi e storici della cultura, l'ermeneutica comincia a essere interpretata come un metodo di analisi delle fonti storiche, che differisce dalla verifica della loro affidabilità storica. Come metodologia per le scienze culturali, l'ermeneutica è sviluppata appositamente da Dilthey. Lasciando da parte i metodi delle scienze naturali e umane, “spiegazione” e “comprensione”, vede nell'ermeneutica un metodo per comprendere l'originalità e l'integrità della vita creativa di un artista o filosofo, registrata nelle sue opere. A differenza della spiegazione scientifica naturale, l'ermeneutica, secondo Dilthey, non può rivendicare validità e affidabilità generali, e i suoi risultati non possono essere verificati o confutati, perché si basano sull'intuizione dell'interprete. Pertanto, i metodi dell’ermeneutica ricevono un’interpretazione irrazionalistica. Nella fenomenologia e nell'esistenzialismo l'ermeneutica si trasforma in un metodo per costruire un nuovo tipo di ontologia, in un modo per giustificare l'esistenza umana. Allo stesso tempo, il ruolo del linguaggio, così come del “sentimento” come mezzo per comprendere la vita di un'altra persona, è assoluto, sono dichiarati la base della comunicazione tra le persone, la condizione principale per la loro comprensione reciproca e , in definitiva, il senso della loro esistenza (Gadamer).
E.D. Vladimirova CONCETTI ANTROPOLOGICI DELLA SCIENZA MODERNA Parte I: paleoantropologia SAMARA 2008 3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA DELLA FEDERAZIONE RUSSA ISTITUTO EDUCATIVO STATALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE "UNIVERSITÀ STATALE DI SAMARA" DIPARTIMENTO DI ZOOLOGIA, GENETICA ED ECOLOGIA GENERALE E.D Vladimirova IE CONCETTI DI SCIENZA MODERNA Un libro di testo per i corsi “Concetti di scienze naturali moderne” e “ Antropologia" per studenti delle specialità "Sociologia" e "Lavoro sociale" Parte 1: paleoantropologia Samara Casa editrice "Univers Group" 2008 4
Concetti antropologici della scienza moderna. Libro di testo per i corsi “Concetti di scienze naturali moderne” e “Antropologia” per studenti delle specialità “Sociologia” e “Lavoro sociale”: in 2 parti Parte 1: paleoantropologia / E.D Vladimirova. Samara: Casa editrice "Univers Group", 2007. 103 p. Revisori: Ph.D. biol. Scienze S.I. Pavlov (Università pedagogica statale di Samsung), Ph.D. filosofo. Scienze A.N. Ognev (Università Samara Nayanova) Il manuale è scritto sulla base di lezioni tenute dall'autore agli studenti della facoltà di sociologia per più di dieci anni. Viene presentato il materiale che, di regola, causa le maggiori difficoltà agli studenti durante la loro preparazione indipendente utilizzando i libri di testo attuali. Oltre a temi tradizionalmente compresi nell'ambito dei problemi delle scienze naturali, dal punto di vista della biologia moderna, viene proposta una spiegazione di alcuni aspetti “nebbiosi” dell'antropologia culturale e filosofica. Conoscenze di questo tipo sono necessarie per formare una visione coerente della “natura” dell’Homo sapiens e dell’umanità nel suo complesso. Letteratura didattica, spiegazioni metodologiche, prove programmate vengono fornite sugli argomenti principali dei corsi "Antropologia" e "Concetti di scienze naturali moderne", toccando la moderna gamma di problemi della paleoantropologia, la teoria dell'evoluzione, la biologia dell'uomo moderno, Antroposociogenesi, origine del linguaggio e della coscienza. Il manuale è destinato agli studenti a tempo pieno del primo anno che studiano nella specialità "Sociologia", ma può essere utilizzato anche nel corso "Antropologia" dagli studenti della specialità "Lavoro sociale". Le attività di test hanno lo scopo di testare le conoscenze durante il lavoro in classe. Sono adatti anche per il lavoro autonomo degli studenti in preparazione a seminari, colloqui ed esami. La prima parte comprende 5 argomenti ed è incentrata principalmente sullo studio dell'origine naturale della specie Homo sapiens. UDC 572, 612.014 BBK 28.7, 15.5 Vladimirova, 2008 5
Concetti antropologici della scienza moderna Introduzione Per formare un quadro moderno, unitario e coerente del mondo, inclusa una visione scientifica dell'uomo, è particolarmente rilevante la sintesi delle informazioni fornite dalle discipline naturali e umanistiche. L'uomo, come sappiamo, è un essere sia biologico che sociale. Allo stesso tempo, le relazioni sociali delle persone, che hanno iniziato a prendere forma nel processo di evoluzione sociobiologica come forma di adattamento di gruppo, si basano su relazioni intersoggettive e si svolgono attraverso la comunicazione vocale. Entrando in interazioni adattive con il mondo esterno, trasformandolo, la personalità umana individuale funziona come un soggetto attivo che desidera il riconoscimento da parte di altre persone. Le persone hanno intelligenza grazie alla loro esposizione alla lingua e alla cultura nel loro insieme. La sfera delle relazioni socioculturali tra le persone è impensabile senza l'attività linguistica. Pertanto, in questo manuale, insieme alle questioni sull'evoluzione biologica della razza umana, grande importanza viene data ai problemi dei prerequisiti biologici e all'origine del linguaggio naturale 1. Attualmente, il contributo delle scienze naturali allo studio completo dell'uomo non può essere sopravvalutato. Per quanto riguarda lo studio umanitario dell'uomo, qui, fino a tempi recenti, prevaleva un punto di vista ampiamente riconosciuto, che giustificava la particolare specificità dei metodi delle discipline umanistiche. Secondo questa posizione, nelle “scienze dello spirito”, cioè nelle discipline umanistiche, la priorità non è la conoscenza “oggettiva”, quanto più libera possibile dalla posizione individuale del ricercatore (questo è il metodo e lo scopo delle scienze naturali). , ma “comprensione” 2. “Spieghiamo la natura, comprendiamo la vita mentale”, credeva il filosofo, psicologo e storico culturale tedesco Wilhelm Dilthey. Una caratteristica innovativa della scienza alla fine del XX e all'inizio del XXI secolo è l'emergere di metodi oggettivi di conoscenza umanistica, associati, prima di tutto, allo sviluppo della linguistica, in particolare della linguistica strutturale. Un altro punto di contatto tra le scienze umanistiche e le scienze naturali negli ultimi tempi riguarda l’idea di una relazione “genetica” tra i sistemi di comunicazione animale e il linguaggio naturale umano. "I sistemi di segni naturali precedono la lingua sulla scala dell'evoluzione della natura vivente, sono primari rispetto ad essa, e le lingue artificiali, nello stesso ordine di evoluzione, seguono la lingua, sono secondarie rispetto ad essa", scrive il più grande linguista russo, accademico Yu.S. Stepanov 3. 1 Le questioni relative all'evoluzione biologica della razza umana sono presentate principalmente nella prima parte del manuale, gli aspetti biologici e sociali dell'antroposociogenesi nella seconda. 2 Queste sono le idee dei filosofi I.G Herder, M. Weber, V. Dilthey, M. Heidegger e altri 3 Stepanov Yu.S. Semiotica. M.: Nauka, 1971. P. 47. 6
In questo manuale i fenomeni antropologici, tradizionalmente di interesse per le discipline umanistiche, sono esaminati dal punto di vista delle scienze naturali. Da questa posizione, la capacità simbolica umana, la comunicazione dei segni, il linguaggio, il rituale, la ragione, la coscienza e l'inconscio rappresentano le condizioni necessarie e le conseguenze storico-evolutive dell'adattamento naturale dei rappresentanti socializzati della specie Homo sapiens (L.). L'ordine di presentazione del materiale in questo manuale corrisponde alla sequenza del curriculum e del corso di lezioni approvati. Dopo il titolo dell'argomento vengono forniti i concetti principali, le idee di base e le principali disposizioni teoriche della sezione educativa. Questo materiale è una sorta di "guida" all'argomento, facilitando un'ulteriore comprensione indipendente delle informazioni. Questo manuale è la continuazione del manuale didattico “Antropologia” 1 pubblicato in precedenza, che contiene il programma generale del corso, letteratura aggiuntiva (più di 150 fonti), tabelle cronologiche esplicative, un glossario didattico e argomenti per abstract. Questo manuale, insieme agli appunti delle lezioni e ai libri di testo, deve essere utilizzato durante la scrittura di un saggio, nonché per la preparazione a seminari, prove, colloqui ed esami. Per prepararsi ai test, dovresti utilizzare anche il testo delle lezioni, nonché i libri di testo universitari su "Concetti di scienze naturali moderne" e "Antropologia". In alcuni casi, su alcune questioni del programma, viene offerta anche letteratura educativa speciale. Nel selezionarlo, il criterio principale era l'accessibilità del contenuto dei testi per gli studenti del primo anno che non avevano ancora conoscenze particolari. Durante la padronanza sequenziale del materiale didattico, non è consigliabile saltare i test. Se vengono forniti più test su un argomento, questi vengono organizzati in ordine di complessità e profondità del materiale. Le prove programmate sono progettate in modo tale che, oltre a valutare le conoscenze possedute dagli studenti al momento dello svolgimento della prova, durante lo svolgimento del compito della prova stessa, forniscano informazioni didattiche aggiuntive, stimolino gli studenti a riflettere, li invitino a provare a risolvere i problemi problema da soli e sottolineano le lacune esistenti nella conoscenza. Pertanto, il completamento dei test indicati in questo manuale è un requisito obbligatorio per l'apprendimento. Qualunque sia il risultato del test che hai completato, è necessario, dopo aver verificato e chiarito, ricordare le risposte corrette. Letteratura didattica di base per l'intero corso: 1. Antropologia. Libro di testo per studenti di istituti di istruzione superiore. Team di autori: V.M. Kharitonov, A.P. Ozhigova, E.Z. Godina, E.N. Khrisanfova, V.A. Bacevich. M.: Centro Editoriale Umanitario VLADOS, 2004. 2. Antropologia. Manuale didattico e metodologico per gli studenti delle specialità “sociologia” e “servizio sociale”. Comp. Vladimirova E.D. Samara: Casa editrice dell'Università di Samara, 1999, 2003. 3. Antropologia. Lettore. Libro di testo per studenti. Ed. DI. Feldstein. Mosca-Voronezh: MPSI, MODEK, 2003. 4. Gorelov A.A. Concetti delle scienze naturali moderne. Corso di lezioni. M.: Centro, 1998. 5. Tegako L.I., Salivon I.I. Fondamenti di antropologia moderna. Minsk, 1989. 1 Antropologia. Manuale didattico e metodologico per gli studenti delle specialità “Sociologia” e “Lavoro sociale” 1. Comp. Vladimirova E.D. Samara: Casa editrice dell'Università di Samara, 1999, 2003. 7
6. Tegako L., Klitinsky E. Antropologia. Esercitazione. M.: New Knowledge, 2004. 7. Harrison J., Weiner J., Tenner J., et al. Traduzione dall'inglese Ed. V.V. Bunaka. M., 1979. 8. Khasanova G.B. Antropologia. Esercitazione. M.: KNORUS, 2004. 9. Khomutov A.E. Antropologia. Rostov-on-Don: Phoenix, 2002. Letteratura didattica aggiuntiva per l'intero corso: 1. Antropologia. Lettore. Libro di testo / Compilatori: L.B. Rybalov, T.E. Rossolimo et al.: casa editrice IPO MODEK, 2003. 2. Budanov V.G., Melekhova O.P. Concetti delle scienze naturali moderne. M.: MGTUGA. 1998. 3. Dubnischeva I.A. Concetti delle scienze naturali moderne. Novosibirsk, SKEA: 1997. 4. Karpenkov S.Kh. Concetti di scienze naturali moderne: libri di testo per le università. M.: Cultura e sport, UNITI, 1997. 5. Kartashkin B.A. Concetti moderni delle scienze naturali. M.: LLP "Lux-art", 1997. 6. Roginsky Y.Ya., Levin M.G. Antropologia. M.: Educazione, 1978. 7. Ruzavin G.I. Concetti di scienze naturali moderne: libri di testo per le università. M.: Cultura e sport, UNITI, 1997. 8. Stepin V.S., Kuznetsova L.I. Quadro scientifico moderno del mondo. M.: Nauka, 1997. 9. Khrisanfova E.N., Perevozchikov I.V. Antropologia. M.: Casa editrice dell'Università statale di Mosca, 1991, 2007. Risorse Internet: 1. Arutsev A.A., Ermolaev B.V., Kutateladze I.O., Slutsky M.S. Concetti delle scienze naturali moderne. Esercitazione. Variante elettronica. http://zaoch.pomorsu.ru/multimedia/est/pos/index.html o http://www.philosophy.ru/edu/ref/kse/arucev/ 2. Vladimirova E.D. Antropologia. Manuale didattico e metodologico. Problemi chiave dell'antropologia. Prove di antropologia. http://www.ssu.samara.ru/~zoo/base/base.html 3. Gnatik E.N. Concetti di scienze naturali moderne: curriculum per argomento, letteratura, elenco di domande per lo studio autonomo. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/55201 4. Ivanov-Shats A.K. Concetti della scienza naturale moderna o “Universo, vita, mente”. http://www.limm.mgimo.ru/science/ 5. Naydysh V.M. Concetti delle scienze naturali moderne: http://www.iu.ru/biblio/archive/naydishev_koncepcija/13.aspx 6. Poteev M.I. Concetti di scienze naturali moderne: libro di testo elettronico. http://de.ifmo.ru/bk_netra/start.php?bn=12 7. Siparov S.V. Concetti di scienze naturali moderne: corso di lezioni http://www.philosophy.ru/edu/ref/kse/siparov/ 8
Argomento 1. Oggetto e compiti dell'antropologia moderna L'antropologia è un ramo interdisciplinare della conoscenza che studia in modo completo l'uomo e l'umanità in tutte le fasi del suo sviluppo, compreso il periodo di formazione evolutiva. L’unità dell’antropologia, che è essenzialmente un insieme di discipline scientifiche sull’uomo, crea un argomento specifico di questa scienza: “universali di tutta l’umanità”. In altre parole, oggetto dell'antropologia sono le proprietà integrative dell'umanità, che consentono di presentarla come un tutto unico. Una caratteristica dell’antropologia, come scienza interdisciplinare, è “l’analisi multidimensionale dei fenomeni studiati”. 11.1. Visione storica del tema dell'antropologia Il tema e i compiti dell'antropologia sono cambiati nel tempo, a seconda delle proprietà e delle qualità di una persona, che in un dato periodo di tempo erano considerate più degne di studio, nonché in base alle esigenze ideologiche della società. Il filosofo greco Aristotele, vissuto nel IV secolo a.C., prestò, ad esempio, particolare attenzione alle differenze tra animali e esseri umani, che considerava un “doppio essere” (biologico e sociale). Per l'antropologia moderna, gli aspetti della comprensione dei fondamenti biologici dell'esistenza dell'Homo sapiens sono ancora rilevanti. È anche interessante studiare le capacità “naturali” delle persone e le limitazioni loro “imposte” in relazione alla loro organizzazione somatica (corporea) o, come si dice anche, “biologia”. Negli ultimi 150 anni, il tema dell'antropologia ha subito cambiamenti significativi. Così, l'antropologo scozzese James George Fraser (1854-1941) studiò le caratteristiche culturali e antropologiche degli abitanti delle colonie britanniche e della popolazione della metropoli, considerando le differenze scoperte come l'oggetto principale della scienza dell'antropologia. Credeva che la società umana si evolvesse, passando successivamente attraverso tre fasi di sviluppo: magia, religione, scienza”. 2 In modo simile, condusse le sue ricerche l'antropologo e sociologo francese Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), che cercò differenze nel funzionamento dei meccanismi di pensiero di persone di diverse civiltà: tecnocratica e tradizionale. Attualmente, al contrario, l’enfasi principale in antropologia è sullo studio dei modelli universali che garantiscono gli adattamenti socio-biologici umani. I modelli generali che interessano gli antropologi si verificano a causa del fatto che tutte le persone moderne appartengono a rappresentanti socializzati della stessa specie, l'Homo sapiens, indipendentemente dalle specifiche realtà culturali e storiche della loro esistenza. Di grande interesse, quindi, è lo studio antropologico dei più 1 Tereshkovich P.V. Antropologia // Dizionario filosofico più recente. Minsk: Servizio Interpress, 1999, pag. 39.2 Tereshkovich P.V. Frazer // Dizionario filosofico più recente. Minsk: Servizio Interpress, 1999, pag. 782.9
caratteristiche adattative generali delle persone che sono caratteristiche di tutti i rappresentanti della specie Homo sapiens, sia quelli che hanno mai vissuto nella società sia quelli che vivono attualmente. L'antropologia studia le caratteristiche inerenti a qualsiasi Homo sapiens socializzato, indipendentemente dal tempo della sua esistenza sulla Terra o dall'appartenenza a una particolare civiltà. Quindi, dal punto di vista delle scienze naturali, l'antropologia può essere definita come la scienza dei metodi più generali di adattamento di un individuo socializzato. Di interesse per l'antropologia è anche lo studio dei modelli di formazione delle manifestazioni private e soggettive di vari fenomeni della natura umana. Il termine "antropologia" è di origine greca. Letteralmente la parola “antropologia” significa “scienza dell’uomo” (anthropos uomo, parola logos, conoscenza, scienza). Il primo utilizzo di questo termine è attribuito ad Aristotele, che usò la parola "antropologia" principalmente nello studio della natura spirituale dell'uomo. Nella scienza moderna dell’Europa occidentale ha messo radici una doppia comprensione del termine “antropologia”. L'antropologia è da un lato la scienza dell'organizzazione fisica e biologica dell'uomo, dall'altro la scienza delle caratteristiche della vita sociale, della cultura, della psicologia e del funzionamento dei sistemi simbolici di varie tribù e popoli nel mondo. passato e presente. Analizzando le priorità dell'antropologia occidentale, gli autori di uno dei libri di testo moderni scrivono che "l'antropologia americana è un livello intermedio di combinazione delle scienze dell'uomo e della società, gli inglesi preferiscono parlare di antropologia sociale, gli americani di antropologia culturale". 1 In Francia i termini antropologia, etnografia ed etnologia sono ampiamente utilizzati. Nella scienza domestica del periodo sovietico, i confini dell’antropologia erano significativamente più ristretti di quelli moderni. Gli antropologi sovietici studiarono principalmente le variazioni del tipo fisico di una persona nel tempo e nello spazio. “L’antropologia è una branca delle scienze naturali che studia l’origine e l’evoluzione dell’organizzazione fisica dell’uomo e delle sue razze.<...>Il compito dell’antropologia è quello di tracciare il processo di transizione dalle leggi biologiche che governavano l’esistenza dell’antenato animale dell’uomo alle leggi sociali”, informarono i lettori nel 1978 gli antropologi sovietici Ya.Ya. Roginsky e M.G. Levin. 2 L'antropologia nel nostro Paese è stata tradizionalmente classificata come scienza naturale, con riserve circa la sua posizione “speciale” nell'ambito delle discipline biologiche. Studiando l'antropologia nel periodo sovietico, si comprese che le caratteristiche principali della transizione dell'uomo dall'essere animale all'essere sociale erano già state scoperte e descritte nelle opere di uno dei fondatori del comunismo scientifico, F. Engels, “Dialettica della Natura”, “Antiduring”, “L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato””, “Il ruolo del lavoro nel processo di trasformazione della scimmia in uomo”. Queste opere furono create da F. Engels nel secolo scorso. Attualmente è generalmente accettato che F. Engels prevedesse l'importanza decisiva del ruolo speciale, “segno” dell'attività lavorativa nella formazione della socialità degli ominidi primitivi. Nel XX secolo è stato dimostrato che forme iconiche di attività assicurano l’“ingresso” del bambino, fin dalla nascita di un essere biologico, “nell’ordine sociale umano”. Questo processo di umanizzazione è caratteristico sia dell'ontogenesi che della filogenesi dell'Homo sapiens. Lo psicologo domestico L.S. Vygotsky, descrivendo il processo di socializzazione delle persone, ha sottolineato che “lo sviluppo culturale consiste nell'assimilazione di tali metodi di comportamento basati sull'uso e sull'uso dei segni come mezzi per 1 Meshcheryakov B., Meshcheryakova I. Introduzione alle scienze umane . M.: Russo. stato umanista Univ., 1994. P. 73. 2 Roginsky Ya.Ya., Levin M.G. Antropologia. M.: Scuola superiore, 1978. P. 7. 10
attuazione dell'una o dell'altra operazione psicologica.< > Lo sviluppo culturale sta proprio nella padronanza di quei mezzi ausiliari di comportamento che l'umanità ha creato nel processo del suo sviluppo storico, come la lingua, la scrittura e il sistema numerico." 1. Per questo motivo, nella seconda parte di questo manuale , grande importanza è data alle teorie sull'origine della parola nel processo di antropogenesi e ai modelli di funzionamento del linguaggio nella società moderna. Considerando la natura “biologica” dell'uomo, non dobbiamo dimenticare la sua dualità, o meglio, molteplicità. Da un lato, l'uomo è un animale sociale della classe dei piccoli mangiatori e dell'ordine dei primati, dall'altro è un essere spirituale, dotato di ragione, volontà, autocoscienza e con una specifica organizzazione mentale. La “spiritualità” si riferisce alla capacità di una persona di amare, creare, essere libera e stabilire il significato della propria esistenza. Queste, insieme al pensiero specifico e complesso, sono le qualità fondamentali che distinguono gli esseri umani dagli animali. Gli studenti di sociologia studiano in seguito le leggi della vita sociale delle persone e la psicologia umana. Uno degli obiettivi di questo corso di conferenze è mostrare che i meccanismi adattativi di base, le motivazioni e le risposte comportamentali dell'uomo, compresi i suoi aspetti spirituali, sono in gran parte basati sulla natura biologica dell'uomo, piuttosto che in opposizione ad essa. Secondo le parole del grande pensatore cristiano, il filosofo russo V.S Solovyov (1853-1900), l'anima umana è “incarnata” nell'involucro corporeo dell'Homo sapiens. La versatilità della natura umana è stata compresa a livello intuitivo da molti popoli che abitano il nostro pianeta. Nei miti di diverse culture ci sono idee simili sull'essenza dell'uomo, espresse in teorie cosmogoniche (cosmogonia, dal greco, l'origine del mondo, antropogonia, l'origine dell'uomo). Così, nelle antiche cosmogonie si dice che gli dei scesero dal cielo sugli animali terreni, e dalla fusione della parte superiore, “divina” del corpo e di quella inferiore, “animale”, furono create le persone. Successivamente, l'idea dell'esistenza degli animali, il "fondo" naturale dell'uomo, che costituisce il simbolismo della cultura del carnevale della risata, fu sviluppata dai filosofi russi M.M. Bachtin (1895-1975) e V.N. Voloshinov (1895-1936). Questa idea delle origini umane è profondamente simbolica. Lo spostamento di alcuni stimoli umani somatici 2 nella sfera inconscia della psiche, la loro ulteriore trasformazione simbolica, che avviene in conformità con le regole sociali, sono le scoperte più importanti della psicoanalisi moderna, senza le cui idee, così come senza le idee della linguistica strutturale , l’antropologia moderna non può essere immaginata. Il nome biologico della specie a cui appartiene l’uomo moderno, Homo sapiens (L), che viene tradotto dal latino come “uomo ragionevole, secondo Linneo”. Il termine fu proposto dal naturalista svedese Carlo Linneo (1707-1778), ideatore della nomenclatura binomiale (doppia) delle specie della natura vivente. Alcuni filosofi e scienziati considerano il nome Homo sapiens inadatto a persone che hanno intrapreso guerre infinite tra loro nel corso della storia umana, ma per la prima volta in biologia si è deciso di non cambiare il nome di questa specie, anche se in seguito si è scoperto che non si giustificava nel significato. In tempi diversi, alla razza umana sono stati dati nomi aforistici diversi. Aristotele definì l'uomo un "animale sociale", B. Franklin gli diede il nome di "animale che fabbrica utensili". C'erano nomi “uomo disarmato”, “uomo che parla”, “uomo che fa”. Dal nostro punto di vista, riflette nel modo più completo la situazione speciale di 1 Vygotsky L.S. Il problema dello sviluppo culturale del bambino // Vestn. Mosca un-ta. Ser. 14. Psicologia. 1991. 4. P. 6. 2 Stimolo somatico, in questo contesto uno stimolo proveniente dal funzionamento del corpo. undici
nome della specie umana "homo dualus", dato dal naturalista francese Georges Buffon (1707-1788). Questo nome riflette il fatto che, in una certa misura, l'uomo è un animale, poiché ha l'organizzazione corporea dei primati, e d'altra parte, l'uomo, in senso figurato, è un "figlio degli dei", poiché ha un desiderio di ricerca del senso più alto dell'esistenza e della perfezione. La duplice natura dell'uomo fu notata, ovviamente, dalla scienza sovietica, ma non erano i principi animali e spirituali dell'uomo ad essere opposti, ma, di regola, quelli biologici e sociali. I principali metodi antropologici nell'URSS erano metodi biologici: paleoantropologia, anatomia comparata, embriologia. Il corso dell'antropogenesi è stato considerato sulla base di una sintesi di biologia, archeologia e filosofia marxista-leninista. Attualmente, i lavori degli scienziati che si definiscono antropologi riflettono i problemi dell'antropologia strutturale, della linguistica antropologica, dell'antropologia filosofica, insieme al tema tradizionale dell'antropologia fisica. Quindi, tenendo conto dell'esperienza nazionale ed estera, la seguente definizione del soggetto dell'antropologia sembra essere quella di maggior successo: “L'antropologia è la scienza dell'universale e dell'oggettivo nella natura umana e dei modelli di manifestazione del particolare e del soggettivo. La natura umana significa norme, costumi, comportamenti, istinti, istituzioni sociali, sia esistenti da tempo immemorabile, inerenti a tutte le persone, sia individuali e speciali, caratteristiche di una data società e di un dato individuo. Soffermiamoci su alcuni dei problemi antropologici più urgenti della scienza naturale moderna. 1.2. Problemi attuali dell'antropologia moderna Uno dei problemi più importanti dell'antropologia è identificare le specificità dell'Homo sapiens come specie biologica e essere sociale. È possibile far luce su questo problema studiando lo sviluppo evolutivo delle persone, identificando i fattori che hanno portato all'emergere della società umana. Consideriamo le ragioni principali della sfiducia della coscienza quotidiana (cioè quotidiana, non scientifica) nei confronti del quadro scientifico naturale dell'antroposociogenesi. L'uomo 1 discendeva da antenati comuni con le scimmie moderne e questo processo naturale seguiva le leggi caratteristiche dell'evoluzione di tutta la natura vivente. Tali idee sono chiamate scienze naturali. Le idee mitiche più comuni sull'evoluzione umana, caratteristiche dei nostri contemporanei, includono le seguenti opinioni. 1) L'uomo non si è evoluto; Dio ha creato la forma moderna e già pronta dell'uomo. Questa idea è smentita da numerosi ritrovamenti paleoantropologici e archeologici. 2) L'uomo si è evoluto da forme di vita che non hanno nulla in comune con le scimmie moderne. Sorpresi dalle enormi tracce dell'attività umana in un lontano passato, in un'epoca in cui non esisteva la tecnologia moderna, alcune persone comuni credono che questi oggetti siano la creazione non di mani umane, ma di mani aliene. Gigantesche piramidi di pietra, statue dell'Isola di Pasqua e antichi edifici religiosi trovati nell'Inghilterra moderna danno origine a fantasie sull'origine extraterrestre delle persone. Alcuni credono che l'uomo discenda da alcune fantastiche razze di umanoidi arrivate da altri pianeti. Il poeta Joseph Brodsky ha le seguenti righe: 1 Stiamo parlando del corpo di una persona, non della sua anima. 12
Ero in Messico, scalando le piramidi. Masse geometriche impeccabili sono sparse qua e là sull'istmo di Teguantepec. Mi piacerebbe credere che siano stati eretti dagli alieni spaziali, perché di solito queste cose vengono fatte dagli schiavi. E l'istmo è costellato di funghi di pietra. In effetti, in tempi lontani, le persone trattavano lo sforzo sovrumano della forza fisica in modo diverso rispetto ai giorni nostri, molto più con noncuranza, poiché gli sforzi muscolari del lavoro vivo erano apprezzati molto meno. Pertanto, ai nostri contemporanei un'attività così estremamente laboriosa dei nostri antenati può sembrare non plausibile. L'immaginazione suggerisce idee sulla parentela umana con sirene da favola, persone innevate e "della foresta". Altri credono che le persone provengano dagli abitanti ormai estinti della mitica Atlantide. Le persone lontane dalla scienza a volte “raccolgono” miti scientifici sull'antico passato dell'umanità, presentati dalla stampa come una sensazione. I lettori scarsamente istruiti sono convinti che “per uno studio storico completo non siano affatto necessarie una formazione professionale e conoscenze specifiche, anzi, impediscono addirittura di “lasciare volare liberamente la propria immaginazione”1 of the Future” si basa su tale psicologia, quando lo spettatore “prende con entusiasmo questo gioco di “scienza pubblica”, permeato ad ogni passo dalla convinzione che risolvere enigmi scientifici e interpretare monumenti storici non sia molto più difficile che risolvere una farsa o un cruciverba."<...>l'immagine risultante “per le persone non iniziate è più attraente dei concetti “noiosi” e “nebbiosi” degli scienziati” 2. 3) Vari gruppi microsociali o tribù di persone hanno avuto origine dall'uno o dall'altro totem. In generale, il totemismo è la convinzione dei popoli primitivi che i singoli gruppi sociali facciano risalire le loro origini a una o all'altra specie di animali, piante, elementi del paesaggio e altri oggetti circostanti o fenomeni quotidiani. L'Australia, ad esempio, è solitamente chiamata il “paese del totemismo”, poiché questa credenza religiosa è caratteristica degli aborigeni australiani ed è lì molto diffusa. Le visioni totemistiche sono attualmente caratteristiche dei rappresentanti dei popoli paleo-asiatici del nostro paese. Ad esempio, i Chukchi, i Koryaks, i Nenets e gli Aleutini fin dai tempi antichi credevano di discendere dagli animali corvo, ragno, lupo e renna. D’altronde, come ha rivelato l’antropologo francese C. Lévi-Strauss, il totemismo non è soltanto una religione. Il totemismo, secondo Levi-Strauss, è un metodo visivamente sensuale, cioè piuttosto primitivo, per classificare la società in raggruppamenti 3. Tali opinioni sul proprio posto nella società, quando una persona ha bisogno di un segno esterno per comodità di autoidentificazione pratica , sono radicati negli strati profondamente inconsci dell'anima e si rivelano anche tra le persone moderne. Ad esempio, per la maggior parte dei residenti della Russia del XX secolo, era necessario identificarsi socialmente con gli operai o i contadini, nascondendo le proprie origini alla nobiltà, alla borghesia o all’intellighenzia, se presente. L'origine "corretta" ha aiutato l'individuo a identificarsi con il concetto di "noi", che ha portato molti vantaggi pratici nella vita e lo ha salvato dalla repressione. Queste sono le visioni mitiche più comuni sull'origine delle persone. La scienza sostiene che i primi uomini apparvero in Africa circa 2,3 2,7 milioni di anni fa, in 1 Cit. di: Meshcheryakov B., Meshcheryakova I. Decreto. cit., p.125. 2Ibidem. 3 Più sviluppati (astratti) sono i metodi di classificazione concettuali piuttosto che simbolici. Le associazioni primitive di un fenomeno con qualche segno "utile" furono chiamate "bricolage" da C. Levi-Strauss. 13
il risultato dell'evoluzione dei primati fossili. Nonostante la parentela biologica tra gli esseri umani moderni e gli scimpanzé moderni, con i quali gli esseri umani condividono il 95-98% dell’identità genetica, le differenze fondamentali tra esseri umani e animali dovrebbero essere descritte non nel campo della biologia, ma nel campo della pratica sociale. Solo l'uomo ha coscienza, pensiero concettuale e parola; trasforma il suo ambiente attraverso sforzi di lavoro volontario e non si adatta passivamente ad esso, come fanno gli animali. Il problema più importante dell'antropologia è lo sviluppo di criteri per l'appartenenza degli ominidi fossili al genere Man. Gli animali non hanno storia, né antenati. Con essi «l'individuo scompare completamente nel genere, e nessun tratto memorabile distingue la sua nascita effimera da quella successiva, destinata a riprodurre il genere, mantenendo l'immutabilità del tipo», scriveva Jacques Lacan, psicoanalista francese. fondatore della direzione strutturale-linguistica della psicoanalisi 1. L'uomo fossile diventa “effettivamente” una persona quando inizia a seppellire i suoi antenati, facendo ciò nel rispetto delle norme sociali e delle regole da loro ereditate, “introducendo così questi concetti nella sua coscienza .”< >“Il primo simbolo in cui riconosciamo l'umanità dai suoi resti è la tomba” (J. Lacan) 2. Un altro strato di problemi antropologici moderni è associato alla necessità di coltivare la tolleranza verso i rappresentanti di altri strati sociali della società, culture e nazionalità. La tolleranza verso gli “altri” diventa particolarmente rilevante in connessione con lo sviluppo di nuove forme di armi e la diffusione dell’estremismo religioso. Da questo punto di vista, la visione dell’umanità formata dall’antropologia scientifica come entità integrale con un’origine comune diventa di grande importanza nella formazione della tolleranza etnica (e di classe). Perché la teoria evoluzionistica dell'origine umana incontra spesso un'opposizione attiva, che può essere osservata anche tra persone altamente istruite, personaggi della cultura, famosi umanisti, per non parlare della gente comune? Nella società moderna, ci sono una serie di ragioni per la sfiducia delle persone nei confronti del quadro scientifico naturale dell’antroposociogenesi, che sono di natura socioculturale, esistenziale e psicologica. Le persone che hanno poca familiarità con i fatti antropologici credono erroneamente che più l'antenato di una persona è antico, più è simile alle scimmie moderne: ha capelli più spessi, mascella inferiore più grande, zanne più pronunciate, arti superiori più lunghi, andatura tozza, ecc. . È assolutamente chiaro che, già a livello inconscio, nessuno vuole avere tra i propri “antenati” una creatura che appartenga ai film horror. Pertanto, la frase pronunciata da un prete a un biologo evoluzionista ai tempi di Charles Darwin è “destinata al successo” tra il grande pubblico: “I tuoi antenati potrebbero essere stati scimmie, ma i miei antenati erano persone”. È noto il seguente fatto storico. “Nel secolo scorso, nella famosa disputa di Oxford, il vescovo Wilberforce chiese ironicamente al difensore del darwinismo Huxley: in che linea si considera un discendente di una scimmia - attraverso sua nonna o suo nonno? Huxley rispose con un tono che avrebbe preferito venire da una scimmia piuttosto che da un uomo che ficca il naso in qualcosa che non capisce. 3 Così, per molti anni, “il darwinismo è diventato uno spauracchio con cui spaventare le persone pie” 4. Il punto di vista materialistico sull’origine dell’uomo nel nostro paese è stato impiantato con la forza per molti anni, e l’alternativa (divina, cosiddetta 1 Lacan J. Funzioni e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi. M.: Gnosis, 1995. 2 Ibid. 3 Citato da: Men A. Storia della religione: Alla ricerca della via, della verità e della vita: Slovo,. 1991. P. 200. 4 Idem
“creazionismo”) non veniva affatto insegnato nelle istituzioni educative secolari. La distruzione dell’ideologia comunista e il conseguente vuoto ideologico portarono al rafforzamento delle posizioni separatiste e religiose nella società. È noto dalla psicologia sociale che, in caso di disaccordo con le autorità pubbliche, le persone si fidano più facilmente delle idee opposte rispetto a quelle ortodosse 1, inoltre, la religione è un sistema psicoterapeutico collaudato nel tempo. Contrastando sconsideratamente l'origine dell'uomo “da Dio” con l'origine “dalla scimmia”, va tenuto presente che in alcune confessioni religiose, ad esempio nel cattolicesimo, il punto di vista religioso sull'origine dell'uomo non contraddice la teoria evolutiva. Gli aderenti a una posizione che concilia gli opposti tra creazionismo e darwinismo, pur mantenendo la fede in Dio, credono che la natura abbia un'origine divina, ma allo stesso tempo intendono che una delle proprietà della natura insita in essa dall'Essere Supremo è la capacità degli organismi viventi di evolversi secondo quelle leggi, divenute note alla biologia moderna. Il punto di vista della Chiesa su questo tema si riflette nell'enciclica del papa cattolico Pio HP "Sulla razza umana". Questo documento della Chiesa afferma che la Chiesa raccomanda di studiare la teoria evoluzionistica "nella misura in cui la ricerca suggerisce l'origine del corpo umano da materia vivente preesistente, ma attenendosi al fatto che le anime sono create direttamente da Dio". L'enciclica papale fu pubblicata nel 1958. Questo approccio si basa sull'idea della creazione divina del mondo come un processo (atto), al quale prendono parte le persone che vivono oggi, e non un singolo evento (fatto) della creazione del mondo immutato una volta, allo stesso tempo certo momento. L'autore del testo di questo manuale ritiene che con l'aiuto dei metodi e dei dati fattuali delle scienze naturali sia impossibile provare o confutare la creazione del mondo e la natura della Terra da parte di Dio. Molti scienziati aderiscono allo stesso punto di vista. Il fatto è che le scienze naturali si occupano di fenomeni regolari e ripetitivi e la creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, secondo i credenti, è un fenomeno di importanza unica, che non ha analoghi naturali, che si è verificato una volta. Di conseguenza, questo gruppo di fenomeni non rientra nella competenza delle scienze naturali 2. Ulteriore letteratura sull'argomento: 1. Malyshevsky A.F. Mondo umano. Esperienza del concetto di educazione filosofica. M.: Interprax, 1993. 2. Meshcheryakov B., Meshcheryakova I. Introduzione alle scienze umane. M., 1994. 3. Minyushev F.I. Antropologia sociale. Uh. indennità. M.: Progetto accademico, 2004. 4. Il mondo dell'uomo. Lettore. M.: Interpraks, 1995. 5. Raigorodskaya I.A., Raigorodskaya Zh.I. Antropologia. Corso di lezioni. Esercitazione. M.: Casa editrice dell'Accademia agricola di Mosca, 2003. 6. Tegako L., Klitinsky E. Antropologia. Esercitazione. M.: Nuova conoscenza, 2004. 7. Sharonov V.V. Fondamenti di antropologia sociale. San Pietroburgo: Casa editrice Lan, 1997. 1 Aronson E. Animale sociale. Introduzione alla psicologia sociale / Trans. dall'inglese AA. Kovalčuk, ed. V.S. Maguna. M.: Aspect-Press, 1999. 2 Sfortunatamente, l'autore del manuale è abituato a ignorare questo principio nella formazione dei sacerdoti ortodossi. L’insegnamento della teoria apparentemente “scientifica” dell’evoluzione della vita sulla Terra è stato condotto da un professore di fisica sulla base di storie bibliche e dell’esperienza quotidiana del docente secondo i canoni della versione ortodossa della religione ortodossa. 15
Prova 1 Connessioni interdisciplinari dell'antropologia. Il posto dell'antropologia tra le altre scienze Completa le seguenti affermazioni scegliendo il termine o concetto appropriato dal seguente elenco: a) ominizzazione; b) antropogenesi; c) polimorfismo; d) Carlo Darwin; e) antropologia; f) Aristotele; g) adattamento; g) antropologia filosofica; h) Immanuel Kant; i) Claude Lévi-Strauss; j) istinto; j) filogenesi; k) ecologia; l) etologia; m) etnologia; o) zoopsicologia; n) antroposociogenesi; p) paleontologia; c) linguistica; r) antropogeno; y) Paleolitico; t) tassonomia; x) metodo; v) determinazione; h) immunologia; w) fisiologia umana; y) J. Fraser; b) scienze cognitive (teoria della conoscenza); s) ambito sociale; b) antropologismo; e) sociobiologia; j) antropometria; i) fenotipo. Le risposte devono essere formattate come segue (ad esempio): 1c; 2a; 3t; e così via. 1. La scienza dell'uomo, che occupa una posizione di confine nel sistema delle discipline dei cicli naturali e umanitari, è. 2. Il problema centrale dell'antropologia evoluzionistica. 3. La formazione di una persona nel processo di formazione della società è chiamata 4. Scienza che studia le funzioni del corpo umano, i processi che si verificano in esso, il metabolismo, l'adattamento all'ambiente di vita. 5. Disciplina biologica che studia la resistenza degli organismi viventi alla penetrazione di proteine e polisaccaridi estranei, inclusa la reazione agli agenti infettivi 6. Viene chiamata la presenza di diverse forme diverse all'interno di un tipo di organismo vivente. 7. Per la prima volta è stato utilizzato il termine “antropologia”.... 8. La sfera della conoscenza che comprende i problemi della natura umana e dell'esistenza umana, determina il posto dell'uomo nel quadro moderno del mondo è 9. A Antropologo francese che ha ampiamente utilizzato metodi umanitari di linguistica strutturale e semiotica per dimostrare i processi di pensiero di parentela dei "primitivi" e rappresentanti di civiltà tecnicamente sviluppate, filosofo-strutturalista, ricercatore delle popolazioni indigene del Sud America è 10. L'insieme di tutti gli aspetti interni ed esterni vengono chiamate caratteristiche e proprietà di un individuo, formate sulla base del genotipo dell'individuo nel processo della sua ontogenesi. 11. Il campo della conoscenza che studia le relazioni degli organismi e delle loro comunità con l'ambiente è. 12. La scienza del comportamento animale in condizioni naturali lo è. 13. La scienza che studia i modelli che caratterizzano le peculiarità della costruzione di modelli di realtà da parte degli animali. 14. Scienza che spiega l'origine, l'insediamento, le connessioni culturali, quotidiane, socio-psicologiche e le relazioni delle nazionalità. 15. Viene chiamato il processo di "umanizzazione" di una scimmia. 16. Disciplina biologica che studia gli organismi fossili, le loro relazioni familiari e le condizioni di vita. 17. Un altro nome per la linguistica è. 18. Il periodo più antico dell'età della pietra, così chiamato per le peculiarità dello sviluppo culturale e tecnico degli antenati dell'uomo moderno. 16
19. L'ultimo dei periodi geologici dell'era Cenozoica (l'era della “nuova vita”), che si divide in Pleistocene e Olocene. 20. Una branca della biologia dedicata alla descrizione, designazione e classificazione sistematica di tutti gli organismi esistenti ed estinti, nonché alla creazione di relazioni correlate tra singole specie e gruppi di specie. 21. Un insieme di tecniche e operazioni per lo sviluppo teorico della realtà, il percorso di uno scienziato per comprendere l'oggetto di studio, dato dalle ipotesi principali. 22. Nome latino per determinare le condizioni di un processo o fenomeno. 23. Una forma di comportamento (innata) evolutivamente sviluppata caratteristica degli animali di una determinata specie, che garantisce la loro adattabilità alle condizioni ambientali più stereotipate. 24. In biologia viene chiamato un complesso di caratteristiche adattative di un individuo, popolazione o specie che garantisce la sopravvivenza e la competizione di successo. 25. Una scienza che combina metodi utilizzati in psicologia, informatica, linguistica, filosofia e neuroscienze per spiegare come funziona la mente umana. 26. Un insieme di fattori interagenti di natura sociale che influenzano il comportamento di un individuo o gruppo di persone. 27. Un approccio sociologico che costruisce il concetto di società basato su una certa comprensione dell'essenza dell'uomo. 28. La scienza, situata all'intersezione tra la conoscenza delle scienze umanitarie e quelle naturali, il cui oggetto è la ricerca dei “confini” tra i fondamenti biologici e specificamente umani dell'Homo sapiens a, è chiamata. Test 2 Oggetto, soggetto e metodi dell'antropologia Compito: Selezionare la risposta corretta (o le risposte corrette) tra le opzioni proposte. Completa il lavoro come segue (ad esempio): 1a, b; 2b; 3 g. 1. Studi di antropologia fisica: a) il tipo fisico, il funzionamento mentale e la struttura sociale dei rappresentanti delle culture tradizionali (cioè rappresentanti dei moderni popoli primitivi) rispetto alle caratteristiche corrispondenti dei rappresentanti delle moderne società tecnocratiche. b) comprendere i fondamenti biologici dell'uomo, nonché il problema dell'adattamento (adattamento) di un individuo socializzato in una direzione personale (sociale), cioè nell'interazione con altre persone; c) il funzionamento, l'adattamento e la diversità delle forme dei rappresentanti del genere Homo nella serie evolutiva, nonché le variazioni razziali e costituzionali (somatotipiche) delle persone moderne. 2. L'antropologia sociale è una scienza che studia i seguenti problemi: a) la diversità delle razze e delle costituzioni dell'uomo moderno; b) i meccanismi mentali e la vita sociale dei selvaggi; c) problemi generali di adattamento personale nella società; d) società primitiva. 17
3. La “duplice”, nelle parole di Aristotele, la “natura umana” è spiegata nella scienza moderna dalle seguenti circostanze: a) nella sua pratica sociale quotidiana, una persona è costretta a fare una scelta tra due aspirazioni contraddittorie: istintiva e culturale . La ragione di questa dualità è che la vera natura dell'uomo, ereditata dai suoi antenati scimmieschi biologici, è opposta alle esigenze della cultura; b) in primo luogo, una persona vive nella realtà somatica (corporea), cioè si adatta e agisce secondo i bisogni biologici dell'essenza corporea dell'Homo sapiens, in cui è incarnata l'anima umana. Tali bisogni possono essere la fame, la sete, il bisogno di riposo, ecc. In secondo luogo, una persona vive nella realtà sociale, cioè agisce in conformità con la necessità di riconoscere i suoi desideri, azioni, valutazioni da parte della società. 4. Oggetto di ogni scienza, inclusa l'antropologia, è: a) un elenco di domande e problemi che questa scienza deve affrontare; b) teorie, concetti, approcci che consentono di costruire modelli scientifici, pianificare osservazioni ed esperimenti, spiegare i dati ottenuti e porre nuove domande; c) l'area della realtà di cui si occupa questa scienza. 5. Oggetto di qualsiasi scienza, compresa l'antropologia, è a) problemi e questioni di interesse per questa disciplina scientifica; b) metodologia della scienza (dottrina filosofica sui modi più generali di organizzare il processo di cognizione e costruire l'attività teorica), metodi utilizzati da questa scienza, nonché metodi specifici per ottenere dati sperimentali; c) l'apparato categorico di una data scienza: i suoi assiomi, concetti e termini di base che fanno parte di modelli scientifici accettati dalla maggior parte delle scuole e direzioni teoriche. 6. Il metodo scientifico, in contrasto con una metodologia specifica, è a) competenze tecniche, principi, regole e metodi per organizzare il processo per ottenere dati empirici (sperimentali) specifici; b) il percorso verso la conoscenza, fissato da un'ipotesi, un insieme di tecniche per lo sviluppo teorico della realtà. 7. Oggetto dell'antropologia possono essere a) l'uomo e l'umanità nel suo insieme; b) evoluzione umana; c) costituzioni somatiche dell'uomo moderno; d) antroposociogenesi. 8. L'antropologia nella scienza moderna è convenzionalmente divisa in descrittiva ed esplicativa. Nell'antropologia descrittiva, la base per unificare la conoscenza sull'uomo e sull'umanità è la filosofia. Le funzioni della filosofia, in questo contesto, sono le seguenti: a) definisce l'apparato concettuale della scienza, offre un approccio teorico alla comprensione della materia (ad esempio, in antropologia tali approcci teorici possono essere evolutivi, comparativi, ecc. ); b) assicura la comprensione sistematica dell'oggetto studiato, come parte della realtà, e del soggetto, come insieme di problemi studiati. 18
9. Secondo il quadro scientifico naturale dell'antropogenesi, l'uomo discende dagli antenati biologici attualmente estinti degli animali della classe dei mammiferi appartenenti all'ordine dei primati. Allo stesso tempo, durante le trasformazioni degli antichi primati e degli organismi che li hanno preceduti, si sono verificati cambiamenti evolutivi, in primo luogo, secondo le stesse leggi secondo le quali tutti gli organismi viventi che vivono sulla Terra si sono evoluti e si stanno evolvendo, e, in secondo luogo, ha avuto luogo l'evoluzione sotto l'influenza di quegli stessi fattori di evoluzione noti alla moderna teoria sintetica in relazione all'evoluzione di tutti gli altri animali, piante, funghi, microrganismi e virus. Nelle fasi finali dell'evoluzione degli esseri umani fossili, anche l'isolamento culturale entrò in gioco come fattore evolutivo. Dalle seguenti idee che raccontano l'apparizione dell'uomo sulla Terra, seleziona quelle che non contraddicono la teoria delle scienze naturali (l'immagine naturale dell'antropogenesi): a) creazionismo (la creazione dell'uomo da parte di un essere superiore); b) la teoria dell'intervento delle civiltà extraterrestri; c) idee espresse nei miti dei popoli del mondo; d) teoria evoluzionistica di Charles Darwin; e) moderna teoria sintetica dell'evoluzione. 10. Secondo una definizione, l’antropologia è la scienza degli “universali umani”, intesi come i modelli di adattamento sociale e biologico inerenti a tutte le persone, indipendentemente dal tempo e dal luogo specifici in cui risiedono. Le ragioni dell'esistenza di tali leggi universali, che descrivono le proprietà di tutti gli individui socializzati e controllano il comportamento delle persone, sono: a) identici somatici (cioè organizzazione corporea) dell'Homo sapiens a, gli stessi bisogni biologici del corpo, presente in rappresentanti di tutte le razze, nazionalità, popolazioni e gruppi microsociali di persone che vivono sulla Terra; b) l'esistenza di persone in condizioni ambientali relativamente simili (alternanza del giorno e della notte, stagioni). Metodi di base identici di categorizzazione (cioè di ordinamento per concetti) di eventi e fenomeni, basati sulla classificazione della realtà rispetto agli assi e ai bisogni del proprio corpo. Modi significativamente simili di valutare gli eventi nel mondo esterno, basati sull'unità delle motivazioni e aspirazioni umanistiche di base delle persone; c) la presenza di identiche immagini mentali iniziali “incorporate” nella psiche delle persone dall'Essere Supremo; d) pensiero logico basato sulla formulazione concettuale e consapevolezza dei significati linguistici. Il pensiero logico è apparso nel processo di antroposociogenesi, come conseguenza dello sviluppo dell'attività razionale socialmente normalizzata degli antichi, in connessione con la vita in mezzo a pericoli imprevedibili e con la consapevolezza della paura della morte; e) la presenza di strutture universali che operano sulla base di opposizioni binarie (es. doppie opposizioni) e sintassi logica, nelle lingue naturali di qualsiasi gruppo etnico di persone. 11. Studi di antropologia strutturale: a) la struttura interna del corpo umano; b) la struttura dei processi evolutivi avvenuti durante l'antroposociogenesi; c) fatti della vita sociale delle persone, che rivelano significati e significati nascosti dietro di loro, per analogia con la struttura del linguaggio naturale e la struttura del funzionamento dello strato inconscio della psiche. 19
Argomento 2. Regolarità del processo evolutivo 2.1. Principi di base dell'evoluzione Il processo evolutivo è lo sviluppo della natura vivente, a seguito della quale compaiono nuove forme di esseri viventi, meglio adattate alle condizioni del loro habitat. Il pianeta Terra, lo spazio, il mondo intero cambiano costantemente, questa è una legge della natura. Compresi i cambiamenti nell'ambiente esterno degli organismi viventi. L'espressione "forme meglio adattate", presa in relazione agli esseri viventi, significa che l'idoneità delle nuove forme di vita che sono apparse come risultato del processo evolutivo e si sono diffuse è, di regola, superiore all'idoneità delle precedenti forme. 1 In altre parole, l'“adattamento” della struttura e delle funzioni delle nuove forme di vita alle esigenze del mondo esterno è più coerente con le mutate condizioni della loro esistenza. Inoltre, gli stessi organismi viventi e le loro comunità ecologicamente interconnesse, formatesi durante l'evoluzione, diventano costantemente più complessi e migliorati. Emergono nuovi principi di adattamento e il ritmo dell’evoluzione stessa accelera. Pertanto, gli antichi organismi che vivevano sulla Terra si adattarono principalmente attraverso la comparsa di caratteristiche morfologiche più complesse, e questo fu un processo molto lento. Con la comparsa dei mammiferi sulla Terra, nell'arsenale degli esseri viventi si è diffuso un nuovo metodo di adattamento attraverso un comportamento adattivo appropriato. Con l'avvento dell'uomo, la vita sulla Terra ha gradualmente acquisito forme intelligenti e attualmente sulla Terra si sta formando la Noosfera. La capacità di evoluzione degli organismi viventi è dimostrata più chiaramente dalla selezione artificiale, cioè dall'allevamento di razze animali e varietà vegetali che prima non esistevano in natura, secondo le preferenze stabilite dalle persone che effettuano la selezione. Allo stesso modo, la selezione naturale “produce” l’habitat degli esseri viventi. La selezione artificiale dimostra che le specie di organismi viventi si modificano con relativa facilità e rapidità, a causa della naturale variabilità ereditaria insita negli esseri viventi, sotto l'influenza di influenze esterne unidirezionali. Formuliamo le principali leggi del processo evolutivo (sono evidenziate in corsivo di seguito). L'evoluzione avviene come risultato della selezione naturale basata sulla variazione ereditaria. L'adattabilità (cioè l'idoneità) di un particolare gruppo di organismi viventi è sempre relativa: può essere valutata solo in relazione alle condizioni di esistenza di questo gruppo. Una conseguenza dell'elevata forma fisica, secondo un noto evoluzionista domestico, è la popolazione 1 Se, come risultato dell'evoluzione, appaiono gruppi di esseri viventi che si sono adattati peggio dei loro "vicini" e "parenti" alle mutate condizioni, tali gruppi degli organismi, di regola, muoiono. Un quadro simile si osserva se il processo evolutivo non tiene il passo con i cambiamenti esterni. Il processo di estinzione, così come la "scala" evolutiva delle forme successivamente modificate di qualsiasi gruppo in via di sviluppo di organismi viventi, è un fenomeno evolutivo diffuso. 20
biologo e ambientalista della fauna selvatica A.V. Yablokov, risulta che "il maggiore successo di alcuni genotipi rispetto ad altri", espresso in "elevata fertilità e probabilità di raggiungere l'età riproduttiva" 1. Il processo evolutivo di qualsiasi specie o gruppo sistematico non può essere completamente completato (a meno che questo gruppo non sia estinto), poiché gli organismi viventi (individui, popolazioni, biocenosi) non possono essere adattivi “da soli”, ma solo in relazione alle condizioni della loro esistenza. Le condizioni di vita, come l'intero mondo materiale, sono soggette a continui cambiamenti. Il processo di evoluzione degli organismi viventi è irreversibile. Nessuna specie di organismo vivente può trasformarsi nel suo antenato evolutivo. I singoli gruppi possono regredire, adattandosi all'ambiente utilizzando metodi evolutivamente obsoleti, ma, in generale, il processo evolutivo va solo avanti. Il quadro dell'evoluzione unidirezionale si osserva in natura perché, insieme ai processi regolari noti alla moderna scienza biologica, i fattori casuali svolgono un ruolo importante nel corso dell'evoluzione. La sequenza d'azione dei fattori evolutivi “casuali” non può essere ripetuta mediante movimento retrospettivo, cioè movimento nella direzione temporale inversa, non solo in natura, ma anche in un modello di laboratorio più o meno complesso nella moderna teoria sintetica dell'evoluzione , le mutazioni e la deriva sono considerati i principali fattori dei cambiamenti evolutivi geni, selezione naturale, selezione sessuale, fluttuazioni periodiche naturali nella dimensione della popolazione, isolamento, flusso genetico che si verifica a seguito di migrazioni (trasferimenti) Sebbene i singoli organismi cambino nel corso dell'evoluzione , non sono gli individui che si evolvono, ma le popolazioni e gli ecosistemi. Le popolazioni sono polimorfiche, cioè sono costituite da organismi che differiscono tra loro: sia geneticamente che fenotipicamente, alcuni organismi inclusi in una determinata popolazione corrispondono meglio di altri a quella attuale. “richieste” dell’ambiente, altre sono peggiori, ma allo stesso tempo, in questo caso, ad esempio, possono avere caratteristiche geneticamente codificate che sono di scarso significato in un dato momento, ma sono necessarie per la sopravvivenza in un ambiente cambiato. Diversi organismi della stessa popolazione hanno un potenziale diverso per le dinamiche di forma e funzione. Il polimorfismo delle popolazioni è la chiave della loro vitalità, la capacità di subire cambiamenti evolutivi, la dinamica del rapporto quantitativo di organismi con caratteristiche diverse e, in definitiva, la chiave della loro sopravvivenza. Secondo i ricercatori moderni 2, per l'evoluzione umana, tra tutti i fattori evolutivi, l'isolamento e, in particolare, quello culturale, diventa il fattore decisivo. Apparentemente, diversi gruppi di ominidi fossili che vivevano in territori adiacenti e avevano organizzazioni sociali diverse differivano anche per diversi gradi di adattabilità. In tali microsocietà, la principale forza trainante dei cambiamenti evolutivi era una combinazione di fattori non biologici, ma socio-psicologici. L'isolamento culturale di alcuni gruppi di popoli antichi era apparentemente basato sull'identificazione di alcuni individui con il loro gruppo. Questa forma di isolamento, assente nei mammiferi, ha causato un aumento drammatico del tasso di evoluzione degli esseri umani fossilizzati rispetto ai tassi precedenti. L'accelerazione dell'evoluzione in gruppi isolati di persone primitive si è verificata a causa delle leggi genetiche ordinarie, poiché popolazioni relativamente piccole e isolate di organismi viventi 1 Yablokov A.V. Prefazione dell'editore dell'edizione russa // Levontin R. Fondamenti genetici dell'evoluzione. M.: Mir, 1978. P. 10. 2 Un punto di vista simile è condiviso da P.I. Boriskovsky (1979), V.P. Alekseev e A.I. Pershits (1990), R. Carroll (1992), V.A. Shkuratov (1995) e altri 21
Edizione didattica
Belik A.A. In 43 - Studi culturali. Teorie antropologiche delle culture. M.: Stato russo. umanista univ. M., 1999. 241 s
BBK71.1 B 43 La letteratura educativa sulle discipline umanistiche e sociali per le scuole superiori e gli istituti di istruzione secondaria specializzata è preparata e pubblicata con l'assistenza dell'Open Society Institute (Fondazione Soros) nell'ambito del programma di istruzione superiore. Le opinioni e gli approcci dell'autore non coincidono necessariamente con la posizione del programma. In casi particolarmente controversi, nelle prefazioni e nelle postfazioni si riflette un punto di vista alternativo.
Comitato editoriale: V.I. Bakhmin, Y.M. Berger, E.Yu.
ISBN 5-7281-0214-X © Belik A.A., 1999 © Università statale russa di studi umanistici, design, 1999
Prefazione
Sezione 1. Concetti di base. Oggetto di studi culturali
introduzione
Evoluzionismo
Diffusionismo
Biologia
Psicologismo
Psicoanalisi
Funzionalismo
Sezione 2. Concetti culturali e antropologici olistici della metà del XX secolo
La teoria di White
Antropologia di Kroeber
Antropologia di Herskovitz
Sezione 3. Interazione tra cultura e personalità. Caratteristiche del funzionamento e della riproduzione delle colture.
Direzione "cultura-e-personalità"
L'infanzia come fenomeno culturale
Pensiero e cultura
etnoscienza
Stati estatici di coscienza
Interazione tra cultura, personalità e natura
Studio etnopsicologico delle culture
Sezione 4. Teorie delle culture dell'orientamento psicologico e antropologico negli anni 70-80 del XX secolo
La psicoanalisi classica
Gli studi culturali di Fromm
Psicologia umanistica Maslow
Approccio etologico allo studio delle culture
Culturologia e problemi del futuro sviluppo globale
Dizionario di concetti e termini
PREFAZIONE
Questo libro di testo è stato creato sulla base di un corso di studi culturali tenuto dall'autore presso la Facoltà di Management, nonché presso le facoltà psicologiche ed economiche dell'Università statale russa di scienze umane. Il libro utilizza gli sviluppi scientifici dell'autore riguardanti vari aspetti dello studio delle culture nell'antropologia culturale, sociale e psicologica.
L'introduzione analizza problemi teorici, come la definizione del concetto di “cultura”, il suo rapporto con la realtà storica concreta, e caratterizza i due tipi più importanti di culture: moderna e tradizionale. L'originalità qualitativa della cultura si manifesta attraverso un tipo speciale di attività (sociale), inerente solo alle comunità di persone. La prima sezione esamina varie teorie delle culture, approcci allo studio dei fenomeni, elementi della cultura (evoluzionismo, diffusionismo, biologismo, psicoanalisi, direzione psicologica, funzionalismo), sorti tra il XIX e la metà del XX secolo. L'autore ha cercato di mostrare la gamma più ampia possibile di diverse opzioni per lo studio delle culture, di presentare un panorama di opinioni e punti di vista sull'essenza degli studi culturali. Questa sezione è strettamente adiacente alla seconda sezione, che racconta concetti olistici di cultura (A. Kroeber, L. White, M. Herskowitz), riflettendo le tendenze della tradizione culturale-antropologica.
La terza sezione è dedicata allo studio dell'interazione tra cultura e personalità. Si tratta di una novità per tali corsi, ma l'autore ritiene che tale ricerca dovrebbe diventare parte integrante degli studi culturali. Questa sezione include lo studio di come una persona pensa, sperimenta il mondo, agisce e si sente nelle diverse culture. Un ruolo significativo nell'analisi di questi processi è dato all'infanzia come fenomeno culturale speciale. La questione dei tipi di pensiero nelle società con diversi livelli di sviluppo tecnologico si pone in un modo nuovo. Si riflette anche il lato emotivo delle culture, il suo tratto dionisiaco è visto attraverso stati alterati di coscienza e rituali estatici. Anche lo studio etnopsicologico delle culture divenne oggetto di un'attenta analisi.
L'ultima sezione esamina le teorie culturali diffusesi negli anni '70 e '80 del XX secolo. Hanno aperto nuovi orizzonti nello sviluppo degli studi culturali, hanno aggiornato metodi e ampliato l'oggetto della ricerca. I vari approcci allo studio delle culture studiati in questo corso hanno un altro scopo: mostrare la diversità (pluralismo) di punti di vista e concetti che contribuiscono allo sviluppo di una propria visione del processo storico e culturale.
L'autore non si è posto l'obiettivo e non ha potuto, a causa dello spazio limitato, considerare tutti i tipi di teorie culturali. Alcune teorie delle culture vengono considerate in base a una serie di circostanze, e principalmente alla struttura del corso, che contiene come parte importante i problemi degli studi culturali (cultura e pensiero, personalità, natura e cultura, ecc.). Vorrei sottolineare che l'obiettivo principale del corso è mostrare le interazioni dell'individuo nella cultura, attirare l'attenzione degli studenti sul fatto che dietro i vari “volti della cultura” c'è una persona con le sue capacità, bisogni, obiettivi, grazie ai quali gli studi culturali acquisiscono un orientamento umanistico. È in connessione con l'espressione del principio personale che l'ultima sezione esamina le teorie delle culture di orientamento psicologico e antropologico.
In una certa misura, è questa circostanza che spiega la mancanza di teorie tra i ricercatori culturali russi, poiché la loro enfasi principale è sullo studio etnografico dei popoli. Il concetto di “cultura” gioca per loro un ruolo meno significativo e quasi non esplorano l’interazione tra cultura e personalità. Inoltre, l'autore segue la tradizione che si è sviluppata nel nostro paese: considerare i concetti degli scienziati culturali nazionali come un argomento di ricerca separato*.
* Vedi: Tokarev S.A. Storia dell'etnografia russa. M., 1966; Zalkind N.G. Scuola di antropologi di Mosca per lo sviluppo della scienza domestica dell'uomo. M., 1974.
Va notato che un'aggiunta significativa a questo corso è l'antologia “Antologia di studi culturali: antropologia culturale e sociale” (M., 1998).
L'autore è grato all'Open Society Institute (Fondazione Soros) per aver sostenuto questo progetto, al membro corrispondente dell'Accademia russa delle scienze S.A. Arutyunov e al dottore in scienze storiche V.I. Kozlov per i buoni consigli e il supporto nella ricerca scientifica inclusa in questo libro di testo, Doctor of Scienze storiche V.N. Basilov - per l'assistenza attiva nella creazione del progetto del libro di testo. Separatamente, l'autore desidera ringraziare il dottore in scienze storiche E.G. Aleksandrenkov per il suo aiuto nella stesura del capitolo "Diffusionismo". L'autore è particolarmente grato al professore del Dipartimento di Storia e Teoria della Cultura dell'Università statale russa di scienze umane G.I. Zvereva, il cui atteggiamento sensibile e attento ha reso possibile la creazione di uno speciale corso educativo - studi culturali.
Inoltre, l'autore ringrazia il comitato editoriale della rivista "Ethos" (USA), il professor E. Bourguignon (USA) e il professor I. Eibl-Eibesfeldt (Germania) per aver fornito letteratura che non è disponibile nelle biblioteche russe. Nel valutare una serie di tendenze nello studio delle culture, l'autore si è basato sul lavoro del classico dell'etnologia russa S.A. Tokarev.
Sezione 1 . Concetti basilari. Oggetto di studi culturali.
INTRODUZIONE
1. Un'idea dell'oggetto di studio degli studi culturali e delle scienze della cultura.
LA PAROLA cultura (dal latino) significa “lavorazione”, “agricoltura”, in altre parole è coltivazione, umanizzazione, cambiamento della natura come habitat. Il concetto stesso contiene un contrasto tra il corso naturale di sviluppo dei processi e dei fenomeni naturali e la "seconda natura" creata artificialmente dall'uomo: la cultura. La cultura, quindi, è una forma speciale di vita umana, qualitativamente nuova rispetto alle precedenti forme di organizzazione degli esseri viventi sulla terra.
Nella storia e nell'era moderna, un'enorme varietà di tipi di culture esisteva ed esiste nel mondo come forme storiche locali di comunità umane. Ogni cultura, con i propri parametri spaziali e temporali, è strettamente connessa con il suo creatore: il popolo (gruppo etnico, comunità etno-confessionale). Qualsiasi cultura è divisa in parti componenti (elementi) e svolge determinate funzioni. Lo sviluppo e il funzionamento delle culture sono assicurati da un modo speciale di attività umana - sociale (o culturale), la cui principale differenza sono le azioni non solo con formazioni oggettive-materiali, ma anche con entità a forma ideale, forme simboliche. La cultura esprime le specificità dello stile di vita, il comportamento dei singoli popoli, il loro modo speciale di percepire il mondo nei miti, nelle leggende, nel sistema di credenze religiose e negli orientamenti di valore che danno significato all'esistenza umana. Un complesso di credenze religiose a vari livelli di sviluppo (animismo, totemismo, magia, politeismo e religioni del mondo) gioca un ruolo serio nel funzionamento delle culture. Spesso la religione (e agisce come l'elemento più importante della cultura spirituale) è un fattore determinante nel determinare l'unicità delle culture e la principale forza regolatrice nelle comunità umane. La cultura, quindi, è una forma speciale di attività vitale delle persone, che consente la manifestazione di una varietà di stili di vita, modi materiali di trasformare la natura e creare valori spirituali.
Strutturalmente, la cultura comprende: caratteristiche dei modi per mantenere la vita di una comunità (economia); modi specifici di comportamento; modelli di interazione umana; forme organizzative (istituzioni culturali) che assicurano l'unità della comunità; formazione dell'uomo come essere culturale; parte o divisione associata alla “produzione”, creazione e funzionamento di idee, simboli, entità ideali che danno significato alla visione del mondo che esiste in una cultura.
Dopo l’era delle “grandi scoperte geografiche”, un mondo completamente nuovo, pieno di diversità di forme culturali e di stili di vita, si è aperto davanti agli occhi stupiti degli europei, appena risvegliati dal “letargo medievale”. Nel 19 ° secolo vari tipi di culture, descrizioni di rituali e credenze specifici che esistevano in Africa, Nord e Sud America, Oceania e in numerosi paesi asiatici costituirono la base per lo sviluppo dell'antropologia culturale e sociale. Queste discipline costituiscono una vasta gamma di studi sulle culture locali, sulla loro interazione tra loro e sulle peculiarità dell'influenza delle condizioni naturali su di esse. Molte culture locali sono state quindi presentate sotto forma di un processo storico-culturale in due forme:
- evoluzione a stadi lineari di natura progressiva (dalle società più semplici a quelle più complesse);
- sviluppo multilineare di diverse tipologie di colture. In quest’ultimo caso, si è posto maggiormente l’accento sull’originalità, se non addirittura sull’unicità, delle culture dei singoli popoli, e il processo culturale è stato visto come l’attuazione di diverse tipologie storicamente determinate (sviluppo europeo, culture di tipo “asiatico”, culture tradizionali dell’Africa, dell’Australia, del Sud America, ecc.).
Negli anni '30 del XX secolo. Dall'antropologia culturale è emersa una speciale disciplina antropologica: l'antropologia psicologica, che ha fatto oggetto della sua considerazione l'interazione tra personalità e cultura di vario tipo. In altre parole, negli studi culturali si cominciò a prendere in considerazione il fattore personale. Va notato che tutta la conoscenza culturale e antropologica è spesso chiamata etnologia. L'etnologia è lo studio di varie culture nell'unità di livelli di analisi teorici generali e specifici empirici (etnografici). Questo è il significato in cui questo termine viene utilizzato in questo libro di testo. Alla parola “etnografico” è stato assegnato il significato della raccolta primaria di informazioni sulle culture (sia sperimentali che sul campo, ottenute con il metodo dell'osservazione partecipante, nonché attraverso questionari e interviste).
Il termine "antropologia" è usato dall'autore in due sensi principali. In primo luogo, questo termine denota la scienza generale della cultura e dell'uomo. I ricercatori culturali usarono questo significato nel 19° secolo. Inoltre, l'antropologia era chiamata antropologia culturale, antropologia psicologica e antropologia sociale. Esiste anche l'antropologia fisica, il cui oggetto è la variabilità biologica dell'organismo, le caratteristiche “razziali” esterne di una persona, la specificità dei suoi processi intraorganici, determinati da varie condizioni geografiche.
Lo studio antropologico delle culture è il nucleo, il nucleo della conoscenza culturale nel suo complesso. Tale studio è organicamente connesso con lo studio della storia delle culture, individuate sulla base della periodizzazione delle fasi dello sviluppo culturale (la cultura del mondo antico, il Medioevo, la cultura europea moderna, la cultura della società postindustriale ), regioni di distribuzione (cultura dei paesi europei, americani, africani, ecc.) o tradizioni religiose principali (tipi di cultura taoista, cristiana, islamica, buddista...).
L'oggetto di studio dell'antropologia culturale sono principalmente le società tradizionali e l'oggetto di studio sono i sistemi di parentela, le relazioni tra lingua e cultura, le caratteristiche del cibo, dell'abitazione, del matrimonio, della famiglia, la diversità dei sistemi economici, la stratificazione sociale, l'importanza della religione e arte nelle comunità etnoculturali. L'antropologia sociale è il nome dato alla conoscenza culturale e antropologica in Europa, principalmente in Inghilterra e Francia. Le sue caratteristiche distintive includono una maggiore attenzione alla struttura sociale, all'organizzazione politica, alla gestione e all'applicazione del metodo di ricerca strutturale-funzionale.
Oggetto degli studi culturali possono essere varie forme di culture, la base per identificare quale è il tempo, il luogo di distribuzione o l'orientamento religioso. Inoltre, oggetto degli studi culturali possono essere le teorie della cultura sviluppate in forma artistica (belle arti, scultura, musica), in letteratura, come elementi di sistemi filosofici. Gli studi culturali possono basarsi sull'analisi del testo, sugli aspetti individuali dello sviluppo della cultura spirituale, in particolare su varie forme d'arte.
2. Approcci alla definizione del concetto di “cultura”
QUASI tutte le definizioni di cultura sono unite in una cosa: questa è una caratteristica o uno stile di vita di una persona, non di animali. La cultura è il concetto di base per denotare una forma speciale di organizzazione della vita delle persone. Il concetto di “società” è interpretato da molti, anche se non tutti, ricercatori culturali come un insieme o un aggregato di individui che vivono insieme. Questo concetto descrive la vita sia degli animali che degli esseri umani. Si può certo contestare una simile interpretazione, ma essa è molto diffusa nella tradizione culturale e antropologica, soprattutto negli Stati Uniti. Pertanto, è più appropriato utilizzare il concetto di “cultura” per esprimere le specificità dell’esistenza umana*.
* In questo libro di testo i concetti di “società” e “cultura” sono spesso usati come sinonimi.
Diverse definizioni del concetto di "cultura" sono associate a una direzione o all'altra nello studio del concetto teorico utilizzato da vari ricercatori. La prima definizione del concetto fu data dal classico del movimento evoluzionista E. Taylor. Considerava la cultura come la totalità dei suoi elementi: credenze, tradizioni, arte, costumi, ecc. Questa idea di cultura ha lasciato un'impronta nel suo concetto culturale, in cui non c'era posto per la cultura nel suo insieme. Lo scienziato lo ha studiato come una serie di elementi che diventano più complessi nel processo di sviluppo, ad esempio, come la graduale complicazione di oggetti della cultura materiale (strumenti di lavoro) o l'evoluzione di forme di credenze religiose (dall'animismo alle religioni del mondo ).
Oltre alla definizione descrittiva, negli studi culturali esistevano due approcci concorrenti all’analisi del concetto di “cultura” e, di conseguenza, alla sua definizione. Il primo appartiene ad A. Kroeber e K. Kluckhohn. " La cultura consiste- in accordo con loro, - da norme contenute internamente e manifestate esternamente che determinano il comportamento, dominate e mediate attraverso i simboli; nasce come risultato dell'attività umana, inclusa la sua incarnazione in mezzi [materiali]. Il nucleo essenziale della cultura è costituito dalle idee tradizionali (storicamente stabilite), principalmente quelle a cui viene attribuito un valore speciale. I sistemi culturali possono essere considerati, da un lato, come il risultato dell’attività umana, e dall’altro, come i suoi regolatori""(1) . In questa definizione, la cultura è il risultato dell'attività umana; gli stereotipi comportamentali e le loro caratteristiche occupano un posto significativo nello studio delle culture secondo questo approccio alla definizione.
L. White, nel definire la cultura, ha fatto ricorso a un'interpretazione oggettivo-materiale. La cultura, secondo lui, è una classe di oggetti e fenomeni che dipendono dalla capacità di simbolizzazione di una persona, considerata in un contesto extrasomatico (2) . Per lui la cultura è una forma organizzativa integrale dell'esistenza umana, ma vista dalla prospettiva di una classe speciale di oggetti e fenomeni.
Il libro di A. Kroeber e K. Kluckhohn “Cultura, una revisione critica delle definizioni” (1952) è stato appositamente dedicato al problema della definizione della cultura, in cui gli autori hanno citato circa 150 definizioni di cultura. Il successo del libro fu enorme, tanto che la seconda edizione di quest'opera comprendeva più di 200 definizioni di cultura. Vorrei sottolineare che ogni tipo di definizione evidenzia il proprio aspetto nello studio delle culture, che a volte diventa il contesto iniziale per l'uno o l'altro tipo di teoria culturale. Oltre alle definizioni di cultura di L. White, A. Kroeber ed E. Taylor, esistono numerosi altri tipi di definizioni.
Le cosiddette definizioni normative di cultura sono associate al modo di vivere di una comunità. Quindi, secondo K. Wissler, " lo stile di vita seguito da una comunità o tribù è considerato cultura... La cultura di una tribù è un insieme di credenze e pratiche..."(3) .
Un ampio gruppo è costituito da definizioni psicologiche di cultura. Ad esempio, W. Sumner definisce la cultura " come insieme di adattamenti umani alle sue condizioni di vita"(4) . R. Benedict intende la cultura come comportamento appreso che deve essere reimparato da ogni generazione di persone. G. Stein ha espresso un punto di vista specifico sulla cultura. Secondo lui la cultura lo è ricerca della terapia nel mondo moderno. M. Herskowitz considerava la cultura " come la somma dei comportamenti e dei modi di pensare che formano una data società"(5) .
Un posto speciale è occupato dalle definizioni strutturali della cultura. Il più caratteristico appartiene a R. Linton:
"a) La cultura non è, in definitiva, altro che le reazioni organizzate e ripetute dei membri di una società;
b) La cultura è una combinazione di comportamenti acquisiti e risultati comportamentali, le cui componenti sono condivise ed ereditate dai membri di una data società" (6)
.
La definizione data da J. Honigman può essere classificata anche come strutturale. Credeva che la cultura fosse composta da due tipi di fenomeni.
Il primo è "comportamento socialmente standardizzato: azione, pensiero, sentimenti di un certo gruppo".
Il secondo è "i prodotti materiali... del comportamento di qualche gruppo"(7)
.
Nei capitoli successivi verrà mostrato come i punti di partenza incorporati in certi tipi di definizioni vengono implementati nel tessuto reale della teoria culturale. Dopo una breve panoramica dei tipi di definizioni (in realtà ce ne sono ancora di più: definizioni genetiche, funzionali...), possiamo concludere che si tratta ancora della forma di organizzazione della vita umana, delle sue caratteristiche , appartenenti a diverse nazioni. In questo manuale, il termine “comunità etnoculturale” sarà utilizzato anche per designare una cultura separata.
Negli studi culturali moderni (così come nell'antropologia degli anni '50 e '60) c'è un importante problema discutibile - sullo status del concetto di "cultura": come il concetto di "cultura" si riferisce ai fenomeni, oggetti della realtà che descrive. Alcuni credono che il concetto di cultura (così come il concetto di ethnos e alcune altre categorie generali-universali) siano solo tipi ideali puri, astrazioni che esistono nella testa degli individui (in questo caso, scienziati culturali), costrutti logici che sono difficile da correlare con una specifica realtà storica. Altri (tra questi, prima di tutto, dovremmo nominare il fondatore degli studi culturali L. White) sono dell'opinione sulla natura oggettiva-materiale della cultura, che, tra l'altro, si esprime nelle definizioni, considerando la cultura come una classe di oggetti, fenomeni... e correlare il tipo di cultura direttamente con i corrispondenti fenomeni della realtà sociale.
Come si risolve questa contraddizione? Innanzitutto, ciascuna parte difende la propria causa basandosi sulle proprie definizioni di cultura. In questo senso c’è del vero in entrambe le posizioni. È vero, rimane il problema di correlare il concetto e la realtà vivente e diversa. I sostenitori della comprensione della cultura come costrutto logico di solito chiedono: mostra questa cultura, spiega come percepirla empiricamente. Naturalmente, la cultura come forma di organizzazione dell'esperienza umana, il modo di vivere di un singolo popolo, è difficile da vedere e toccare, come una cosa materiale. Gli stereotipi culturali esistono solo nelle azioni umane e nella tradizione culturale. Inoltre c’è qui una circostanza molto significativa per gli studi culturali e per le scienze umane in generale.
La peculiarità della cultura sta proprio nel fatto che alcuni dei suoi elementi e fenomeni esistono come idee (formazioni ideali) condivise da tutti i membri di una data comunità etnoculturale. Le idee o le immagini possono essere oggettivate, incarnate in parole, leggende, in forma scritta sotto forma di poemi epici o opere di narrativa, ecc. Il concetto stesso di "è" o "esiste" quando applicato alla cultura significa non solo esistenza materiale, ma funzionamento ideale, figurato. La cultura presuppone la presenza di una realtà soggettiva speciale, l'esempio più semplice della quale è una visione del mondo, o mentalità, speciale. Pertanto, quando si considera la questione fondamentalmente molto complessa del rapporto tra il concetto di cultura e la realtà storica, dobbiamo ricordare che la realtà sociale umana ha due dimensioni: quella oggettiva-materiale e quella ideale-immaginativa.
3. Culture tradizionali e moderne
Lo studio ANTROPOLOGICO delle culture include necessariamente l'opposizione esplicita o implicita e il confronto tra tipi di società tradizionali e moderni. La cultura tradizionale (o tipo di società) è (in prima approssimazione) una società in cui la regolamentazione viene effettuata sulla base di costumi, tradizioni e istituzioni. Il funzionamento della società moderna è assicurato dalla legge codificata, un insieme di leggi modificate attraverso organi legislativi eletti dal popolo.
La cultura tradizionale è comune nelle società in cui i cambiamenti sono impercettibili nella vita di una generazione: il passato degli adulti risulta essere il futuro dei loro figli. Qui regna un'usanza conquistatrice, una tradizione preservata e tramandata di generazione in generazione. Le unità di organizzazione sociale sono costituite da persone familiari. La cultura tradizionale combina organicamente i suoi elementi costitutivi; una persona non si sente in disaccordo con la società. Questa cultura interagisce organicamente con la natura ed è tutt'uno con essa. Questo tipo di società si concentra sulla preservazione della propria identità e identità culturale. L'autorità della vecchia generazione è indiscutibile, il che rende possibile risolvere eventuali conflitti senza spargimento di sangue. La fonte delle conoscenze e delle competenze è la generazione più anziana.
Il tipo moderno di cultura è caratterizzato da cambiamenti abbastanza rapidi che si verificano nel processo di continua modernizzazione. La fonte della conoscenza, delle competenze e delle competenze culturali è il sistema istituzionalizzato di istruzione e formazione. Una famiglia tipica è quella dei “figli-genitori”, non esiste la terza generazione. L'autorità della generazione più anziana non è così elevata come nella società tradizionale; il conflitto tra generazioni (“padri e figli”) è chiaramente espresso. Uno dei motivi della sua esistenza è la mutevole realtà culturale, che ogni volta determina nuovi parametri per il percorso di vita della nuova generazione. La società moderna è anonima, è composta da persone che non si conoscono. La sua differenza importante è che è un sistema industriale unificato, universalmente identico. Una tale società esiste principalmente nelle città (o anche nelle megalopoli, in una realtà urbana infinita, come la costa orientale degli Stati Uniti), che si trovano in uno stato di disarmonia con la natura, uno squilibrio globale, chiamato crisi ecologica. Una caratteristica specifica della cultura moderna è l'alienazione dell'uomo dall'uomo, l'interruzione della comunicazione, l'esistenza delle persone come individui atomizzati, cellule di un gigantesco superorganismo.
La cultura tradizionale è preindustriale, solitamente non scritta, e la sua occupazione principale è l'agricoltura. Ci sono culture che sono ancora nella fase di caccia e raccolta. Un’ampia varietà di informazioni sulle culture tradizionali è raccolta nell’“Atlante etnografico” di J. Murdoch, pubblicato per la prima volta nel 1967. Attualmente è stata creata una banca dati informatica di oltre 600 società tradizionali (nota anche come “ Area Relazioni Umane” Fascicoli). Analizzando i singoli problemi degli studi culturali, utilizziamo i suoi dati. Nella presentazione che segue, insieme al termine “cultura tradizionale” (società), verrà utilizzato come sinonimo il concetto di “società arcaica” (cultura), così come quello di “società primitiva” (cultura). quest'ultimo da un certo numero di ricercatori culturali.
È del tutto naturale mettere in discussione la correlazione dei tipi di culture identificati con la realtà storica reale. Le società tradizionali esistono ancora in Sud America, Africa e Australia. Le loro caratteristiche corrispondono in gran parte al tipo di cultura che abbiamo descritto in precedenza. La vera incarnazione della cultura industriale sono gli Stati Uniti, la parte urbanizzata dei paesi europei. È vero, bisogna tenere presente che nelle zone rurali dei paesi industriali sviluppati c'è la tendenza a preservare lo stile di vita tradizionale. Pertanto, due tipi di cultura possono essere combinati in un paese: unificato-industriale ed etnicamente distintivo, orientato tradizionalmente. La Russia, ad esempio, è una complessa combinazione di culture tradizionali e moderne.
Le culture tradizionale e moderna sono due poli in una vasta gamma di studi interculturali. Si può anche distinguere un tipo misto di società-culture coinvolte nella modernizzazione industriale, ma che tuttavia conservano le loro tradizioni culturali. In un tipo di cultura mista tradizionale-industriale, elementi di modernizzazione e stereotipi di comportamento, stile di vita, costumi e caratteristiche nazionali della visione del mondo determinati etnicamente sono combinati in modo relativamente armonioso. Esempi di tali società sono il Giappone, alcuni paesi del sud-est asiatico e la Cina.
4. Modi di vita culturali (sociali) e biologici
COME È CHIARO dalla presentazione precedente, un ruolo fondamentale nell'emergere, nello sviluppo e nella riproduzione delle culture è svolto dalle caratteristiche dell'attività umana. Questo è anche lo scopo di molte delle definizioni originali di cultura su cui si basano gli antropologi. Stiamo parlando della natura simbolica della cultura, degli stereotipi di azione acquisiti, di un tipo speciale (culturale) di comportamento umano o di forme o tipi specifici di attività che esistono all'interno di una cultura. Quindi, l'uomo, interagendo con la realtà circostante in modo speciale, ha creato una "seconda natura" - cultura materiale e una sfera di attività a forma ideale. Le creature che vivono sulla Terra hanno formato due tipi di vita: istintiva-biologica e culturale-. conveniente (sociale). Dopo averli confrontati, proveremo a rispondere alla domanda su quale sia la specificità del modo di attività culturale.
Nel tipo di vita istintivo prevalgono stereotipi comportamentali acquisiti ereditariamente (innati), spesso strettamente legati alle condizioni naturali esterne. La natura dell'attività è predeterminata dalla struttura anatomica e fisiologica dell'organismo, che porta alla specializzazione dell'attività animale (ad esempio predatore, erbivoro, ecc.) e all'esistenza in un determinato territorio in un ambiente vivente, in condizioni climatiche limitate. Nelle azioni degli animali, un ruolo decisivo è giocato dalle reazioni ereditarie agli eventi esterni: gli istinti. Servono gli animali di una determinata specie come un modo per soddisfare i loro bisogni, garantire la sopravvivenza e la riproduzione della popolazione (comunità). L'oggetto dei cambiamenti (necessari durante la trasformazione delle condizioni esterne) è l'organismo, il corpo dell'animale. Naturalmente sarebbe un'estrema semplificazione descrivere il tipo biologico dell'attività vitale solo nell'ambito della formula s-r ("stimolo-risposta"). Nel tipo di vita istintivo c'è spazio per l'apprendimento e la modifica degli stereotipi innati. Gli animali negli esperimenti sono in grado di risolvere problemi mentali e in condizioni naturali mostrano intraprendenza immediata. Inoltre, gli scienziati etologi parlano della presenza di sentimenti negli animali (devozione, amore disinteressato per il proprietario), ecc.
È importante capire che il tipo di organizzazione della vita animale non è meno (e forse più) complessa di quella umana. Dopotutto, gli animali hanno milioni (!) di anni di selezione delle forme di interazione tra loro e con l'ambiente esterno. Nonostante il ruolo determinante del programma genetico nel tipo biologico, gli studi sul comportamento animale condotti negli ultimi decenni hanno scoperto un mondo di relazioni molto complesso, regolato da meccanismi di comportamento finemente sintonizzati e allo stesso tempo plastici. Il tipo biologico di vita non può essere definito inferiore, cioè un modo di attività meno sviluppato rispetto al modo culturale. Questo è un tipo di attività diverso, qualitativamente diverso, le peculiarità del funzionamento di cui stiamo gradualmente imparando solo ora.
Diamo solo un esempio delle possibilità di adattamento e sviluppo dei mezzi di protezione e sopravvivenza dal mondo animale. Tutti sanno che i pipistrelli utilizzano localizzatori ad ultrasuoni (sonar) per catturare e localizzare le loro vittime. Più recentemente, si è scoperto che alcuni insetti (una specie di farfalla) hanno sviluppato reazioni difensive contro i pipistrelli. Alcuni percepiscono sensibilmente il tocco di un localizzatore ad ultrasuoni, altri hanno un meccanismo di protezione multilivello più complesso che consente loro non solo di sentire il tocco di un raggio ultrasonico, ma anche di creare forti interferenze, portando a un temporaneo "blocco del sonar" del pipistrello e la perdita della sua capacità di navigare. spazio. Il rilevamento di un fenomeno simile negli animali è diventato possibile solo con l'aiuto della moderna tecnologia elettronica ultrasensibile. Per riassumere la breve descrizione del tipo di vita istintivo, è necessario sottolineare la sua complessità come forma di organizzazione degli esseri viventi e la presenza al suo interno di una serie di fenomeni da cui successivamente si è sviluppato lo stile di vita umano (caratteristiche del gruppo comportamento, organizzazione dell'interazione collettiva in uno stormo, ecc.).
La struttura anatomica e fisiologica del corpo umano non predetermina alcun tipo di attività in condizioni naturali fisse. L'uomo è universale per natura, può esistere in qualsiasi parte del globo, padroneggiare un'ampia varietà di attività, ecc. Ma diventa un uomo solo in presenza di un ambiente culturale, in comunicazione con altre creature simili a lui. In assenza di questa condizione, anche il suo programma biologico di essere vivente non si realizza, ed egli muore prematuramente. Al di fuori della cultura, l’uomo come essere vivente muore. Nel corso della storia culturale, l'uomo rimane organicamente invariato (nel senso dell'assenza di speciazione): tutti i cambiamenti vengono trasferiti al suo "corpo inorganico" culturale. L'uomo, in quanto unica specie biologica, ha creato allo stesso tempo una ricca varietà di forme culturali che esprimono la sua natura universale. Secondo le parole del famoso biologo E. Mayr, l'uomo si specializzò verso la despecializzazione, cioè. ha oggettivamente una base di scelta, un elemento di libertà.
L'attività umana è indiretta. Tra sé e la natura pone oggetti della cultura materiale (strumenti, animali e piante domestiche, abitazioni, vestiti, se necessario). I mediatori – parole, immagini, competenze culturali – esistono nella sfera interpersonale. L'intero organismo culturale è costituito da intermediari organizzati in modo complesso, istituzioni culturali. In questo senso, la cultura è considerata una sorta di superorganismo, un corpo umano inorganico. L’attività umana non è soggetta allo schema “stimolo-risposta” e non è solo una risposta a stimoli esterni. Contiene un momento mediatore di riflessione, un'azione cosciente secondo un obiettivo che esiste in forma ideale sotto forma di piano, immagine, intenzione. (Non per niente lo scienziato russo I.M. Sechenov considerava il pensiero come un riflesso inibito, cioè mediato da un periodo di tempo.)
Il carattere ideale-progettuale dell'attività è una caratteristica fondamentale che rende possibile l'esistenza e la riproduzione costante della cultura. Avendo un'idea di una cosa o di un'azione, una persona la incarna nella realtà esterna. Oggettiva idee e immagini emergenti in forma materiale o ideale. Una caratteristica specifica del modo di attività culturale è l'esternalizzazione dei suoi prodotti. E. Fromm ha parlato della necessità di realizzazione esterna dell'abilità creativa umana; M. Heidegger ha utilizzato una metafora per descrivere questo processo: il concetto di “essere gettato nel mondo”; Hegel definì questo fenomeno come oggettivazione (delle idee).
La particolarità del modo di attività umano è tale che un'altra persona può comprendere il significato dello scopo di questo o quel prodotto culturale incarnato. Hegel chiamò questa deoggettivazione. Diamo l'esempio più semplice di un tale fenomeno. Sulla base delle forme degli strumenti di lavoro dell'era preistorica scoperti dagli archeologi, si può capire la loro funzione, lo scopo e l'“idea” che aveva in mente il loro creatore. Questo modo di lavorare apre la possibilità di comprendere le culture di popoli scomparsi da tempo.
Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che una persona agisce non solo con oggetti materiali, ma anche con forme ideali (attività mentale dei più svariati tipi). Ciò determina la divisione della realtà culturale in ideale e materiale oggettivo. Allo stesso tempo, il primo acquisisce uno sviluppo indipendente nella cultura e diventa il regolatore più importante delle relazioni tra le persone. La presenza di una caratteristica di pianificazione ideale dell'attività ci consente di parlare di modelli, modelli di comportamento e azione desiderati che un individuo apprende in ciascuna cultura.
Una persona può trasformare il mondo con l'aiuto dell'immaginazione, in modo simile a come un bambino durante l'infanzia trasforma gli oggetti ordinari in oggetti fiabeschi nella realtà del gioco. K. Lorenz ha definito questo aspetto creativo dell'attività la capacità di visualizzare, creare situazioni che non hanno analoghi nella realtà.
Un aspetto importante dell'attività umana è il suo carattere simbolico. I segni più comuni nella cultura sono le parole, il cui significato non è legato alla forma materiale e sonora. Molti rituali, o meglio il loro scopo e le loro funzioni culturali, non derivano direttamente dal contenuto delle azioni rituali, ma hanno un significato simbolico
Sostantivo antropologia deriva dalle parole greche (uomo e pensiero, parola) e significa ragionamento, o insegnamento, su una persona. Aggettivo filosofico indica un modo di studiare l'uomo in cui si tenta di spiegare attraverso il pensiero razionale l'essenza stessa dell'uomo.
Antropologia filosofica- branca della filosofia che si occupa dell'indagine della natura e dell'essenza dell'uomo.
Oltre all'antropologia filosofica, una serie di altre scienze sono interessate all'uomo (antropologia fisica - l'oggetto di questa scienza sono questioni di poliontologia, genetica delle popolazioni, etologia - la scienza del comportamento animale).
Antropologia psicologica, lo studio del comportamento umano da una prospettiva mentale e psicologica.
Antropologia culturale(il più sviluppato) - studia i costumi, i rituali, i sistemi di parentela, la lingua e la moralità dei popoli primitivi.
Antropologia sociale– studia le persone moderne.
Antropologia teologica– l’industria esamina e spiega gli aspetti religiosi della comprensione umana.
La svolta ideologica verso il naturalismo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. portò all’usurpazione del concetto di antropologia da parte delle scienze sociali empiriche, e in particolare della biologia, della genetica e delle scienze razziali. Solo alla fine degli anni ’20, o più precisamente nel 1927, Max Scheler (1874-1928) nella sua opera “La posizione dell’uomo nello spazio” fece rivivere il concetto di antropologia nel suo significato filosofico originario. Quest'opera di Scheler, insieme alla sua famosa opera "L'uomo e la storia", ha riportato l'antropologia ad essere una disciplina assolutamente filosofica. Altri pensatori: Helmut Plesner, Arnold Gehlen. Scheler decise di affermare che, in un certo senso, “tutti i problemi centrali della filosofia si riducono alla questione di cosa sia l’uomo e quale posizione metafisica occupi tra tutto l’essere, il mondo e Dio”.
Antropologia filosofica– scienza fondamentale sull’essenza e la struttura essenziale dell’uomo, sul suo rapporto con il regno della natura, sul suo aspetto fisico, psicologico, spirituale nel mondo, sulle principali direzioni e leggi del suo sviluppo biologico, psicologico, spirituale, storico e sociale sviluppo.
In questo rientra anche il problema psicofisico del corpo e dell'anima.
Max Scheler credeva che il circolo culturale dell’Europa occidentale fosse dominato da cinque tipi principali di autocomprensione umana, vale a dire direzioni ideologiche nella comprensione dell'essenza dell'uomo.
Prima idea sull'uomo, dominante negli ambienti teistici (ebraici e cristiani) e ecclesiastici - religioso.È un risultato complesso dell'influenza reciproca dell'Antico Testamento, della filosofia antica e del Nuovo Testamento: il noto mito sulla creazione dell'uomo (il suo corpo e la sua anima) da parte di un Dio personale, sull'origine della prima coppia di le persone, sullo stato paradisiaco (la dottrina dello stato originale), sulla sua caduta, quando fu sedotto da un angelo caduto - caduto indipendentemente e liberamente; sulla salvezza da parte dell'Uomo-Dio, che ha una duplice natura, e sul ritorno così ottenuto nel numero dei figli di Dio; l'escatologia, la dottrina della libertà, della personalità e della spiritualità, l'immortalità dell'anima, la risurrezione della carne, il Giudizio Universale, ecc. Questa antropologia della fede biblica ha creato un numero enorme di prospettive storico-mondane, che vanno dalla “Città” di Agostino di Dio” alle ultime tendenze teologiche del pensiero.
Secondo,è l’idea dell’uomo che ancora oggi ci domina Greco antico. Questa è un'idea "homo sapiens" espresso in modo più definito e chiaro da Anassagora, Platone e Aristotele. Questa idea fa una distinzione tra l'uomo e gli animali in generale. La ragione (λόγος, νους) nell'uomo è considerata come una funzione del principio divino. La personalità nell'uomo è l'autoconcentrazione individuale dello spirito divino. Lo spirito è la mente, cioè pensare per idee; la sfera dei sentimenti, delle emozioni, della volontà; centro attivo, cioè noi stessi; autocoscienza.
Precisando le definizioni: 1. l'uomo è dotato di un principio divino, che tutta la natura non contiene soggettivamente; 2. questo è l'inizio e ciò che eternamente forma e modella il mondo come mondo (razionalizza il caos, la “materia” nello spazio), l'essenza nel suo principio uno tu lo stesso; quindi la conoscenza del mondo è vera; 3. questo inizio, come λόγος e come mente umana, è capace di tradurre in realtà i suoi contenuti ideali (“la potenza dello spirito”, “l'autocrazia dell'idea”).
Quasi tutta l'antropologia filosofica da Aristotele a Kant e Hegel (compreso M. Scheler) differiva in modo insignificante dalla dottrina dell'uomo presentata in queste quattro definizioni.
Terzo l'ideologia umana lo è naturalistico, "positivistico", anche più tardi pragmatico insegnamenti che voglio riassumere con una breve formula "homo faber". Essa differisce nella maniera più fondamentale dalla teoria dell'uomo come "homo sapiens" appena delineata.
Questa dottrina dell’“homo faber” nega innanzitutto in generale la capacità speciale e specifica della ragione dell’uomo. Non esiste una distinzione essenziale tra uomo e animale: esiste solo energia differenze; L'uomo è solo un tipo speciale di animale. L'uomo, innanzitutto, non è un essere razionale, non è “homo sapiens”, ma "un essere determinato dalle pulsioni." Ciò che viene chiamato spirito, mente, non ha un'origine metafisica indipendente, isolata, e non possiede uno schema elementare autonomo coerente con le leggi stesse dell'esistenza: è solo un ulteriore sviluppo delle capacità mentali superiori, che troviamo già nelle scimmie antropomorfe. .
Che cos'è una persona qui in primo luogo? Egli è: 1. un animale che usa segni (linguaggio), 2. un animale che usa strumenti, 3. una creatura dotata di cervello, cioè una creatura il cui cervello, in particolare la corteccia cerebrale, consuma molta più energia che in un animale . Anche i segni, le parole, i cosiddetti concetti sono giusti pistole, vale a dire, solo strumenti psichici raffinati. Non c'è nulla nell'uomo che non sia presente in forma rudimentale in alcuni vertebrati superiori...
L'immagine dell'uomo, inteso come homo faber, è stata progressivamente costruita, a partire da Democrito ed Epicuro, da filosofi come Bacon, Hume, Mill, Comte, Spencer, e successivamente dalla dottrina evoluzionista associata ai nomi di Darwin e Lamarck, e anche più tardi da dottrine filosofiche pragmatico-convenzionaliste (oltre che romanzative)…. Questa idea trovò un significativo sostegno presso i grandi psicologi delle pulsioni: Hobbes e Machiavelli vanno considerati i loro padri; tra questi ci sono L. Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, e tra i ricercatori dei tempi moderni ci sono 3. Freud e A. Adler.
Il quarto avanza la tesi dell’inevitabile decadenza l'uomo lungo tutta la sua storia e il motivo di questa decadenza va visto nell'essenza stessa e nell'origine dell'uomo. Alla semplice domanda: “Cos’è una persona?” questa antropologia risponde: l’uomo è disertore della vita, la vita in generale, i suoi valori fondamentali, le sue leggi, il suo sacro significato cosmico. Theodor Lessing (1872-1933) scrisse che: “L’uomo è una specie di scimmia predatrice che ha gradualmente sviluppato manie di grandezza dal suo cosiddetto ‘spirito’”. L'uomo, secondo questo insegnamento, è un vicolo cieco della vita in generale. Una singola persona non è malata, può essere sana all'interno della sua organizzazione di specie, ma una persona come... come c'è una malattia. L'uomo crea la lingua, la scienza, lo stato, l'arte, gli strumenti solo a causa della sua debolezza e impotenza biologica, a causa dell'impossibilità del progresso biologico.
Questa strana teoria risulta però logicamente strettamente coerente se - a questo punto, in pieno accordo con la dottrina dell'"homo sapiens" - separiamo spirito (rispettivamente mente) e vita come ultimi due principi metafisici, ma a livello allo stesso tempo identifica la vita con l'anima, e lo spirito - con l'intelligenza tecnica, e allo stesso tempo - e questo decide tutto - per rendere i valori della vita i valori più alti. Lo spirito, come la coscienza, appare quindi in modo abbastanza coerente come un principio che semplicemente distrugge, distrugge la vita, cioè il valore più alto.
Rappresentanti di questa concezione: Schopenhauer, Nietzsche, per certi aspetti anche Bergson e la direzione moderna della psicoanalisi.
Quinto- accettò l'idea superuomo Nietzsche e ne pose un nuovo fondamento razionale. In una forma strettamente filosofica, ciò avviene soprattutto tra due filosofi: Dietrich Heinrich Kerler e Nikolai Hartmann (“ Etica").
In N. Hartmann troviamo l'ateismo di nuovo tipo e che costituisce il fondamento di una nuova idea dell'uomo. a Dio è vietato esiste e Dio no dovere esistere in nome della responsabilità, della libertà, dello scopo, in nome del significato dell'esistenza umana. Nietzsche ha una frase che raramente viene compresa appieno: “Se gli Dei esistessero, come potrei sopportare di non essere Dio, quindi non ci sono Dei?” Heinrich Kerler una volta espresse questo pensiero con ancora maggiore audacia: “Qual è per me la base del mondo se io, come essere morale, so chiaramente e chiaramente cosa è bene e cosa dovrei fare? Se il fondamento del mondo esiste e concorda con ciò che considero buono, allora lo rispetto come si rispetta un amico; ma se non è d'accordo, non me ne frega niente di lei, anche se mi riduce in polvere insieme a tutti i miei obiettivi. Va tenuto presente: la negazione di Dio qui non significa deresponsabilizzazione e diminuzione dell'indipendenza e della libertà dell'uomo, ma proprio il massimo consentito aumentare la responsabilità e la sovranità. Così Hartmann dice: “I predicati di Dio (predestinazione e provvidenza) dovrebbero essere trasferiti nuovamente all’uomo”. Ma non sull'umanità, ma su personalità - vale a dire, a quella persona che ha il massimo di volontà responsabile, integrità, purezza, intelligenza e potere.