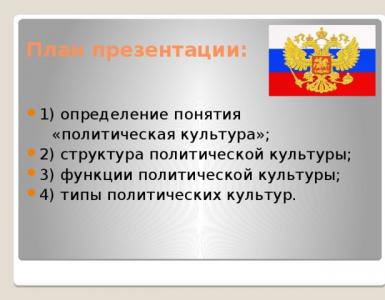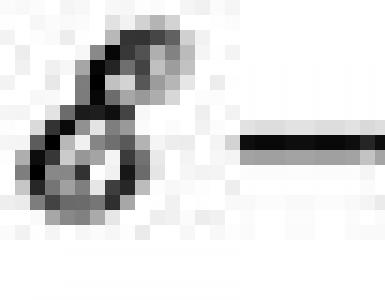Trattamento dell'emofilia A nei bambini. Emofilia nei neonati e nei bambini più grandi: tutto quello che i genitori devono sapere. Foto: albero genealogico della famiglia reale britannica, tenendo conto dell'incidenza dell'emofilia
Cos'è questa malattia?
L’emofilia è una malattia ereditaria causata da una carenza di fattori della coagulazione del sangue. Con l'emofilia, anche lesioni minori possono portare a gravi emorragie.
La forma più comune di emofilia, emofilia A o emofilia classica, si verifica nell'80% dei casi. È causato dall'insufficienza VIII fattore di coagulazione del sangue. La quota di emofilia B causata da carenza IX fattore di coagulazione del sangue, che rappresenta circa il 15% di tutti i casi della malattia.
Grazie ai nuovi progressi nel trattamento dell’emofilia, molti pazienti sono in grado di condurre una vita normale. Con un decorso lieve della malattia, non si osservano sanguinamenti spontanei e deformità degli arti. Alcuni emofiliaci possono persino sottoporsi ad un intervento chirurgico in centri di cura speciali senza timore di morire.
Quali sono le cause dell'emofilia?
L'emofilia A e B sono ereditate in modo recessivo legate al cromosoma X. L'emofilia colpisce solo gli uomini e le portatrici della malattia sono le donne, che trasmettono il gene difettoso nel 50% dei casi. Le figlie che hanno ricevuto un gene difettoso diventano esse stesse portatrici di emofilia, e i ragazzi nati da loro ereditano questa malattia (vedi RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI GENITORI SULL'EREDITÀ DELL'EMOFILIA).
CONVERSAZIONE SENZA INTERMEDIARI
Risposte alle domande dei genitori sull'ereditarietà dell'emofilia
Nella nostra famiglia non ci sono stati casi di emofilia. Come è successo che mio figlio abbia avuto l'emofilia?
Nel 20-25% dei casi la malattia non viene riscontrata nelle famiglie dei pazienti affetti da emofilia. Ovviamente c'era una mutazione nei geni responsabili della produzione VIII e IX fattori della coagulazione del sangue. La mutazione potrebbe essersi verificata in un bambino, in uno dei genitori o in antenati più lontani.
Se in una famiglia c'è un bambino affetto da emofilia, qual è il rischio che anche il figlio successivo abbia l'emofilia?
Per un maschio nato da madre portatrice di emofilia il rischio di ammalarsi è del 50%, e lo stesso rischio per una femmina di essere portatrice del gene difettoso. In un centro medico specializzato ti verrà spiegato in dettaglio la probabilità di sviluppare la malattia e i metodi di esame esistenti.
Nostro figlio ha l'emofilia. Anche i suoi figli si ammaleranno?
Se tuo figlio sposa una donna che ha l'emofilia, i suoi figli potrebbero avere l'emofilia. Se sua moglie è una donna sana, anche i suoi figli saranno sani. Tuttavia, tutte le sue figlie saranno portatrici di emofilia e i suoi pronipoti potrebbero avere l'emofilia. Il diagramma mostra come la malattia si trasmette attraverso un'ereditarietà di tipo recessivo legata al cromosoma X. La seconda riga del diagramma (seconda generazione) mostra che per ogni figlio di un portatore di emofilia, il rischio di ereditare l'emofilia è del 50% e le figlie nel 50% dei casi risultano portatrici di emofilia. Le ultime due righe mostrano come la malattia viene ereditata nella terza generazione se gli uomini della seconda generazione sposano donne sane.
Designazioni
donna sana
uomo sano
donna portatrice di emofilia
uomo affetto da emofilia
Quali sono i sintomi della malattia?
L'emofilia è caratterizzata da sanguinamento anomalo, che può essere lieve, moderato o grave, a seconda del grado di carenza del fattore di coagulazione. Spesso, l’emofilia lieve non viene diagnosticata fino all’età adulta e viene scoperta dopo un infortunio o un intervento chirurgico. In questi casi, dopo l'operazione, la ferita continua a sanguinare leggermente, oppure il sanguinamento si ferma o riprende.
Nei casi più gravi, l’emofilia può causare sanguinamento spontaneo. Un sanguinamento tardivo o grave dopo un lieve infortunio può portare alla formazione di grandi ematomi (tumori formati dal sangue penetrato nel corpo) nei muscoli e sotto la pelle. A volte il sangue scorre nelle articolazioni e nei muscoli, causando forte dolore, gonfiore e deformità irreversibili.
I sintomi dell’emofilia moderata e grave sono simili. Fortunatamente, gli episodi di sanguinamento spontaneo sono rari nell’emofilia moderata.
Il sanguinamento vicino ai nervi periferici può portare a infiammazione e degenerazione, dolore, sensazioni anomale e atrofia muscolare. Se il sanguinamento porta alla compressione di un vaso di grandi dimensioni, l'afflusso di sangue alla parte corrispondente del corpo può essere interrotto, per cui a volte si sviluppa cancrena con la morte dei tessuti molli. Emorragie nella gola, nella lingua, nel cuore, nel cervello e nel cranio possono portare allo sviluppo di shock e morte del paziente.
Come viene diagnosticata la malattia?
Se una persona, dopo un infortunio o un intervento chirurgico (inclusa l'estrazione del dente), continua a sanguinare per un lungo periodo e presenta anche emorragie nei muscoli o nelle articolazioni, si sospetta l'emofilia.
La determinazione del contenuto dei fattori della coagulazione del sangue ci consente di determinare la forma e la gravità della malattia. Anche la storia familiare gioca un ruolo importante nella diagnosi di emofilia (sebbene circa il 20% delle persone affette da emofilia non abbia una storia familiare della malattia).
Come viene trattata l'emofilia?
L’emofilia non ha cura. Tuttavia, i moderni metodi di trattamento consentono di prolungare la vita del paziente ed evitare deformità irreversibili. Con l'aiuto dei farmaci, puoi fermare rapidamente l'emorragia aumentando il livello dei fattori di coagulazione mancanti nel sangue. Questo a sua volta aiuta a prevenire l'atrofia muscolare e le contratture articolari, che possono verificarsi a causa di ripetute emorragie nei muscoli e nelle articolazioni.
A chi soffre di emofilia A possono essere prescritti fattori antiemolitici che ripristinano la normale coagulazione del sangue. Ai pazienti con emofilia B viene prescritto un concentrato IX fattore della coagulazione durante gli episodi di sanguinamento per aumentare i livelli di questo fattore.
Se una persona affetta da emofilia necessita di un intervento chirurgico, questo dovrebbe essere eseguito sotto la supervisione di un ematologo, un esperto nella cura delle persone affette da emofilia. Prima e dopo l’intervento chirurgico, al paziente vengono somministrati i fattori della coagulazione mancanti. Tali misure sono necessarie anche con interventi chirurgici minimi, anche con l'estrazione del dente. In quest'ultimo caso può essere prescritto anche l'acido epsilon-aminocaproico, un medicinale per il sanguinamento della bocca.
Una persona affetta da emofilia deve stare attenta ed evitare lesioni. Deve imparare a fermare le emorragie minori e a riconoscere le emorragie che richiedono cure mediche immediate (vedere COSA DEVONO SAPERE I GENITORI DI BAMBINI CON EMOFILIA).
Cosa può fare una persona affetta da emofilia?
Se soffri di emofilia, dovresti essere curato in un centro specializzato, dove verrà sviluppato per te un regime terapeutico, al quale potrai sottoporti sotto la supervisione di uno specialista qualificato. Segua sempre tutte le istruzioni del medico.
CONSIGLI PER LA CURA
Cosa dovrebbero sapere i genitori di bambini affetti da emofilia
Controlla le condizioni di tuo figlio
Informi immediatamente il medico se suo figlio è ferito, anche lieve. Le lesioni alla testa, al collo o all'addome sono particolarmente pericolose. Dopo tali lesioni, potrebbe essere necessaria un'infusione del fattore di coagulazione mancante. Se tuo figlio sta subendo un intervento chirurgico o un'estrazione di un dente, parla con il tuo medico di quali misure intraprendere.
Monitora attentamente il tuo bambino per rilevare segni di emorragia interna estesa, come dolore intenso (anche nell'addome), gonfiore di un'articolazione o di un muscolo, movimento articolare limitato, sangue nelle urine, feci catramose e un forte mal di testa.
Sii consapevole dei fattori di rischio
Poiché il bambino riceve infusioni di componenti del sangue, esiste il rischio di contrarre l'epatite. I primi segni di infezione possono comparire da 3 settimane a 6 mesi dopo che il bambino ha ricevuto i componenti del sangue. Sintomi: mal di testa, febbre, scarso appetito, nausea, vomito, dolore addominale e dolore nella zona del fegato (nell'ipocondrio e al centro dell'addome).
Non dare mai l'aspirina a tuo figlio perché potrebbe causare sanguinamento. Come antidolorifico, puoi offrire a tuo figlio Tylenol o un altro farmaco contenente paracetamolo.
Se tuo figlio ha ricevuto componenti del sangue prima che venisse sottoposto al test di routine per l'infezione da HIV, potrebbe risultare positivo all'infezione da HIV.
Se avete figlie femmine, rivolgetevi ad un centro medico specializzato per verificare se sono portatrici di emofilia. I familiari maschi malati necessitano di aiuto psicologico.
Assicurati che tuo figlio indossi sempre un braccialetto di identificazione medica.
Insegna a tuo figlio a lavarsi i denti regolarmente e accuratamente con spazzolini morbidi. Evitare l'estrazione del dente.
Proteggere il bambino da eventuali infortuni, ma non praticare restrizioni inutili che ne ritarderebbero lo sviluppo. Cucire ginocchiere e gomitiere imbottite nei suoi vestiti per proteggere le articolazioni in caso di cadute. I bambini più grandi non dovrebbero praticare sport di contatto (come il calcio), ma possono nuotare o giocare a golf.
È possibile applicare impacchi freddi e ghiaccio sulla zona interessata e si possono applicare bende a leggera pressione sulle aree sanguinanti. Per evitare che l'emorragia ritorni, limita la mobilità del bambino per 48 ore dopo che si è fermata.
Per evitare ricoveri frequenti, dovresti imparare a somministrare componenti del sangue con fattori di coagulazione. Non esitate a somministrare il concentrato dei fattori della coagulazione se inizia il sanguinamento. Tieni il concentrato sempre pronto, anche in vacanza.
Assicurati che tuo figlio venga regolarmente esaminato da un ematologo.
Cosa fare se inizia il sanguinamento
Rivolgiti a un medico. Il medico probabilmente ti somministrerà un'infusione del fattore di coagulazione o del plasma mancante.
Applicare un impacco freddo o del ghiaccio sulla parte del corpo ferita e sollevarla.
Per evitare che il sanguinamento si ripeta, ridurre l'attività fisica al minimo per 48 ore dopo la sua interruzione.
Se hai dolore, prendi un analgesico (es Tylenol o altri medicinali contenenti paracetamolo). Non assumere aspirina o farmaci contenenti aspirina perché potrebbero aumentare il sanguinamento.
Cosa fare se c'è sanguinamento nell'articolazione?
Se si avverte dolore all'articolazione, gonfiore, formicolio e la temperatura dei tessuti circostanti è aumentata, si può sospettare un'emorragia, in particolare nelle articolazioni del ginocchio, del gomito, della spalla, della caviglia, del polso e dell'anca.
Spostare immediatamente l'articolazione in una posizione elevata.
Per ripristinare la mobilità articolare, il medico può consigliarti di eseguire esercizi per aumentare l'ampiezza dei movimenti, ma dovrebbero iniziare 48 ore dopo l'arresto dell'emorragia. Evitare l’attività fisica (camminare) finché il sanguinamento non si arresta completamente.
L’emofilia è una malattia ereditaria associata a difetti genetici nei fattori della coagulazione del sangue. Viene trasmesso a un bambino da una madre malata nata in una famiglia i cui membri soffrivano di tale malattia. Una caratteristica importante è che la madre stessa può essere completamente sana. È portatrice di geni “rotti”.
Di norma, i primi segni della malattia iniziano a comparire nei bambini nel terzo anno di vita, molto meno spesso durante il periodo neonatale e l'infanzia. L'emofilia appartiene al gruppo delle diatesi emorragiche.
Cause dell'emofilia nei bambini:
La malattia si sviluppa a seguito di mutazioni ereditarie nei geni responsabili della produzione e del funzionamento dei fattori della coagulazione del sangue in un bambino. Come risultato di tali processi patologici nel corpo del bambino, si verifica quanto segue:
La formazione di un coagulo di sangue completo è compromessa
Il sanguinamento non si ferma o il processo è notevolmente ritardato
Una significativa perdita di sangue si sviluppa anche con sanguinamenti minori
Forme della malattia:
A seconda del tipo di disturbo nella sintesi dei fattori della coagulazione, l'emofilia può essere dei seguenti tipi:
1. classica - emofilia A. Associato a una mancanza di globulina antiemofila e tromboplastinogeno
2. Malattia di Natale: emofilia B. Causato dall'assenza di un altro fattore di coagulazione nel sangue del bambino: la tromboplastina plasmatica o il fattore di Natale
3. emofilia C . In questa forma della malattia non è presente tromboplastina nel sangue del bambino
4. emofilia D . Causato dall'assenza del quinto fattore di coagulazione del sangue nei bambini
5. emofilia acquisita. Non ereditato. Appare in età avanzata.
Gruppo a rischio: chi è più suscettibile alla malattia?:
L'emofilia di qualsiasi forma colpisce prevalentemente i ragazzi. Le ragazze e le donne possono soffrire solo di emofilia C e D. L'ereditarietà è associata a cambiamenti nei cromosomi X. Nella maggior parte dei casi, la malattia nei bambini è grave, il che limita le capacità del bambino e spesso porta alla disabilità del paziente.
Nei neonati, le manifestazioni dell'emofilia sono spesso assenti o lievi. Nella maggior parte dei pazienti, i primi sintomi visibili della malattia sono stati rilevati all'età di 2-3 anni. Man mano che il bambino invecchia, i segni dell’emofilia possono indebolirsi o, al contrario, intensificarsi, a seconda di molti fattori.
Manifestazioni di emofilia nei bambini:
I principali sintomi dell'emofilia nei bambini sono il sanguinamento e l'emorragia. Si verifica con il minimo danno ai vasi sanguigni. Nei casi più gravi, il sanguinamento appare senza motivo apparente ed è difficile da fermare. Insieme a queste manifestazioni della malattia, si notano quanto segue:
Pelle pallida e sottile in un bambino
delicata struttura corporea
scarso sviluppo del tessuto adiposo sottocutaneo
emorragie intraarticolari - emartro - uno dei sintomi più pericolosi dell'emofilia nei bambini. Spesso si verificano ripetutamente, portando a gravi deformazioni e disabilità del bambino
I danni si verificano più spesso nelle grandi articolazioni: ginocchia, gomiti, caviglie
aumento della temperatura corporea
infiammazione delle articolazioni
mobilità limitata dell'articolazione colpita da emorragia
sanguinamento interno, che è accompagnato da danni agli organi interni del bambino
dolore nell'area dell'emorragia se l'ematoma comprime le terminazioni nervose
In rari casi di malattia nelle ragazze e nelle donne, i sintomi saranno gli stessi. Nel caso dei portatori di geni “emofilici”, le donne hanno un'alta probabilità di gravi perdite di sangue intrapartum e postpartum.
L'entità del sanguinamento e dell'emorragia nei bambini dipende dal grado di riduzione della quantità di fattori della coagulazione. Se la carenza è lieve, il sanguinamento si verifica solo in caso di lesioni gravi o durante interventi chirurgici. Con una grave carenza di fattori della coagulazione, il sanguinamento è spontaneo, il che lo rende più pericoloso.
Cambiamenti nel quadro del sangue nell'emofilia:
L'esame del sangue rivelerà una carenza di un determinato fattore di coagulazione del sangue, a seconda della forma di emofilia. La sua quantità diminuisce entro limiti diversi, fino alla completa assenza.
I cambiamenti nell'emofilia nei bambini si verificano anche in altre cellule del sangue. Si segnalano le seguenti violazioni:
Leggera diminuzione dell'emoglobina e del numero dei globuli rossi
valori normali della conta dei globuli bianchi
leggero aumento del numero dei linfociti
la conta piastrinica è spesso entro i limiti normali
la forma delle piastrine non è corretta
conteggio piastrinico irregolare
tasso estremamente basso di coagulazione del sangue e di formazione di coaguli di sangue
il tempo di sanguinamento è spesso entro i limiti normali
È importante distinguere l’emofilia da altre malattie:
Esistono numerose patologie in cui il sanguinamento è uno dei segni principali. Pertanto, l’emofilia dovrebbe essere distinta dalle seguenti patologie:
Anemia perniciosa - causata dalla carenza di vitamina B12
anemia aplastica - associata a disturbi nella sintesi delle cellule del sangue nel midollo osseo
leucemia
policitemia – aumento del numero di globuli rossi nel sangue
sepsi
tifo
ittero
pertosse
tubercolosi
La malattia di Werlhof
Infantilismo intestinale di Herter
Malattia di Henoch-Schönlein
Tutte le malattie presentate differiscono dall'emofilia per il quadro clinico caratteristico e per i cambiamenti nel sangue. Sulla base dei risultati della ricerca, fare una diagnosi raramente causa difficoltà ai medici.
Caratteristiche del trattamento dell'emofilia nei bambini:
Il trattamento dell’emofilia è un processo lungo che non è sempre molto efficace. Spesso il successo del trattamento non dura a lungo e migliora la qualità della vita del bambino solo per un breve periodo di tempo. Allo stesso tempo, i moderni metodi di trattamento e i farmaci consentono di affrontare con successo la malattia.
La dietoterapia nel trattamento dell’emofilia
Il cibo per un bambino affetto da emofilia dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
Nutrizione e contenuto calorico
diversità
alto contenuto di proteine e grassi
ricco di vitamine
alti livelli di tuorli d’uovo nella dieta
Terapia farmacologica per l'emofilia
Tutti i farmaci usati per trattare l'emofilia nei bambini hanno i seguenti effetti:
Migliora la coagulazione del sangue in vari modi
ridurre la durata del sanguinamento
aumentare il tono e la forza delle pareti dei vasi sanguigni
Preparati di calcio nel trattamento dell'emofilia
Il calcio aiuta a ridurre la permeabilità vascolare e aumenta anche la resistenza capillare. Grazie a questa azione, questi farmaci aiutano a migliorare la coagulazione del sangue. Le forme più comuni sono il lattato di calcio e il gluconato.
Importante! Per aumentare la ritenzione di calcio nel sangue, si raccomanda di somministrare farmaci ai bambini in combinazione con olio di pesce in qualsiasi forma.
Integratori di ferro
I farmaci vengono prescritti per trattare qualsiasi forma di emofilia. Utilizzato in grandi dosaggi su lunghi corsi. Durante i periodi di remissione dell'emofilia, viene utilizzato un trattamento combinato che comprende integratori di ferro e calcio.
Trasfusione di sangue, somministrazione di fattori della coagulazione
Si tratta di una variante della terapia sostitutiva, che consiste nel somministrare al paziente i fattori della coagulazione mancanti, gli elementi del sangue e il complesso protrombinico. I bambini affetti da emofilia ricevono ripetute infusioni di sangue per via endovenosa per 8 settimane con pause di 6 giorni. In alcuni casi, viene somministrato il sangue ottenuto da un donatore. Spesso vengono infuse solo parti separate del sangue: plasma, piastrine, eritrociti o leucociti, a seconda delle condizioni del bambino e della forma di emofilia. L'eparina viene prescritta con la somministrazione del complesso protrombinico per prevenire la formazione di coaguli di sangue.
Applicazione di una spugna emostatica
Questo è un rimedio locale per fermare il sanguinamento. Fatto dal plasma sanguigno. Utilizzato direttamente sul sito del danno alla nave. Dona un effetto rapido e duraturo. Più spesso utilizzato per sanguinamenti minori, anche sulle mucose.
Vitamine nel trattamento dell'emofilia
I farmaci obbligatori utilizzati per il trattamento e la prevenzione dell'emofilia nei bambini sono le vitamine. È giustificata la prescrizione delle seguenti vitamine: A, B2, B6, B12, C, K, P
Agenti emostatici
Nella medicina moderna è diffuso l'uso di emostatici, che non solo aiutano a fermare il sanguinamento, ma rafforzano anche le pareti dei vasi sanguigni: etamsylate, acido aminocaproico, dicinone.
Trattamento dell'emorragia articolare
L'articolazione interessata deve essere mantenuta il più immobile possibile. In futuro, i coaguli di sangue dovrebbero essere rimossi dall'area danneggiata, quindi dovrebbero essere somministrati corticosteroidi (prednisolone).
Un bambino affetto da emofilia deve avere sempre con sé una documentazione medica contenente le seguenti informazioni:
Forma di emofilia
gruppo sanguigno
Fattore Rh
Prevenzione e prognosi della malattia:
È necessario prevenire varie lesioni e danni all'integrità dei vasi sanguigni nei bambini affetti da emofilia. Dovresti proteggere le articolazioni del tuo bambino ed evitare sforzi fisici eccessivi, che possono causare sanguinamento ed emorragia.
La prognosi per l’emofilia è spesso favorevole. Attualmente, questa malattia è abbastanza facile da identificare. Il trattamento razionale con un regime delicato e una corretta alimentazione del bambino dà un risultato positivo.
In rari casi, con lesioni estese e spesso ripetute alle articolazioni, il bambino può diventare disabile, il che è associato a mobilità limitata.
108. Emofilia nei bambini. Eziologia, patogenesi, classificazione, clinica, trattamento
L'emofilia è un gruppo di malattie in cui una carenza di fattori della coagulazione (solitamente VIII e IX) porta alla comparsa della sindrome emorragica.
Esistono forme congenite e acquisite di emofilia. Le emofilie congenite più comuni sono l'emofilia A (carenza del fattore VIII) e l'emofilia B (carenza del fattore IX, malattia di Christmas). Molto meno comune è l'emofilia C (carenza del fattore XI), molto raramente - emofilia concomitante (carenza simultanea dei fattori VIII e IX), spesso accompagnata da una visione dei colori compromessa. L'emofilia acquisita nei bambini è rara, di solito quando compaiono anticorpi contro i fattori della coagulazione nelle malattie autoimmuni e mieloproliferative.
Epidemiologia dell'emofilia
L'incidenza dell'emofilia è di 13-14 ogni 100.000 uomini. Il rapporto tra emofilia A ed emofilia B è 4:1. La natura ereditaria dell'emofilia è stata notata nel 70-90% dei pazienti, sporadica nel 10-30%.
Classificazione dell'emofilia
Una forma molto grave di emofilia (in una forma di emofilia molto grave, l'attività del fattore VIII/IX non supera lo 0,99%).
Forma grave di emofilia (l'attività del fattore VIII/IX è 1-2,99%).
Forma moderata di emofilia (attività del fattore VIII/IX - 3-4%).
Forma lieve di emofilia (attività del fattore VIII/IX - 5-12%).
Forma cancellata di emofilia (attività di fattore VIII/IX - 13-50%).
emofilia A (carenza dell'attività del fattore VIII della coagulazione);
emofilia B (attività carente del fattore IX della coagulazione);
emofilia C (attività carente del fattore XI della coagulazione).
Gravità (corso):
polmone (attività del fattore - 5-10%);
moderato (attività del fattore inferiore all'1-5%);
grave (attività del fattore inferiore all'1%);
latente (attività del fattore superiore al 15%).
Stadio di emartrosi e artropatia:
emartro senza disfunzione dell'articolazione;
emartro con sinovite fibrinosa adesiva e osteoporosi, disfunzione iniziale dell'articolazione;
regressione con allargamento e completa deformazione delle articolazioni, grave compromissione della funzione articolare;
sono possibili un forte restringimento dello spazio intra-articolare, sclerosi e cistosi delle epifisi, fratture intra-articolari; anchilosi delle articolazioni.
Cause dell'emofilia
La causa diretta dell'emofilia A e B è una mutazione genetica nella regione del braccio lungo q27-q28 del cromosoma X. Circa 3/4 dei pazienti affetti da emofilia hanno una storia familiare di sindrome emorragica nei parenti, e in circa 1/4 l'ereditarietà della malattia non viene rintracciata e in tali casi si presuppone una mutazione spontanea dei geni sul cromosoma X.
Patogenesi dell'emofilia. La mancanza di fattori della coagulazione del plasma (VIII, IX, XI) provoca un disturbo nel collegamento interno della coagulazione dell'emostasi e provoca un sanguinamento ritardato di tipo ematomatoso.
La concentrazione dei fattori VIII e IX nel sangue è bassa (rispettivamente 1-2 mg e 0,3-0,4 mg per 100 ml o una molecola di fattore VIII per 1 milione di molecole di albumina), ma in assenza di uno di essi la coagulazione del sangue avviene nella sua prima fase lungo la via esterna, l'attivazione rallenta molto bruscamente o non avviene affatto
I sintomi dell'emofilia A e dell'emofilia B sono identici; il tipo di emofilia viene determinato solo attraverso test di laboratorio, inclusa la determinazione quantitativa dei fattori della coagulazione.
La gravità della sindrome emorragica nell'emofilia A dipende direttamente dalla gravità della lesione, dall'attività della coagulazione e dal livello del fattore VIII antiemofilico: meno dell'1% - grave, 1-5% - moderato, 5-10 - lieve, più di 15 % - forma latente della malattia. La stessa gradazione di gravità viene utilizzata per l'emofilia B in relazione all'attività della coagulazione e al livello del fattore IX e dell'emofilia C (deficit dell'attività del fattore XI della coagulazione). Solo traumi significativi causano un aumento del sanguinamento quando il livello e l'attività della coagulazione dei fattori VIII o IX diminuiscono del 50-25%; ad un livello del 25-5%, il sanguinamento maggiore si verifica a causa di lesioni minori o interventi chirurgici minori; ad un livello inferiore a 5%, si verifica sanguinamento spontaneo.
Le prime manifestazioni della sindrome emorragica nell'emofilia si verificano alla fine del primo anno di vita, quando si interrompe l'allattamento al seno. Il latte materno contiene una quantità sufficiente di trombochinasi attiva, che compensa la carenza di fattori della coagulazione del sangue nei pazienti affetti da emofilia (effetto protettivo). Dopo un anno, il bambino inizia a muoversi attivamente e il rischio di lesioni aumenta in modo significativo, quindi, prima di 1 anno di età, l'emofilia viene diagnosticata solo nella metà dei pazienti e prima dei 4 anni la diagnosi viene stabilita nel 95% di casi.
Nell'emofilia infantile esiste una chiara evoluzione legata all'età dei vari sintomi della malattia. Nelle forme gravi di emofilia, il neonato già dalle prime ore di vita presenta estesi cefaloematomi, emorragie intradermiche e talvolta sanguinamento tardivo dalla ferita ombelicale. Nella seconda metà dell'anno si verifica spesso sanguinamento gengivale dalla mucosa orale, associato alla sua traumatizzazione da parte di vari oggetti, e sono tipiche anche emorragie nella zona dei glutei.
Il decorso dell'emofilia è caratterizzato da periodi di esacerbazioni e remissioni.
Segni opzionali di emofilia sono lo sviluppo di anemia postemorragica, anchilosi articolare e atrofia muscolare.
Le caratteristiche della sindrome emorragica nell'emofilia nei bambini sono le seguenti.
Sanguinamento
Il sanguinamento ritardato si verifica diverse ore dopo l'infortunio. Sanguinamento nel periodo neonatale: cefaloematoma, emorragia dei glutei durante la presentazione podalica, sanguinamento dal cordone ombelicale. Successivamente: sanguinamento durante la dentizione o quando viene ferito il frenulo della lingua, ematomi in luoghi di lividi e iniezioni intramuscolari, sanguinamento durante la circoncisione del prepuzio.
Il sanguinamento gastrointestinale è tipico dei bambini più grandi, sono associati a patologie erosive e ulcerative del tratto gastrointestinale.
Emorragie
Sono possibili emorragie alle articolazioni, il più delle volte in quelle grandi: ginocchia, caviglie, gomiti. Dal momento in cui il bambino cammina autonomamente, gli ematomi intermuscolari diventano il sintomo principale. Il sangue nella cavità articolare provoca l'infiammazione della membrana sinoviale e ripetute emorragie portano alla distruzione della cartilagine articolare, allo sviluppo di osteoartrite, fibrosi e anchilosi dell'articolazione, seguite da atrofia muscolare. L'articolazione colpita di solito diventa sede di ripetute emorragie.
L'emorragia nel muscolo ileopsoas provoca dolore addominale, contrattura in flessione dell'anca (che simula clinicamente un danno all'articolazione dell'anca) e rigidità dei muscoli della parete addominale anteriore, che viene spesso confusa con un'appendicite acuta. Alla palpazione dell'area del muscolo interessato, viene rilevata una formazione densa e dolorosa.
Ematuria
L'ematuria è più spesso osservata nei bambini di età superiore ai 5 anni. Le sue cause possono essere lesioni alla regione lombare, danni renali del complesso immunitario, elevata attività dell'urochinasi, ossaluria in pazienti con emartrosi ripetuta e uso frequente di analgesici, sviluppo o posizione anormali dei reni. L'ematuria macroscopica spesso si verifica spontaneamente. A volte è accompagnato da disuria, dolore nella regione lombare (fino alla colica renale), lungo gli ureteri o l'uretra. Dopo diversi stimoli dolorosi di urinare, i coaguli di sangue scompaiono e il dolore diminuisce.
Una forma lieve di emofilia è accompagnata da un sanguinamento minimo e viene rilevata in età avanzata durante un intervento chirurgico o un trauma significativo.
Le emorragie intracraniche sono le più pericolose; Secondo varie fonti, la loro frequenza è del 4-13% e il tasso di mortalità raggiunge il 70%. Con l'aumento dell'ematoma intracranico si notano: disturbi di mal di testa, ansia, disorientamento e disturbi della coscienza, sintomi del tronco cerebrale (nistagmo, anisocoria), congestione dei vasi del fondo, bradicardia e tipi patologici di respirazione.
Diagnosi di laboratorio dell'emofilia
Diagnosticato dal prolungamento del tempo di coagulazione del sangue intero e dal tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT); il tempo di sanguinamento e il tempo di protrombina non sono stati modificati.
Il tipo e la gravità dell'emofilia sono determinati da una diminuzione dell'attività coagulante delle globuline antiemofiliche nel plasma (fattori VIII e IX).
Poiché l'attività del fattore VIII può essere ridotta anche nella malattia di von Willebrand, nei pazienti con emofilia A di nuova diagnosi è necessario determinare il livello dell'antigene del fattore di von Willebrand (nell'emofilia A il livello dell'antigene rimane normale).
Lo screening dei pazienti per gli inibitori del fattore VIII e/o IX è particolarmente necessario prima dell'intervento chirurgico elettivo.
Diagnosi prenatale e identificazione del portatore.
Piano di esame per sospetta emofilia
esame del sangue: numero di globuli rossi, reticolociti ed emoglobina; indice di colore, formula leucocitaria, VES; diametro dei globuli rossi (su uno striscio colorato);
coagulogramma: conta piastrinica; tempo di sanguinamento e tempo di coagulazione del sangue; tromboplastina parziale attivata e tempo di protrombina; contenuto di fattore IX e VIII e anticorpi contro il fattore VIII;
biochimica del sangue: bilirubina diretta e indiretta; transaminasi ALT e AST; urea; creatinina; elettroliti (K, Na, Ca, P);
analisi generale delle urine (esclusa ematuria);
test del sangue occulto nelle feci (test di Gregersen);
marcatori dell'epatite (A, B, C, D, E);
gruppo sanguigno e fattore Rh;
diagnostica funzionale: ECG; se indicato, ecografia della cavità addominale e delle articolazioni colpite e loro radiografia;
consultazioni: ematologo, genetista, neurologo, medico ORL; dentista
Caratteristiche di laboratorio dell'emofilia:
un aumento di molte volte della durata della coagulazione del sangue venoso secondo Lee-White;
aumentare il tempo di ricalcificazione del plasma;
aumento del tempo di tromboplastina parziale;
riduzione del consumo di protrombina;
bassi livelli di fattore VIII o IX nel sangue.
La valutazione della gravità dell'emofilia è determinata dalla gravità delle sindromi emorragiche e anemiche, dal livello di attività della coagulazione e dal contenuto di globuline antiemofiliche, nonché dalla presenza di complicanze.
Complicanze dell'emofilia: l'emartro è la complicanza più comune che porta alla disabilità precoce dei pazienti; sanguinamento renale con ostruzione parziale o completa delle vie urinarie e sviluppo di insufficienza renale acuta; emorragie nel cervello o nel midollo spinale.
La diagnosi differenziale dell'emofilia nel periodo postnatale viene effettuata con malattie emorragiche dei neonati, coagulopatie e sindrome DIC. La sindrome emorragica nell'emofilia A e B non presenta differenze caratteristiche e la diagnosi differenziale viene effettuata utilizzando metodi di laboratorio e di genetica medica.
L'emofilia A viene diagnosticata testando il gene del fattore VIII, mentre l'emofilia B viene diagnosticata testando il gene del fattore IX. Vengono utilizzati due metodi: "reazione a catena della polimerasi - polimorfismo della lunghezza del frammento di restrizione" e "reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa". Ciascun metodo richiede una piccola quantità di sangue o di biopsia dei villi coriali, che consente di diagnosticare l'emofilia prenatale in una fase iniziale della gravidanza (8-12 settimane).
La componente principale del trattamento dell'emofilia è una terapia sostitutiva tempestiva e adeguata che ripristina il livello del fattore carente nel plasma. Attualmente esistono tre metodi di trattamento per i pazienti affetti da emofilia:
profilattico;
trattamento a casa;
trattamento in caso di sanguinamento.
Trattamento preventivo per l'emofilia
Questo è il metodo più progressivo. Il suo obiettivo è mantenere l'attività del fattore di carenza ad un livello pari a circa il 5% del normale per evitare emorragie alle articolazioni. Il trattamento preventivo inizia all'età di 1-2 anni prima della comparsa del primo emartro o immediatamente dopo. Nel trattamento vengono utilizzati concentrati di fattori della coagulazione (CFC) con un elevato grado di purificazione. I farmaci vengono somministrati 3 volte a settimana per l'emofilia A e 2 volte a settimana per l'emofilia B (poiché l'emivita del fattore IX è più lunga) ad una velocità di 25-40 UI/kg. La durata del trattamento preventivo varia da diversi mesi a tutta la vita. I pazienti non presentano lesioni del sistema muscolo-scheletrico, sono completamente socialmente adattati e possono praticare sport.
Trattamento dell'emofilia a casa
È raccomandato per i pazienti con sindrome emorragica meno grave o con opzioni di fornitura di farmaci limitate. Il farmaco viene somministrato immediatamente dopo l'infortunio o al minimo segno di emorragia incipiente. La somministrazione immediata del farmaco aiuta a fermare l'emorragia in una fase precoce, previene danni ai tessuti o la formazione di emartro massiccio con un minore consumo di farmaco. L'FSC viene utilizzato anche per il trattamento domiciliare.
Trattamento dell'emofilia basato sulla comparsa di sanguinamento
Questo trattamento richiede una piccola quantità di farmaci, ma non evita massicci ematomi intermuscolari e retroperitoneali ed emorragie nel sistema nervoso centrale. I pazienti soffrono di artropatia progressiva e sono socialmente disadattati. Vengono prescritti farmaci grezzi che non hanno subito inattivazione virale: fattore VIII della coagulazione del sangue (crioprecipitato), FFP, concentrato plasmatico nativo (NPC).
La scelta del trattamento dipende dalla forma e dalla gravità dell'emofilia, nonché dalla sede dell'emorragia o del sanguinamento.
Per il trattamento delle forme lievi di emofilia con un livello di fattore superiore al 10% e delle donne portatrici di emofilia A con un livello di fattore VIII inferiore al 50%, viene utilizzata la desmopressina, che garantisce il rilascio del fattore VIII e del fattore von Willebrand da il deposito di cellule endoteliali. La desmopressina viene somministrata per via endovenosa alla dose di 0,3 mcg/kg in 50 ml di soluzione isotonica di cloruro di sodio in 15-30 minuti. La desmopressina è indicata per interventi chirurgici minori e per interventi su donne portatrici. L'emofilia grave richiede un trattamento con concentrati di fattore VIII/IX.
È noto che 1 UI di fattore, somministrata per 1 kg di peso del paziente, aumenta l'attività del fattore VIII nel plasma sanguigno del 2% nell'emofilia A e del fattore IX dell'1% nell'emofilia B. La dose dei fattori VIII/IX è determinato dalle formule:
Dose per un bambino di età inferiore a un anno = peso corporeo x livello del fattore desiderato (%);
Dose per un bambino dopo un anno = peso corporeo x livello del fattore desiderato (%) x 0,5.
Nella fase iniziale dell'emartro acuto, la FSC viene somministrata alla velocità di 10 UI/kg, nella fase tardiva - 20 UI/kg con somministrazioni ripetute ogni 12 ore. Il livello di fattore desiderato è del 30-40%.
Puntura articolare
Indicazioni per la puntura articolare: emartro primario; sindrome del dolore dovuta a emartro massiccio; emartro ricorrente; esacerbazione della sinovite cronica.
Dopo l'aspirazione del sangue, l'idrocortisone (idrocortisone emisuccinato) 50-100 mg viene iniettato nella cavità articolare a giorni alterni e, per un trattamento prolungato, il betametasone (diprospan).
Se ci sono segni di sinovite cronica nella fase acuta e di emartro ricorrente, si consiglia una serie di punture 1-3 volte a settimana fino alla completa risoluzione dell'infiammazione sullo sfondo del trattamento emostatico quotidiano (4-6 punture in totale).
In assenza di effetti sufficienti o nell'impossibilità di un trattamento adeguato, è indicata la sinovectomia (radioisotopica, artroscopica o aperta). 1-2 giorni dopo l'intervento chirurgico, ai pazienti viene prescritta la terapia fisica e un ciclo di trattamento emostatico preventivo per 3-6 mesi.
Trattamento per emorragie nel muscolo ileopsoas
La FSC viene somministrata alla dose di 30-40 UI/kg ogni 8-12 ore per 2-3 giorni, soggetto a riposo a letto e attività fisica limitata.
Trattamento per sangue dal naso
Per le epistassi, la FSC viene somministrata ad una velocità di 10-20 UI/kg ogni 8-12 ore con simultanea irrigazione della mucosa nasale con carbazocromo (adroxon), transamina, etamsilato (dicinone), acido aminocaproico al 5% e trombina.
Trattamento del sanguinamento delle mucose del cavo orale
Tale sanguinamento è prolungato. Nel sito della lesione si forma spesso un coagulo sciolto che non consente il collegamento dei bordi della ferita. Dopo la somministrazione di FSC, alla velocità di 20-40 UI/kg ogni 8-12 ore, il coagulo deve essere rimosso e i bordi della ferita devono essere collegati. Agenti antifibrinolitici: acido aminocaproico, transamina. La colla di fibrina e la purea di cibo refrigerata promuovono l'emostasi locale.
Igienizzazione del cavo orale
Prima di trattare un dente cariato è sufficiente una singola iniezione endovenosa di concentrati di fattori o, in caso di emofilia A, del fattore VIII della coagulazione del sangue (crioprecipitato). Entro 72-96 ore prima e dopo la procedura, viene prescritto acido aminocaproico: bambini 5% di acido aminocaproico per via endovenosa in una dose di 100 mg/kg per infusione, adulti - fino a 4-6 g/giorno di acido aminocaproico per via orale in 4 dosi. Il trattamento emostatico inizia prima dell'intervento chirurgico e continua per 2-3 giorni dopo l'intervento. Il farmaco viene somministrato ad una velocità di 10-15 UI/kg per l'estrazione degli incisivi e 20 UI/kg per la rimozione dei grandi molari. Inoltre vengono utilizzati agenti antifibrinolitici locali e sistemici e colla di fibrina. Si consiglia una dieta rigorosa e blanda e bevande fredde.
Trattamento per sanguinamento renale
Il trattamento emostatico viene effettuato fino alla risoluzione della macroematuria con una dose di 40 UI/kg per iniezione. Il livello del fattore desiderato è del 40%. Inoltre, viene prescritto un breve ciclo di prednisolone orale alla dose di 1 mg/kg al giorno, seguito da una rapida sospensione.
L'uso dell'acido aminocaproico nei pazienti con sanguinamento renale è controindicato a causa del rischio di trombosi glomerulare.
Sanguinamento gastrointestinale
In caso di sanguinamento gastrointestinale, è indicato l'esame endoscopico per chiarire la causa e la fonte del sanguinamento. Il livello del fattore desiderato è del 60-80%. È necessario l'uso attivo degli inibitori della fibrinolisi, nonché il trattamento generalmente accettato per le malattie erosive e ulcerative dello stomaco e dell'intestino.
Sanguinamenti potenzialmente letali, inclusa l'emorragia cerebrale, e interventi chirurgici estesi richiedono la somministrazione di CPS ad una velocità di 50-100 UI/kg 1-2 volte al giorno fino alla scomparsa dei segni di sanguinamento e il successivo trattamento di mantenimento in dosi più piccole fino alla scomparsa della ferita. guarisce. L'infusione continua di CPS alla dose di 2 UI/kg all'ora garantisce che il loro livello costante non sia inferiore al 50% della norma. Inoltre, è indicato l'uso di inibitori della fibrinolisi. Successivamente, il trattamento emostatico viene effettuato secondo un regime di trattamento preventivo per 6 mesi.
In assenza di FSC, vengono utilizzati il fattore VIII della coagulazione del sangue (crioprecipitato), FFP e CNP (contiene il fattore IX).
L'attività media di 1 dose di fattore VIII della coagulazione del sangue (crioprecipitato) è di 75 UI. Il farmaco mantiene i livelli di fattore VIII entro il 20-40%, sufficiente per gli interventi chirurgici. Si somministra lentamente, per via endovenosa in flusso, alla dose di 30-40 unità/kg dopo 8, 12, 24 ore, a seconda del livello e del tipo di sanguinamento desiderato. 1 unità/kg del farmaco aumenta il livello del fattore dell'1%.
Se è impossibile trattare pazienti affetti da emofilia B con concentrato di fattore IX, si utilizza CNP alla dose di 20-30 ml/kg al giorno in 2 dosi fino alla stabilizzazione della condizione e, in sua assenza, FFP. 1 dose di FFP/KNP contiene in media 50-100 UI di fattore IX. FFP/KNP viene somministrato in ragione di 1 dose per 10 kg di peso del paziente.
Restrizioni oggettive all'uso del fattore VIII della coagulazione del sangue (crioprecipitato), FFP e CNP:
non standardizzazione ed effetto emostatico insignificante (portano dall'infanzia all'artropatia con limitazione dei movimenti e successivamente alla disabilità precoce);
bassa purificazione dei farmaci e mancanza di inattivazione antivirale (quindi, il 50-60% dei pazienti emofilici ha marcatori positivi dell'epatite C, il 7% è portatore permanente del virus dell'epatite B;
alta frequenza di reazioni allergiche e trasfusionali;
la minaccia di sovraccarico circolatorio dovuto alla somministrazione di grandi volumi di questi farmaci con una concentrazione minima di fattori della coagulazione in essi;
immunosoppressione;
bassa qualità di vita dei pazienti.
Era conosciuto nel mondo antico. Tuttavia, fu identificata per la prima volta come malattia indipendente e descritta in dettaglio nel 1874 da Fordyce. L’emofilia è una malattia molto grave e pericolosa.
Emofilia
è una malattia ereditaria caratterizzata da un'aumentata tendenza al sanguinamento. La causa di questa malattia è la presenza di una mutazione “cattiva” nel cromosoma sessuale X. Ciò significa che esiste una certa sezione (gene) sul cromosoma X che causa tale patologia. Questo gene alterato sul cromosoma X è la vera mutazione (recessiva). A causa del fatto che la mutazione si trova sul cromosoma, l'emofilia viene ereditata, cioè dai genitori ai figli.
Come funzionano i geni e cosa sono le malattie genetiche?
Consideriamo il concetto di geni recessivi e dominanti, poiché ciò è necessario per un'ulteriore comprensione delle caratteristiche della manifestazione dell'emofilia. Il fatto è che tutti i geni sono divisi in dominanti e recessivi. Come sapete, ogni persona riceve un set di geni da entrambi i genitori: madre e padre, cioè ha due varianti dello stesso gene. Ad esempio, due geni per il colore degli occhi, due per il colore dei capelli e così via. Inoltre, ciascuno dei geni può essere dominante o recessivo. Il gene dominante è espresso Sempre e sopprime quello recessivo, ma quello recessivo appare solo quando è presente su entrambi i cromosomi: materno e paterno. Ad esempio, il gene per gli occhi marroni è dominante e il gene per gli occhi azzurri è recessivo. Ciò significa che se un bambino riceve un gene per gli occhi marroni da sua madre e un gene per gli occhi azzurri da suo padre, allora nascerà con gli occhi marroni, cioè il gene dominante per gli occhi marroni si manifesterà e sopprimerà gli occhi marroni. gene recessivo per gli occhi azzurri. Affinché un bambino possa nascere con gli occhi azzurri, deve ricevere due geni recessivi degli occhi azzurri sia da sua madre che da suo padre, solo in questo caso apparirà un tratto recessivo: gli occhi azzurri.Perché la malattia si trasmette attraverso la linea femminile e solo gli uomini la contraggono?
 Torniamo all'emofilia. La particolarità dell'emofilia è che le donne sono portatrici di questa patologia e gli uomini ne sono colpiti. Perché è così? Il gene dell'emofilia è recessivo e si trova sul cromosoma sessuale X. La sua eredità è legata al genere. Cioè, per la sua manifestazione è necessario avere due cromosomi X con tale mutazione. Tuttavia, una donna ha due cromosomi sessuali X e un uomo ha i cromosomi X e Y. Pertanto, affinché la malattia dell'emofilia si manifesti, una donna deve avere una mutazione in entrambi i cromosomi X. Tuttavia, un fatto del genere è impossibile. Perché? Quando una donna rimane incinta di una ragazza con mutazioni in entrambi i cromosomi X, a 4 settimane di gravidanza, quando inizia il processo di formazione del sangue stesso del feto, si verifica un aborto spontaneo, poiché un tale feto non è vitale. Pertanto, una ragazza può nascere solo con una mutazione in un cromosoma X. E in questo caso, la malattia non si manifesterà, poiché il gene dominante del secondo cromosoma X non consentirà al gene recessivo, che porta all'emofilia, di manifestarsi. Pertanto, le donne sono solo portatrici di emofilia.
Torniamo all'emofilia. La particolarità dell'emofilia è che le donne sono portatrici di questa patologia e gli uomini ne sono colpiti. Perché è così? Il gene dell'emofilia è recessivo e si trova sul cromosoma sessuale X. La sua eredità è legata al genere. Cioè, per la sua manifestazione è necessario avere due cromosomi X con tale mutazione. Tuttavia, una donna ha due cromosomi sessuali X e un uomo ha i cromosomi X e Y. Pertanto, affinché la malattia dell'emofilia si manifesti, una donna deve avere una mutazione in entrambi i cromosomi X. Tuttavia, un fatto del genere è impossibile. Perché? Quando una donna rimane incinta di una ragazza con mutazioni in entrambi i cromosomi X, a 4 settimane di gravidanza, quando inizia il processo di formazione del sangue stesso del feto, si verifica un aborto spontaneo, poiché un tale feto non è vitale. Pertanto, una ragazza può nascere solo con una mutazione in un cromosoma X. E in questo caso, la malattia non si manifesterà, poiché il gene dominante del secondo cromosoma X non consentirà al gene recessivo, che porta all'emofilia, di manifestarsi. Pertanto, le donne sono solo portatrici di emofilia. I ragazzi hanno un cromosoma X e l'altro Y, che non contiene il gene dell'emofilia. In questo caso, se c'è un gene dell'emofilia recessivo sul cromosoma X, non c'è nessun altro gene dominante sul cromosoma Y che sopprime questo gene recessivo. Pertanto, il gene si manifesta nel ragazzo e soffre di emofilia.
L’emofilia femminile è una “malattia vittoriana”
Nella storia esiste un solo esempio conosciuto di donna affetta da emofilia: la regina Vittoria. Tuttavia, questa mutazione è avvenuta in lei dopo la nascita, quindi questo caso è unico e costituisce un'eccezione che conferma la regola generale. Per questo fatto eccezionale, l’emofilia è anche chiamata “malattia vittoriana” o “malattia reale”.
Quali sono i tipi di emofilia?
 L'emofilia è divisa in tre tipi A, B e C. Con l'emofilia di tutti e tre i tipi, non c'è la quantità necessaria di proteine nel sangue, che è chiamata fattore di coagulazione e garantisce la coagulazione del sangue, oltre a fermare il sanguinamento. Esistono solo 12 fattori della coagulazione: nell'emofilia A c'è una carenza nel sangue del fattore numero VIII, nell'emofilia B c'è una carenza del fattore numero IX e nell'emofilia C c'è una carenza del fattore numero XI. L'emofilia di tipo A è classica e rappresenta l'85% di tutti i tipi di emofilia; l'emofilia B e C rappresentano rispettivamente il 15% del numero totale di tutti i casi di emofilia. L'emofilia di tipo C si distingue perché le sue manifestazioni differiscono significativamente dalle manifestazioni dell'emofilia B e A. Le manifestazioni dell'emofilia A e B sono le stesse. L'emofilia C si riscontra più spesso tra gli ebrei ashkenaziti e possono esserne colpite anche le donne, non solo gli uomini. Oggi l'emofilia C è generalmente esclusa dall'emofilia, quindi considereremo l'emofilia A e B.
L'emofilia è divisa in tre tipi A, B e C. Con l'emofilia di tutti e tre i tipi, non c'è la quantità necessaria di proteine nel sangue, che è chiamata fattore di coagulazione e garantisce la coagulazione del sangue, oltre a fermare il sanguinamento. Esistono solo 12 fattori della coagulazione: nell'emofilia A c'è una carenza nel sangue del fattore numero VIII, nell'emofilia B c'è una carenza del fattore numero IX e nell'emofilia C c'è una carenza del fattore numero XI. L'emofilia di tipo A è classica e rappresenta l'85% di tutti i tipi di emofilia; l'emofilia B e C rappresentano rispettivamente il 15% del numero totale di tutti i casi di emofilia. L'emofilia di tipo C si distingue perché le sue manifestazioni differiscono significativamente dalle manifestazioni dell'emofilia B e A. Le manifestazioni dell'emofilia A e B sono le stesse. L'emofilia C si riscontra più spesso tra gli ebrei ashkenaziti e possono esserne colpite anche le donne, non solo gli uomini. Oggi l'emofilia C è generalmente esclusa dall'emofilia, quindi considereremo l'emofilia A e B. Cosa è pericoloso per i pazienti affetti da emofilia?
Come si manifesta l'emofilia? Quali sono i suoi sintomi? C'è un'opinione tra le persone secondo cui un paziente affetto da emofilia dovrebbe essere protetto dalle più piccole lesioni minori: tagli, morsi, graffi, ecc. Poiché queste lesioni lievi possono portare alla morte a causa della perdita di sangue. Tuttavia, questa è una chiara esagerazione. Lesioni gravi, emorragie gravi, estrazioni dentarie e operazioni chirurgiche sono pericolose per queste persone. Naturalmente, non dovresti trascurare le misure di sicurezza: devi fare attenzione a contusioni, lesioni, tagli, ecc. Le lacerazioni sono particolarmente pericolose. È particolarmente necessario spiegare le norme di comportamento ai bambini e agli adolescenti affetti da emofilia, poiché i bambini e gli adolescenti svolgono un'elevata attività fisica e molti giochi di contatto, che possono portare a lesioni accidentali.Sintomi congeniti e infantili dell'emofilia
 Se un bambino ha l'emofilia A o B, dalla nascita vengono rilevati i seguenti sintomi:
Se un bambino ha l'emofilia A o B, dalla nascita vengono rilevati i seguenti sintomi: - formazione di ematomi (lividi) in vari punti (sotto la pelle, nelle articolazioni, negli organi interni). Questi ematomi si formano a causa di colpi, contusioni, ferite, cadute, tagli, ecc.
- sangue nelle urine
- sanguinamento eccessivo dovuto a trauma (estrazione di un dente, intervento chirurgico)
Quando si sviluppa il sanguinamento nei pazienti affetti da emofilia?
 I pazienti affetti da emofilia sono caratterizzati dallo sviluppo di sanguinamento non solo immediatamente dopo l'infortunio, ma anche dopo un certo periodo di tempo dallo sviluppo di sanguinamenti ripetuti. Tali sanguinamenti ripetuti possono svilupparsi dopo poche ore o dopo pochi giorni. Per questi motivi, se un paziente affetto da emofilia necessita di un intervento chirurgico o di un'estrazione di un dente, allora è necessario preparare attentamente la persona all'intervento ed effettuarlo solo se assolutamente necessario.Il sanguinamento prolungato contribuisce anche alla formazione dell'anemia postemorragica.
I pazienti affetti da emofilia sono caratterizzati dallo sviluppo di sanguinamento non solo immediatamente dopo l'infortunio, ma anche dopo un certo periodo di tempo dallo sviluppo di sanguinamenti ripetuti. Tali sanguinamenti ripetuti possono svilupparsi dopo poche ore o dopo pochi giorni. Per questi motivi, se un paziente affetto da emofilia necessita di un intervento chirurgico o di un'estrazione di un dente, allora è necessario preparare attentamente la persona all'intervento ed effettuarlo solo se assolutamente necessario.Il sanguinamento prolungato contribuisce anche alla formazione dell'anemia postemorragica. In quali aree le emorragie sono più comuni nei pazienti affetti da emofilia?
La frequenza delle emorragie articolari nell'emofilia raggiunge il 70%, la frequenza di formazione di ematomi sottocutanei (lividi) è del 10-20%. E molto raramente con l'emofilia si verificano emorragie nel sistema nervoso centrale e sanguinamento gastrointestinale. Gli ematomi sono localizzati prevalentemente in quei luoghi in cui i muscoli subiscono il carico massimo: questi sono i muscoli delle cosce, della schiena e della parte inferiore delle gambe. Se una persona usa le stampelle, compaiono ematomi anche sotto le ascelle.Gli ematomi sono comuni nei pazienti affetti da emofilia
 Gli ematomi dei pazienti affetti da emofilia assomigliano a un tumore nell'aspetto e si risolvono in un lungo periodo di tempo, fino a 2 mesi. A volte, quando l'ematoma non si risolve per molto tempo, potrebbe essere necessario aprirlo. Con la formazione di estesi ematomi è possibile la compressione dei tessuti e dei nervi circostanti, che porta a disturbi della sensibilità e del movimento.
Gli ematomi dei pazienti affetti da emofilia assomigliano a un tumore nell'aspetto e si risolvono in un lungo periodo di tempo, fino a 2 mesi. A volte, quando l'ematoma non si risolve per molto tempo, potrebbe essere necessario aprirlo. Con la formazione di estesi ematomi è possibile la compressione dei tessuti e dei nervi circostanti, che porta a disturbi della sensibilità e del movimento. L’emoartrosi è una manifestazione comune dell’emofilia
 Il sanguinamento nelle articolazioni è il sintomo più specifico dell'emofilia. Le emorragie articolari sono la causa della formazione di malattie articolari - emoartrosi - nei pazienti affetti da emofilia. Questo danno alle articolazioni porta a malattie dell'intero sistema muscolo-scheletrico e, di conseguenza, alla disabilità. L'emoartrosi si sviluppa più rapidamente nei pazienti con forme gravi di emofilia, in altre parole, quanto più grave è l'emofilia, tanto più velocemente una persona sviluppa l'emoartrosi. I primi segni di emoartrosi si sviluppano intorno agli 8-10 anni di età. Nell'emofilia grave, le emorragie articolari si verificano spontaneamente e, nei casi lievi, si verificano a seguito di lesioni.
Il sanguinamento nelle articolazioni è il sintomo più specifico dell'emofilia. Le emorragie articolari sono la causa della formazione di malattie articolari - emoartrosi - nei pazienti affetti da emofilia. Questo danno alle articolazioni porta a malattie dell'intero sistema muscolo-scheletrico e, di conseguenza, alla disabilità. L'emoartrosi si sviluppa più rapidamente nei pazienti con forme gravi di emofilia, in altre parole, quanto più grave è l'emofilia, tanto più velocemente una persona sviluppa l'emoartrosi. I primi segni di emoartrosi si sviluppano intorno agli 8-10 anni di età. Nell'emofilia grave, le emorragie articolari si verificano spontaneamente e, nei casi lievi, si verificano a seguito di lesioni.
Sangue nelle urine, malattia renale nell'emofilia
L'ematuria (sangue nelle urine) può essere asintomatica o accompagnata da dolore acuto, un attacco di colica renale, che si verifica quando i coaguli di sangue attraversano le vie urinarie. I pazienti affetti da emofilia possono sviluppare malattie renali come pielonefrite, idronefrosi e sclerosi capillare.Quali farmaci non dovrebbero assumere le persone affette da emofilia?
Per i pazienti affetti da emofilia, i farmaci che riducono la coagulazione del sangue, come l'acido acetilsalicilico (aspirina), il butadione, ecc., sono strettamente controindicati.Segni di emofilia nei neonati
 Se un neonato non smette di sanguinare dal cordone ombelicale per molto tempo e presenta ematomi sulla testa, sui glutei e sul perineo, è necessario sottoporsi al test per la presenza di emofilia. Sfortunatamente, attualmente è impossibile prevedere la nascita di un bambino affetto da emofilia. Esistono metodi di diagnosi prenatale (prenatale), ma non sono diffusi a causa della loro complessità. Se un ragazzo ha l'emofilia nella sua famiglia, le sue sorelle sono portatrici del gene dell'emofilia e potrebbero avere figli affetti da emofilia. Pertanto, la storia familiare è di grande importanza nel prevedere la nascita di bambini che potrebbero soffrire di questa malattia.
Se un neonato non smette di sanguinare dal cordone ombelicale per molto tempo e presenta ematomi sulla testa, sui glutei e sul perineo, è necessario sottoporsi al test per la presenza di emofilia. Sfortunatamente, attualmente è impossibile prevedere la nascita di un bambino affetto da emofilia. Esistono metodi di diagnosi prenatale (prenatale), ma non sono diffusi a causa della loro complessità. Se un ragazzo ha l'emofilia nella sua famiglia, le sue sorelle sono portatrici del gene dell'emofilia e potrebbero avere figli affetti da emofilia. Pertanto, la storia familiare è di grande importanza nel prevedere la nascita di bambini che potrebbero soffrire di questa malattia. Diagnosi di emofilia
 I seguenti metodi di laboratorio vengono utilizzati per diagnosticare l'emofilia:
I seguenti metodi di laboratorio vengono utilizzati per diagnosticare l'emofilia: - determinazione della quantità di fattori della coagulazione nel sangue
- determinazione del tempo di coagulazione del sangue
- quantità di fibrinogeno nel sangue
- tempo di trombina (TT)
- indice di protrombina (PTI)
- rapporto internazionale normalizzato (INR)
- tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT)
- misto – APTT
Trattamento dell'emofilia
Questa malattia è incurabile e può essere controllata e fornita solo con una terapia di supporto. Per fare questo, alle persone affette da emofilia vengono somministrate soluzioni di un fattore di coagulazione che non hanno abbastanza nel sangue. Attualmente questi fattori della coagulazione vengono ottenuti dal sangue di donatori o dal sangue di animali allevati appositamente. Con un trattamento adeguato, l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da emofilia non differisce dall'aspettativa di vita delle persone che non soffrono di questa patologia. Tuttavia, poiché i farmaci per il trattamento dell’emofilia sono ottenuti dal sangue dei donatori, i pazienti affetti da emofilia corrono il rischio di malattie pericolose comeDi tutte le malattie del sangue e degli organi emopoietici, la gente comune ne conosce soprattutto due: l'anemia e l'emofilia. Il primo viene riscontrato dall'80% delle donne durante la gravidanza, mentre il secondo è diventato noto. Tsarevich Alexei, figlio dell'imperatore russo, aveva l'emofilia. Diamo un'occhiata a questa malattia in modo più dettagliato. Come si manifesta l'emofilia? Come viene trattata? Come convivere con questa diagnosi?
Definizione
Esistono molte definizioni di emofilia, ma nella sostanza sono tutte simili. Nella lingua ufficiale, l'emofilia è definita come una malattia ereditaria trasmessa da un tipo recessivo, legato all'X, caratterizzato da un sanguinamento bruscamente lento e aumentato a causa dell'insufficiente attività di coagulazione dei fattori della coagulazione del sangue.
Ora proviamo a rispondere in linguaggio semplice alla domanda: emofilia, che cos’è? Questa è una forma congenita di sanguinamento che un bambino riceve come “eredità” dai suoi genitori. A causa di un gene cattivo (difettoso), il bambino ne ha alcuni speciali che aiutano a fermare l'emorragia. Queste proteine sono chiamate fattore VIII (nell'emofilia di tipo A, il tipo più comune) e fattore IX (nell'emofilia di tipo B, il secondo tipo più comune della malattia).
La malattia dell'emofilia si verifica in 1 su 8.000 bambini. Secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo sono circa 450mila le persone che convivono con l’emofilia. In Russia sono registrati circa 12mila pazienti affetti da emofilia, di cui circa 5000 sono bambini. Il dottor Frank Schneibel ha fondato la World Hemophilia Association. Il suo compleanno, il 17 aprile, è diventata la Giornata mondiale dell’emofilia.
Qual è il pericolo?
In un bambino sano, il sanguinamento minore si arresta entro pochi minuti. Un ginocchio rotto, un dito tagliato, un gomito sbucciato sono compagni costanti dei giochi dei bambini. E nessuno presta molta attenzione. L'aiuto più serio a cui accetta un piccolo paziente è ungere il luogo della lesione con del verde brillante. Questo non è il caso dei bambini affetti da emofilia.
L'emofilia nei bambini può portare a gravi conseguenze: ogni piccolo taglio, perdita di un dente, contusione al ginocchio è complicata e può portare a lunghi giorni di ricovero in ospedale.
Catena ereditaria
Come viene ereditato il gene dell'emofilia? Quale matrimonio ha maggiori probabilità di avere un figlio affetto da emofilia? Consideriamo diverse opzioni in cui le persone si sposano con un'alta probabilità di avere un figlio affetto da emofilia.
Opzione uno: un uomo malato e una donna, portatrice del gene (conduttore).
 Padre malato, madre portatrice
Padre malato, madre portatrice Opzione due: un uomo malato e una donna sana.
 Padre malato, madre sana
Padre malato, madre sana La terza opzione per ereditare l'emofilia in un bambino: un uomo sano e una donna - un conduttore.
 Padre sano, madre portatrice
Padre sano, madre portatrice Da tutto ciò che è stato detto, segue la conclusione: è stata studiata l'eredità di un gene difettoso. Molto probabilmente i medici genetici possono prevedere la nascita di un bambino con coagulopatia. Soprattutto se i genitori sono a rischio, cioè uno dei genitori o entrambi avevano coagulopatie ereditarie. Di conseguenza, è noto a quali primi segni della malattia si dovrebbe prestare particolare attenzione e cosa dovrebbero ricordare genitori e pediatri.
Diagnosi precoce
Quando si esamina un bambino da un pediatra immediatamente dopo la nascita, è possibile rilevare i primi sintomi dell'emofilia nei bambini:
- sanguinamento dal cordone ombelicale legato;
- grandi (ematomi) sul sedere, sulla schiena, sulla testa del neonato.
Tutto quanto sopra conferma che il bambino ha ereditato il gene dell'emofilia. Ma sfortunatamente un neonatologo non può sempre fare una diagnosi. Dopo che la madre e il bambino vengono dimessi dall'ospedale di maternità, vengono tenuti sotto osservazione dal pediatra locale. Visitano regolarmente la clinica durante il primo anno di vita. A cosa dovresti prestare attenzione e cosa dovresti dire al tuo medico per una diagnosi tempestiva?
Esistono diversi segni di coagulopatia ereditaria che allarmano i genitori e attirano la loro attenzione:
- abbondante quando compaiono i primi denti;
- grandi lividi costanti, anche da colpi minori;
- di lunga durata
Dopo che i genitori notano i sintomi dell'emofilia nel bambino e consultano un medico, inizia la fase dell'esame e della diagnosi dell'emofilia. Questo viene fatto da uno specialista o da un ematologo.

Esame da parte di un ematologo
Il processo di diagnosi dell'emofilia nei bambini avviene in fasi:
- Innanzitutto vengono raccolti i reclami. Se un bambino è piccolo e non riesce a capire cosa sta succedendo, glielo dicono i suoi genitori.
- poi il medico raccoglie l'anamnesi, compresa la storia familiare. Cioè: chiede quanto tempo fa sono comparsi i segni di problemi di emostasi e se qualche parente aveva tali malattie.
- Ha luogo un esame dettagliato del paziente: ci sono abrasioni, ematomi, sanguinamento delle gengive e della mucosa nasale, gonfiore e gonfiore delle grandi articolazioni (ginocchia e gomiti. Nell'emofilia sono comuni emorragie intraarticolari).
Per confermare la diagnosi della malattia, vengono prescritti test di laboratorio:
- Il tempo viene esplorato;
- viene determinato il tempo di ricalcificazione del plasma e l'APTT (tempo di tromboplastina parziale attivata).
- Viene eseguita la diagnostica del DNA
E solo dopo aver ricevuto tutti i dati, l'ematologo fa la diagnosi finale.
Classificazione
Il passo successivo, quando l'emofilia viene confermata in un bambino, è determinarne il tipo. Il tipo di malattia dipenderà dai farmaci con cui verrà trattato il bambino. Per determinare il tipo di coagulopatia ereditaria, vengono esaminati i fattori. Ci sono tredici proteine specifiche coinvolte nel processo di coagulazione, ma solo 2 di esse sono suscettibili di mutazioni genetiche. Pertanto, la quantità di globulina antiemofila e il fattore Natale vengono studiati in dettaglio.
L’emofilia si divide in due tipologie:
- emofilia A, quando la quantità di globulina antiemofila (fattore VIII) è ridotta. Si tratta dell'80-85% di tutti i casi di coagulopatie ereditarie;
- emofilia B(malattia del Natale), associata a deficit del fattore Natale (o fattore IX), che rappresenta il 15-20% dei casi.
Oltre al tipo di malattia, viene determinata la sua gravità:
- La gravità lieve della malattia è definita quando l'attività dei fattori della coagulazione è pari al 5-40% del normale. In questo caso, la vita di un paziente emofilico differisce poco dalla vita di una persona sana.
- Quando l'attività proteica è compresa tra l'1 e il 5% della norma, si ritiene che la malattia abbia una gravità media.
- Se l'attività della globulina è inferiore all'1%, viene diagnosticata un'emofilia grave. Sfortunatamente, con una tale gravità, la malattia è praticamente incurabile.
Perché è necessario conoscere la gravità della malattia? La gravità della malattia determinerà il piano di trattamento, lo stile di vita e la prognosi futura per un bambino affetto da emofilia.
Trattamento
Dopo aver confermato la diagnosi, i genitori devono comprendere una semplice verità: l'emofilia è incurabile. Questa malattia è apparsa in un bambino perché c'è un gene difettoso e l'umanità non ha ancora imparato a correggere tali disturbi. Ma nonostante tutta la gravità della situazione, non bisogna prendere la diagnosi come una condanna a morte.
Un numero enorme di farmaci moderni contenenti globulina antiemofilica e fattore di Natale contribuiranno a fornire assistenza in modo rapido ed efficace al bambino, prolungare la vita e migliorarne la qualità.
Il trattamento dell'emofilia nei bambini viene effettuato tenendo conto di alcune caratteristiche:
- ai pazienti con coagulopatie non devono essere somministrate iniezioni intramuscolari. La somministrazione di tutti i farmaci è possibile sia per via orale che endovenosa;
- se si verifica sanguinamento di qualsiasi intensità e localizzazione, dolore, gonfiore e gonfiore delle grandi articolazioni, se si sospetta emorragia negli organi interni, è necessario iniziare immediatamente la terapia con farmaci antiemofilici concentrati;
- la terapia urgente con farmaci antiemofilici deve essere iniziata se si verifica una lesione con danno cutaneo (ferite da puntura, morsi);
- Il bambino dovrebbe essere portato dal dentista una volta ogni tre mesi. Il medico deve avere esperienza nel trattamento di bambini affetti da coagulopatie;
- Prima di qualsiasi intervento chirurgico o estrazione di un dente, è necessario somministrare la globulina antiemofila. Le iniezioni endovenose vengono somministrate solo nelle vene superficiali.
Per il trattamento dell'emofilia utilizzare:
- globulina antiemofila liofilizzata;
- concentrato di complesso protrombinico;
- crioconcentrato di plasma sanguigno umano;
- farmaci ricombinanti;
- spugne emostatiche per uso locale.
Questo è solo un breve elenco di farmaci che i medici attualmente utilizzano per stabilizzare le condizioni di un piccolo paziente. C’è un domani per la cura dell’emofilia? Senza dubbio. Attualmente è in fase di sviluppo una nuova metodica per il trattamento delle coagulopatie: la creazione dei cosiddetti “mini-organi” costituiti da linee specifiche di epatociti. Dopo essere state iniettate sotto la pelle di un bambino malato, queste stesse cellule sintetizzano la globulina antiemofila.
Oltre ai farmaci per l'emofilia, vengono utilizzati numerosi metodi ausiliari: per aumentare l'efficacia del trattamento, puntura articolare per rimuovere il sangue dalla capsula articolare e molto altro. Sono stati sviluppati regimi di trattamento per l'emofilia in un bambino e il medico può sempre scegliere l'opzione ottimale per questo particolare paziente.
Decorso della malattia
Il decorso dell'emofilia, come molte altre malattie croniche, è caratterizzato dalla periodicità. Fasi di esacerbazione si alternano a fasi di remissione (riposo). Durante la remissione, il bambino malato si sente bene. Non ci sono manifestazioni cliniche di coagulopatia. La durata delle remissioni può variare: da diverse settimane a diversi anni.
Possibili complicazioni
Nonostante il trattamento regolare della malattia da emofilia, l'osservazione da parte di un ematologo, l'aderenza al regime e l'attuazione delle raccomandazioni, possono verificarsi complicazioni dell'emofilia nei bambini:
- a causa di estese emorragie sottocutanee (ematomi), le terminazioni nervose vengono compresse e può svilupparsi paralisi o cancrena dell'arto;
- Il sanguinamento abbondante e costante porta allo sviluppo di;
- con emorragie nella cavità articolare, nel tempo si può formare immobilità completa o parziale (contrattura);
- Se ciò accade, può verificarsi paresi o paralisi.
È un'idea completamente sbagliata che un bambino affetto da emofilia possa morire per emorragia esterna. Molto più pericolosi sono quelli invisibili agli occhi.
Previsione
È necessario comprendere che anche con l'uso dei farmaci e delle tecniche più moderne, la prognosi, anche per le forme lievi di emofilia nei bambini, è grave.
È necessaria una costante osservazione clinica, che sarà effettuata da un ematologo, insieme al pediatra locale. Le visite dal medico non dovrebbero mancare. A casa, devi eseguire tu stesso la fitoterapia, cioè somministrare al bambino decotti alle erbe (ad esempio origano e labbro leporino inebriante). È meglio consultare il proprio medico su quali erbe sono le migliori per il tuo bambino. Attenzione: l'alimentazione di un bambino affetto da emofilia dovrebbe essere ricca di vitamine, calcio e ferro.
Cos’altro possono fare i genitori? Prima di tutto, assicurati di ricevere un aiuto psicologico specializzato. Un bambino malato cambia lo stile di vita dei genitori. Ha bisogno di più attenzioni e cure speciali. Ad esempio, le lesioni a un bambino affetto da emofilia sono pericolose, ma l'attività fisica è necessaria.
I genitori devono aiutare i propri figli ad imparare a vivere correttamente; l’emofilia non è solo una diagnosi, è uno stile di vita. Ma spesso i genitori stessi hanno bisogno di aiuto. Non essere timido nell’accettare il consiglio di uno psicologo o psicoterapeuta. Quando i genitori sono calmi e sicuri di fare tutto bene, il bambino si sente protetto. E il morale spesso influenza notevolmente il decorso della malattia.
Con i moderni metodi di trattamento, la prognosi dell'emofilia nei bambini è notevolmente migliorata e la mortalità è stata praticamente eliminata.