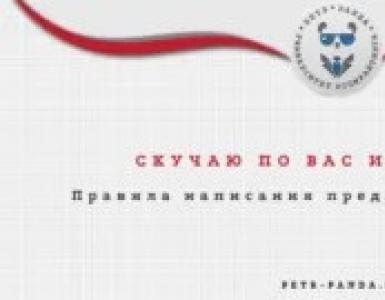Qual è la struttura dell'orecchio interno umano e le sue funzioni? Orecchio interno. Struttura dell'orecchio interno Cos'è l'orecchio interno
Un orecchio umano sano può distinguere un sussurro a una distanza di 6 metri e una voce abbastanza forte a 20 passi. Il punto sta nella struttura anatomica e nella funzione fisiologica dell'apparecchio acustico:
- Orecchio esterno;
- Orecchio medio;
- Nell'orecchio interno.
Struttura dell'orecchio interno umano
La struttura dell'orecchio interno comprende il labirinto osseo e membranoso. Se prendiamo un'analogia con un uovo, allora il labirinto osseo sarà l'albume e il labirinto membranoso sarà il tuorlo. Ma questo è solo un confronto per rappresentare una struttura all'interno di un'altra. La parte esterna dell'orecchio interno umano è unita da uno stroma osseo duro. Contiene: il vestibolo, la coclea, i canali semicircolari.
Nella cavità, al centro, il labirinto osseo e membranoso non è un luogo vuoto. Contiene un fluido con proprietà simili al liquido spinale: la perilinfa. Mentre il labirinto nascosto contiene endolinfa.
Struttura del labirinto osseo
Il labirinto osseo nell'orecchio interno si trova alla profondità della piramide dell'osso temporale. Ci sono tre parti:

L'orecchio interno è formato in modo tale che tutte le sue parti e sezioni interagiscono e si trovano in una struttura ossea solida separata.
Struttura del labirinto membranoso
Duplica la struttura del labirinto osseo e contiene quindi il vestibolo, i dotti cocleari e semicircolari:
- Orecchio interno. Nel vestibolo, il labirinto membranoso è costituito da due sacche che giacciono nella fossa ellittica e sferica del vestibolo del labirinto osseo. Comunicano attraverso uno stretto condotto dove ha origine il canale endolinfatico. Una sacca ellittica, altrimenti chiamata utricolo. Ci sono cinque passaggi dei condotti semicircolari. In una cavità "piccola" separata ci sono macchie bianche costituite da cellule sensibili. Controllano i movimenti diritti e regolari della testa;
- Orecchio interno. I condotti semicircolari del labirinto membranoso - simili ai tratti ossei - contengono anche ampolle, solo membranose. Sul lato nascosto di queste estensioni si trovano le cellule sensoriali (cellule ciliate) e c'è un pettine ampollare, la cui funzione è quella di registrare lo spostamento della testa nello spazio. Le eccitazioni fissate dalla capesante, dalle macchie, vengono effettuate al nervo vestibolococleare, che è direttamente collegato al cervelletto;
- Orecchio interno. Il dotto cocleare del labirinto membranoso si trova alla profondità del canale spirale della coclea ossea. Il punto di origine e di conclusione è il punto cieco. All'interno sporge una sporgenza, dove la lumaca è divisa in due parti:
- La scala timpanica dell'orecchio interno del labirinto membranoso - interagisce con l'orecchio medio, grazie all'apertura della coclea;
- La scala del vestibolo dell'orecchio interno, il labirinto membranoso, ha origine nella cavità sferica del vestibolo e interagisce con l'orecchio medio, grazie alla finestra del vestibolo. Questi due passaggi sono chiusi da una membrana e da una staffa, quindi l'endolinfa non li attraversa.
 L'orecchio interno umano, in fondo al condotto lungo la parete, contiene l'organo Corti o organo a spirale, contenente fibre sottili tese lungo la lunghezza della coclea, come le corde di uno strumento musicale. Qui si trovano anche le cellule di supporto e sensoriali. Sentono lo spostamento della perilinfa che si verifica quando la staffa si contrae nel lume del vestibolo. Le onde partono dal vestibolo della scala e raggiungono la membrana timpanica accessoria.
L'orecchio interno umano, in fondo al condotto lungo la parete, contiene l'organo Corti o organo a spirale, contenente fibre sottili tese lungo la lunghezza della coclea, come le corde di uno strumento musicale. Qui si trovano anche le cellule di supporto e sensoriali. Sentono lo spostamento della perilinfa che si verifica quando la staffa si contrae nel lume del vestibolo. Le onde partono dal vestibolo della scala e raggiungono la membrana timpanica accessoria.
Il movimento della perilinfa e dell'endolinfa porta al funzionamento dell'apparato di ricezione del suono (cellule sensoriali, ciliate), la sua funzione è convertire le vibrazioni in impulsi.
Dopo un lungo viaggio, entra nei nuclei uditivi, quindi nella corteccia cerebrale.
Fisiologia della percezione umana del suono
Le vibrazioni sonore attraversano l'orecchio esterno e muovono il timpano che si intromette.  Dopodiché, le ossa dell'orecchio medio vengono attivate e, in uno stato ingrandito, passano nell'orecchio interno attraverso l'apertura ovale, penetrando nel vestibolo della coclea. Questo movimento fa sì che la perilinfa e l'endolinfa si scuotano e durante il percorso le onde vengono risucchiate nelle cellule dell'organo del Corti. Il movimento di queste strutture crea un contatto con le fibre della membrana tegumentaria, sotto l'influenza i peli si piegano e si forma un impulso che passa nella sottocorteccia del cervello. Il suono ha le sue caratteristiche:
Dopodiché, le ossa dell'orecchio medio vengono attivate e, in uno stato ingrandito, passano nell'orecchio interno attraverso l'apertura ovale, penetrando nel vestibolo della coclea. Questo movimento fa sì che la perilinfa e l'endolinfa si scuotano e durante il percorso le onde vengono risucchiate nelle cellule dell'organo del Corti. Il movimento di queste strutture crea un contatto con le fibre della membrana tegumentaria, sotto l'influenza i peli si piegano e si forma un impulso che passa nella sottocorteccia del cervello. Il suono ha le sue caratteristiche:
- Frequenza – vibrazioni al secondo (orecchio umano da 21 a 19.999 Hz);
- Forza – la gamma delle vibrazioni;
- Volume;
- Altezza;
- Spettro: il numero di movimenti aggiuntivi.
Le sacche ellittiche e sferiche del vestibolo dell'orecchio interno contengono più punti sulla parete nascosta: l'apparato otolitico.  All'interno c'è un liquido gelatinoso, sopra il quale si trovano gli otoliti (cristalli) e le cellule recettrici, da cui si estendono i peli. Le funzioni degli otoliti sono la pressione costante sulle cellule. Il movimento del corpo piega i singoli peli, creando eccitazione che viene inviata al midollo allungato, che regola e, se necessario, normalizza la condizione. I canali semicircolari (osso e labirinto membranoso) hanno uno stiramento - ampolla. Sulla sua superficie interna ci sono cellule sensibili e l'endolinfa scorre nella cavità. Come risultato dell'accelerazione, della decelerazione e del movimento del corpo, il fluido irrita le cellule e queste, a loro volta, inviano un impulso al cervello. A causa del fatto che i canali si trovano reciprocamente perpendicolari tra loro, qualsiasi modifica viene registrata.
All'interno c'è un liquido gelatinoso, sopra il quale si trovano gli otoliti (cristalli) e le cellule recettrici, da cui si estendono i peli. Le funzioni degli otoliti sono la pressione costante sulle cellule. Il movimento del corpo piega i singoli peli, creando eccitazione che viene inviata al midollo allungato, che regola e, se necessario, normalizza la condizione. I canali semicircolari (osso e labirinto membranoso) hanno uno stiramento - ampolla. Sulla sua superficie interna ci sono cellule sensibili e l'endolinfa scorre nella cavità. Come risultato dell'accelerazione, della decelerazione e del movimento del corpo, il fluido irrita le cellule e queste, a loro volta, inviano un impulso al cervello. A causa del fatto che i canali si trovano reciprocamente perpendicolari tra loro, qualsiasi modifica viene registrata.
L'orecchio interno è l'organo responsabile dell'udito e dell'equilibrio, quindi le sue malattie portano a sintomi gravi. Esistono molte cause gravi di patologie dell'orecchio interno, il che significa che la prevenzione è di grande importanza.
Questa struttura è caratterizzata da una struttura complessa associata alle funzioni che svolge. Nei processi infiammatori possono verificarsi disturbi circolatori, lesioni, aumento della pressione endolinfatica, vertigini, ronzii e tintinnii e dolore che si irradia alla mascella.
Come funziona l'orecchio interno?
L'orecchio interno è un organo dell'equilibrio e dell'udito, costituito da tessuti molli e duri. La sua struttura comprende le seguenti formazioni:
- Labirinti ossei, membranosi e vestibolari.
- Il vestibolo.
- La coclea e i canali semicircolari attraverso i quali circola il fluido.
L'orecchio interno si trova all'interno delle ossa temporali del cranio. La coclea capta i suoni e i canali semicircolari trasmettono informazioni sulla posizione del corpo nello spazio. I segnali provenienti da questi organi entrano nel sistema nervoso centrale attraverso il nervo vestibolococleare.
Patologie dell'orecchio interno
L'orecchio interno è un organo importante la cui attività viene interrotta durante processi infiammatori e lesioni. Sintomi come:
- Disturbo dell'udito.
- Perdita del senso dell'equilibrio.
- Vertigini.
- Dolore all'interno dell'orecchio che si irradia alla mascella.
- Tremore degli occhi a riposo.
Esistono diverse malattie principali dell'orecchio interno con i sintomi sopra descritti:
- Otosclerosi.
- Labirintite.
- Perdita dell'udito neurosensoriale.
- Vertigine parossistica posizionale benigna.
Importante! Queste patologie sono potenzialmente pericolose a causa della perdita dell'udito (sia completa che parziale).
la malattia di Meniere
La malattia è associata ad un aumento della quantità di endolinfa nell'orecchio interno, che provoca vertigini, diminuzione dell'udito e persino perdita dell'udito. I medici ritengono che la causa del disturbo siano i disturbi endocrini (ipotiroidismo), la distonia vegetativa-vascolare, che causa gonfiore. Allergie, processi infiammatori, reazioni vasomotorie (cambiamenti nel tono dei capillari e delle arterie) provocano attacchi.
La malattia a volte provoca panico nel paziente, perché le vertigini riducono significativamente la qualità della vita e rendono difficile camminare. Le vertigini rendono impossibile guidare un veicolo come conducente. Oltre ai disturbi vestibolari, il paziente può smettere di sentire i suoni. Durante un attacco, si avverte dolore all'interno dell'orecchio e talvolta si irradia alla mascella.
I farmaci anticolinergici (atropina, amitriptilina) vengono utilizzati per il trattamento per ridurre l'eccessiva influenza del sistema parasimpatico sul tono vascolare. Tali rimedi aiutano ad eliminare la nausea e il vomito, che sono alcuni dei sintomi della malattia di Meniere.
Usano anche farmaci che migliorano la circolazione cerebrale: Betaserc, Stugeron, Sermion. Nei casi più gravi è indicato l’intervento chirurgico.
Otosclerosi
Una malattia caratterizzata da una ridotta mobilità dell'ossicolo uditivo (staffa) a causa di un alterato metabolismo del calcio. Le donne hanno maggiori probabilità di soffrire di otosclerosi. I provocatori per lo sviluppo della malattia possono essere la gravidanza, l'assunzione di contraccettivi orali e problemi alla tiroide.
Con l'otosclerosi si verifica la decalcificazione delle ossa, la comparsa di cavità spugnose e la loro crescita con il tessuto connettivo: il processo della sclerosi. L'udito è compromesso a causa delle cicatrici. La malattia può essere ereditaria.
Labirintite
Si tratta di un'infiammazione dell'orecchio interno che colpisce sia l'udito che l'equilibrio. I disturbi vestibolari si manifestano con nistagmo (tremore dei bulbi oculari), vertigini, nausea e ronzii.
Esistono diverse forme della malattia:
- Timpanogenico.
- Ematogeno.
- Traumatico.
- Meningogenico.
Questa è una malattia infiammatoria, la cui causa è un'infezione che penetra attraverso il flusso sanguigno e linfatico, così come nella meningite e nelle lesioni, il pus che entra dal lato del timpano.
L'agente eziologico della labirintite purulenta, sierosa e necrotica può essere un batterio che proviene dalla fonte dell'infiammazione delle meningi. Ciò accade con vari tipi di meningite.
 Con l'otite media è possibile lo scioglimento purulento del timpano e il rilascio di contenuti patologici. In questo caso, il paziente avverte dolore alla testa, che può irradiarsi alla mascella. L'interno dell'orecchio spesso diventa insensibile.
Con l'otite media è possibile lo scioglimento purulento del timpano e il rilascio di contenuti patologici. In questo caso, il paziente avverte dolore alla testa, che può irradiarsi alla mascella. L'interno dell'orecchio spesso diventa insensibile.
La carie, la presenza di colesteatoma, l'infiammazione dell'articolazione temporo-mandibolare possono agire come provocatori della malattia.
La labirintite traumatica è una conseguenza dell'infezione attraverso la rottura dell'integrità del timpano causata da oggetti perforanti o da un'onda d'urto.
Il medico prescrive una terapia con farmaci antibatterici per fermare l'infezione. Sono possibili effetti residui dopo il recupero.
Perdita dell'udito neurosensoriale
Si tratta di un disturbo dell'udito causato da un danno all'ottavo paio di nervi cranici. Tra le cause della malattia vi sono il neuroma del nervo vestibolococleare, l'intossicazione e il danno alla sclerosi multipla.
I processi infettivi sono dannosi anche per le fibre sensoriali che conducono gli impulsi al cervello. La terapia antibiotica con farmaci ototossici come la gentamicina può provocare la perdita dell’udito.
Diagnostica
Se compaiono segni di compromissione vestibolare e uditiva, è necessario visitare un medico ORL, un audiologo o un neurologo. Dovresti sottoporti a procedure diagnostiche:
- Doppler ad ultrasuoni.
- Reoencefalografia, EEG, EcoEG.
- Analisi del sangue generale.
- Sangue per la biochimica per determinare il livello degli ormoni tiroidei, dell'insulina, della sensibilità ad esso.
- Audiometria, otoscopia.
Perché si verifica: cause della patologia.
È importante imparare perché ascoltiamo e come affrontarlo.
Tutto su: cause principali, sintomi, diagnosi di patologia nei pazienti.
Conclusione
La prevenzione di queste patologie consiste nel trattamento tempestivo delle malattie otorinolaringoiatriche, degli accidenti cerebrovascolari e dei disturbi endocrini. Ai primi sintomi (vertigini, perdita dell'udito), è necessario rivolgersi a un medico specializzato. L'automedicazione può peggiorare la malattia.
L'orecchio interno è una delle sezioni dell'orecchio umano. Per il suo aspetto specifico, l'orecchio interno è anche chiamato labirinto. Percepisce le pulsazioni inviate solo dal timpano.
L’orecchio interno è un mediatore tra il mondo esterno e il cervello. L'orecchio interno contiene gli elementi più importanti dell'intero sistema uditivo umano.
METODI DI RICERCA
I metodi moderni per studiare la funzione dell'orecchio interno includono la determinazione dello stato di entrambe le sue funzioni: uditiva e vestibolare. Quando si studia la funzione uditiva, il suono di varia frequenza e intensità viene utilizzato sotto forma di toni puri, rumore e segnali vocali. Come sorgente sonora vengono utilizzati diapason, audiometri, parlato sussurrato e ad alta voce. La ricerca utilizzando questo insieme di strumenti consente di determinare lo stato di funzionamento del sistema di conduzione del suono, dell'apparato recettore dell'orecchio interno, nonché delle sezioni conduttive e centrali dell'analizzatore uditivo.
Lo studio della funzione vestibolare (vestibulometria) comprende l'identificazione dei sintomi spontanei (non indotti artificialmente) derivanti da malattie dell'orecchio interno o del sistema nervoso centrale. Tra questi si riscontrano spesso il nistagmo spontaneo causato da un processo infiammatorio unilaterale nell'orecchio interno, che cade nella posizione di Romberg, e disturbi dei test di coordinazione. Lo stato della funzione vestibolare viene studiato durante la rotazione su una sedia Barany o su uno speciale supporto rotazionale, utilizzando test calorici, galvanici, pressori e altri.
In ambito clinico, un otorinolaringoiatra esamina i pazienti con sospetto danno all'orecchio interno. Comprende la raccolta mirata dell'anamnesi e il chiarimento dei reclami del paziente, la redazione di un passaporto dell'udito (dati dai test dell'udito del parlato e del diapason), il rilevamento visivo del nistagmo spontaneo, ecc. Per chiarire la diagnosi, vengono effettuati ulteriori studi secondo le indicazioni - radiografia delle ossa temporali, reografia dei vasi cerebrali, ecc.
PATOLOGIA
I disturbi tipici dei pazienti affetti da malattie della parte uditiva dell'orecchio interno sono la diminuzione dell'udito e l'acufene. La malattia può esordire in modo acuto (ipoacusia neurosensoriale acuta) o gradualmente (neurite cocleare, cocleite cronica). Quando l'udito è danneggiato, di regola, anche la parte vestibolare dell'orecchio interno è coinvolta in un modo o nell'altro nel processo patologico, che si riflette nel termine "cocleovestibolite".
Difetti dello sviluppo. C'è una completa assenza di labirinto o sottosviluppo delle sue singole parti. Nella maggior parte dei casi, c'è un sottosviluppo dell'organo a spirale, molto spesso il suo apparato specifico: le cellule ciliate. A volte le cellule ciliate dell'organo a spirale sono sottosviluppate solo in alcune aree, mentre la funzione uditiva può essere parzialmente preservata sotto forma delle cosiddette isole uditive. Gli effetti patologici sul feto dal corpo della madre (intossicazione, infezione, lesioni al feto), soprattutto nei primi mesi di gravidanza, giocano un ruolo nella comparsa di difetti congeniti dell'orecchio interno. Anche i fattori genetici giocano un ruolo. I danni all'orecchio interno durante il parto dovrebbero essere distinti dalle malformazioni congenite.
DANNO
Il danno meccanico isolato all'orecchio interno è raro. La lesione all'orecchio interno è possibile con fratture della base del cranio, quando la fessura passa attraverso la piramide dell'osso temporale. Nelle fratture trasversali della piramide, la frattura coinvolge quasi sempre l'orecchio interno, e tale frattura è solitamente accompagnata da un grave deterioramento della funzione uditiva e vestibolare, fino alla loro completa estinzione.
Danni specifici all'apparato recettore della coclea si verificano con l'esposizione a breve o prolungata a suoni ad alta intensità. L’esposizione a lungo termine dell’orecchio interno a forti rumori può causare danni all’udito.
Cambiamenti patologici nell'orecchio interno si verificano quando il corpo è esposto a traumi cerebrali. Con improvvisi cambiamenti della pressione atmosferica esterna o della pressione sott'acqua a causa di un'emorragia nell'orecchio interno, possono verificarsi cambiamenti irreversibili nelle cellule recettoriali dell'organo a spirale.
MALATTIE
I processi infiammatori si verificano nell'orecchio interno, di regola, secondari, più spesso come complicazione dell'otite media purulenta acuta o cronica (labirintite timpanogena), meno spesso a causa della diffusione di agenti infettivi nell'orecchio interno dallo spazio subaracnoideo attraverso il canale uditivo interno lungo le membrane del nervo vestibolococleare nelle infezioni da meningococco (labirintite meningogenica). In alcuni casi, non sono i microbi a penetrare nell'orecchio interno, ma le loro tossine. Il processo infiammatorio che si sviluppa in questi casi avviene senza suppurazione (labirintite sierosa). L'esito di un processo purulento nell'orecchio interno è sempre una sordità completa o parziale; dopo la labirintite sierosa, a seconda dell'entità dell'estensione del processo, la funzione uditiva può essere parzialmente o completamente ripristinata.
Disturbi delle funzioni dell'orecchio interno (uditivo e vestibolare) possono verificarsi a causa di disturbi circolatori e della circolazione dei fluidi labirintici, nonché a seguito di processi degenerativi. Le cause di tali disturbi possono essere l'intossicazione, incl. alcuni farmaci (chinino, streptomicina, neomicina, monomicina, ecc.), disturbi autonomici ed endocrini, malattie del sangue e cardiovascolari, disfunzione renale. Le malattie non infiammatorie dell'orecchio interno sono combinate in un gruppo chiamato labirintopatia. In alcuni casi, la labirintopatia si presenta sotto forma di ripetuti attacchi di vertigini e progressiva perdita dell'udito. Nell'età avanzata e senile, i cambiamenti distrofici nell'orecchio interno si sviluppano a causa dell'invecchiamento generale dei tessuti corporei e dell'insufficiente afflusso di sangue all'orecchio interno.
Lesioni dell'orecchio interno possono verificarsi con la sifilide. Con la sifilide congenita, il danno all'apparato recettoriale sotto forma di una forte diminuzione dell'udito è una delle manifestazioni tardive e di solito viene rilevato all'età di 10-20 anni. Il sintomo di Hennebert è considerato caratteristico del danno all'orecchio interno nella sifilide congenita: la comparsa del nistagmo con un aumento e una diminuzione della pressione dell'aria nel canale uditivo esterno. Con la sifilide acquisita, il danno all'orecchio interno si verifica spesso nel periodo secondario e può manifestarsi in modo acuto, sotto forma di una perdita dell'udito in rapido aumento fino alla completa sordità. A volte la malattia dell'orecchio interno inizia con attacchi di vertigini, acufeni e sordità improvvisa. Negli stadi avanzati della sifilide, la perdita dell’udito si sviluppa più lentamente. Un accorciamento più pronunciato della conduzione del suono osseo rispetto alla conduzione aerea è considerato caratteristico delle lesioni sifilitiche dell'orecchio interno. Il danno alla funzione vestibolare nella sifilide si osserva meno frequentemente. Il trattamento per le lesioni sifilitiche dell'orecchio interno è specifico. Per quanto riguarda i disturbi delle funzioni dell'orecchio interno, quanto prima si inizia, tanto più efficace è.
I neuromi del nervo vestibolococleare e le cisti nella regione dell'angolo cerebellopontino del cervello sono spesso accompagnati da sintomi patologici dell'orecchio interno, sia uditivo che vestibolare, dovuti alla compressione del nervo che passa qui. Gradualmente compaiono gli acufeni, l'udito diminuisce, insorgono disturbi vestibolari fino alla completa perdita delle funzioni del lato affetto in combinazione con altri sintomi focali. Il trattamento è mirato alla malattia di base.
Un orecchio umano sano può distinguere un sussurro a una distanza di 6 metri e una voce abbastanza forte a 20 passi. Il punto sta nella struttura anatomica e nella funzione fisiologica dell'apparecchio acustico:
- Orecchio esterno;
- Orecchio medio;
- Nell'orecchio interno.
Struttura dell'orecchio interno umano
La struttura dell'orecchio interno comprende il labirinto osseo e membranoso. Se prendiamo un'analogia con un uovo, allora il labirinto osseo sarà l'albume e il labirinto membranoso sarà il tuorlo. Ma questo è solo un confronto per rappresentare una struttura all'interno di un'altra. La parte esterna dell'orecchio interno umano è unita da uno stroma osseo duro. Contiene: il vestibolo, la coclea, i canali semicircolari.
Nella cavità, al centro, il labirinto osseo e membranoso non è un luogo vuoto. Contiene un fluido con proprietà simili al liquido spinale: la perilinfa. Mentre il labirinto nascosto contiene endolinfa.
Struttura del labirinto osseo
Il labirinto osseo nell'orecchio interno si trova alla profondità della piramide dell'osso temporale. Ci sono tre parti:
L'orecchio interno è formato in modo tale che tutte le sue parti e sezioni interagiscono e si trovano in una struttura ossea solida separata.
Per trattare ed eliminare il catarro, i nostri lettori utilizzano con successo un rimedio naturale per il catarro. Si tratta di un rimedio naturale al 100%, a base esclusivamente di erbe e miscelato in modo tale da combattere la malattia nel modo più efficace possibile. Il prodotto ti aiuterà a superare la tosse in modo rapido ed efficace in breve tempo, una volta per tutte. Poiché il farmaco è costituito solo da erbe, non ha effetti collaterali. Non influisce sulla pressione sanguigna o sulla frequenza cardiaca. Liberati del catarro..."
Struttura del labirinto membranoso
Duplica la struttura del labirinto osseo e contiene quindi il vestibolo, i dotti cocleari e semicircolari:
- Orecchio interno. Nel vestibolo, il labirinto membranoso è costituito da due sacche che giacciono nella fossa ellittica e sferica del vestibolo del labirinto osseo. Comunicano attraverso uno stretto condotto dove ha origine il canale endolinfatico. Una sacca ellittica, altrimenti chiamata utricolo. Ci sono cinque passaggi dei condotti semicircolari. In una cavità "piccola" separata ci sono macchie bianche costituite da cellule sensibili. Controllano i movimenti diritti e regolari della testa;
- Orecchio interno. I condotti semicircolari del labirinto membranoso - simili ai tratti ossei - contengono anche ampolle, solo membranose. Sul lato nascosto di queste estensioni si trovano le cellule sensoriali (cellule ciliate) e c'è un pettine ampollare, la cui funzione è quella di registrare lo spostamento della testa nello spazio. Le eccitazioni fissate dalla capesante, dalle macchie, vengono effettuate al nervo vestibolococleare, che è direttamente collegato al cervelletto;
- Orecchio interno. Il dotto cocleare del labirinto membranoso si trova alla profondità del canale spirale della coclea ossea. Il punto di origine e di conclusione è il punto cieco. All'interno sporge una sporgenza, dove la lumaca è divisa in due parti:
- La scala timpanica dell'orecchio interno del labirinto membranoso - interagisce con l'orecchio medio, grazie all'apertura della coclea;
- La scala del vestibolo dell'orecchio interno, il labirinto membranoso, ha origine nella cavità sferica del vestibolo e interagisce con l'orecchio medio, grazie alla finestra del vestibolo. Questi due passaggi sono chiusi da una membrana e da una staffa, quindi l'endolinfa non li attraversa.
![]() L'orecchio interno umano, in fondo al condotto lungo la parete, contiene l'organo Corti o organo a spirale, contenente fibre sottili tese lungo la lunghezza della coclea, come le corde di uno strumento musicale. Qui si trovano anche le cellule di supporto e sensoriali. Sentono lo spostamento della perilinfa che si verifica quando la staffa si contrae nel lume del vestibolo. Le onde partono dal vestibolo della scala e raggiungono la membrana timpanica accessoria.
L'orecchio interno umano, in fondo al condotto lungo la parete, contiene l'organo Corti o organo a spirale, contenente fibre sottili tese lungo la lunghezza della coclea, come le corde di uno strumento musicale. Qui si trovano anche le cellule di supporto e sensoriali. Sentono lo spostamento della perilinfa che si verifica quando la staffa si contrae nel lume del vestibolo. Le onde partono dal vestibolo della scala e raggiungono la membrana timpanica accessoria.
Il movimento della perilinfa e dell'endolinfa porta al funzionamento dell'apparato di ricezione del suono (cellule sensoriali, ciliate), la sua funzione è convertire le vibrazioni in impulsi.
Dopo un lungo viaggio, entra nei nuclei uditivi, quindi nella corteccia cerebrale.
Fisiologia della percezione umana del suono
Le vibrazioni sonore attraversano l'orecchio esterno e muovono il timpano che si intromette. ![]() Dopodiché, le ossa dell'orecchio medio vengono attivate e, in uno stato ingrandito, passano nell'orecchio interno attraverso l'apertura ovale, penetrando nel vestibolo della coclea. Questo movimento fa sì che la perilinfa e l'endolinfa si scuotano e durante il percorso le onde vengono risucchiate nelle cellule dell'organo del Corti. Il movimento di queste strutture crea un contatto con le fibre della membrana tegumentaria, sotto l'influenza i peli si piegano e si forma un impulso che passa nella sottocorteccia del cervello. Il suono ha le sue caratteristiche:
Dopodiché, le ossa dell'orecchio medio vengono attivate e, in uno stato ingrandito, passano nell'orecchio interno attraverso l'apertura ovale, penetrando nel vestibolo della coclea. Questo movimento fa sì che la perilinfa e l'endolinfa si scuotano e durante il percorso le onde vengono risucchiate nelle cellule dell'organo del Corti. Il movimento di queste strutture crea un contatto con le fibre della membrana tegumentaria, sotto l'influenza i peli si piegano e si forma un impulso che passa nella sottocorteccia del cervello. Il suono ha le sue caratteristiche:
- Frequenza – vibrazioni al secondo (orecchio umano da 21 a 19.999 Hz);
- Forza – la gamma delle vibrazioni;
- Volume;
- Altezza;
- Spettro: il numero di movimenti aggiuntivi.
Le sacche ellittiche e sferiche del vestibolo dell'orecchio interno contengono più punti sulla parete nascosta: l'apparato otolitico. ![]() All'interno c'è un liquido gelatinoso, sopra il quale si trovano gli otoliti (cristalli) e le cellule recettrici, da cui si estendono i peli. Le funzioni degli otoliti sono la pressione costante sulle cellule. Dal movimento del corpo si piegano i singoli peli, a causa dei quali si crea un'eccitazione che viene inviata al midollo allungato, che regola e, se necessario, normalizza la condizione. I canali semicircolari (osso e labirinto membranoso) hanno uno stiramento - ampolla. Sulla sua superficie interna ci sono cellule sensibili e l'endolinfa scorre nella cavità. Come risultato dell'accelerazione, della decelerazione e del movimento del corpo, il fluido irrita le cellule e queste, a loro volta, inviano un impulso al cervello. A causa del fatto che i canali si trovano reciprocamente perpendicolari tra loro, qualsiasi modifica viene registrata.
All'interno c'è un liquido gelatinoso, sopra il quale si trovano gli otoliti (cristalli) e le cellule recettrici, da cui si estendono i peli. Le funzioni degli otoliti sono la pressione costante sulle cellule. Dal movimento del corpo si piegano i singoli peli, a causa dei quali si crea un'eccitazione che viene inviata al midollo allungato, che regola e, se necessario, normalizza la condizione. I canali semicircolari (osso e labirinto membranoso) hanno uno stiramento - ampolla. Sulla sua superficie interna ci sono cellule sensibili e l'endolinfa scorre nella cavità. Come risultato dell'accelerazione, della decelerazione e del movimento del corpo, il fluido irrita le cellule e queste, a loro volta, inviano un impulso al cervello. A causa del fatto che i canali si trovano reciprocamente perpendicolari tra loro, qualsiasi modifica viene registrata.
L'apparato vestibolare umano, cioè il labirinto osseo e membranoso dell'orecchio interno, interagisce strettamente con il sistema nervoso autonomo.
In considerazione di ciò, quando è eccitato, si verificano varie reazioni, come: diminuzione o aumento della pressione sanguigna, aumento della respirazione, aumento del lavoro delle ghiandole salivari e di altre ghiandole digestive e altro ancora. Tutti gli organi svolgono le loro funzioni in modo armonioso.
Le malattie dell'orecchio interno sono un gruppo di patologie otorinolaringoiatriche di diversa eziologia e patogenesi, causate da un precedente processo infiammatorio-distruttivo. Questa categoria di disturbi otiatrici comprende l'acufene, la sindrome vestibolare, la perdita dell'udito neurosensoriale e la malattia di Meniere. Ciascuna delle malattie di cui sopra è un problema medico indipendente che richiede una soluzione obbligatoria.
Funzioni dell'orecchio interno
L'orecchio interno è la parte più complessa dell'organo uditivo, situato nella parte profonda dell'osso temporale. Le sue funzioni principali:
- . conduttività sonora;
- . protezione contro l'eccessiva stimolazione sonora;
- . mantenimento del tono normale dell'apparato di conduzione del suono (membrana timpanica e catena degli ossicini uditivi);
- . adattamento dell'organo uditivo a suoni di diversa altezza e intensità;
- . ricezione delle accelerazioni angolari e lineari;
- . percezione della gravità.
Cause delle malattie dell'orecchio interno
Le malattie dell’orecchio interno, che hanno un importante significato medico e sociale per la società, colpiscono con uguale frequenza persone di tutte le fasce d’età. La varietà dei meccanismi patogenetici dei disturbi otiatrici è determinata dal fattore causale, dall'anatomia e dalla fisiologia dell'organo, nonché dallo stato delle forze immunitarie del corpo. Spesso le parti principali dell'orecchio medio (cavità timpanica, processo mastoideo e tubo uditivo) sono coinvolte nel processo patologico.
I principali fattori che provocano la comparsa di segni di malattia dell'orecchio interno:
- . raffreddori e malattie infettive (ARVI, influenza, morbillo, rosolia, sinusite catarrale, sinusite, meningite, ecc.);
- . danno meccanico;
- . lesioni cerebrali traumatiche;
- . disturbi vascolari;
- . adenoidi;
- . allergia;
- . stress, tensione nervosa;
Le malattie dell'orecchio interno di natura infiammatoria (otite interna o, come vengono anche chiamate, labirinto) sono accompagnate da sintomi di vertigini spontanee. Di norma, sono una complicazione dell'otite media o della meningite. I primi segni di un disturbo si manifestano 1-2 settimane dopo una malattia infettiva. Un grave attacco di vertigini può essere accompagnato da nausea, vomito, tinnito, perdita dell'udito e frequenti vibrazioni riflesse dei bulbi oculari. Con lo sviluppo di una forma purulenta di patologia, spesso si sviluppa una sordità completa sul lato affetto. Se il processo infiammatorio raggiunge il tronco del nervo facciale, è possibile la paralisi dei muscoli facciali su un lato del viso.
Le malattie non infiammatorie dell'orecchio interno (malattia di Meniere e sindrome vestibolare periferica) sono accompagnate da periodiche forti vertigini, squilibrio, tachicardia, debolezza della percezione del suono, nausea, vomito, tinnito e perdita dell'udito. In questa condizione, la scelta della tattica medica viene effettuata dopo un esame diagnostico completo e un'accurata determinazione del tipo di malattia.
Trattamento delle patologie dell'orecchio interno
Il trattamento delle malattie dell'orecchio interno e la successiva prevenzione delle ricadute viene effettuato tenendo conto dei sintomi e delle cause che hanno provocato lo sviluppo della condizione patologica. Se il labirinto sieroso è limitato, al paziente viene prescritto un trattamento conservativo complesso, compresa la terapia antibatterica, di disidratazione e disintossicante. I pazienti affetti da otite purulenta interna sono indicati per l'intervento chirurgico volto ad eliminare il processo infettivo-infiammatorio, seguito dalla prescrizione di antibiotici.
Il trattamento delle malattie dell'orecchio interno, accompagnate da compromissione della funzione uditiva e vestibolare, si basa su fasi cliniche specifiche. Può essere non operatorio e chirurgico. La correzione terapeutica delle malattie associative otiatriche comprende la riflessologia, la terapia fisica, l'ossigenoterapia o la terapia con carbogeno, l'uso di analgesici, disidratazione e sedativi, l'irradiazione dei nodi simpatici cervicali e dei centri cerebrali autonomi.
Nella clinica della medicina tibetana, ai pazienti vengono prescritti massaggi della testa e della regione cervico-brachiale, agopuntura, massaggio microzonale e digitopressione dei padiglioni auricolari, applicazioni medicinali, nonché l'assunzione di agenti fitoterapeutici che normalizzano l'afflusso di sangue e l'innervazione delle strutture del orecchio interno.
Nelle forme gravi di patologia e in assenza di effetto del trattamento conservativo, è indicata la correzione chirurgica, mirata ad aumentare le soglie di eccitabilità dei recettori vestibolari, migliorare il drenaggio dell'endolinfa, preservare e migliorare le funzioni uditive.
L'orecchio interno contiene l'apparato recettore di due analizzatori: il vestibolare (canali vestibolari e semicircolari) e l'uditivo, che comprende la coclea con l'organo del Corti.
Viene chiamata la cavità ossea dell'orecchio interno, contenente un gran numero di camere e passaggi tra di loro labirinto . È costituito da due parti: il labirinto osseo e il labirinto membranoso. Labirinto osseo- una serie di cavità situate nella parte densa dell'osso; in esso si distinguono tre componenti: i canali semicircolari sono una delle fonti degli impulsi nervosi che riflettono la posizione del corpo nello spazio; vestibolo; e la lumaca - un organo.
Labirinto membranoso racchiuso nel labirinto osseo. È pieno di un fluido, l'endolinfa, ed è circondato da un altro fluido, la perilinfa, che lo separa dal labirinto osseo. Il labirinto membranoso, come il labirinto osseo, è costituito da tre parti principali. Il primo corrisponde in configurazione ai tre canali semicircolari. La seconda divide il vestibolo osseo in due sezioni: l'utricolo e il sacculo. La terza parte allungata forma la scala media (cocleare) (canale a spirale), ripetendo le curve della coclea.
Canali semicircolari. Ce ne sono solo sei, tre per ciascun orecchio. Hanno una forma arcuata e iniziano e finiscono nell'utero. I tre canali semicircolari di ciascun orecchio si trovano ad angolo retto tra loro, uno orizzontalmente e due verticalmente. Ogni canale ha un'estensione ad un'estremità: un'ampolla. I sei canali sono disposti in modo tale che per ciascuno esiste un canale opposto sullo stesso piano, ma in un orecchio diverso, ma le loro ampolle si trovano alle estremità reciprocamente opposte.
Coclea e organo del Corti. Il nome della lumaca è determinato dalla sua forma a spirale contorta. Questo è un canale osseo che forma due giri e mezzo di una spirale ed è pieno di fluido. I riccioli girano attorno a un'asta distesa orizzontalmente - un fuso, attorno alla quale, come una vite, è attorcigliata una piastra a spirale ossea, forata da sottili canalicoli, dove passano le fibre della parte cocleare del nervo vestibolococleare - l'VIII paio di nervi cranici. All'interno, su una parete del canale a spirale per tutta la sua lunghezza è presente una sporgenza ossea. Due membrane piatte si estendono da questa sporgenza alla parete opposta in modo che la coclea sia divisa per tutta la sua lunghezza in tre canali paralleli. Le due esterne si chiamano scala vestibuli e scala tympani; comunicano tra loro all'apice della coclea. Centrale, cosiddetto il canale spirale della coclea termina ciecamente e il suo inizio comunica con il sacco. Il canale spirale è pieno di endolinfa, la scala vestibolo e la scala timpanica sono piene di perilinfa. La perilinfa ha un'alta concentrazione di ioni sodio, mentre l'endolinfa ha un'alta concentrazione di ioni potassio. La funzione più importante dell'endolinfa, che è caricata positivamente rispetto alla perilinfa, è la creazione di un potenziale elettrico sulla membrana che le separa, che fornisce energia per il processo di amplificazione dei segnali sonori in arrivo.
La scala vestibolare inizia in una cavità sferica, il vestibolo, che si trova alla base della coclea. Un'estremità della scala attraverso la finestra ovale (la finestra del vestibolo) entra in contatto con la parete interna della cavità piena d'aria dell'orecchio medio. La scala timpanica comunica con l'orecchio medio attraverso la finestra rotonda (finestra della coclea). Liquido
non può passare attraverso queste finestre, poiché la finestra ovale è chiusa dalla base della staffa, e la finestra rotonda da una sottile membrana che la separa dall'orecchio medio. Il canale spirale della coclea è separato dalla cosiddetta scala timpanica. la membrana principale (basilare), che ricorda uno strumento a corda in miniatura. Contiene un numero di fibre parallele di varia lunghezza e spessore tese attraverso un canale elicoidale, con le fibre alla base del canale elicoidale corte e sottili. Si allungano e si ingrossano gradualmente verso l'estremità della coclea, come le corde di un'arpa. La membrana è ricoperta da file di cellule sensibili dotate di capelli che compongono il cosiddetto. l'organo del Corti, che svolge una funzione altamente specializzata, converte le vibrazioni della membrana principale in impulsi nervosi. Le cellule ciliate sono collegate alle terminazioni delle fibre nervose che, uscendo dall'organo del Corti, formano il nervo uditivo (ramo cocleare del nervo vestibolococleare).
Labirinto cocleare membranoso, o condotto, ha l'aspetto di una protuberanza vestibolare cieca situata nella coclea ossea e che termina ciecamente al suo apice. È pieno di endolinfa ed è una sacca di tessuto connettivo lunga circa 35 mm. Il condotto cocleare divide il canale a spirale osseo in tre parti, occupandone la parte centrale: la scala media (scala media), o condotto cocleare o canale cocleare. La parte superiore è la scala vestibolare (scala vestibuli), o la scala vestibolare, la parte inferiore è la scala timpanica o timpanica (scala tympani). Contengono perilinfa. Nella zona della cupola della coclea entrambe le scale comunicano tra loro attraverso l'apertura della coclea (elicotrema). La scala timpanica si estende fino alla base della coclea, dove termina con la finestra rotonda della coclea, chiusa dalla membrana timpanica secondaria. La scala vestibolare comunica con lo spazio perilinfatico del vestibolo. Va notato che la perilinfa nella sua composizione ricorda il plasma sanguigno e il liquido cerebrospinale; ha un contenuto predominante di sodio. L'endolinfa differisce dalla perilinfa per la sua concentrazione più elevata (100 volte) di ioni potassio e per la concentrazione inferiore (10 volte) di ioni sodio; nella sua composizione chimica assomiglia al fluido intracellulare. In relazione alla perilinfa è caricata positivamente.
Il condotto cocleare in sezione trasversale ha una forma triangolare. La parete vestibolare superiore del condotto cocleare, rivolta verso la scala del vestibolo, è formata da una sottile membrana vestibolare (Reissner) (membrana vestibularis), che è ricoperta dall'interno con epitelio squamoso monostrato, e all'esterno - dall'endotelio. Tra di loro c'è un sottile tessuto connettivo fibrillare. La parete esterna si fonde con il periostio della parete esterna della coclea ossea ed è rappresentata da un legamento a spirale, presente in tutti i riccioli della coclea. Sul legamento è presente una striscia vascolare (stria vascolare), ricca di capillari e ricoperta di cellule cubiche che producono endolinfa. Quella inferiore, la parete timpanica, rivolta verso la scala timpanica, è strutturata in modo più complesso. È rappresentato dalla membrana basilare, o lamina (lamina basilaris), sulla quale è situata la spirale, o organo del Corti, che produce i suoni. La placca basilare densa ed elastica, o membrana basilare, è attaccata ad un'estremità alla placca ossea spirale e all'estremità opposta al legamento spirale. La membrana è formata da fibre di collagene radiali sottili e debolmente allungate (circa 24 mila), la cui lunghezza aumenta dalla base della coclea al suo apice - vicino alla finestra ovale, la larghezza della membrana basilare è 0,04 mm, e quindi verso l'apice della coclea, espandendosi gradualmente, raggiunge l'estremità 0,5 mm (cioè la membrana basilare si espande dove la coclea si restringe). Le fibre sono costituite da sottili fibrille anastomizzanti tra loro. La debole tensione delle fibre della membrana basilare crea le condizioni per i loro movimenti oscillatori.
L'organo dell'udito vero e proprio, l'organo del Corti, è situato nella coclea ossea. L'organo del Corti è una parte recettrice situata all'interno del labirinto membranoso. Nel processo di evoluzione, nasce sulla base delle strutture degli organi laterali. Percepisce le vibrazioni delle fibre situate nel canale dell'orecchio interno e le trasmette alla corteccia uditiva, dove si formano i segnali sonori. Nell'Organo di Corti inizia la formazione primaria dell'analisi dei segnali sonori.
Posizione. L'organo del Corti si trova nel canale osseo arricciato a spirale dell'orecchio interno - il passaggio cocleare, pieno di endolinfa e perilinfa. La parete superiore del passaggio è adiacente al cosiddetto. vestibolo della scala ed è chiamata membrana di Reisner; il muro inferiore confinante con il cosiddetto. scala timpanica, formata dalla membrana principale attaccata alla placca ossea spirale. L'organo del Corti è composto da cellule di sostegno o di sostegno e da cellule recettrici o fonorecettori. Esistono due tipi di cellule di supporto e due tipi di cellule recettrici: esterne e interne.
Cellule di supporto esterne si trovano più lontano dal bordo della placca ossea a spirale, e interno- più vicino a lui. Entrambi i tipi di cellule di supporto convergono ad angolo acuto l'uno rispetto all'altro e formano un canale di forma triangolare - un tunnel interno (Corti) pieno di endolinfa, che corre a spirale lungo l'intero organo del Corti. Il tunnel contiene fibre nervose non mielinizzate provenienti dai neuroni del ganglio spirale.
Fonorecettori giacciono su cellule di supporto. Sono sensoriali secondari (meccanocettori) che trasformano le vibrazioni meccaniche in potenziali elettrici. I fonorecettori (in base al loro rapporto con il tunnel di Corti) si dividono in interni (a forma di fiasco) ed esterni (cilindrici) separati tra loro dagli archi di Corti. Le cellule ciliate interne sono disposte in un'unica fila; il loro numero totale lungo l'intera lunghezza del canale membranoso raggiunge i 3500. Le cellule ciliate esterne sono disposte in 3-4 file; il loro numero totale raggiunge i 12.000-20.000. Ciascuna cellula ciliata ha una forma allungata; uno dei suoi poli è vicino alla membrana principale, il secondo si trova nella cavità del canale membranoso della coclea. Alla fine di questo polo ci sono i peli, o stereociglia (fino a 100 per cellula). I peli delle cellule recettrici vengono lavati dall'endolinfa e entrano in contatto con la membrana tegumentaria o tettoria (membrana tectoria), che si trova sopra le cellule ciliate lungo l'intero corso del canale membranoso. Questa membrana ha una consistenza gelatinosa, un bordo della quale è attaccato alla placca a spirale ossea e l'altro termina liberamente nella cavità del dotto cocleare leggermente più lontano delle cellule recettrici esterne.
Tutti i fonorecettori, indipendentemente dalla posizione, sono collegati sinapticamente a 32.000 dendriti di cellule sensoriali bipolari situate nel nervo spirale della coclea. Queste sono le prime vie uditive, che formano la parte cocleare (cocleare) dell'VIII paio di nervi cranici; trasmettono segnali ai nuclei cocleari. In questo caso, i segnali provenienti da ciascuna cellula ciliata interna vengono trasmessi alle cellule bipolari simultaneamente lungo diverse fibre (probabilmente ciò aumenta l'affidabilità della trasmissione delle informazioni), mentre i segnali provenienti da diverse cellule ciliate esterne convergono su una fibra. Pertanto, circa il 95% delle fibre del nervo uditivo trasporta informazioni dalle cellule ciliate interne (sebbene il loro numero non superi 3500) e il 5% delle fibre trasmette informazioni dalle cellule ciliate esterne, il cui numero raggiunge 12.000-20.000. Questi dati evidenziano l’enorme importanza fisiologica delle cellule ciliate interne nella ricezione del suono.
Alle cellule ciliate Sono adatte anche le fibre efferenti - assoni dei neuroni dell'olivo superiore. Le fibre che arrivano alle cellule ciliate interne non finiscono su queste cellule stesse, ma su fibre afferenti. Si ipotizza che abbiano un effetto inibitorio sulla trasmissione del segnale uditivo, promuovendo una maggiore risoluzione della frequenza. Le fibre che arrivano alle cellule ciliate esterne le influenzano direttamente e, modificandone la lunghezza, ne modificano la sensibilità fono. Pertanto, con l'aiuto delle fibre efferenti olivo-cocleari (fibre del fascio di Rasmussen), i centri acustici superiori regolano la sensibilità dei fonorecettori e il flusso degli impulsi afferenti da essi ai centri cerebrali.
Conduzione delle vibrazioni sonore nella coclea . La percezione del suono viene effettuata con la partecipazione dei fonorecettori. Sotto l'influenza di un'onda sonora, portano alla generazione di un potenziale recettore, che provoca l'eccitazione dei dendriti del ganglio spirale bipolare. Ma come vengono codificate la frequenza e l'intensità del suono? Questo è uno dei problemi più complessi nella fisiologia dell'analizzatore uditivo.
L'idea moderna di codificare la frequenza e l'intensità del suono si riduce a quanto segue. Un'onda sonora, agendo sul sistema degli ossicini uditivi dell'orecchio medio, mette in movimento oscillatorio la membrana della finestra ovale del vestibolo, che, piegandosi, provoca movimenti ondulatori della perilinfa dei canali superiore ed inferiore, che attenuarsi gradualmente verso l'apice della coclea. Poiché tutti i fluidi sono incomprimibili, queste oscillazioni sarebbero impossibili se non fosse per la membrana della finestra rotonda, che si gonfia quando la base della staffa viene premuta sulla finestra ovale e ritorna nella sua posizione originale quando la pressione viene rilasciata. Le vibrazioni della perilinfa vengono trasmesse alla membrana vestibolare, nonché alla cavità del canale medio, mettendo in movimento l'endolinfa e la membrana basilare (la membrana vestibolare è molto sottile, quindi il fluido nei canali superiore e medio vibra come se entrambi i canali sono uno). Quando l'orecchio è esposto a suoni a bassa frequenza (fino a 1000 Hz), la membrana basilare si sposta per tutta la sua lunghezza dalla base all'apice della coclea. All'aumentare della frequenza del segnale sonoro, la colonna oscillante di liquido, accorciata in lunghezza, si avvicina alla finestra ovale, alla parte più rigida ed elastica della membrana basilare. Quando deformata, la membrana basilare sposta i peli delle cellule ciliate rispetto alla membrana tettoria. Come risultato di questo spostamento, nelle cellule ciliate si verifica una scarica elettrica. Esiste una relazione diretta tra l'ampiezza dello spostamento della membrana principale e il numero di neuroni della corteccia uditiva coinvolti nel processo di eccitazione.
|
Il meccanismo delle vibrazioni sonore nella coclea Le onde sonore vengono captate dal padiglione auricolare e inviate attraverso il condotto uditivo al timpano. Le vibrazioni del timpano, attraverso il sistema degli ossicini uditivi, vengono trasmesse attraverso la staffa alla membrana della finestra ovale, e attraverso di essa vengono trasmesse al fluido linfatico. A seconda della frequenza di vibrazione, solo alcune fibre della membrana principale rispondono alle vibrazioni del fluido (risuonano). Le cellule ciliate dell'organo del Corti si eccitano quando le fibre della membrana principale le toccano e vengono trasmesse in impulsi lungo il nervo uditivo, dove viene creata la sensazione finale del suono. |
Il cervello umano analizza, riconosce e interpreta le informazioni ricevute in diversi modi: attraverso la vista, l'udito, il tatto, la cinestetica (segnali provenienti da muscoli, tendini, articolazioni) e l'apparato vestibolare. L'orecchio interno invia al cervello dati sull'equilibrio, sul movimento del corpo umano e segnali acustici dal mondo circostante.
- Le vibrazioni meccaniche vengono trasmesse dall'ambiente esterno (aria, oggetti) alle ossa del cranio.
- La perilinfa riceve vibrazioni dalle pareti della capsula ossea.
- La membrana basilare viene spostata e i recettori nervosi uditivi situati in essa vengono eccitati.
Dopo che le vibrazioni meccaniche si riflettono in una sequenza di impulsi, il nervo uditivo le trasmette alla parte uditiva del cervello per l'elaborazione.
Perché l'orecchio interno è così sensibile che è necessario un amplificatore idraulico (leva ossea)? Scopo del labirinto membranoso— percepire le vibrazioni inviate solo dal timpano. Ecco perché è circondato da ossa forti.