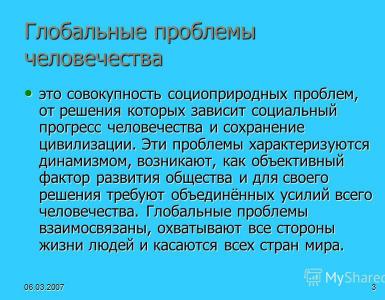Disegna i tipi di connessioni ossee continue. Tipi di connessioni ossee: breve descrizione. Patologie del tessuto connettivo
Composti fibrosi, articolazioni fibrose(Fig.), forniscono una connessione continua delle ossa dovuta a vari tipi di tessuto connettivo: tessuto denso, connettivo, cartilagineo o osseo.
Le articolazioni fibrose formate da tessuto connettivo denso comprendono sindesmosi, suture e occlusioni.
Sindesmosi, includono i legamenti, che sono connessioni tra le ossa costituite da tessuto connettivo denso. Per esempio, legamento pterigospinoso, lig. pterigospinale, parte dalla spina dorsale dell'osso sfenoide e si attacca al processo pterigospinoso, situato sulla placca laterale del processo pterigoideo; legamento stiloioideo, lig. stiloioideo, sottile e lungo, parte dal processo stiloideo e, scendendo e anteriormente, si attacca ai piccoli corni dell'osso ioide, ecc. Talvolta le sindesmosi possono contenere una quantità significativa di fibre elastiche, come, legamenti gialli, ligg. flava situato tra gli archi vertebrali, legamento nucale, lig. nuchae, ecc. Inoltre, le sindesmosi sono ampi legamenti che collegano le ossa su una distanza considerevole: membrane interossee dell'avambraccio e della parte inferiore della gamba, membrana interossea antebrachii, membrana interossea cruris. Le sindesmosi comprendono anche le fontanelle del cranio, costituite da tessuto connettivo primario.
Suture, suture, collegano le ossa della volta cranica e del viso. Sono formati da brevi filamenti di tessuto connettivo denso che corrono tra i bordi delle ossa adiacenti e penetrano in esse. Con l'età, si verifica l'ossificazione delle suture dovuta alla sostituzione del tessuto connettivo denso con tessuto osseo. In base al rilievo delle suture e al metodo di applicazione dei bordi di collegamento delle ossa, si distinguono i seguenti tipi di suture: cucitura seghettata, sutura serrata; sutura squamosa, sutura squamosa; cucitura piatta, sutura plana. Le ossa della volta cranica sono collegate da suture squamose e seghettate. Le ossa del viso sono spesso unite da una sutura piatta, garantendo un allineamento preciso e uniforme dei bordi. Inoltre, c'è una cucitura nella forma schindilosi (scissione), schindilesi, è la connessione del bordo di un osso con il solco di un altro, come nella formazione della sutura cuneo-vomere sutura sphenomeriana.
Articolazioni dentoalveolari, articolazioni dentoalveolari (gonfosi), si verificano nella connessione delle radici dei denti, ricoperte di parodonto, con l'alveolo. Qui, fasce di tessuto connettivo denso trattengono i denti negli alveoli dentali. Con l'età, questa connessione si indebolisce e i denti si allentano (vedi Vol. II “Apparato digerente”).
Composti cartilaginei, articolazioni cartilaginee, è un tipo di articolazione fibrosa formata da tessuto cartilagineo. Tra le articolazioni cartilaginee si distinguono sincondrosi e sinfisi:
- Sincondrosi, sono formati da strati continui di cartilagine che collegano i bordi delle ossa e limitano il movimento. Sono molto diffusi nel sistema scheletrico dei bambini e degli adolescenti: collegano parti delle ossa (ad esempio, la diafisi di un osso lungo con le epifisi, le vertebre sacrali tra loro, ecc.). Si tratta di sincondrosi non permanenti; con l'età, il tessuto cartilagineo viene sostituito dall'osso. Le sincondrosi che persistono nel sistema scheletrico di un adulto comprendono la sincondrosi del cranio (sfenoid-occipitale, sfenoide-petrosale, petrooccipitale, sfenoide-etmoide) e la sincondrosi dello sterno (sincondrosi del manubrio e del processo xifoideo).
- Sinfisi, sono formati da cartilagine fibrosa e all'interno della placca cartilaginea è presente una cavità. Tali connessioni si osservano tra i corpi vertebrali - sinfisi intervertebrale, sinfisi intervertebrale(vedi figura), sinfisi manubriosternale(vedi fig.
Le connessioni continue si dividono in fibrose e cartilaginee. Le articolazioni fibrose (junturae fibrosae) sono caratterizzate dalla presenza di vari tipi di tessuto connettivo fibroso tra le ossa connettive. Queste connessioni includono: sindesmosi, suture, impattazione.
La sindesmosi, o articolazioni del tessuto connettivo delle ossa, comprende numerose articolazioni: fontanelle, membrane interossee, legamenti.
Le membrane interossee (membra-nae interosseae) collegano le ossa a lunga distanza (ossa dell'avambraccio, parte inferiore della gamba, ecc.).
I legamenti (legamenti) sono fasci di tessuto fibroso di varie dimensioni e forme che collegano le ossa adiacenti o parti di esse.
Le suture craniche (suturae cranii) collegano i bordi delle ossa con un sottile strato di tessuto connettivo. In base alla loro struttura esistono tre tipi di cuciture:
1) sutura frastagliata (sutura serrata) - i bordi irregolarmente frastagliati delle ossa adiacenti sono saldamente collegati tra loro (di norma, è impossibile separare le ossa senza romperle). Questa sutura collega la maggior parte delle ossa del tetto del cranio;
2) sutura squamosa (sutura squamosa) - il bordo smussato di un osso è sovrapposto allo stesso bordo dell'altro bordo di un altro osso. Questa sutura avviene tra l'osso squamoso ed il bordo squamoso dell'osso parietale;
3) una sutura piatta (sutura plana) collega le ossa del viso in contatto tra loro.
La gonfosi è un tipo di connessione ossea in cui un osso sembra essere spinto nella sostanza di un altro. Disponibile solo tra le radici dei denti e le cavità delle mascelle.
Le articolazioni cartilaginee (juntu-rae cartilagineae) sono articolazioni in cui la cartilagine si trova tra le ossa. Queste connessioni sono divise nelle connessioni cartilaginee stesse, o sincondrosi, e nella sinfisi, o fusione.
Le sincondrosi si dividono a seconda della struttura della cartilagine - in ialina (cartilagine costale) e fibrosa (dischi intervertebrali, ecc.) e a seconda dello stato di queste connessioni durante la vita in temporanee (cartilagine epifisaria) e permanenti (cartilagine delle aperture lacerate della il teschio, ecc.).
La sinfisi, o fusione, è una sorta di connessione cartilaginea con uno stretto spazio nello spessore della cartilagine lungo il piano sagittale mediano. La fusione avviene solo alla giunzione delle ossa pubiche e delle estremità distali delle ossa della tibia.
L'articolazione sinoviale è caratterizzata dalla presenza di una membrana sinoviale (metnbrana synovia-lis), che riveste l'intera cavità articolare, fino al bordo della cartilagine articolare, e secerne liquido sinoviale (sinovia). La membrana sinoviale è sottile, delicata, trasparente e in alcuni punti di alcune articolazioni forma sporgenze, pieghe e villi sinoviali. Queste formazioni aumentano la produzione di sinovia e alcune di esse (borse) facilitano lo scorrimento dei muscoli lungo l'osso.
Inoltre, ci sono strutture articolari che non si trovano in un complesso in ogni articolazione. Questi includono: il disco articolare (discus articularis), che divide la cavità articolare in due camere; menisco articolare (meniscus articularis), che delimita parzialmente la cavità articolare; labbro articolare (labrum glenoidale), che aumenta la conformità delle superfici articolari approfondendo la cavità glenoidea; legamenti intra ed extracapsulari (legamenti), rinforzanti delle articolazioni e ossa sesamoidi (ossa sesa-moidea), inserite nei tendini di alcuni muscoli nei punti della loro transizione attraverso lo spazio articolare, ecc.
I movimenti nelle articolazioni umane sono molto diversi. Ogni movimento è composto dai seguenti elementi:
1) flessione (flexio) - movimento della leva ossea nella direzione ventrale (per la parte inferiore della gamba - nella dorsale, per il piede - nella plantare) attorno all'asse trasversale, chiamato frontale;
2) estensione (extensio) - movimento direttamente opposto al precedente attorno allo stesso asse;
3) abduzione (abductio) - movimento della leva ossea lateralmente attorno all'asse anteroposteriore, chiamato sagittale;
4) adduzione (adductio) - movimento attorno allo stesso asse medialmente;
5) rotazione esterna (rotatio externa, s. supinatio) - movimento di uno dei bracci di leva attorno ad un asse verticale lateralmente;
6) rotazione interna (rotatio interna, s. pronatio) - movimento attorno allo stesso asse verso l'interno;
7) rotazione circolare (circumductio) - movimento di una leva ossea con il suo movimento sequenziale attorno ai tre assi sopra menzionati, mentre l'estremità distale della leva descrive un cerchio.
L'ampiezza dei movimenti articolari è determinata principalmente dal grado di corrispondenza tra dimensione e curvatura delle piattaforme articolari: maggiore è la differenza nelle dimensioni delle piattaforme (incongruenza delle articolazioni), maggiore è la probabilità di spostamento delle piattaforme ossa l'una rispetto all'altra, e maggiore è la curvatura delle piattaforme, maggiore è l'angolo di deviazione. Va tuttavia tenuto presente che l'ampiezza del movimento delle articolazioni può essere limitata in una certa misura dalla capsula e da molte formazioni extra ed intracapsulari e principalmente dall'apparato legamentoso.
I movimenti delle articolazioni sono determinati principalmente dalla forma delle aree articolari, che di solito vengono paragonate a figure geometriche. Da qui il nome dei giunti in base alla loro forma: sferica, ellissoidale, cilindrica, ecc. Poiché i movimenti dei collegamenti articolari vengono eseguiti attorno a uno, due o più assi, anche i giunti vengono solitamente divisi in multiassiali, biassiali e monoassiali.
Articolazioni multiassiali: l'articolazione sferica (articulatio spheroidea), di regola, ha piattaforme articolari incongruenti (la fossa è più piccola della testa). La funzione di questa articolazione è la flessione, l'estensione attorno all'asse frontale, l'adduzione, l'abduzione attorno all'asse sagittale, la rotazione esterna ed interna attorno all'asse verticale e il movimento circolare (circumductio). La capsula articolare nelle articolazioni sferiche è ampia e l'apparato legamentoso, di regola, è poco sviluppato, per cui qui l'ampiezza dei movimenti è maggiore. L'articolazione sferica più tipica è la spalla. L'articolazione dell'anca (a forma di dado) è considerata un tipo speciale di articolazione sferica.
Un'articolazione piatta (articulatio plana) presenta aree articolari piatte (o nettamente appiattite) e congruenti, che dovrebbero essere considerate come piccole sezioni della superficie di una grande palla. I legamenti e la capsula articolare sono tesi. Queste articolazioni, numerose nel corpo umano e animale, hanno una mobilità limitata, espressa in un leggero scorrimento (a volte direzionale), e nell'uomo svolgono una triplice funzione:
1) un cambiamento generale nella forma del corpo sommando i movimenti in un gran numero di articolazioni di un dato tipo (articolazioni della colonna vertebrale);
2) mitigazione degli shock e delle scosse trasmesse dal suolo (funzione tampone).
Tipi di connessioni ossee (schema):
A - connessione continua: 1 - periostio; 2 - osso; 3 - tessuto fibroso (composto fibroso).
B - connessione continua: 1 - periostio; 2 - osso; 3 - cartilagine (connessione cartilaginea).
Articolazione B-sinoviale (articolazione): 1 - periostio; 2 - osso; 3 - cartilagine articolare; 4 - cavità articolare; 5 - membrana sinoviale della capsula articolare; 6 - membrana fibrosa della capsula articolare.
Numerosi presenti nel corpo umano connessioni ossee Si consiglia di presentarlo sotto forma di classificazione. Secondo questa classificazione, esistono due tipi principali di connessioni ossee: continue e discontinue, ciascuna delle quali a sua volta è divisa in diversi gruppi (Gayvoronsky I.V., Nichiporuk G.I., 2005).
Tipi di articolazioni ossee
| Connessioni continue (sinartrosi, sinartrosi) | Articolazioni discontinue (diartrosi, diartrosi; articolazioni sinoviali o articolazioni, articolazioni sinoviali) |
|
I. Composti fibrosi (articulationes librosae): legamenti (ligamenta); membrane (membrane); fontanelle (fonticoli); suture (suture); gonfosi II. Connessioni cartilaginee (articulationes cartilagineae): connessioni che utilizzano cartilagine ialina (temporanee); connessioni con fibrocartilagine (permanente) III. Connessioni con il tessuto osseo (sinostosi) |
Secondo gli assi di rotazione e la forma delle superfici articolari: Dal numero di superfici articolari: semplice (art. simplex); complesso (art. composito) Secondo funzione articolare monostadio: combinato (art. combinatoria) |
Va notato che il rilievo delle ossa spesso riflette il tipo specifico di articolazione. Le articolazioni continue sulle ossa sono caratterizzate da tuberosità, creste, linee, cavità e rugosità, mentre le articolazioni discontinue sono caratterizzate da superfici articolari lisce di varie forme.
Connessioni ossee continue
Esistono tre gruppi di connessioni ossee continue: fibrose, cartilaginee e ossee.
I. Giunture fibrose di ossa o connessioni che utilizzano il tessuto connettivo - sindesmosi. Questi includono legamenti, membrane, fontanelle, suture e occlusioni.
I legamenti sono connessioni costituite da tessuto connettivo che assomigliano a fasci di collagene e fibre elastiche. Per la loro struttura, i legamenti con una predominanza di fibre di collagene sono chiamati fibrosi e i legamenti contenenti prevalentemente fibre elastiche sono chiamati elastici. A differenza dei legamenti fibrosi, i legamenti elastici sono in grado di accorciarsi e ritornare alla loro forma originale dopo la rimozione del carico.
A seconda della lunghezza delle fibre, i legamenti possono essere lunghi (legamenti longitudinali posteriori e anteriori della colonna vertebrale, legamento sopraspinoso), che collegano diverse ossa su una lunga distanza, e corti, che collegano le ossa adiacenti (legamenti interspinosi, intertrasversali e la maggior parte dei legamenti del le ossa delle estremità).
In relazione alla capsula articolare si distinguono i legamenti intrarticolari ed extraarticolari. Questi ultimi sono considerati extracapsulari e capsulari. I legamenti, come tipo indipendente di connessione ossea, possono svolgere varie funzioni:
- ritenzione o fissaggio (legamento sacrotuberoso, legamenti sacrospinosi, interspinosi, intertrasversali, ecc.);
- il ruolo dello scheletro molle, poiché è il luogo di origine e di attacco dei muscoli (la maggior parte dei legamenti degli arti, legamenti della colonna vertebrale, ecc.);
- formativi, quando insieme alle ossa formano volte o aperture per il passaggio dei vasi sanguigni e dei nervi (legamento trasverso superiore della scapola, legamenti pelvici, ecc.).
Le membrane sono connessioni costituite da tessuto connettivo che assomigliano a membrane interossee che, a differenza dei legamenti, riempiono ampi spazi tra le ossa. Le fibre del tessuto connettivo nelle membrane, principalmente il collagene, si trovano in una direzione che non interferisce con il movimento. Il loro ruolo è per molti versi simile a quello dei legamenti. Inoltre tengono le ossa l'una rispetto all'altra (membrane intercostali, membrane interossee dell'avambraccio e della parte inferiore della gamba), servono come origine dei muscoli (le stesse membrane) e formano aperture per il passaggio dei vasi sanguigni e dei nervi (membrana otturatoria).
Le fontane sono formazioni di tessuto connettivo con una grande quantità di sostanza intermedia e fibre di collagene scarsamente localizzate. Fontana creano le condizioni per lo spostamento delle ossa del cranio durante il parto e promuovono un'intensa crescita ossea dopo la nascita. La fontanella anteriore raggiunge le dimensioni maggiori (30 x 25 mm). Si chiude nel secondo anno di vita. La fontanella posteriore misura 10 x 10 mm e scompare completamente entro la fine del secondo mese dopo la nascita. Le fontanelle accoppiate a forma di cuneo e mastoidi sono ancora più piccole. Guariscono prima della nascita o nelle prime due settimane dopo la nascita. Le fontanelle vengono eliminate a causa della proliferazione delle ossa del cranio e della formazione di tessuto connettivo di sutura tra di esse.
Le suture sono sottili strati di tessuto connettivo situati tra le ossa del cranio, contenenti un gran numero di fibre di collagene. La forma delle suture è frastagliata, squamosa e piatta; fungono da zona di crescita per le ossa del cranio e hanno un effetto ammortizzante durante i movimenti, proteggendo il cervello, gli organi della vista, l'udito e l'equilibrio dai danni.
Le impattazioni sono connessioni dei denti con le cellule dei processi alveolari delle mascelle utilizzando un tessuto connettivo denso, che ha un nome speciale: parodonto. Sebbene si tratti di una connessione molto forte, ha anche spiccate proprietà di assorbimento degli urti quando il dente viene caricato. Lo spessore del parodonto è 0,14–0,28 mm. È costituito da fibre collagene ed elastiche orientate per tutta la lunghezza perpendicolarmente dalle pareti degli alveoli alla radice del dente. Tra le fibre si trova il tessuto connettivo lasso contenente un gran numero di vasi e fibre nervose. Quando le mascelle sono fortemente serrate a causa della pressione del dente antagonista, il parodonto viene fortemente compresso e il dente viene immerso nella cellula fino a 0,2 mm.
Con l'età, il numero delle fibre elastiche diminuisce e, in caso di stress, il parodonto viene danneggiato, il suo afflusso di sangue e la sua innervazione vengono interrotti, i denti si allentano e cadono.
II. Giunti cartilaginei delle ossa- sincondrosi. Questi composti sono rappresentati dalla cartilagine ialina o fibrosa. Confrontando queste cartilagini tra loro, si può notare che la cartilagine ialina è più elastica, ma meno resistente. Con l'aiuto della cartilagine ialina, le metafisi e le epifisi delle ossa tubolari e le singole parti dell'osso pelvico vengono collegate. La cartilagine fibrosa è costituita principalmente da fibre di collagene, quindi è più resistente e meno elastica. Questa cartilagine collega i corpi vertebrali. La forza delle articolazioni cartilaginee aumenta anche grazie al fatto che il periostio da un osso passa all'altro senza interruzione. Nella zona della cartilagine si trasforma in pericondrio, che a sua volta si fonde saldamente con la cartilagine ed è sostenuto dai legamenti.
A seconda della durata della loro esistenza, la sincondrosi può essere permanente o temporanea, cioè esistere fino ad una certa età e poi sostituita dal tessuto osseo. In condizioni fisiologiche normali, le cartilagini metaepifisarie, le cartilagini tra le singole parti delle ossa piatte e la cartilagine tra la parte principale dell'occipitale e il corpo delle ossa sfenoidi sono temporanee. Questi composti sono rappresentati principalmente dalla cartilagine ialina. La cartilagine che forma i dischi intervertebrali è detta permanente; cartilagine situata tra le ossa della base del cranio (sfenoid-petroso e sfenoide-occipitale), e cartilagine tra la prima costa e lo sterno. Questi composti sono rappresentati principalmente dalla cartilagine fibrosa.
Lo scopo principale della sincondrosi è attenuare gli urti e le sollecitazioni sotto carichi pesanti sull'osso (assorbimento degli urti) e garantire una forte connessione tra le ossa. Le articolazioni della cartilagine allo stesso tempo hanno una grande mobilità. L'ampiezza dei movimenti dipende dallo spessore dello strato cartilagineo: più è spesso, maggiore è l'ampiezza dei movimenti. Ad esempio, possiamo citare vari movimenti della colonna vertebrale: piegamenti in avanti, indietro, di lato, torsioni, movimenti elastici, che sono particolarmente sviluppati nei ginnasti, negli acrobati e nei nuotatori.
III. Connessioni tramite tessuto osseo- sinostosi. Queste sono le connessioni più forti del gruppo di quelle continue, ma hanno completamente perso la loro elasticità e le proprietà di assorbimento degli urti. In condizioni normali, le sincondrosi temporanee vanno incontro a sinostosi. In alcune malattie (malattia di Bechterew, osteocondrosi, ecc.), L'ossificazione può verificarsi non solo in tutte le sincondrosi, ma anche in tutte le sindesmosi.
Connessioni ossee discontinue
Le articolazioni discontinue sono articolazioni o articolazioni sinoviali. Un'articolazione è un'articolazione a cavità discontinua formata dall'articolazione di superfici articolari ricoperte di cartilagine, racchiusa in una capsula articolare (capsula), che contiene liquido sinoviale.
L'articolazione deve necessariamente comprendere tre elementi principali: la superficie articolare ricoperta di cartilagine; Capsula articolare; cavità articolare.
1. Superfici articolari- Si tratta di aree ossee ricoperte di cartilagine articolare. Nelle ossa tubolari lunghe si trovano sulle epifisi, in quelle corte - sulle teste e sulle basi, nelle ossa piatte - sui processi e sul corpo. Le forme delle superfici articolari sono rigorosamente determinate: più spesso su un osso c'è una testa, sull'altro una fossa, meno spesso sono piatte. Le superfici articolari sulle ossa articolari devono corrispondere tra loro in forma, cioè essere congruenti. Più spesso, le superfici articolari sono rivestite da cartilagine ialina (vitreo). La cartilagine fibrosa ricopre, ad esempio, le superfici articolari dell'articolazione temporo-mandibolare. Lo spessore della cartilagine sulle superfici articolari è 0,2-0,5 cm, e nella fossa articolare è più spesso sul bordo e sulla testa articolare al centro.
Negli strati profondi la cartilagine è calcificata e saldamente collegata all'osso. Questo strato è detto vischio, ovvero impregnato di carbonato di calcio. I condrociti (cellule della cartilagine) in questo strato sono circondati da fibre di tessuto connettivo situate perpendicolarmente alla superficie, cioè in righe o colonne. Sono adatti a resistere alle forze di pressione sulla superficie articolare. Negli strati superficiali predominano le fibre del tessuto connettivo sotto forma di archi, che iniziano e terminano negli strati profondi della cartilagine. Queste fibre sono orientate parallelamente alla superficie della cartilagine. Inoltre, questo strato contiene una grande quantità di sostanza intermedia, quindi la superficie della cartilagine è liscia, come se fosse lucidata. Lo strato superficiale della cartilagine è atto a resistere alle forze di attrito (forze tangenziali). Con l'età, la cartilagine subisce una desalinizzazione, il suo spessore diminuisce e diventa meno liscia.
Il ruolo della cartilagine articolare è quello di attenuare le irregolarità e le rugosità della superficie articolare dell'osso, conferendogli una maggiore congruenza. Grazie alla sua elasticità, ammorbidisce gli urti e gli shock, quindi nelle articolazioni che sopportano un carico elevato, la cartilagine articolare è più spessa.
2. Borsa- si tratta di una capsula ermetica che circonda la cavità articolare, che cresce lungo il bordo delle superfici articolari o ad una leggera distanza da esse. È costituito da una membrana esterna (fibrosa) e da una interna (sinoviale). La membrana fibrosa, a sua volta, è costituita da due strati di tessuto connettivo denso (longitudinale esterno e circolare interno), in cui si trovano i vasi sanguigni. È rinforzato da legamenti extraarticolari, che formano ispessimenti locali e si trovano nelle zone di maggior carico. I legamenti sono solitamente strettamente collegati alla capsula e possono essere separati solo artificialmente. Raramente ci sono legamenti isolati dalla capsula articolare, ad esempio il tibioperone e il perone laterali. Nelle articolazioni sedentarie la membrana fibrosa è ispessita. Nelle articolazioni mobili è sottile, debolmente tesa, e in alcuni punti è così sottile che la membrana sinoviale sporge addirittura verso l'esterno. Si formano così le inversioni sinoviali (borse sinoviali), solitamente situate sotto i tendini.
La membrana sinoviale è rivolta verso la cavità articolare, è abbondantemente irrorata di sangue ed è rivestita dall'interno da sinoviociti capaci di secernere liquido sinoviale. La membrana sinoviale copre l'intera cavità articolare dall'interno, si estende alle ossa e ai legamenti intrarticolari. Solo le superfici rappresentate dalla cartilagine ne rimangono libere. La membrana sinoviale è liscia, lucida e può formare numerosi processi: i villi. A volte questi villi si rompono e diventano corpi estranei sulle superfici interarticolari, causando dolore a breve termine e impedendo il movimento. Questa condizione è chiamata "mouse congiunto". La membrana sinoviale può giacere direttamente sulla membrana fibrosa oppure essere separata da essa da uno strato subsinoviale o da uno strato grasso, si distinguono quindi membrane sinoviali fibrose, areolari e grasse.
Il liquido sinoviale nella sua composizione e natura della formazione è un trasudato: un versamento di plasma sanguigno e linfa dai capillari adiacenti alla membrana sinoviale. Nella cavità articolare, questo fluido è mescolato con detriti di cellule sinoviocitarie rigettate e cartilagine abrasa. Inoltre, il liquido sinoviale contiene mucina, mucopolisaccaridi e acido ialuronico, che gli conferiscono viscosità. La quantità di fluido dipende dalla dimensione dell'articolazione e varia da 5 mm3 a 5 cm3. Il liquido sinoviale svolge le seguenti funzioni:
- lubrifica le superfici articolari (riduce l'attrito durante i movimenti, aumenta lo scivolamento);
- collega le superfici articolari, le tiene l'una rispetto all'altra;
- ammorbidisce il carico;
- nutre la cartilagine articolare;
- partecipa al metabolismo.
3. Cavità articolare- questo è uno spazio ermeticamente chiuso, limitato dalle superfici articolari e dalla capsula, pieno di liquido sinoviale. È possibile distinguere una cavità articolare su un'articolazione intatta solo condizionatamente, poiché non c'è spazio tra le superfici articolari e la capsula è piena di liquido sinoviale; La forma e il volume della cavità dipendono dalla forma delle superfici articolari e dalla struttura della capsula. Nelle articolazioni a basso movimento è piccolo, in quelle molto mobili è grande e può avere eversione, diffondendosi tra ossa, muscoli e tendini. C'è una pressione negativa nella cavità articolare. Quando la capsula è danneggiata, l'aria entra nella cavità e le superfici articolari divergono.
Oltre agli elementi principali, i giunti possono contenere elementi ausiliari che garantiscono il funzionamento ottimale del giunto. Si tratta di legamenti e cartilagini intraarticolari, labbra articolari, pieghe sinoviali, ossa sesamoidi e borse sinoviali.
- Legamenti intrarticolari- Si tratta di legamenti fibrosi ricoperti da una membrana sinoviale che collegano le superfici articolari nell'articolazione del ginocchio, nell'articolazione della testa della costola e nell'articolazione dell'anca. Tengono le superfici articolari l'una rispetto all'altra. Questa funzione è particolarmente chiaramente visibile nell'esempio dei legamenti crociati dell'articolazione del ginocchio. Quando si rompono, si osserva un sintomo del "cassetto" quando, quando si piega l'articolazione del ginocchio, la tibia si sposta anteriormente e posteriormente rispetto alla coscia di 2-3 cm. Il legamento della testa del femore funge da conduttore per i vasi sanguigni la testa articolare.
- Cartilagine intrarticolare- Queste sono cartilagini fibrose situate tra le superfici articolari sotto forma di placche. La placca che separa completamente l'articolazione in due “piani” è chiamata disco articolare (discus articularis). In questo caso si formano due cavità separate, come ad esempio nell'articolazione temporo-mandibolare. Se la cavità articolare è divisa solo parzialmente da placche cartilaginee, cioè le placche hanno la forma di una mezzaluna e i loro bordi sono fusi con la capsula, questi sono menischi (menischi), che sono presenti nell'articolazione del ginocchio. La cartilagine intrarticolare garantisce la congruenza delle superfici articolari, aumentando così la gamma dei movimenti e la loro varietà, contribuendo ad ammorbidire gli shock e ridurre la pressione sulle superfici articolari sottostanti.
- Labbro articolare- questa è una cartilagine fibrosa a forma di anello che completa la fossa articolare lungo il bordo; in questo caso, un bordo del labbro si fonde con la capsula articolare e l'altro passa nella superficie articolare. Il labbro si trova in due articolazioni: la spalla e l'anca (labbro glenoidale, labbro acetabulare). Aumenta l'area della superficie articolare, la rende più profonda, limitando così la gamma di movimenti.
- Pieghe sinoviali (plicae synoviales)- Si tratta di formazioni di tessuto connettivo ricche di vasi sanguigni, ricoperte da una membrana sinoviale. Se al loro interno si accumula tessuto adiposo, si formano delle pieghe di grasso. Le pieghe riempiono gli spazi liberi della cavità articolare, che è ampia. Aiutando a ridurre la cavità articolare, le pieghe aumentano indirettamente l'adesione delle superfici articolari e quindi aumentano l'ampiezza del movimento.
- Ossa sesamoidi (ossa sesamoidea)- Si tratta di ossa intercalari strettamente collegate alla capsula articolare e ai tendini muscolari che circondano l'articolazione. Una delle loro superfici è ricoperta di cartilagine ialina ed è rivolta verso la cavità articolare. Le ossa intercalate aiutano a ridurre la cavità articolare e ad aumentare indirettamente la gamma di movimento al suo interno. Fungono anche da blocchi per i tendini dei muscoli che agiscono sull'articolazione. L'osso sesamoide più grande è la rotula. Piccole ossa sesamoidi si trovano spesso nelle articolazioni della mano e del piede (nell'articolazione interfalangea, carpometacarpale del 1o dito, ecc.).
- Borse sinoviali (bursae synoviales)- Si tratta di piccole cavità rivestite da membrana sinoviale, spesso comunicanti con la cavità articolare. La loro dimensione varia da 0,5 a 5 cm3. Un gran numero di essi si trova nelle articolazioni degli arti. Al loro interno si accumula il liquido sinoviale, che lubrifica i tendini vicini.
I movimenti delle articolazioni possono avvenire solo attorno a tre assi di rotazione:
- frontale (asse corrispondente al piano frontale che divide il corpo in superfici anteriore e posteriore);
- sagittale (asse corrispondente al piano sagittale che divide il corpo nelle metà destra e sinistra);
- verticale o il proprio asse.
Per l'arto superiore l'asse verticale passa per il centro della testa dell'omero, la testa del condilo omerale, la testa del radio e l'ulna. Per l'arto inferiore - in linea retta che collega la spina iliaca antero-superiore, il bordo interno della rotula e il pollice.
La superficie articolare di una delle ossa articolari, che ha la forma di una testa, può essere presentata sotto forma di palla, ellisse, sella, cilindro o blocco. Ciascuna di queste superfici corrisponde ad una fossa articolare. Va notato che la superficie articolare può essere formata da più ossa, che insieme le conferiscono una certa forma (ad esempio, la superficie articolare formata dalle ossa della fila prossimale del polso).
1 - ellissoidale; 2 - a forma di sella; 3 - sferico; 4 - a forma di blocco; 5 - piatto
I movimenti delle articolazioni attorno agli assi di rotazione sono determinati dalla forma geometrica della superficie articolare. Ad esempio, il cilindro e il blocco ruotano solo attorno a un asse; ellisse, ovale, sella - attorno a due assi; una palla o una superficie piana - circa tre.
Il numero e le possibili tipologie di movimenti attorno agli assi di rotazione esistenti sono presentati nelle tabelle. Si notano quindi due tipi di movimenti attorno all'asse frontale (flessione ed estensione); esistono inoltre due tipi di movimenti attorno all'asse sagittale (adduzione e abduzione); quando ci si sposta da un asse all'altro, si verifica un altro movimento (circolare o conico); attorno all'asse verticale c'è un movimento (rotazione), ma può avere sottotipi: rotazione verso l'interno o verso l'esterno (pronazione o supinazione).
Assi di rotazione, numero e tipologie dei movimenti possibili
Il numero massimo di possibili tipi di movimenti nelle articolazioni, a seconda del numero di assi di rotazione e della forma della superficie articolare
| Allineamento congiunto | Forma della superficie articolare | Assi di rotazione implementati | Numero di movimenti | Tipi di movimenti |
| Uniassiale | A forma di blocco | Frontale | 2 | Flessione, estensione |
| Rotativo (cilindrico) | Verticale | 1 | Rotazione | |
| Biassiale | Ellittico, a forma di sella | Sagittale e frontale | 5 | Flessione, estensione, adduzione, abduzione, movimento circolare |
| Condilo | Frontale e verticale | 3 | Flessione, estensione, rotazione | |
| Multiasse | sferico, piatto | Frontale, sagittale e verticale | 6 | Flessione, estensione, adduzione, abduzione, movimento circolare, rotazione |
Pertanto, ci sono solo 6 tipi di movimenti. Sono possibili anche movimenti aggiuntivi, come lo scorrimento, il molleggio (rimozione e riavvicinamento delle superfici articolari durante la compressione e l'allungamento) e la torsione. Questi movimenti non riguardano singole articolazioni, ma un gruppo di articolazioni combinate, ad esempio quelle intervertebrali.
In base alla classificazione delle articolazioni è necessario caratterizzare ogni singolo gruppo.
I. Classificazione delle articolazioni in base agli assi di rotazione e alla forma delle superfici articolari:
Giunti uniassiali- si tratta di articolazioni in cui i movimenti vengono effettuati solo attorno ad un asse. In pratica tale asse è frontale o verticale. Se l'asse è frontale, i movimenti in queste articolazioni vengono eseguiti sotto forma di flessione ed estensione. Se l'asse è verticale, è possibile un solo movimento: la rotazione. I rappresentanti delle articolazioni uniassiali secondo la forma delle superfici articolari sono: cilindrici (articulatio trochoidea) (rotazionali) e a forma di blocco (ginglymus). I giunti cilindrici eseguono movimenti attorno ad un asse verticale, cioè ruotano. Esempi di tali articolazioni sono: l'articolazione atlo-assiale mediana, le articolazioni radioulnari prossimale e distale.
L'articolazione trocleare è simile a un'articolazione cilindrica, solo che non si trova verticalmente, ma orizzontalmente e presenta una cresta sulla testa articolare e una tacca sulla fossa articolare. A causa della cresta e della tacca, lo spostamento laterale delle superfici articolari è impossibile. La capsula di tali articolazioni è libera davanti e dietro ed è sempre rinforzata da legamenti laterali che non interferiscono con i movimenti. I giunti a blocchi funzionano sempre attorno all'asse frontale. Un esempio sono le articolazioni interfalangee.
Un tipo di articolazione trocleare è l'articolazione cocleare (articulatio cochlearis), o articolazione a forma di vite, in cui l'incisura e la cresta sono smussate e hanno un movimento elicoidale. Un esempio di articolazione cocleare è l'articolazione ulno-omerale, che opera anche attorno all'asse frontale. Pertanto, le articolazioni unassiali hanno uno o due tipi di movimento.
Giunti biassiali- giunti che lavorano attorno a due dei tre assi di rotazione disponibili. Quindi, se i movimenti vengono eseguiti attorno agli assi frontale e sagittale, tali articolazioni realizzano 5 tipi di movimenti: flessione, estensione, adduzione, abduzione e movimento circolare. A seconda della forma delle superfici articolari, queste articolazioni sono ellissoidali o a forma di sella (articulatio ellipsoidea, articulatio sellaris). Esempi di articolazioni ellissoidali: atlanto-occipitale e radiocarpale; sella: articolazione carpometacarpale del 1° dito.
Se i movimenti vengono eseguiti attorno agli assi frontale e verticale, è possibile realizzare solo tre tipi di movimenti: flessione, estensione e rotazione. Nella forma si tratta delle articolazioni condilari (articulatio bicondyllaris), ad esempio il ginocchio e le articolazioni temporo-mandibolari.
Le articolazioni condilari sono una forma di transizione tra le articolazioni uniassiali e biassiali. L'asse principale di rotazione in essi è quello frontale. A differenza delle articolazioni monoassiali, presentano una differenza maggiore nelle aree delle superfici articolari e quindi aumenta la gamma di movimenti.
Giunti multiasse- si tratta di giunti in cui i movimenti vengono effettuati attorno a tutti e tre gli assi di rotazione. Fanno il numero massimo possibile di movimenti: 6 tipi. Si tratta di articolazioni sferiche (articulatio spheroidea), ad esempio la spalla. Un tipo di articolazione sferica è a forma di coppa (articulatio cotylica) o a forma di nocciola (articulatio enartrosi), ad esempio l'anca. È caratterizzato da una fossa articolare profonda, una capsula forte rinforzata da legamenti e una minore libertà di movimento. Se la superficie di una palla ha un raggio di curvatura molto ampio, allora si avvicina ad una superficie piana. Un'articolazione con tale superficie è chiamata piatta (articulatio plana). Le articolazioni piatte sono caratterizzate da una piccola differenza nelle aree delle superfici articolari, legamenti forti e i movimenti in essi sono nettamente limitati o del tutto assenti (ad esempio, nell'articolazione sacroiliaca). A questo proposito, queste articolazioni sono chiamate sedentarie (anfiartrosi).
II. Classificazione delle articolazioni in base al numero di superfici articolari.
Articolazione semplice (articulatio simplex)- un'articolazione che presenta solo due superfici articolari, ciascuna delle quali può essere formata da una o più ossa. Ad esempio, le superfici articolari delle articolazioni interfalangee sono formate solo da due ossa e una delle superfici articolari nell'articolazione del polso è formata da tre ossa della fila prossimale del polso.
Giunto compostoè un'articolazione in una capsula di cui esistono diverse superfici articolari, quindi diverse articolazioni semplici che possono funzionare sia insieme che separatamente. Un esempio di articolazione complessa è l'articolazione del gomito, che ha 6 superfici articolari separate che formano 3 articolazioni semplici: brachioradiale, omeroulnare, radioulnare prossimale. Alcuni autori includono anche l'articolazione del ginocchio come articolazione complessa. Considerando le superfici articolari sul menisco e sulla rotula, distinguono articolazioni semplici come femoro-meniscale, menisco-tibiale e femoro-rotulea. Consideriamo semplice l'articolazione del ginocchio, poiché i menischi e la rotula sono elementi ausiliari.
III. Classificazione delle articolazioni in base alla funzione articolare simultanea.
Articolazioni combinate (articulatio combinatoria)- si tratta di articolazioni anatomicamente separate, cioè situate in diverse capsule articolari, ma funzionanti solo insieme. Ad esempio, l'articolazione temporo-mandibolare, le articolazioni radioulnari prossimali e distali. Va sottolineato che nelle vere articolazioni combinate è impossibile eseguire il movimento solo in una di esse, ad esempio solo in un'articolazione temporo-mandibolare. Quando si combinano articolazioni con diverse forme di superfici articolari, i movimenti vengono realizzati lungo un'articolazione che ha un numero minore di assi di rotazione.
Fattori che determinano l'ampiezza del movimento delle articolazioni.
- Il fattore principale è la differenza nelle aree delle superfici articolari articolari. Di tutte le articolazioni, la differenza maggiore nelle aree delle superfici articolari si trova nell'articolazione della spalla (l'area della testa dell'omero è 6 volte maggiore dell'area della cavità glenoidea sulla scapola), quindi l'articolazione della spalla ha la più ampia gamma di movimenti. Nell'articolazione sacroiliaca, le superfici articolari hanno la stessa area, quindi praticamente non c'è movimento al suo interno.
- Disponibilità di elementi ausiliari. Ad esempio, menischi e dischi, aumentando la congruenza delle superfici articolari, aumentano l'ampiezza del movimento. Le labbra, aumentando l'area della superficie articolare, aiutano a limitare i movimenti. I legamenti intrarticolari limitano il movimento solo in una certa direzione (i legamenti crociati dell'articolazione del ginocchio non impediscono la flessione, ma resistono all'estensione eccessiva).
- Combinazione di giunti. Nei giunti combinati i movimenti sono determinati dal giunto che ha meno assi di rotazione. Sebbene molte articolazioni, in base alla forma delle superfici articolari, siano in grado di eseguire un range di movimento maggiore, questo è limitato a causa della combinazione. Ad esempio, a seconda della forma delle superfici articolari, le articolazioni atlantoassiali laterali sono piatte, ma in combinazione con l'articolazione atlantoassiale mediana funzionano come articolazioni rotatorie. Lo stesso vale per le articolazioni delle costole, della mano, del piede, ecc.
- Condizione della capsula articolare. Con una capsula sottile ed elastica, i movimenti avvengono in un volume maggiore. Anche lo spessore irregolare della capsula nella stessa articolazione influisce sulla sua funzione. Ad esempio, nell'articolazione temporo-mandibolare la capsula è più sottile nella parte anteriore che nella parte posteriore e laterale, quindi la massima mobilità è nella parte anteriore.
- Rafforzare la capsula articolare con i legamenti. I legamenti hanno un effetto inibitorio e guidante, poiché le fibre di collagene non solo hanno una grande resistenza, ma anche una bassa estensibilità. Nell'articolazione dell'anca, il legamento ileofemorale impedisce l'estensione e la rotazione verso l'interno dell'arto, mentre il legamento pubofemorale impedisce l'abduzione e la rotazione verso l'esterno. I legamenti più potenti si trovano nell'articolazione sacroiliaca, quindi praticamente non c'è movimento al suo interno.
- Muscoli che circondano l'articolazione. Possedendo un tono costante, fissano, uniscono e fissano le ossa articolari. La forza di trazione muscolare arriva fino a 10 kg per 1 cm2 di diametro muscolare. Se rimuovi i muscoli e lasci i legamenti e la capsula, la gamma di movimento aumenta notevolmente. Oltre all'effetto inibitorio diretto sui movimenti delle articolazioni, i muscoli hanno anche un effetto indiretto, attraverso i legamenti da cui iniziano. Quando i muscoli si contraggono, i legamenti diventano rigidi ed elastici.
- Liquido sinoviale. Ha un effetto adesivo e lubrifica le superfici articolari. Con l'artrosi-artrite, quando la secrezione del liquido sinoviale viene interrotta, compaiono dolore, scricchiolii nelle articolazioni e la gamma di movimenti diminuisce.
- Deflessione elicoidale. È presente solo nell'articolazione spalla-gomito e ha un effetto inibitorio durante i movimenti.
- Pressione atmosferica. Promuove il contatto delle superfici articolari con una forza di 1 kg per 1 cm2, ha un effetto di contrazione uniforme e quindi limita moderatamente il movimento.
- Condizione della pelle e del grasso sottocutaneo. Nelle persone obese l'ampiezza dei movimenti è sempre ridotta a causa dell'abbondante grasso sottocutaneo. Le persone snelle, in forma e atletiche eseguono movimenti con un volume maggiore. Nelle malattie della pelle, quando si perde l'elasticità, i movimenti si riducono drasticamente e spesso, dopo gravi ustioni o ferite, si formano contratture che impediscono anche in modo significativo il movimento.
Esistono diversi metodi per determinare l'ampiezza di movimento delle articolazioni. I traumatologi lo determinano utilizzando un goniometro. Ogni giunto ha le proprie posizioni iniziali. La posizione di partenza per l'articolazione della spalla è la posizione del braccio sospeso liberamente lungo il corpo. Per l'articolazione del gomito - estensione completa (180°). La pronazione e la supinazione vengono determinate con l'articolazione del gomito piegata ad angolo retto e la mano posizionata sul piano sagittale.
Negli studi anatomici, l'entità dell'angolo di mobilità può essere calcolata dalla differenza negli archi di rotazione su ciascuna delle superfici articolari articolari. L'entità dell'angolo di mobilità dipende da una serie di fattori: sesso, età, grado di formazione, caratteristiche individuali.
Malattie articolari
IN E. Mazurov
| Continua (sinartrosi), sinartrosi | Mezze articolazioni (emiartrosi), emiartrosi | Intermittente (diartrosi), diartrosi (articolazioni sinoviali, giunzione sinoviale) o articolazioni (articulatio) | ||
| I. Composti fibrosi, giunzione fibrosa (connessione tramite tessuto connettivo, o sindesmosi, sindesmosi); - legamenti, legamenti; - membrane, membranee; - fontanelle, fonticoli; - suture, suture (dentate, squamose, piatte); - impattazione, gonfosi. | I. Classificazione delle articolazioni in base agli assi di movimento e alla forma delle superfici articolari | |||
| 1. Monoassiale: a) cilindrico, art. cilindrica, o rotazionale, art. trocoidea; b) a forma di blocco, art. ginglymus, varietà – cocleare o elicoidale, art. cochlearis. | 2. Biassiale: a) ellissoidale; arte. ellissoidea; b) a sella, art. sellaris; c) condilare, art. bicondilare. | 3. Multiassiali: a) sferici, art. spheroidea, varietà – a coppa, art. cotylica o a forma di noce, art. enartrosi; b) appartamento, art. plana | ||
| II. Connessioni cartilaginee, giunzione cartilaginea (connessioni che utilizzano cartilagine, o sincondrosi, sincondrosi) - temporanee e permanenti: - connessioni che utilizzano cartilagine ialina; - connessioni con cartilagine fibrosa. III. Sinostosi, sinostosi (connessioni che utilizzano tessuto osseo). | II. Per struttura a) semplice, arte. semplice(formato da due superfici articolate). B) complesso, art. composita(formato da tre o più superfici articolari delle ossa). V) complesso, art. complessa(presenza di un disco o menisco intrarticolare). G) combinato, art. combinatorio(due articolazioni anatomicamente isolate ma che funzionano insieme). | |||
4.3. CONNESSIONI CONTINUE (SINARTROSI), SINARTROSI
A seconda della natura del tessuto che collega le ossa, si distinguono quattro gruppi di connessioni ossee continue: fibroso, cartilagineo, osso E muscolare(Fig. 4.4).
I. Composti fibrosi - sindesmosi, giunture fibrose o connessioni che utilizzano tessuto connettivo (fibroso). Questi includono legamenti, membrane, fontanelle, suture e occlusioni.
Legamenti,legamenti– si tratta di connessioni realizzate dal tessuto connettivo, che assomigliano a fasci di collagene o fibre elastiche e servono a rinforzare le articolazioni ossee. Possono essere molto corti, collegando ossa adiacenti, ad esempio legamenti interspinosi, intertrasversali, la maggior parte dei legamenti delle ossa degli arti, e lunghi, collegando diverse ossa su una lunga distanza (legamenti longitudinali posteriori e anteriori della colonna vertebrale, legamento sopraspinoso). Un tipo speciale di legamento è il legamento giallo, legamento giallo formato da fibre elastiche.
membrane,membranae- Si tratta di placche di collegamento tese tra le diafisi di lunghe ossa tubolari. Il loro ruolo è per molti versi simile a quello dei legamenti. Inoltre tengono le ossa in relazione tra loro (membrane intercostali, membrane interossee dell'avambraccio e della parte inferiore della gamba), servono come origine dei muscoli e formano aperture per il passaggio dei vasi sanguigni e dei nervi (membrana otturatoria).
fontanelle,fonticoli– si tratta di formazioni connettive che creano le condizioni per lo spostamento delle ossa del cranio durante il parto e contribuiscono alla crescita ossea intensiva dopo la nascita. Nelle zone in cui convergono più ossa, sono presenti 6 fontanelle ricoperte da placche di tessuto connettivo: 2 spaiate (anteriore o frontale e posteriore o occipitale) e 2 pari (sfenoidale e mastoideo). Le fontanelle vengono eliminate a causa della proliferazione delle ossa del cranio e della formazione di tessuto connettivo di sutura tra di esse.
Riso. 4.4. Connessioni ossee continue e semi-articolazioni.
A – sindesmosi, membrana interossea dell'avambraccio (1); B – sincondrosi, disco intervertebrale (2); B – semi-articolare, sinfisi pubica (3).
cuciture,suture- Si tratta di sottili strati di tessuto connettivo situati tra le ossa del cranio. A seconda della forma delle ossa del cranio, si distinguono le seguenti suture: seghettate - sutura serrata(tra le ossa della volta cranica, ad esempio frontale e parietale), squamoso - sutura squamosa(tra i bordi delle ossa temporali e parietali) e piatto - sutura piana(tra le ossa del cranio facciale, ad esempio il nasale). Le suture fungono da zona di crescita per le ossa del cranio e hanno un effetto ammortizzante durante i movimenti, proteggendo il cervello, gli organi della vista, gli organi dell'udito e dell'equilibrio dai danni.
Iniezione,gonfosi- questo è un tipo speciale di connessione fibrosa dei denti con le cellule dei processi alveolari delle mascelle con l'aiuto del tessuto connettivo denso - parodonto, che ha uno scopo speciale. Questa è una connessione molto forte che ha una pronunciata proprietà di assorbimento degli urti quando caricata sui denti.
II. Articolazioni cartilaginee – sincondrosi,giunture cartilaginee, sono connessioni tra ossa che utilizzano tessuto cartilagineo. Lo scopo principale della sincondrosi è attenuare gli urti e le sollecitazioni sotto carichi pesanti sull'osso (assorbimento degli urti) e garantire una forte connessione tra le ossa. Allo stesso tempo hanno una grande mobilità (ad esempio, vari movimenti nella colonna vertebrale).
Secondo la durata dell'esistenza della sincondrosi, possono esserlo permanente(rimanere per tutta la vita di una persona) e temporaneo(esistente fino ad una certa età e poi sostituito dal tessuto osseo). Le cartilagini permanenti (connessioni con fibrocartilagine) sono le cartilagini che formano i dischi intervertebrali, le cartilagini situate tra la piramide dell'osso temporale e le ossa vicine: lo sfenoide, l'occipitale e le estremità cartilaginee anteriori delle costole. Le sincondrosi temporanee (connessioni con cartilagine ialina) sono cartilagini metaepifisarie, cartilagini tra le singole parti delle ossa (pelviche), cartilagine tra la parte principale dell'occipitale e il corpo delle ossa sfenoidi.
Se la connessione continua temporanea viene sostituita da tessuto osseo, si parla di sinostosi.
III. Articolazioni ossee – sinostosi, sinostosi- una connessione con l'aiuto del tessuto osseo che si verifica nel sito di una connessione temporanea. Queste sono le connessioni più forti del gruppo di quelle continue. Hanno completamente perso la loro elasticità e proprietà di assorbimento degli urti (ad esempio, le connessioni tra le singole ossa della base del cranio, metà della mascella inferiore, tra le vertebre sacrali, le ossa che compongono l'osso pelvico, ecc.)
IV. Articolazioni muscolari – sinmiosi (sinsarcosi), sinmiosi, – connessioni tra le ossa usando i muscoli. Rafforzano l'articolazione, mantengono le superfici articolari delle ossa l'una rispetto all'altra, grazie al tono muscolare costante. Un esempio sono i muscoli del cingolo scapolare ( mm. cinguli membri superioris). Formano un discontinuo giunzione muscolare ( sinsarcosi) , attaccando la scapola e l'omero al torace e alle vertebre cervicali.
4.4. Mezze articolazioni (emiaartrosi), emiartrosi
Mezze articolazioni O sinfisi, sinfisi(dal greco: sinfisi- fusione) - sono connessioni cartilaginee, che sono un tipo di connessione intermedia tra connessioni continue e discontinue. Le sinfisi contengono cartilagine situata tra due ossa, in cui è presente una piccola cavità a fessura. Le pareti di questa cavità non hanno un rivestimento sinoviale e la cavità stessa non è riempita di liquido sinoviale. Un esempio di questa connessione è la sinfisi del manubrio dello sterno, sinfisi manubriosternale, sinfisi intervertebrale, sinfisi intervertebrale, e sinfisi pubica, sinfisi pubica. In alcuni casi, le sinfisi si formano alla connessione delle vertebre V lombare e I sacrale, nonché tra l'osso sacro e il coccige.
4.5. CONNESSIONI INTERRUTIVE (DIARTROSI), DIARTROSI
Le articolazioni discontinue sono articolazioni o articolazioni sinoviali. Giunto,articolazione- Questo è un tipo di connessione ossea, caratterizzata da grande mobilità e varietà di movimenti. Ogni articolazione è una connessione discontinua di ossa che comprende quattro elementi principali delle articolazioni(figura 4.5):
1. Superfici articolari ricoperte di cartilagine ialina.
2. Capsula articolare.
3. Cavità articolare.
4. Fluido articolare.
Riso. 4.5. Schema della struttura di un giunto.
1 – periostio; 2 – osso; 3 – capsula articolare; 4 – superfici articolari ricoperte di cartilagine articolare; 5 – cavità articolare.
1. Superfici articolari,facies articolare- Si tratta di aree ossee ricoperte di cartilagine articolare. Nella maggior parte dei casi, quando le ossa si articolano, le superfici articolari corrispondono tra loro, cioè Essi congruente. Se una superficie articolare è convessa (testa articolare), la seconda, articolandosi con essa, è concava (cavità glenoidea). In alcune articolazioni queste superfici non corrispondono tra loro né per forma né per dimensione. Tali giunti sono chiamati incongruente.
cartilagine articolare, cartilagine articolare, saldamente collegato all'osso. Il ruolo della cartilagine articolare è quello di attenuare le irregolarità e le rugosità delle superfici articolari delle ossa, conferendo loro una maggiore congruenza. Grazie alla sua elasticità, attenua gli urti e gli shock. Maggiore è il carico che un'articolazione subisce dalla gravità, maggiore è lo spessore della cartilagine articolare sulle superfici articolari.
2. Capsula articolare,capsula articolare- si tratta di una sacca che circonda ermeticamente la cavità articolare, crescendo sul bordo delle superfici articolari o ad una leggera distanza da esse. Si fonde saldamente con il periostio, formando una cavità articolare chiusa. La capsula è costituita da uno strato esterno, la membrana fibrosa, e da uno strato interno, la membrana sinoviale. membrana fibrosa, membrana fibrosa, resistente e spesso. In alcuni punti si ispessisce formando legamenti che rafforzano la capsula. La membrana sinoviale è rivolta verso la cavità articolare, è ricca di sangue ed è rivestita dall'interno di sinoviociti, che secernono liquido sinoviale, che ha le proprietà dei macrofagi. La membrana sinoviale presenta numerosi villi e pieghe che ne aumentano la superficie.
3. Cavità articolare,cavita articolare- questo è uno spazio ermeticamente chiuso, limitato dalle superfici articolari e dalla capsula, pieno di liquido sinoviale. La forma della cavità articolare dipende dalla forma delle superfici articolari, dalla struttura della capsula, dalla presenza o assenza di formazioni ausiliarie all'interno dell'articolazione (disco articolare o menisco) e dei legamenti intracapsulari.
4. Fluido articolare. Il liquido sinoviale nella composizione e nella natura della formazione è un trasudato: un versamento di plasma sanguigno e linfa dai capillari adiacenti alla membrana sinoviale. Liquido sinoviale: lubrifica le superfici articolari (riduce l'attrito durante i movimenti, aumenta lo scivolamento), aderisce alle superfici articolari, ammorbidisce il carico, nutre la cartilagine articolare.
Elementi ausiliari delle articolazioni. Oltre a quelli principali, i giunti contengono anche elementi ausiliari dei giunti, che garantiscono un funzionamento articolare ottimale. I principali sono: legamenti extra-articolari e intra-articolari, cartilagine intra-articolare (disco articolare e menischi), labbro articolare, pieghe sinoviali, ossa sesamoidi, borse sinoviali.
Legamenti fungono da freni passivi, limitando il movimento dell'articolazione. In relazione alla cavità articolare si possono dividere in intra ed extra articolari.
Legamenti extra-articolari considerati capsulari ed extracapsulari. I legamenti capsulari sono ispessimenti della membrana fibrosa. I legamenti possono trovarsi all'esterno della capsula (senza fondersi con essa), e quindi sono chiamati extracapsulari.
Legamenti intrarticolari,legamenti intraarticolari, sono legamenti fibrosi ricoperti da una membrana sinoviale che collegano le superfici articolari nell'articolazione del ginocchio (legamenti crociati dell'articolazione del ginocchio), nell'articolazione della testa della costola e nell'articolazione dell'anca.
Cartilagine intraarticolare, cartilagine intraarticolare, sono cartilagini fibrose situate tra le superfici articolari sotto forma di placche cartilaginee - dischi e menischi:
- disco articolare,disco articolare, è una placca cartilaginea che divide l'articolazione in due piani. In questo caso si formano due cavità separate, come, ad esempio, nelle articolazioni temporo-mandibolari, sternoclavicolari e acromionclavicolari;
- menisco articolare, menisco articolare, – le placche hanno forma semilunare (lat. menischi- mezzaluna) e i bordi sono fusi con la capsula (ad esempio l'articolazione del ginocchio), la cavità articolare è divisa solo parzialmente da placche cartilaginee. Dischi e menischi assicurano la congruenza delle superfici articolari, attenuano gli shock e riducono la pressione sulle superfici articolari sottostanti.
Labbro articolare,labbro articolare,- Questo è un bordo cartilagineo che completa la fossa articolare lungo il bordo. Il labbro si trova in due articolazioni: la spalla e l'anca ( labbro glenoidale e labbro acetabolare). Aumenta l'area della superficie articolare, la rende più profonda, limitando così la gamma di movimenti.
Pieghe sinoviali, pliche sinoviali,- Si tratta di formazioni di tessuto connettivo ricche di vasi sanguigni che riempiono gli spazi liberi della cavità articolare. Se al loro interno si accumula tessuto adiposo, si formano delle pieghe di grasso. Le pieghe aiutano a ridurre la cavità articolare e ad aumentare la libertà di movimento.
Ossa sesamoidi, ossa sesamoidea,- Si tratta di ossa intercalari strettamente collegate alla capsula articolare e ai tendini muscolari che circondano l'articolazione. Aiutano a ridurre la cavità articolare e ad aumentare indirettamente la gamma di movimento in questa articolazione. L'osso sesamoide più grande è la rotula. Piccole ossa sesamoidi si trovano spesso nelle articolazioni della mano e del piede, ad esempio nell'articolazione interfalangea, nell'articolazione carpometacarpale del primo dito, ecc.
Borse sinoviali, borse sinoviali, sono piccole cavità che comunicano o non comunicano con la cavità articolare. Il maggior numero di essi si trova nell'articolazione del ginocchio. Al loro interno si accumula il liquido sinoviale, che lubrifica i tendini vicini.
Le ossa dello scheletro umano sono combinate in un sistema funzionale comune (la parte passiva del sistema muscolo-scheletrico) utilizzando vari tipi di connessioni. Tutte le connessioni ossee sono divise in tre tipi: continue, discontinue e sinfisiche. A seconda del tipo di tessuto che collega le ossa, si distinguono i seguenti tipi di connessioni continue: fibrose, ossee e sincondrosi (connessioni cartilaginee) (Fig. 9).
Riso. 9.
A - giunto; B - connessione fibrosa; B - sincondrosi (giunzione cartilaginea); Sinfisi G (emiartrosi); 1 - periostio; 2- osso; 3- tessuto connettivo fibroso; 4 - cartilagine; 5 - membrana sinoviale; 6 - membrana fibrosa; 7 - cartilagine articolare; 8 - cavità articolare; 9 - divario nel disco interpubico; Disco 10-interpubico
Le articolazioni fibrose hanno grande forza e bassa mobilità. Questi includono sindesmosi (legamenti e membrane interossee), suture e impattazioni.
I legamenti sono fasci o placche spessi formati da tessuto connettivo fibroso denso con un gran numero di fibre di collagene. Nella maggior parte dei casi, i legamenti collegano due ossa e rafforzano le articolazioni, limitandone il movimento e resistendo a carichi significativi.
Le membrane interossee collegano le diafisi delle ossa tubolari e servono come luogo di attacco muscolare. Le membrane interossee hanno fori attraverso i quali passano i vasi sanguigni e i nervi.
Un tipo di articolazioni fibrose sono le suture del cranio che, a seconda della configurazione dei bordi collegati dell'osso, sono spugnose, squamose e piatte. In tutti i tipi di sutura sono presenti sottili strati di tessuto connettivo tra le ossa collegate.
L'inclusione è un tipo speciale di connessione fibrosa che si osserva nella connessione del dente con il tessuto osseo dell'alveolo dentale. Tra il dente e la parete ossea si trova una sottile lamina di tessuto connettivo: il parodonto.
Le sincondrosi sono connessioni tra le ossa che utilizzano il tessuto cartilagineo. Sono caratterizzati da elasticità e resistenza; svolgono una funzione ammortizzante.
La sostituzione dello strato di cartilagine tra le ossa con tessuto osseo è chiamata sinostosi. La mobilità in tali articolazioni scompare e la forza aumenta.
Le articolazioni discontinue (sinoviali o articolari) sono le articolazioni più mobili delle ossa. Hanno una grande mobilità e varietà di movimenti. Le caratteristiche di un'articolazione sono la presenza di superfici articolari, una cavità articolare, liquido sinoviale e una capsula. Le superfici articolari delle ossa sono ricoperte da cartilagine ialina con uno spessore da 0,25 a 6 mm, a seconda del carico sull'articolazione. La cavità articolare è uno spazio a fessura tra le superfici articolari delle ossa, circondato su tutti i lati dalla capsula articolare e contenente una grande quantità di liquido sinoviale.
La capsula articolare copre le estremità di collegamento delle ossa, forma un sacco sigillato, le cui pareti hanno due strati: la membrana esterna - fibrosa e quella interna - sinoviale.
Lo strato fibroso esterno è costituito da tessuto connettivo fibroso denso con una direzione longitudinale delle fibre e fornisce alla capsula articolare una resistenza significativa. In alcune articolazioni lo strato fibroso può formare ispessimenti (legamenti capsulari) che rinforzano la capsula articolare.
Lo strato interno (sinovia) presenta piccole sporgenze (villi, ricchi di vasi sanguigni), che aumentano notevolmente la superficie dello strato. La sinovia produce un fluido che idrata le superfici articolari delle articolazioni, eliminando il loro attrito reciproco. Inoltre, questa membrana assorbe il liquido, garantendo un processo metabolico continuo.
Se le superfici articolari non corrispondono, tra loro si trovano placche cartilaginee di diverse forme: dischi articolari e menischi. Sono in grado di spostarsi durante i movimenti, appianare le irregolarità delle superfici articolari e svolgere una funzione di assorbimento degli urti.
In alcuni casi (ad esempio nell'articolazione della spalla), lungo il bordo della superficie articolare in una delle ossa è presente un labbro articolare, che lo approfondisce, aumenta l'area dell'articolazione e conferisce maggiore conformità alla forma delle superfici articolari.
A seconda della struttura delle superfici articolari, i movimenti delle articolazioni possono verificarsi attorno ad assi diversi. La flessione e l'estensione sono movimenti attorno all'asse frontale; rapimento e adduzione - attorno all'asse sagittale; rotazione - attorno all'asse longitudinale; rotazione circolare - attorno a tutti gli assi. L'ampiezza e la gamma dei movimenti delle articolazioni dipendono dalla differenza dei gradi angolari delle superfici articolari. Maggiore è questa differenza, maggiore è la gamma di movimenti.
In termini di numero di ossa articolari e forma delle loro superfici articolari, le articolazioni possono differire l'una dall'altra.
Un'articolazione formata da sole due superfici articolari è detta semplice, mentre un'articolazione composta da tre o più superfici articolari è detta complessa.
Esistono giunti complessi e combinati. I primi sono caratterizzati dalla presenza di un disco articolare o menisco tra le superfici articolari; queste ultime sono rappresentate da due articolazioni anatomicamente isolate che agiscono insieme (articolazione temporo-mandibolare).
Secondo la forma delle superfici articolari, le articolazioni sono divise in cilindriche, ellissoidali e sferiche (Fig. 10).

1 - a forma di blocco; 2 - ellittico; 3 - a forma di sella; 4 - sferico
Esistono anche varianti delle forme congiunte di cui sopra. Ad esempio, un tipo di articolazione cilindrica è un'articolazione trocleare, un'articolazione sferica è un'articolazione a forma di coppa e piatta. La forma delle superfici articolari determina gli assi attorno ai quali avviene il movimento in una determinata articolazione. Con una forma cilindrica delle superfici articolari, il movimento avviene attorno a un asse, con una forma ellissoidale - attorno a due assi, con una forma sferica - attorno a tre o più assi reciprocamente perpendicolari. Esiste quindi una certa relazione tra la forma delle superfici articolari e il numero degli assi di movimento. A questo proposito si distinguono i giunti a uno, due e tre assi (multiassiali).
Le articolazioni uniassiali includono articolazioni cilindriche e trocleari. Ad esempio, in un'articolazione cilindrica, la rotazione avviene attorno ad un asse verticale, che coincide con l'asse dell'osso (rotazione della prima vertebra cervicale insieme al cranio attorno al processo odontoideo della seconda vertebra). Nelle articolazioni trocleari, la rotazione avviene attorno a un asse trasversale, ad esempio la flessione e l'estensione nelle articolazioni interfalangee. L'articolazione trocleare comprende anche un'articolazione a vite, dove il movimento avviene a spirale (articolazione omero-ulnare).
Le articolazioni biassiali comprendono le articolazioni ellissoidali, a sella e condilari. Nell'articolazione ellissoidale, i movimenti avvengono attorno ad assi reciprocamente perpendicolari (ad esempio l'articolazione del polso): flessione ed estensione attorno all'asse frontale, adduzione e abduzione attorno all'asse sagittale.
Nell'articolazione della sella (articolazione carpometacarpale del pollice) si verificano movimenti simili ai movimenti dell'articolazione ellissoidale, cioè non solo abduzione e adduzione, ma anche opposizione del pollice al resto.
L'articolazione condilare (articolazione del ginocchio) è una forma di transizione tra trocleare ed ellissoide. Ha due teste articolari convesse che ricordano la forma di un'ellisse e sono chiamate condili. Nell'articolazione condilare è possibile il movimento attorno all'asse frontale - flessione ed estensione, attorno all'asse longitudinale - rotazione.
I giunti triassiali (multiassiali) comprendono giunti sferici, a tazza e piatti. L'articolazione sferica subisce flessione ed estensione, adduzione, abduzione e rotazione. A causa della differenza significativa nella dimensione delle superfici articolari (testa dell'articolazione e cavità glenoidea), l'articolazione sferica è la più mobile tra tutte le articolazioni.
L'articolazione a tazza (articolazione dell'anca) è un tipo di giunto sferico. Si differenzia da quest'ultimo per la maggiore profondità della cavità glenoidea. A causa della piccola differenza nelle dimensioni angolari delle superfici articolari, l'ampiezza del movimento in questa articolazione è ridotta.
Nelle articolazioni piatte i movimenti vengono eseguiti attorno a tre assi, ma l'ampiezza della rotazione è limitata a causa della leggera curvatura e dimensione delle superfici articolari. Le articolazioni piatte comprendono le faccette (intervertebrali) e le articolazioni tarso-metatarsali.