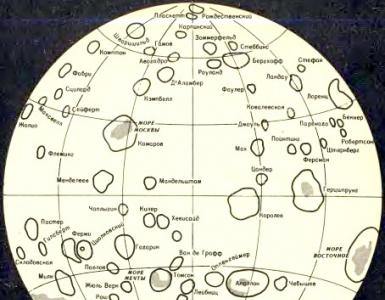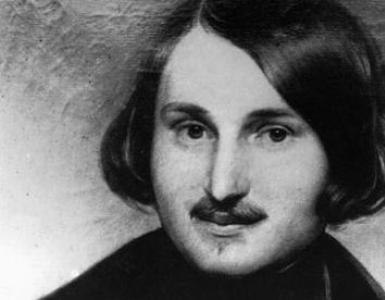Qual è la differenza tra febbre tifoide e febbre paratifoide? Tifo. Febbri paratifoidi A e B. Farmaci di base
TIFO (TYPHUS ABDOMINALIS), PARATYPHI A e B (PARATYPHI A et B)
La febbre tifoide (febbre tifoide - inglese, Abdominaltyphus - tedesco, addominale fievre - francese) è una malattia infettiva acuta causata dalla salmonella (Salmonella typhi), caratterizzata da febbre, sintomi di intossicazione generale, batteriemia, ingrossamento del fegato e della milza, enterite e caratteristiche morfologiche peculiari modifica il sistema linfatico intestinale.
Eziologia. L'agente eziologico della febbre tifoide (S. typhi) appartiene alla famiglia delle Enterobacteriaceae, genere Salmonella, specie Salmonella enterica, sottospecie enterica, sierotipo typhi e non è morfologicamente diverso dalle altre salmonelle. Si tratta di un bastoncino gram-negativo, mobile, con flagelli peritrichi, non forma spore o capsule e cresce bene sui normali terreni nutritivi. Biochimicamente si differenzia dalle altre salmonelle per la fermentazione del glucosio senza formazione di gas e per il rilascio ritardato di idrogeno solforato. La struttura antigenica di S. typhi è caratterizzata dalla presenza del complesso somatico O (9, 12, Vi) e dell'antigene flagellare H (d). A seconda della quantità e della posizione dell'antigene Vi, si distinguono 3 tipi di colture:
1) La forma V contiene l'antigene Vi che copre il complesso O; le colonie di tali colture sono opache e non sono agglutinate dal siero O;
2) La forma W non contiene l'antigene Vi, le colonie sono trasparenti, la coltura è ben agglutinata dal siero O;
3) La forma VW ha una disposizione annidata dell'antigene Vi ed è agglutinata dai sieri O e Vi.
Gli agenti causali della febbre tifoide sono suddivisi in 78 fagi stabili in base alla loro sensibilità ai batteriofagi tipici. La tipizzazione dei fagi fornisce un indicatore utile per stabilire una relazione epidemiologica tra le malattie e identificare la fonte dell'infezione. I batteri del tifo sono capaci di trasformazione L, che può essere il risultato dell'adattamento evolutivo dell'agente patogeno alla sopravvivenza nelle condizioni di un organismo immunitario. S. typhi è moderatamente stabile nell'ambiente esterno - nel suolo e nell'acqua può persistere fino a 1-5 mesi, nelle feci - fino a 25 giorni, sulla biancheria - fino a 2 settimane, sui prodotti alimentari - da diversi giorni a settimane, soprattutto per lungo tempo - nel latte, nella carne macinata, nelle insalate di verdure, dove a temperature superiori a 18°C riescono a riprodursi. Muoiono rapidamente se riscaldati. I disinfettanti (lisolo, cloramina, fenolo, sublimato) in concentrazioni normali uccidono l'agente patogeno in pochi minuti.
Epidemiologia. La febbre tifoide si riferisce alle antroponosi intestinali. L’unica fonte e serbatoio di infezione è l’uomo. La fonte dell'infezione è molto spesso batteri cronici portatori dell'agente eziologico della febbre tifoide, che, pur rimanendo praticamente sani, secernono salmonella per lungo tempo (anni e persino decenni). Anche le persone con forme lievi e atipiche della malattia rappresentano un pericolo, poiché non sempre vengono isolate in modo tempestivo, visitano luoghi pubblici e continuano a svolgere compiti ufficiali, anche presso le strutture di approvvigionamento di cibo e acqua.
Il meccanismo di trasmissione degli agenti patogeni è fecale-orale, cioè. Le persone si infettano bevendo acqua o cibo contaminati. La trasmissione da contatto e domestica di S. typhi è raramente osservata, soprattutto tra i bambini. Le epidemie idriche si verificano quando le fonti d'acqua sono contaminate da acque reflue, malfunzionamento tecnico dell'approvvigionamento idrico, sistemi e strutture fognarie, nonché a causa della violazione del regime di purificazione dell'acqua. Il pericolo di contaminazione alimentare è che in alcuni prodotti (latte, salumi) la salmonella tifoidea può persistere e addirittura moltiplicarsi. Il rischio di sviluppare la malattia in questi casi aumenta a causa della grande dose infettiva dell'agente patogeno.
Suscettibilità persone alla febbre tifoide è diversa, nonostante il fatto che l'agente patogeno abbia patogenicità obbligata e si sia evolutivamente adattato al parassitismo nel corpo umano. L'immunità è solitamente dovuta alla presenza di un'immunità specifica come risultato di una precedente malattia, immunizzazione domestica o vaccinazione. Con un'infezione di massa nei focolai epidemici, fino al 40-50% delle persone può ammalarsi.
La malattia si verifica in tutte le zone climatiche e parti del mondo. Tuttavia, è più comune nei paesi con climi caldi e bassi livelli di servizi sanitari e comunali per la popolazione.
Patogenesi. Sviluppato nel 1924-1934. C. Ashar e V. Laverne, la teoria delle fasi della patogenesi della febbre tifoide è stata generalmente conservata fino ai giorni nostri. Sulla base di esso si distinguono i seguenti collegamenti della patogenesi: introduzione dell'agente patogeno nel corpo, sviluppo di linfoadenite, batteriemia, intossicazione, diffusione parenchimale, rilascio dell'agente patogeno dal corpo, formazione dell'immunità e ripristino dell'omeostasi. Lo schema sopra riportato è condizionato, poiché è stato dimostrato sperimentalmente che, ad esempio, la penetrazione degli agenti patogeni nel sangue avviene già entro le prime due fasi. Di conseguenza, è più corretto parlare di legami interdipendenti e spesso coincidenti nella patogenesi della febbre tifoide.
Perché si manifesti la malattia, una certa dose infettiva di microbi patogeni deve entrare nel tratto gastrointestinale. In studi su volontari, autori americani [Nornick R.V.] hanno scoperto che varia da 10 milioni a 1 miliardo di cellule microbiche. L'introduzione dell'agente patogeno avviene nell'intestino tenue, dal lume del quale la salmonella penetra nei follicoli solitari e nelle placche di Peyer, causando la linfangite. I microbi entrano quindi nei linfonodi mesenterici, dove si moltiplicano e, sfondando la barriera linfatica, entrano nel sangue attraverso il dotto toracico. Si verifica la batteriemia, che coincide con i primi segni clinici della febbre tifoide. Come risultato dell'effetto battericida del sangue, alcuni microbi muoiono rilasciando endotossina. Lo stesso processo avviene nei linfonodi. L'endotossina circolante nel sangue provoca intossicazione del corpo di varia intensità.
L'endotossina ha un pronunciato effetto neurotropico con danno tossico ai centri nervosi e lo sviluppo di processi di inibizione in essi. Clinicamente, questo è caratterizzato da encefalopatia infettiva-tossica, che si manifesta in una sorta di ritardo dei pazienti, coscienza annebbiata. Nei casi più gravi della malattia, è più pronunciato e viene chiamato stato tifoide (status typhosus). L'endotossina agisce anche sulle terminazioni nervose simpatiche del nervo splancnico (nel sito di rilascio) e sui gangli autonomi, il che porta a disturbi trofici e vascolari nella mucosa e nelle formazioni linfatiche dell'intestino tenue. Di conseguenza, si verificano ulcere intestinali, flatulenza e talvolta diarrea. Un meccanismo simile per la comparsa di lesioni ulcerative dell'intestino tenue nella febbre tifoide è supportato dai fatti della formazione di ulcere simili nella morfologia negli animali da esperimento con l'introduzione dell'endotossina tifoide nei nodi vegetativi addominali [Kazantsev A.P., Matkovsky V.S., 1985]. L'endotossina di S. typhi colpisce anche il midollo osseo, provocando leucopenia.
Il danno al miocardio causato dall'endotossina provoca alterazioni degenerative e, nei casi più gravi, miocardite tossica. Nei casi più gravi della malattia, può svilupparsi uno shock tossico-infettivo. In questo caso si verifica una violazione del tono dei vasi periferici (arteriole e sfinteri delle venule post-capillari). Si verifica una deposizione di sangue nel canale periferico e il rilascio della sua parte liquida nello spazio extravasale. Prima si sviluppa un'ipovolemia relativa e poi assoluta con una diminuzione del flusso venoso al cuore. Aumentano l’ipossia, l’acidosi metabolica e gli squilibri idrici ed elettrolitici. Il decorso e la prognosi dello shock infettivo-tossico sono in gran parte determinati dall'insufficienza cardiovascolare, dal danno ai reni ("shock renale"), ai polmoni ("shock polmonare") e al fegato. In condizioni di endotossiemia tifoide prolungata, viene attivato il sistema callicreinchinina, che può contribuire allo sviluppo di shock tossico infettivo, disturbi emodinamici, cambiamenti funzionali e morfologici negli organi interni e disturbi dell'emostasi nella febbre tifoide.
Di conseguenza, l’intossicazione da endotossine gioca un ruolo di primo piano nella patogenesi della febbre tifoide. Tuttavia, anche l’agente patogeno stesso è di grande importanza. La Salmonella tifo viene trasportata dal flusso sanguigno in tutto il corpo e si fissa in vari organi ("diffusione parenchimale da parte dei microbi"), dove viene catturata dagli elementi del sistema fagocitico mononucleare (MPS). A seconda dello stato funzionale della MFS, i microbi negli organi muoiono o causano varie lesioni focali (meningite, osteomielite, pielite, polmonite, ascessi).
Contemporaneamente alla diffusione della Salmonella, la pulizia del corpo inizia rimuovendo l'agente patogeno da vari organi escretori (reni, ghiandole digestive dell'intestino, salivari, ghiandole sudoripare, fegato).
I batteri vengono escreti più intensamente attraverso il fegato, dove la maggior parte muore, e il resto viene escreto con la bile nel lume intestinale. Alcuni di essi vengono escreti con le feci nell'ambiente esterno, altri vengono nuovamente introdotti nelle formazioni linfoidi dell'intestino tenue. L'ipotesi associata a questo fatto sulla genesi allergica della formazione di ulcere nell'intestino tenue sembra ormai improbabile, poiché la febbre tifoide non è caratterizzata da reazioni allergiche pronunciate e i cambiamenti nell'intestino possono essere spiegati dall'effetto tossico dell'endotossia sia sull'organismo nodi e terminazioni vegetative periferiche e direttamente sulle formazioni linfatiche dell'intestino.
Le reazioni protettive del corpo durante la febbre tifoide si sviluppano dall'inizio del processo infettivo. Già al 4-5° giorno di malattia si possono rilevare nel sangue anticorpi specifici legati alle IgM. Entro la 2-3a settimana della malattia, l'immunogenesi specifica raggiunge il suo massimo sviluppo (predominano gli anticorpi IgM O). Allo stesso tempo compaiono gli anticorpi IgG, il cui titolo successivamente aumenta e gli anticorpi IgM diminuiscono. La formazione dell'immunità cellulare è indotta dagli antigeni tifoidi della Salmonella in misura minore rispetto all'immunità umorale, che è una conseguenza di una profonda carenza nel pool generale di cellule T e cellule T helper, nonché di una moderata diminuzione delle cellule T soppressori.
Il decorso ciclico della febbre tifoide può manifestarsi in cinque periodi di cambiamenti patogenetici nell'intestino tenue; talvolta viene colpito anche l'intestino crasso. Il primo periodo (1a settimana di malattia) è caratterizzato da un significativo rigonfiamento dei follicoli linfatici di gruppo; la seconda (2a settimana) è accompagnata dalla necrosi di queste formazioni. Nel terzo periodo le masse necrotiche vengono rigettate e si formano ulcere. Il quarto (3-4 settimane) è chiamato il periodo delle ulcere pulite. Nel quinto periodo (5-6 settimane) le ulcere guariscono. Se trattati con antibiotici, possono svilupparsi cambiamenti patogenetici nell'intestino sullo sfondo della normalizzazione della temperatura corporea.
L'immunità post-infettiva nella febbre tifoide è strettamente specifica e può persistere a lungo (15-20 anni). Tuttavia, attualmente ci sono osservazioni di malattie ripetute di febbre tifoide dopo periodi di tempo relativamente brevi (1,5-2 anni), che sono spesso associate a compromissione dell'immunogenesi a causa della terapia antibiotica.
Sintomi e decorso. Classificazione clinica la febbre tifoide implica la sua divisione in base alle forme cliniche: tipica, atipica (abortiva, cancellata); grado di gravità: lieve, moderatamente grave, grave; la natura del corso è ciclica, ricorrente; presenza di complicazioni: semplice, complicato.
Periodo di incubazione dura molto spesso 9-14 giorni (minimo - 7 giorni, massimo - 25 giorni), che dipende dal numero di microbi che sono entrati nel corpo. Quando i pazienti vengono infettati da una dose elevata dell’agente patogeno (durante le epidemie alimentari), il periodo di incubazione è generalmente breve e la malattia è più grave rispetto all’infezione trasmessa dall’acqua.
Nel corso della malattia si distinguono i seguenti periodi: 1) iniziale; 2) l'altezza della malattia; 3) estinzione delle principali manifestazioni cliniche; 4) recupero. Nei casi tipici di febbre tifoide, la malattia inizia gradualmente e talvolta è persino difficile determinare il giorno della sua insorgenza. I pazienti sviluppano grave debolezza generale, affaticamento, adinamia, cefalea moderata e possono avere lievi brividi. Ogni giorno questi fenomeni si intensificano, la temperatura corporea aumenta e entro il 4-7o giorno di malattia raggiunge il suo massimo. L'intossicazione aumenta, il mal di testa e la debolezza si intensificano, l'appetito diminuisce o scompare, il sonno è disturbato (sonnolenza durante il giorno, insonnia notturna). Le feci vengono solitamente trattenute e appare flatulenza. Entro il 7-9° giorno la malattia raggiunge il pieno sviluppo.
Quando si esamina un paziente nel periodo iniziale della malattia, i sintomi di intossicazione generale si rivelano principalmente senza chiari segni di danno d'organo. Si osserva che i pazienti sono letargici, sono inattivi, preferiscono sdraiarsi con gli occhi chiusi e non rispondono alle domande immediatamente, a monosillabi. Il viso è pallido, meno spesso leggermente iperemico, di solito non si verificano congiuntivite ed eruzione erpetica. La pelle è secca, calda. In alcuni casi è possibile l'iperemia della mucosa della faringe. I linfonodi periferici, di regola, non sono ingranditi, sebbene alcuni pazienti avvertano ingrossamento e sensibilità dei linfonodi cervicali e ascellari posteriori. È caratteristica una relativa bradicardia; alcuni pazienti presentano dicrotia del polso, toni cardiaci ovattati (o solo il primo suono all'apice). La pressione sanguigna diminuisce.
Nei polmoni si sentono rantoli secchi sparsi, che sono considerati una manifestazione di una specifica bronchite tifoide. La polmonite viene rilevata in rari casi durante questo periodo. La lingua è solitamente secca, ricoperta da un rivestimento bruno-grigiastro, ispessita (ci sono segni di denti lungo i bordi), la punta e i bordi della lingua sono privi di placca. L'addome è moderatamente disteso.
A volte si osserva un accorciamento del suono della percussione nella regione iliaca destra (sintomo di Padalka). Alla palpazione si determina un ruvido brontolio del cieco e una maggiore sensibilità al dolore. Dal 3 al 5 giorno di malattia, la milza si ingrandisce e entro la fine della 1a settimana si può rilevare un ingrossamento del fegato. A volte la febbre tifoide inizia sotto forma di gastroenterite acuta o enterite senza grave intossicazione generale, quando nei primi giorni compaiono nausea, vomito, feci molli senza impurità patologiche, dolore addominale diffuso e quindi compaiono i sintomi caratteristici della malattia.
Entro il 7-8o giorno della malattia inizia un periodo di altezza, in cui compaiono una serie di segni caratteristici che facilitano la diagnosi clinica. Un aumento significativo dell'intossicazione si manifesta in una forte letargia dei pazienti, confusione di coscienza (encefalopatia infettiva-tossica).
Sulla pelle appare un caratteristico esantema roseola. Di solito gli elementi dell'eruzione cutanea sono pochi e sono localizzati sulla pelle della parte superiore dell'addome e della parte inferiore del torace. Le roseole sono monomorfe con confini netti, leggermente rialzati sopra il livello della pelle (roseola elevata). Gli elementi esistono da alcune ore a 3-5 giorni. Al posto della roseola rimane una pigmentazione appena percettibile. Durante il periodo febbrile si può osservare la comparsa di roseola fresca. Nelle forme gravi della malattia è possibile l'impregnazione emorragica degli elementi eruzionistici, che è un segno prognostico sfavorevole. Permangono bradicardia relativa e dicrotia del polso e la pressione sanguigna diminuisce ancora di più. I suoni cardiaci diventano ovattati. Circa 1/3 dei pazienti sviluppa distrofia miocardica e in alcuni casi può verificarsi una miocardite tossica specifica. Durante questo periodo, la polmonite può svilupparsi sullo sfondo della bronchite. Può essere causato sia dall'agente patogeno stesso che dalla flora secondaria ad essa collegata, molto spesso coccica. I cambiamenti negli organi digestivi diventano ancora più pronunciati. La lingua è secca, screpolata, con segni di denti, ricoperta da un denso rivestimento marrone sporco o marrone (lingua fuliginosa), i bordi e la punta della lingua sono privi di placca. L'addome è significativamente disteso, alcuni pazienti hanno feci ritardate e la maggior parte presenta diarrea (feci enteritiche). Il brontolio e il dolore alla palpazione nell'area ileopecale, così come il sintomo di Padalka, sono identificati più chiaramente. Durante questo periodo il fegato e la milza sono sempre ingrossati.
Durante il periodo di estinzione delle principali manifestazioni cliniche, la temperatura corporea diminuisce litico per poi ritornare alla normalità. I sintomi di intossicazione generale e mal di testa diminuiscono e successivamente scompaiono. Appare l'appetito, la lingua si schiarisce, le dimensioni del fegato e della milza diminuiscono.
Il periodo di convalescenza inizia dopo che la temperatura corporea si è normalizzata e dura 2-3 settimane, a seconda della gravità della malattia. Di norma, in questo momento persistono un aumento dell'affaticamento e della labilità vascolare.
Oltre alle forme cliniche tipiche, si possono osservare forme atipiche di febbre tifoide. Questi includono forme cliniche abortive e cancellate. Le forme abortive della malattia sono caratterizzate dall'insorgenza e dallo sviluppo di segni più o meno caratteristici della malattia, ma con un rapido (dopo 5-7 giorni, talvolta dopo 2-3 giorni), spesso critico, diminuzione della temperatura, scomparsa della sintomi e transizione alla fase di recupero. Le forme cancellate includono casi di febbre tifoide con febbre di basso grado a breve termine, lievi sintomi di intossicazione e assenza di molti segni caratteristici. La temperatura corporea durante il decorso della malattia non supera i 38°C, l'intossicazione è lieve, non sono presenti bradicardia, flatulenza e nessuna eruzione cutanea.
Secondo le idee consolidate, l'emogramma della febbre tifoide è caratterizzato da leucocitosi moderata a breve termine, nei primi 2-3 giorni, che viene sostituita da leucopenia con uno spostamento della formula leucocitaria a sinistra, an- o ipoeosinofilia e linfocitosi relativa. La VES è spesso moderatamente aumentata. La leucocitosi di solito non viene rilevata nei primi giorni.
Attualmente, il quadro clinico della febbre tifoide è cambiato in modo significativo, il che è in una certa misura spiegato dall'uso frequente di antibiotici e vaccinazioni preventive contro le malattie tifoidi. Sono diventate più frequenti le forme lievi di febbre tifoide, in cui i sintomi dell'intossicazione generale sono lievi e sono assenti molti sintomi del decorso classico della malattia. La febbre dura solo 5-7 giorni (a volte 2-3 giorni) anche senza l'uso di antibiotici. L'esordio acuto della malattia è più comune (nel 60-80% dei pazienti), così come l'ingrossamento dei linfonodi. Anche i casi atipici presentano difficoltà di diagnosi, ad esempio la febbre tifoide con quadro clinico di gastroenterite acuta e febbre a breve termine (1-3 giorni). Durante il periodo di convalescenza, sullo sfondo della normale temperatura corporea, possono verificarsi complicazioni sotto forma di perforazione di un'ulcera intestinale; Tali pazienti sono ricoverati negli ospedali chirurgici. Anche i risultati dei test di laboratorio sono cambiati. Pertanto, quasi la metà dei pazienti presenta normocitosi, gli eosinofili rimangono nel sangue e le reazioni sierologiche possono rimanere negative per tutta la malattia.
Paratifo A e B- malattie infettive acute causate dalla salmonella e che si manifestano come febbre tifoide.
L'agente eziologico del paratifo A è Salmonella enterica subs, enterica se-rovarparatyphi A, il paratifo B è Salmonella enterica subs, enterica serovar paratyphi B. Come i batteri tifoidi, contengono antigeni O e H, ma non hanno antigeni Vi, e hanno le stesse proprietà morfologiche, sono divisi in fagotipi. Le fonti di infezione nel paratifo A sono persone malate e portatori di batteri, mentre nel paratifo B possono essere anche animali (bovini, maiali, pollame). I disturbi patogenetici e patologici nel paratifo A e B sono gli stessi della febbre tifoide.
Le febbri paratifo A e B sono molto simili nei segni clinici e presentano alcune caratteristiche cliniche. È praticamente possibile differenziarli tra loro e dalla febbre tifoide solo batteriologicamente, isolando l'agente patogeno. Si notano solo pochi segni di febbre paratifoide che li distinguono dalla febbre tifoide.
Paratifo A. Si manifesta meno frequentemente della febbre tifoide e del paratifo B. Si presenta spesso sotto forma di malattie di moderata gravità, ma può anche causare forme gravi della malattia. Nel periodo iniziale si osservano iperemia facciale, iniezione di vasi sclerali, eruzione erpetica sulle labbra, naso che cola e tosse. L'eruzione cutanea appare precocemente, già dal 4° al 7° giorno di malattia, e può essere polimorfica (roseolosa, maculare, maculopapulare e persino petecchiale). Il metodo principale per confermare la diagnosi è batteriologico. La reazione di Widal è solitamente negativa per tutta la malattia (in alcuni casi è positiva a titoli molto bassi). Attualmente le complicazioni e le recidive si osservano un po' meno frequentemente rispetto alla febbre tifoide.
Paratifo B. Clinicamente, il paratifo B è più lieve della febbre tifoide, sebbene si verifichino anche forme gravi con complicanze settiche purulente. La malattia spesso esordisce improvvisamente con sintomi di gastroenterite acuta e solo successivamente si aggiungono sintomi simili alle manifestazioni cliniche della febbre tifoide. La curva della temperatura ha un'ampia escursione giornaliera ed è spesso ondulata. L'esantema compare al 4-6° giorno di malattia, a forma di rosa, ma più abbondante che nella febbre tifoide. La diagnosi viene confermata dall'isolamento dell'agente patogeno, ma possono essere utilizzati anche test sierologici, soprattutto quando vengono diagnosticati nel tempo.
Complicazioni. Le complicanze più pericolose della malattia tifo-paratifo (TPD) sono la perforazione delle ulcere intestinali, il sanguinamento intestinale e lo shock tossico-infettivo. Si osservano spesso polmonite e miocardite e, meno spesso, altre complicazioni: colecistocolangite, tromboflebite, meningite, parotite, artrite, pielonefrite, psicosi infettiva, danno ai nervi periferici.
La perforazione intestinale di solito si verifica nella 3a settimana della malattia, ma può verificarsi anche prima (giorni 11-13 della malattia). Durante l'assunzione di antibiotici, si sviluppa anche quando la temperatura corporea è normale e il paziente è in condizioni soddisfacenti. La perforazione è promossa da una grave flatulenza, dalla violazione del riposo a letto da parte del paziente e dalla presenza di un grave sottopeso.
I segni clinici della perforazione dell'intestino tenue sono chiaramente espressi quando si verifica in un contesto di temperatura corporea normale, mentre con grave intossicazione e febbre alta i sintomi di questa complicanza possono essere cancellati e la sua diagnosi è più difficile. I segni più costanti di perforazione e dello stadio iniziale della peritonite sono dolore addominale, tensione nei muscoli della parete addominale e aumento della respirazione. Il sintomo principale è il dolore addominale. A volte i pazienti lamentano un dolore improvviso e intenso all'addome, solitamente nelle parti inferiori a destra, ma più spesso il dolore è moderato o debole.
All'esame si nota tensione nei muscoli della parete addominale, più pronunciata nelle parti inferiori a destra. Compaiono anche sintomi di irritazione peritoneale; il movimento della parete addominale durante la respirazione è assente o limitato. Durante l'auscultazione dell'addome, non si sente il suono della peristalsi intestinale, le feci e lo scarico del gas vengono ritardati. Tuttavia, il rilevamento di rumori intestinali in un paziente non esclude la presenza di perforazione. È possibile rilevare la presenza di gas libero nella cavità addominale (una striscia di suono timpanico sopra l'ottusità epatica, una diminuzione delle dimensioni dell'ottusità epatica, la presenza di gas sotto la cupola destra del diaframma durante l'esame radiografico) . Nelle ore successive il dolore diminuisce, i segni di irritazione peritoneale diminuiscono significativamente o addirittura scompaiono, il che spesso porta alla diagnosi tardiva di questa pericolosa complicanza. Molto spesso, la perforazione si sviluppa nell'ileo terminale (ultimi 20-30 cm). Tuttavia, in alcuni casi, sono interessate le sue parti più prossimali (fino a 100 cm dall'angolo ileocecale). È necessario un intervento chirurgico d'urgenza, che dà i migliori risultati nelle prime 6 ore dopo la perforazione. Se l'operazione non viene eseguita entro questo lasso di tempo, si sviluppano segni di peritonite. La temperatura corporea aumenta, compaiono nausea e vomito, aumenta la flatulenza, la bradicardia viene sostituita dalla tachicardia. Nel sangue c'è leucocitosi neutrofila e VES accelerata. Quando la perforazione intestinale si verifica sullo sfondo di grave intossicazione e febbre alta, tutti i segni soggettivi sono debolmente espressi, quindi la comparsa anche di un leggero dolore addominale in un paziente con SMI dovrebbe attirare la massima attenzione del medico. Anche i sintomi oggettivi della perforazione sono lievi. A volte l'unica manifestazione della complicanza è la tensione locale dei muscoli della parete addominale nella regione iliaca destra. Nelle forme lievi di febbre tifoide e paratifo, talvolta si osserva una perforazione intestinale al di fuori dell'ospedale di malattie infettive e i pazienti vengono ricoverati nel reparto chirurgico con sospetto “addome acuto”.
Il sanguinamento intestinale avviene contemporaneamente alla perforazione intestinale. Se trattato con antibiotici, può manifestarsi non solo durante il periodo febbrile, ma anche dal 3° al 5° giorno della normale temperatura corporea. Con il sanguinamento intestinale al culmine dell'intossicazione, si verifica un forte calo a breve termine della temperatura corporea, chiarezza di coscienza, riduzione del mal di testa e miglioramento del benessere del paziente. Quindi il paziente diventa pallido, i tratti del viso diventano più nitidi, il sudore freddo appare sulla fronte, il polso accelera e la pressione sanguigna diminuisce. Con un sanguinamento massiccio, può svilupparsi il collasso. La mescolanza di sangue nelle feci ("feci catramose") con sanguinamento minore si nota solo 8-12 ore dopo la sua insorgenza. Con sanguinamento massiccio, dopo 1,5-2 ore le feci sono quasi sangue puro. Nel sangue periferico diminuisce il contenuto di emoglobina, globuli rossi ed ematocrito e aumenta il numero di reticolociti.
Shock infettivo-tossico(ITSH) - una complicanza relativamente rara, ma estremamente grave della febbre tifoide e della febbre paratifoide - si sviluppa durante il culmine della malattia (a 2-3 settimane). L’insorgenza dell’ITS può essere facilitata dalla somministrazione di dosi maggiori di antibiotici battericidi senza una terapia disintossicante razionale. Con la ITS le condizioni del paziente peggiorano drasticamente, la letargia caratteristica della febbre tifoide aumenta in modo significativo, fino alla prostrazione. La temperatura corporea scende bruscamente a livelli normali o subnormali. La pelle diventa ancora più chiara, con una tinta grigiastra. Acrocianosi, occhi infossati. Tachicardia grave, riempimento debole, polso filiforme. La pressione sanguigna diminuisce, inizialmente prevalentemente diastolica. La diuresi diminuisce, fino all'anuria. A causa dell'ipotensione arteriosa caratteristica della maggior parte dei pazienti con febbre tifoide grave, diagnosticare la ITS e determinarne il grado in base alla pressione sanguigna e alla frequenza cardiaca è difficile. È necessario tenere conto della gravità della malattia, dei dati di follow-up e di un complesso di altri dati clinici e di laboratorio caratteristici dello shock.
Ricadite. In alcuni pazienti, dopo la normalizzazione della temperatura corporea, si verificano ricadute della malattia, ad es. ricompaiono i sintomi clinici caratteristici della febbre tifoide. Si considera recidiva la ripresa dei sintomi clinici dopo un periodo di apiressia (almeno due giorni), quando la temperatura corporea risale a livelli febbrili e persiste per almeno 48 ore. Clinicamente la recidiva è sempre più lieve della malattia di base. . Se gli antibiotici vengono interrotti precocemente, il tasso di recidiva può raggiungere il 20-30%. L'uso di antibiotici porta a ricadute successive. Se le ricadute precedenti si sviluppavano, di regola, il 10-14esimo giorno di apiressia, ora ci sono casi in cui la recidiva si verifica 1 mese o più dopo la normalizzazione della temperatura corporea. Segni di guarigione incompleta, che indicano la possibilità di una ricaduta, sono febbricola prolungata dopo una diminuzione della temperatura corporea, ingrossamento persistente del fegato e della milza, enosinofilia persistente e adinamia. Tuttavia, non è sempre possibile prevedere la possibilità di ricadute, perché in alcuni casi queste si verificano in pieno benessere. Inoltre, anche un decorso lieve della malattia non garantisce contro le ricadute. Il verificarsi di ricadute è facilitato da malattie concomitanti (colecistite cronica, infestazioni da elminti, ecc.), esaurimento e trattamento antibatterico inadeguato. Il ruolo principale nella genesi delle recidive è giocato dall'inferiorità dell'immunità cellulare e umorale, che può insorgere a causa dell'influenza di antibiotici, glucocorticoidi, dell'agente patogeno stesso e delle sue tossine, come dimostrato da una forte diminuzione della frequenza di ricadute quando si utilizzano farmaci che stimolano l’immunogenesi (vaccini, immunomodulatori).
Portamento batterico cronico. Nel 3-5% di coloro che hanno avuto la febbre tifoide, indipendentemente dalla gravità della malattia, si sviluppa un portatore batterico cronico che dura per molti anni, a volte per tutta la vita.
L'essenza del trasporto batterico cronico da un punto di vista moderno è lo sviluppo della tolleranza immunologica del corpo umano ai singoli antigeni dei batteri tifoidi, vale a dire l'antigene O. L'emergere della tolleranza immunologica è associata a una violazione della normale cooperazione delle cellule immunocompetenti: linfociti T, B, macrofagi. Un posto importante nella formazione del trasporto batterico a lungo termine è dato alla capacità dell'agente patogeno di parassitismo intracellulare nei macrofagi e alla formazione di forme L. L'insorgenza di un portatore batterico cronico è facilitata dalla presenza di complicanze e patologie concomitanti quali pielite, pielonefrite, colecistocolangite ed infestazioni elmintiche.
Diagnosi e diagnosi differenziale. La diagnosi di febbre tifoide, soprattutto nel periodo iniziale, presenta notevoli difficoltà. La febbre tifoide può essere sospettata all'esordio della malattia sulla base delle premesse epidemiologiche, della presenza di febbre e di intossicazione senza danni organici significativi. Tuttavia, fenomeni come mal di testa, malessere, debolezza, aumento della fatica, disturbi del sonno, febbre, pallore della pelle, bronchite diffusa, bradicardia relativa, alterazioni della lingua, gonfiore, sintomo positivo di Papalka, brontolio e dolore all'ileo destro regione consentono di effettuare una diagnosi clinica abbastanza precocemente. Se sono presenti i sintomi caratteristici della febbre tifoide (fegato ingrossato, milza, roseola), la diagnosi clinica diventa più facile.
Grandi difficoltà diagnostiche possono essere create dalla somministrazione prematura (prima che la diagnosi sia chiarita) di cloramfenicolo, poiché ciò porta alla rimozione dell'intossicazione, alla diminuzione della temperatura corporea, alla scomparsa dei microbi dal sangue e alla soppressione delle reazioni immunitarie. Pertanto, in futuro, può essere difficile non solo clinicamente, ma anche in laboratorio confermare la diagnosi di febbre tifoide.
Tra i metodi di laboratorio, l'analisi batteriologica del sangue è di particolare importanza. perché dà risultati positivi già nei primi giorni di malattia. Il sangue viene inoculato su terreni nutritivi contenenti bile - brodo biliare o mezzo Rapoport e, in loro assenza, su acqua distillata sterile (metodo Klodnitsky) o acqua di rubinetto sterile (metodo Samsonov). L'utilizzo del metodo immunofluorescente dopo aver coltivato la coltura per 10-12 ore consente di ottenere un risultato preliminare, che deve essere confermato con il metodo classico dell'emocoltura. Dato che l'intensità della batteriemia cambia nel corso della malattia, quando si eseguono emocolture si consiglia di inoculare 10 ml di sangue nella 1a settimana di malattia, 15 nella 2a settimana, 20 ml nella 3a e più tardi. La quantità di mezzo nutritivo dovrebbe essere 10 volte il volume del sangue. Per diagnosticare e monitorare il recupero, vengono effettuati esami batteriologici delle feci e delle urine e 7-10 giorni prima della dimissione viene eseguita la coltura del contenuto duodenale (porzioni B e C). Per isolare l'agente patogeno è possibile inoculare materiale proveniente dalla roseola e dal midollo osseo. Tuttavia, questi metodi non presentano un vantaggio significativo rispetto al metodo dell’emocoltura e sono tecnicamente più complessi.
I metodi sierologici per confermare la febbre tifoide sono meno importanti per la diagnosi rispetto al metodo batteriologico, poiché i risultati ottenuti utilizzando i test Widal e RIGA sono retrospettivi. È obbligatorio stadiare queste reazioni nel tempo (titolo diagnostico 1:200 e superiore). Inoltre, la RIGA con cisteina viene utilizzata per distinguere tra trasporto batterico cronico e transitorio.
Negli ultimi anni sono stati proposti nuovi metodi immunologici altamente sensibili e specifici per la rilevazione di anticorpi e antigeni dei microbi del tifo: test di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), reazione di controimmunoelettroforesi (CIEF), test radioimmunologico (RIA), reazione di coagglutinazione ( RCA), reazione di emoagglutinazione dell'aggregato O (O-AHA). La sensibilità di questi metodi è del 90-95%, il che consente loro di essere utilizzati per la diagnosi precoce. La febbre tifoide deve essere differenziata dalle malattie respiratorie acute, dalla polmonite, dalla malaria, dalla leptospirosi, dalla febbre Q, dalla brucellosi e da altre malattie che si manifestano con temperatura corporea elevata.
Le malattie respiratorie acute e la polmonite, come la febbre tifoide, si manifestano con febbre, sintomi di intossicazione generale e tosse. Con la febbre tifoide non ci sono segni di danno al tratto respiratorio superiore (rinite, faringite, laringite), non ci sono manifestazioni di polmonite, si nota solo la bronchite tifoide. La febbre e i sintomi di intossicazione generale da febbre tifoide sono più pronunciati e prolungati. Nelle malattie respiratorie acute e nella polmonite non vi è gonfiore o segni di mesadenite.
La malaria nel periodo iniziale in alcuni pazienti si manifesta senza parossismi tipici con una curva della temperatura atipica, simile alla febbre nella febbre tifoide. A differenza della febbre tifoide, i pazienti affetti da malaria avvertono ripetuti brividi e sudorazione profusa, pronunciate fluttuazioni della temperatura corporea (più di 1°C), spesso compare un'eruzione erpetica e vengono rilevati precocemente un significativo ingrossamento della milza e il suo dolore alla palpazione. . Non c'è gonfiore o dolorabilità nella regione iliaca destra.
Leptospirosi si differenzia dalla febbre tifoide per la sua insorgenza improvvisa, forte dolore ai muscoli del polpaccio che rende difficile il movimento, iperemia del viso e del collo, iniezione dei vasi sclerali, ingrossamento precoce del fegato e della milza, comparsa frequente di ittero e sindrome emorragica da il 3-4o giorno di malattia, leucocitosi neutrofila, aumento significativo della VES e cambiamenti pronunciati nelle urine (proteine, leucociti, cilindri).
La febbre Q nel periodo iniziale presenta una serie di sintomi simili alla febbre tifoide: febbre, intossicazione e assenza di danni organici pronunciati. Tuttavia, la febbre Q inizia in modo acuto, con forti brividi, forte sudorazione, dolore ai bulbi oculari quando si muovono gli occhi, rossore al viso e iniezione di vasi sclerali. La polmonite o la bronchite grave si verificano spesso nelle fasi iniziali e dal 3-4° giorno il fegato si ingrandisce.
Brucellosi, che si manifesta nelle forme acute, si differenzia dalla febbre tifoide per buona salute quando la temperatura corporea sale a 39-40 ° C, sudorazione pronunciata, assenza di bronchite, gonfiore e dolore alla regione iliaca destra.
Trattamento. Il ricovero ospedaliero dei pazienti affetti da tutte le forme di febbre tifoide, paratifo A e B è obbligatorio dal punto di vista clinico ed epidemiologico. Il trattamento deve essere completo e comprendere un regime, una dieta, agenti etiotropici e patogenetici, procedure fisioterapeutiche e terapia fisica.
Il regime nel periodo acuto della malattia e fino al decimo giorno di temperatura corporea normale è il riposo a letto e, in caso di complicazioni, il riposo a letto rigoroso. Sono necessari riposo, igiene orale e cutanea, prevenzione della formazione di crepe nella lingua, sviluppo di stomatiti e piaghe da decubito. L’espansione del regime viene effettuata con molta attenzione, sotto attento monitoraggio delle condizioni generali del paziente e dei dati provenienti dagli organi addominali. È necessario avvertire il paziente di non compiere movimenti improvvisi, sollevare oggetti pesanti o sforzarsi durante i movimenti intestinali.
La nutrizione dei pazienti comporta una forte limitazione degli irritanti meccanici e chimici della mucosa del tratto gastrointestinale, l'esclusione di cibi e piatti che migliorano i processi di fermentazione e putrefazione nell'intestino. Per le forme non complicate della malattia, viene prescritta la tabella n. 2, che viene sostituita con la dieta n. 15 5-7 giorni prima della dimissione. È obbligatorio assumere un complesso di vitamine (acido ascorbico - fino a 900 mg/giorno, vitamine B e 62 9 mg ciascuna, PP - 60 mg, P - 300 mg/giorno).
La terapia etiotropica occupa un posto di primo piano nel complesso terapeutico ed è prescritta a tutti i pazienti con febbre tifoide, paratifo A e B. L'uso di un antibiotico specifico (farmaco chemio) è consigliabile se almeno l'80% dei ceppi degli agenti patogeni della febbre tifoide circolanti nella zona ne sono sensibili. Il corso della terapia etiotropica deve continuare fino al 10° giorno di temperatura corporea normale, indipendentemente dalla gravità della malattia e dalla velocità del recupero clinico del paziente. Se entro i successivi 4-5 giorni dall’inizio del trattamento etiotropico non si osserva alcun cambiamento significativo nelle condizioni del paziente, il farmaco utilizzato deve essere sospeso e deve essere prescritto un altro farmaco. Nel trattamento delle recidive, viene effettuato un secondo ciclo di terapia antibatterica con un cambiamento nell'antibiotico (chemioterapia). In questo caso è necessario tenere conto dell'antibiogramma dell'autocoltura se è stata isolata dal paziente.
Il principale farmaco antimicrobico nel trattamento di pazienti affetti da malattie tifo-paratifo è il cloramfenicolo (cloramfenicolo). Viene prescritto agli adulti per via orale 20-30 minuti prima dei pasti alla dose giornaliera di 50 mg/kg, suddivisa in 4 dosi. Dopo la normalizzazione della temperatura corporea, la dose giornaliera può essere ridotta a 30 mg/kg di peso corporeo. Nei casi in cui la somministrazione orale è impossibile (nausea, vomito, dolore epigastrico), il farmaco viene prescritto per via parenterale (per via endovenosa, intramuscolare) sotto forma di cloramfenicolo succinato 3 g al giorno o in supposte. La levomicetina è controindicata in caso di inibizione dell'ematopoiesi, psoriasi, eczema o intolleranza al farmaco. Quando si utilizza cloramfenicolo, sono possibili leucopenia, agranulocitosi, trombocitopenia, anemia ipo o aplastica.
Molto spesso, invece del cloramfenicolo, per trattare la febbre tifoide e la febbre paratifo viene utilizzata l'ampicillina. Il farmaco viene prescritto agli adulti per via orale dopo i pasti (ampicillina triidrato) 1 - 1,5 g 4-6 volte al giorno o per via parenterale (sale sodico) in una dose giornaliera di 6 g L'efficacia dell'ampicillina è inferiore a quella del cloramfenicolo. La controindicazione all'uso è l'intolleranza ai farmaci penicillinici.
L'efficacia della combinazione di trimetoprim (80 mg in compresse) e sulfametossazolo (400 mg in compresse) - biseptolo, bactrim, septrin, co-trimossazolo - è stata stabilita per la febbre tifoide. I farmaci vengono prescritti agli adulti per via orale, 2 compresse 2 volte al giorno dopo i pasti (nelle forme gravi, 3 compresse 2 volte al giorno) per 3-4 settimane. Simile è il farmaco domestico solfato (250 mg di sulfaminometossina e 100 mg di trimetoprim), assunto il 1o giorno, 2 compresse ogni 12 ore, quindi 1 compressa 2 volte al giorno.
Nei casi di trattamento delle forme gravi, complicate e combinate di febbre tifoide, è stata dimostrata l'efficacia della somministrazione parenterale di una combinazione di ampicillina (6-8 g/die) e gentamicina (240 mg/die).
Negli ultimi anni sono apparse informazioni che indicano la comparsa in alcune regioni di Salmonella tifo resistenza al cloramfenicolo, all'ampicillina e al trimetaprim-sulfametossazolo, a causa della presenza di un fattore R trasportabile. Allo stesso tempo, queste colture si sono rivelate sensibili ai fluorochinoloni: ciprofloxacina, ofloxacina e pefloxacina. La ciprofloxacina viene prescritta per via orale alla dose di 500-750 mg (2-3 compresse) 2 volte al giorno dopo i pasti. Per le infusioni endovenose (nei casi gravi e/o nell'impossibilità di somministrazione orale), il farmaco viene somministrato per 60-120 minuti, 2 volte al giorno, 200-400 mg. L'ofloxacina viene somministrata alla dose di 400-800 mg per via orale 2 volte al giorno. I fluorochinoloni dovrebbero essere privilegiati nel trattamento dei casi importati di febbre tifoide e paratifoide (Tagikistan, Afghanistan, Sud-Est asiatico, America Latina, Africa).
La terapia patogenetica dei pazienti con febbre tifoide dovrebbe promuovere la disintossicazione, la correzione dell'omeostasi, aumentare la resistenza del corpo e stimolare i processi riparativi, prevenire e curare le complicanze. Importante è la lotta contro l'ipossia, la correzione dell'equilibrio idrico-elettrolitico e lo stato acido-base. Per la disintossicazione nei casi lievi, bere molti liquidi (fino a 2,5-3 l/giorno), assumere enterosorbenti 2 ore dopo i pasti (enterodesi - 15 g/giorno, polyphepan - 75 g/giorno, assorbenti carboniosi - 90 g/giorno) e inalazione di ossigeno attraverso cateteri nasali per 45-60 minuti 3-4 volte al giorno. In caso di febbre tifoide moderata, la disintossicazione è favorita dalla somministrazione parenterale di soluzioni isotoniche di glucosio-saline fino a 1,2-1,6 l/die (soluzione di glucosio al 5%, lattasolo, quartasolo, acesolo, hlosol), soluzione di albumina al 5-10% a 250 -100 ml, così come l'uso di benzonale di sodio 0,1 g per via orale 3 volte al giorno (a causa della stimolazione degli enzimi epatici microsomiali). Nei casi di malattia grave, il trattamento dei pazienti deve essere effettuato in unità di terapia intensiva (blocchi, reparti), dove viene effettuato un monitoraggio intensivo con correzione degli indicatori di omeostasi. Il numero totale di infusioni è determinato dal bilancio idrico giornaliero, tenendo conto delle perdite attraverso la sudorazione. Le soluzioni colloidali vengono utilizzate dopo l'introduzione di soluzioni cristalloidi in un rapporto non superiore a 1:3. Quando l'intossicazione aumenta, si consiglia di prescrivere prednisolone (45-60 mg/giorno) per via orale in un breve ciclo (5-7 giorni), condurre un ciclo di baroterapia con ossigeno (0,8-1,0 ata per 60 minuti al giorno per 1-2 sessioni ; nel corso 5-8 sessioni). Nei casi in cui la terapia non produce risultati positivi entro 3 giorni, per infezioni miste e recidive della malattia, l'emoassorbimento è indicato nel complesso delle misure terapeutiche. Per ottenere un effetto positivo sono sufficienti 1-2 operazioni. Se ci sono controindicazioni all'emosorbimento (minaccia di perforazione, sanguinamento), è necessario eseguire un'operazione più delicata: l'assorbimento del plasma. Trasfusioni ripetute di sangue rhesus compatibile dello stesso gruppo appena preparato (250 ml ogni 2-3 giorni) hanno un effetto clinico positivo in caso di natura grave e protratta della malattia.
Per prevenire le recidive, la soluzione più efficace è stata la combinazione di terapia antibiotica seguita dall'uso di un vaccino (monovaccino contro il tifo, divaccino contro il tifo-paratifo B, antigene Vi purificato dei batteri del tifo). I preparati vaccinali vengono somministrati per via sottocutanea, intradermica o mediante elettroforesi, mentre viene effettuata l'irradiazione ultravioletta generale. Quando si utilizza il vaccino, la frequenza delle ricadute diminuisce di 3-4 volte e la formazione di portatori batterici cronici di 2 volte.
A tutti i pazienti con febbre tifoide e paratifo vengono prescritti stimolanti della leucopoiesi e dei processi riparativi (metiluracile 0,5 go pentossile 0,3 g 3 volte al giorno dopo i pasti), angioprotettori (ascorutina 1 compressa 3 volte al giorno). Durante il periodo di convalescenza, alle persone con astenia grave si consiglia di utilizzare adattageni - tintura di Eleuterococco, Zamanikha, radice di ginseng, pantocrina, Schisandra chinensis nei consueti dosaggi terapeutici.
Il trattamento dello shock infettivo-tossico consiste nella stabilizzazione dell'emodinamica, nella normalizzazione della microcircolazione, nella correzione dei disturbi metabolici, nel sistema di coagulazione, nell'equilibrio elettrolitico e nell'alleviamento dell'insufficienza renale. A questo scopo viene eseguita un'infusione di soluzioni cristalloidi (lattasolo, quartasolo, soluzione Ringer-Locke - fino a 1,5-2 l/giorno), reopoliglucina o reogluman (0,5-1 l/giorno), soluzione di albumina al 10% (200- 400 ml/die) in associazione con glucocorticoidi (fino a 10-20 mg di prednisolone per 1 kg di peso corporeo al giorno o dosi adeguate di altri farmaci di questo gruppo), una soluzione di bicarbonato di sodio al 4% (200-400 ml/die ), eparina (20 -30 mila unità il primo giorno, quindi - sotto il controllo degli indicatori di coagulazione del sangue), nonché inibitori della proteasi (contrici - 20-40 mila unità, gordox - 100-200 mila unità al giorno o loro analoghi). Se necessario, utilizzare farmaci cardiovascolari e diuretici. Tutte le attività di infusione vengono monitorate in base alle condizioni del paziente, alla pressione venosa centrale, al polso, alla pressione sanguigna, all’equilibrio acido-base, all’equilibrio dei liquidi ed elettrolitico.
In caso di sanguinamento intestinale sono necessari riposo assoluto e raffreddore allo stomaco. Nelle prime 12 ore dopo il sanguinamento, il paziente non viene nutrito (si possono somministrare solo liquidi e succhi - fino a 600 ml), successivamente - gelatina, gelatina, uova alla coque, burro. A poco a poco la dieta viene ampliata e dopo 4-5 giorni si passa alla tabella n. 2. Per arrestare l'emorragia, vengono utilizzati: somministrazione endovenosa di una soluzione al 10% di cloruro di calcio, 10 ml 2 volte al giorno, soluzione al 5% di acido epsilon-aminocaproico, 100 ml 2 volte al giorno, fibrinogeno - 0,5 g in 200 ml di solvente, soluzione di etamilato (dicinone) al 12,5% 2 ml 3 volte al giorno, per via intramuscolare _ \% soluzione di vikasol 1 ml 2 volte al giorno. In caso di sanguinamento ripetuto massiccio e grave, vengono trasfuse piccole dosi (100-150 ml) di sangue, plasma e massa piastrinica di un singolo gruppo di donatori. Se il sanguinamento non viene controllato con misure conservative, viene eseguito l'intervento chirurgico.
In caso di perforazione intestinale è necessario un intervento chirurgico d'urgenza, la cui entità (sutura delle ulcere, resezione intestinale) viene determinata dopo un'ispezione approfondita dell'intestino.
Lo sviluppo di miocardite infettiva-tossica in un paziente con febbre tifoide richiede la correzione della terapia di disintossicazione per infusione al fine di ridurre il carico sul cuore (ritiro di soluzioni colloidali, limitazione del volume di soluzioni cristalloidi in base allo stato del miocardio) . Al paziente viene prescritto un rigoroso riposo a letto, farmaci antinfiammatori, Panangin, Riboxin, citocromo C, ossigenazione iperbarica e, se vi sono segni di insufficienza cardiaca, glicosidi cardiaci.
Quando si sviluppa polmonite in pazienti con febbre tifoide, dovrebbero essere usati antibiotici che agiscono non solo sulla salmonella, ma sopprimono anche gli agenti patogeni che molto spesso causano un processo patologico nei polmoni (pneumococchi, stafilococchi) - ampiox 8-12 g/die, gentamicina - 240 mg/giorno. Il volume delle infusioni viene ridotto di 2-3 volte. Vengono prescritti anallettici, glicosidi cardiaci, farmaci mucolitici, broncodilatatori, inibitori della proteasi, inalazioni di ossigeno e procedure fisioterapeutiche.
Nei casi di psicosi infettiva, ai pazienti viene iniettata per via intramuscolare una miscela litica della seguente composizione: 1-2 ml di una soluzione al 2,5% di clorpromazina, 4 ml di una soluzione allo 0,5% di novocaina, 1 ml di una soluzione al 2% di difenidramina e 10 ml di una soluzione al 25% di solfato di magnesio. Se necessario, la somministrazione viene ripetuta dopo 6 ore ed è necessario un digiuno individuale.
Il trattamento per il trasporto batterico cronico non è stato sviluppato. Vengono utilizzati cicli di trattamento a lungo termine con ampicillina, che si consiglia di combinare con la terapia vaccinale, il trattamento di malattie concomitanti (lesioni croniche delle vie biliari e dei reni) e la prescrizione di farmaci stimolanti. La cessazione dell'escrezione batterica è temporanea e può riprendere dopo un certo tempo (fino a diversi anni).
L'esercizio terapeutico durante il riposo a letto ha lo scopo di prevenire la polmonite e la tromboflebite e successivamente di prepararsi al regime abituale.
I farmaci convalescenti vengono prescritti sullo sfondo del completo recupero clinico, della normalizzazione dei parametri di laboratorio, dopo colture negative per 3 volte di feci, urina e una singola coltura della bile, ma non prima del 21 ° giorno di temperatura corporea normale.
Previsione. Il tasso di mortalità per febbre tifoide è attualmente dello 0,1-0,3%. Tuttavia, nei casi di decorso grave e complicato (soprattutto con perforazione intestinale), la prognosi non è sempre favorevole.
Prevenzione e misure in caso di epidemia. Supervisione sanitaria dell'approvvigionamento idrico, delle imprese alimentari, della vendita di alimenti e delle reti di ristorazione pubblica. Controllo sulla pulizia, fognature e smaltimento delle acque reflue, controllo delle mosche.
Dopo la dimissione dall'ospedale, coloro che sono guariti dalla malattia sono sottoposti a osservazione dispensatoria; dopo 3 mesi viene effettuato un esame batteriologico di feci, urine e bile. Se i risultati sono negativi, l’osservazione viene interrotta. I lavoratori convalescenti delle imprese alimentari e affini sono sottoposti a sorveglianza durante tutta la loro attività lavorativa.
Prevenzione specifica nel nostro Paese viene effettuato con un vaccino contro il tifo ad assorbimento chimico (per l'immunizzazione degli adulti) e con un vaccino contro il tifo alcolico arricchito con antigene Vi (per l'immunizzazione dei bambini). I dipendenti degli ospedali e dei reparti di malattie infettive (per il trattamento delle infezioni intestinali) vengono regolarmente vaccinati; laboratori batteriologici; soggetti addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alimentari, addetti alla manutenzione delle reti e delle strutture fognarie; persone che vivono in dormitori temporanei e scarsamente attrezzati fino al completamento dei miglioramenti comunitari. Secondo le indicazioni epidemiche, le vaccinazioni vengono effettuate anche ad altri gruppi della popolazione, fino all'immunizzazione di massa. Negli ultimi anni negli Stati Uniti è stato sviluppato un vaccino orale per prevenire la febbre tifoide.
Attività durante l'epidemia si tratta di organizzare la disinfezione finale. Le persone a contatto con il paziente vengono poste sotto osservazione medica con termometria giornaliera per 21 giorni. Un esame batteriologico una tantum delle feci e delle urine viene effettuato in tutti i contatti, e nelle persone che hanno precedentemente sofferto di febbre tifoide, e anche in coloro che soffrono di malattie croniche del fegato e delle vie biliari, inoltre, uno studio della bile e sangue in RPGA con cisteina.
I bambini che studiano nelle scuole di istruzione generale e nei collegi sono ammessi in queste istituzioni in caso di trasporto batterico, ma non sono coinvolti nei lavori relativi alla preparazione, al trasporto e alla distribuzione di cibo e acqua. I bambini che frequentano gli istituti per bambini in età prescolare, se vengono rilevati portatori di batteri, non sono ammessi e vengono inviati in ospedale per esami e cure. Se il portatore batterico persiste, la decisione di ricoverare il bambino in un istituto per l'infanzia viene presa in base alle condizioni specifiche.
MALATTIE INFETTIVE
LEZIONE N. 1
TIFO E PARATIFO.
La febbre tifoide e la febbre paratifo sono chiamate malattie tifo-paratifoidi. Le malattie tifoparatifo sono malattie batteriche, generalmente di natura antroponotica, causate da batteri del genere Salmonella con meccanismo di trasmissione oro-fecale, con ciclicità ben definita, febbre, batteriemia, sintomi di intossicazione generale e danni specifici al sistema linfatico del intestino tenue.
EZIOLOGIA: La Salmonella typhi, secondo lo schema Kaufman-White, appartiene al sottogruppo sierologico D, perché ha antigeni: antigene O (antigene somatico, stabile al calore) 9,12 frazioni; Frazione d dell'antigene H (antigene flagellare) (da cui deriva il nome del sottogruppo). Gli agenti causali del tifo e del paratifo spesso contengono anche una frazione termolabile dell'antigene somatico, denominata antigene Vi (antigene di virulenza). La determinazione degli anticorpi contro questo antigene viene spesso utilizzata per decidere se una determinata persona è portatrice del batterio o meno. La Salmonella è un bastoncino mobile, gram-negativo, che cresce bene su terreni semplici: ad esempio il terreno di Ploskirev. Il terreno selettivo per la Salmonella è l'agar solfito di bismuto; tra i terreni liquidi, il terreno più utilizzato e popolare che consente la differenziazione precoce della Salmonella typhi dal bacillo paratifoide è il terreno Rapoport (ha lavorato presso il Dipartimento di Malattie Infettive del nostro Istituto, poi ha lavorato presso laboratorio batteriologico dell'Ospedale Botkin). Questo terreno contiene bile, che inibisce la crescita di altri microrganismi. Il sangue viene seminato in questo mezzo in un rapporto di 1/10. S.typhi produce torbidità quando cresce su questo terreno, mentre il bacillo paratifo produce gas. È possibile utilizzare un mezzo nutritivo meno complesso: il brodo biliare. La temperatura ottimale di crescita per la salmonella è di 37 gradi. Questi microbi sono in grado di sviluppare resistenza a molti farmaci, sono in grado di mutare (transizione in forme L) e quindi vivere per decenni nel corpo umano senza rispondere al trattamento. Le Salmonelle sono eterogenee nella loro attività biochimica: in relazione alla scomposizione dei carboidrati, si dividono in 4 tipi biochimici (indicati con lettere romane). In relazione al fago, questi microbi sono divisi in 2 tipi: fago specifico del gruppo e specifico. Questo è necessario saperlo per essere competenti in materia di epidemiologia, ad esempio quando è necessario capire chi ha infettato chi, ecc. La virulenza dei microbi del tifo e del paratifo varia entro limiti diversi: diminuisce con le malattie sporadiche e aumenta con le epidemie. La stabilità nell'ambiente esterno è relativamente buona: ad esempio si conservano perfettamente alle basse temperature e sono in grado di sopravvivere nell'acqua; possono riprodursi nei prodotti alimentari, in acqua a temperature di 18 gradi e superiori. La luce solare diretta e le alte temperature sono dannose per il microbo. L'ebollizione uccide istantaneamente il microbo; la salmonella viene mantenuta ad una temperatura di 60 gradi per 30 minuti. I disinfettanti in concentrazioni normali sono dannosi per la salmonella (cloramina, candeggina, ecc.)
CARATTERISTICHE EPIDEMIOLOGICHE DELLE MALATTIE DA TIFOPARATYPHID.
L'incidenza in Russia varia da 0,2 a 0,5 ogni 100mila abitanti; per confronto, la dissenteria è di 25 ogni 100mila abitanti. Quelli. la morbilità non è elevata. L'urgenza del problema sta nel fatto che esistono batteri patogeni cronici della febbre tifoide (chi proporrà un metodo di cura radicale riceverà un premio Nobel).
Complicazioni specifiche che si verificano ancora oggi e spesso portano alla morte (sanguinamento intestinale, perforazione di ulcere duodenali).
Meccanismo di trasmissione: oro-fecale
Vie di trasmissione:
acquatico (oggi è diventato molto meno comune)
cibo (particolarmente comune nelle città)
il contatto domestico esiste perché gli escretori di batteri contengono più di 100 milioni di corpi microbici in 1 ml di urina, sebbene 10 siano sufficienti per l'infezione. si mantengono condizioni epidemiologiche sfavorevoli.
5. Fonte dell'infezione: portatore e paziente.
6. Le grandi epidemie, fortunatamente, non sono tipiche per noi, ma in Tagikistan e Uzbekistan questo è tipico. Attualmente la situazione è cambiata tanto che la febbre tifoide è diventata leggermente meno comune in proporzione specifica rispetto alla febbre paratifoide.
7. La stagionalità, come tutte le infezioni intestinali, è estate-primavera, perché la via di trasmissione oro-fecale è più semplice: si consuma più liquido, il che porta ad una diminuzione dell'acidità del succo gastrico, con conseguente più facile penetrazione del microbo .
8. Suscettibilità pari a circa il 50%.
Il gruppo più colpito è quello dei giovani e dei bambini. L’immunità è stabile e duratura (ma in coloro che sono stati trattati con antibiotici la malattia può ripresentarsi.
Il meccanismo di trasmissione è il percorso di movimento dell'agente patogeno dalla fonte all'organismo suscettibile. Nella catena schematica quindi Risulta che ci sono 3 collegamenti: la fonte dell'infezione, le vie e i fattori di trasmissione e l'organismo suscettibile. Pertanto, ai fini della prevenzione, è necessario agire su tutti e tre i link:
1. fonte di infezione (isolamento e insegnamento alla persona come comportarsi)
2. modalità e fattori di trasmissione (adeguato regime sanitario e igienico nell'appartamento, nel reparto, ecc.)
3. microrganismo sensibile: (viene effettuato da coloro che inviano truppe in zone a maggior rischio di infezione) vaccinazione contro la febbre tifoide.
PATOGENESI DEL TIFO E DEL PARATIFO:
Quasi la patogenesi della febbre tifoide e della febbre paratifo è identica. L'agente patogeno entra attraverso la bocca. Fasi della patogenesi:
la fase di introduzione prevede l'ingresso del microbo nella bocca, dove è già possibile penetrare nelle formazioni linfatiche (poiché la salmonella è tropica per il sistema linfatico). Potrebbe esserci un'infiammazione catarrale nel tessuto tonsillare e quindi al culmine della malattia potrebbe esserci un'infiammazione necrotica ulcerativa. Successivamente, il microbo entra nello stomaco, muore parzialmente e passa nell'intestino tenue, dove ci sono tutte le condizioni favorevoli per lo sviluppo della salmonella (ambiente alcalino, ecc.)
fase di linfangite e linfoadenite: i microbi penetrano nelle formazioni linfatiche dell'intestino tenue (placche di Peyer e follicoli solitari) dove si moltiplicano. A questo punto il processo potrebbe essere interrotto. I microbi si accumulano in quantità sufficienti e entrano in modo linfogeno nella barriera successiva: i linfonodi mesenterici. Uno dei sintomi riflette la reazione dei linfonodi mesenterici: alla percussione si nota ottusità nella regione iliaca destra. Tutto ciò avviene durante il periodo di incubazione (da 10-14 giorni a 3 settimane), non sono presenti manifestazioni cliniche. Ma questo può essere rilevato, ad esempio, esaminando i contatti per l'antigene circolante di un determinato agente patogeno. Di conseguenza, si verifica l'iperplasia, la formazione di granulomi con grandi cellule tifoidi nei linfonodi e successivamente in altri organi.
La fase di penetrazione microbica nel flusso sanguigno e batteriemia. Da questo momento in poi compaiono i segni clinici della malattia. L'emocoltura è il primo metodo assolutamente affidabile per diagnosticare la malattia, perché nessun portatore o paziente con un'altra malattia avrà un microbo tifoide o paratifoide nel sangue. Nel sangue, sotto l'influenza di fattori sanguigni, il microbo muore parzialmente e rilascia endotossine. L'endotossiemia si manifesta clinicamente con sintomi di intossicazione, febbre, adinamia, depressione, sonnolenza nel sistema nervoso centrale e in condizioni gravi si sviluppa tifoso. L'effetto tossico colpisce il plesso Auerbach, il plesso solare, che si manifesta con dolore, flatulenza e può esserci stitichezza (che è più tipica) o diarrea. La stitichezza è più comune, poiché predomina il tono del sistema nervoso parasimpatico. Le endotossine colpiscono i vasi sanguigni, portando a disturbi microcircolatori, ridistribuzione del sangue e influenzano il miocardio (ipotensione, alterazioni dell'ECG, tachicardia, miocardite tossica infettiva). Contemporaneamente diffusione parenchimale - il microbo si diffonde in vari tessuti: sono colpiti il fegato (il più delle volte), la milza, il midollo osseo e la pelle. In questi organi si formano focolai secondari di infiammazione e si formano anche granulomi tifoidi. Una caratteristica dei granulomi è la presenza di cellule grandi con un nucleo leggero. Da questi focolai e dai luoghi di localizzazione primaria, i microbi entrano periodicamente nel sangue, mantenendo così la batteriemia, che può durare da 2-3 giorni a 4 settimane o più. Durante questa fase si verifica un ingrossamento del fegato, della milza, una disfunzione del midollo osseo (è caratteristico un peculiare disturbo dell'emocromo) e, naturalmente, ad un certo punto, quando la protezione diventa sufficientemente potente, inizia quanto segue:
fase di eliminazione dell'agente patogeno dall'organismo. Inizia a circa 2 settimane. Il microbo viene rilasciato attraverso i reni, il fegato e le vie biliari nell'intestino, mentre alcuni possono sviluppare fenomeni infiammatori nelle vie biliari (a volte la malattia può essere mascherata da un quadro clinico di colecistite, colangite). Quindi i microbi, entrando nuovamente nell'intestino, incontrano formazioni linfoidi, che portano ad una reazione allergica dell'intestino tenue e al fenomeno di Arthus, che ha una certa consistenza e gravità. E succede che il paziente ha una forma abortiva, la temperatura scende alla normalità dopo una settimana e si verifica il recupero clinico, ma si verificano gravi cambiamenti nell'intestino a causa di una reazione allergica e l'ulcera può perforarsi in qualsiasi momento. Il risultato di una reazione allergica è anche la comparsa di un'eruzione papulare-roseola.
La fase di formazione dell'immunità è una fase isolata artificialmente. Sono importanti sia l'immunità cellulare che quella umorale (è la principale); in alcune persone, a causa dell'inferiorità del sistema immunitario del corpo, si verifica un recupero clinico, ma l'agente patogeno persiste (portatore di batteri, alcuni lo chiamano una forma cronica di infezione da tifo , anche se non esiste una clinica). Nei portatori cronici di batteri, la localizzazione più comune sono le cellule del midollo osseo. Queste persone costituiscono il 3-6% dei malati. Naturalmente, quando le tossine circolano, il sistema nervoso autonomo viene influenzato, la funzione delle ghiandole digestive, compreso il pancreas, viene influenzata, quindi la terapia dietetica è importante nel trattamento. Nei casi più gravi, può verificarsi acidosi. La stessa disbiosi intestinale può causare complicazioni e peggiorare l'intossicazione. La disbatteriosi può molto spesso svolgere un ruolo importante nell'esito della malattia. Da un lato, supporta il processo patologico, può produrre batteriemia aspecifica e portare a complicazioni chirurgiche; sullo sfondo può svilupparsi un'enterite ulcerosa.
ANATOMIA PATOLOGICA
nella prima settimana si osserva nell'intestino uno stadio di gonfiore simile a quello cerebrale delle placche di Peyer e dei follicoli solitari; fenomeni simili possono verificarsi nell'orofaringe. Anche i linfonodi paratracheali, tracheali e sottocutanei possono ingrossarsi.
Nella seconda settimana si nota lo stadio della necrosi. Questo è un periodo molto pericoloso, poiché se la necrosi è profonda potrebbe verificarsi un sanguinamento intestinale (che porta all'erosione vascolare). È necessario utilizzare una dieta chimicamente e termicamente delicata.
Nella terza settimana, le masse necrotiche vengono rigettate e si formano ulcere pulite, possono verificarsi perforazione e sanguinamento.
Nella quarta settimana si osserva lo stadio delle ulcere pulite.
Nella quinta settimana, le ulcere iniziano a cicatrizzare e praticamente non rimangono tracce di infezione.
Questi processi non sono associati alla febbre, quindi i pazienti non vengono dimessi prima di 3 settimane dalla normalizzazione della temperatura. Durante questo periodo può verificarsi una ricaduta. È necessario distinguere chiaramente tra i concetti di recidiva e di esacerbazione.
Una riacutizzazione è una recidiva acuta della malattia quando i sintomi della malattia non sono ancora completamente scomparsi.
La recidiva è la ricomparsa dei sintomi della malattia dopo il recupero per 3 settimane.
Dal punto di vista patoanatomico si evidenziano alterazioni degenerative e distrofiche nel sistema nervoso autonomo e nel cervello (in particolare nei lobi frontali). Il famoso patologo Davydovsky ha affermato che un paziente con febbre tifoide raggiunge il recupero anatomico non prima di 12 settimane dall'inizio della malattia.
CORSO TIPICO
Il periodo di incubazione varia da 10-14 giorni a 3 settimane. Ci sono diversi periodi durante il decorso della malattia:
1. Il periodo iniziale termina quando la temperatura raggiunge il suo massimo, durando 4-7 giorni. L'esordio può essere acuto, sviluppandosi nell'arco di 2-3 giorni, o graduale, e alla fine il paziente diventa letargico e adinamico. Durante questo periodo, il paziente ha un aspetto caratteristico: pelle pallida, febbre alta, appetito ridotto, fino all'anoressia. Il sonno è disturbato, a volte possono verificarsi allucinazioni visive e uditive (raro).
All'esame vengono rilevati bradicardia, temperatura elevata, divisione dell'onda del polso e ipotensione. La lingua è ispessita e ricoperta da una patina bianca. A volte si osserva l'angina di Duguay (angina catarrale). Potrebbe verificarsi una tosse secca dovuta all'irritazione delle vie respiratorie da parte dei linfonodi infiammati. Entro la fine di questo periodo, il fegato e la milza si ingrossano, si determinano flatulenza e ottusità nella regione iliaca destra. Nel sangue: leucopenia, aneosinfilia, linfocitosi e monocitosi. Possono essere presenti proteine nelle urine, talvolta cilindri (danno di origine tossica). In questo periodo non è facile sospettare la febbre tifoide, ma esiste una vecchia regola: se il paziente ha la febbre per 4-5 giorni e non si riesce a scoprirne la causa, allora bisogna pensare alla febbre tifoide o alla febbre paratifoide. - quindi è necessario eseguire un'emocoltura. Spesso durante questo periodo diagnosticano l'influenza, ecc.
2. Il periodo di punta (dura 2-3 settimane). La diagnosi può e deve essere fatta clinicamente: la temperatura diventa costante, le fluttuazioni non superano 1 grado al giorno. L'intossicazione si manifesta fino allo shock tossico-infettivo, che oggi si osserva meno frequentemente, poiché i pazienti iniziano precocemente il trattamento con antibiotici. L'aspetto è tipico: il paziente è letargico, adinamico; sulla pelle, a partire dal 7-8o giorno di malattia o poco prima, appare un'eruzione cutanea con una localizzazione tipica: le superfici laterali dell'addome, la parte inferiore del torace. Ci sono pochi elementi, l'elemento dura 3-5 giorni. Finché c'è batteriemia, possono comparire nuovi elementi.
A volte può verificarsi un leggero ingrandimento dei linfonodi ascellari. Da parte del sistema cardiovascolare si osservano gli stessi cambiamenti, ma più pronunciati, e con lo shock si verifica un forte calo della pressione sanguigna, possibilmente miocardite. Fondamentalmente, i cambiamenti si verificano in base al tipo di distrofia miocardica, che viene rilevata sull'ECG. Bradicardia relativa, talvolta polmonite di origine mista (pneumococco e bacillo tifoide). La lingua è secca, ricoperta da una patina marrone, potrebbe esserci necrosi delle tonsille. Flatulenza naturale, ingrossamento del fegato e della milza. La stitichezza è tipica, ma può verificarsi diarrea (feci enteriche 3-5 volte al giorno). Nel sangue: leucopenia, diminuzione dei globuli rossi, piastrine (che riflette il danno al midollo osseo).
3. Il periodo di sviluppo inverso della malattia e convalescenza. La temperatura scende su larga scala, sia in modo litico che critico, i sintomi scompaiono gradualmente, rimane ancora il fegato ingrossato e le feci ritornano alla normalità. La bradicardia scompare e viene sostituita dalla tachicardia. Potrebbe verificarsi una ricaduta.
MOTIVI DI RICORRENZA:
conservazione dell'agente patogeno nel corpo
risposta immunitaria insufficiente
Contribuire alla ricaduta:
Trauma neuropsichico
Ipotermia e surriscaldamento
Esaurimento
Ipovitaminosi
Stratificazione di malattie intercorrenti
Trattamento inadeguato
In generale, la ricaduta è più facile e più breve. L'eruzione cutanea appare prima. I cambiamenti patoanatomici riprendono, ma passano un po' più velocemente. Il tasso di recidiva è del 5-30%. In chi non è stato trattato con antibiotici la recidiva si verifica nell'11% dei casi; in quelli trattati con antibiotici (cloramfenicolo, ecc.) la recidiva si verifica nel 26% dei casi; se durante la terapia sono stati utilizzati corticosteroidi la recidiva si verifica nel 30% di casi. Se la terapia per la febbre tifoide è combinata con la terapia immunomodulante, la recidiva si verifica nel 14% dei casi. Nel tipo moderno, ovviamente, non c'è un tipo di febbre costante, ma un decorso ondulatorio. Esistono diversi tipi di febbre: può esserci solo febbre lieve o può esserci sepsi. Qualsiasi febbre dovrebbe far sospettare la febbre tifoide e paratifoide.
COMPLICAZIONI
Shock (dovuto all'azione dell'endotossina).
Perforazione dell'ulcera dell'intestino tenue (fino all'8%), dolore addominale acuto non è tipico: solo la comparsa di dolore, tachicardia e un forte calo della temperatura alla normalità. Per qualsiasi gravità è necessario un trattamento chirurgico urgente, poiché altri trattamenti non saranno di aiuto. Il sanguinamento intestinale si manifesta con: pallore pronunciato, tachicardia, diminuzione della pressione sanguigna, gonfiore, aumento della motilità intestinale e possono esserci feci scure o feci con sangue.
Polmonite, meningite secondaria
Infezione meningea secondaria.
Un buon segno nella diagnosi della febbre tifoide è l'eosinofilia, così come una diminuzione della temperatura.
CARATTERISTICHE DELLA TENDENZA MODERNA:
periodo febbrile più breve
lo stato tifoso si verifica raramente
le ricadute si verificano più spesso
le complicanze aspecifiche si verificano meno frequentemente
sintomi clinici meno gravi
forme più spesso cancellate e abortite
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO NELLE PERSONE VACCINATE
esordio spesso acuto, con conseguente breve periodo iniziale
più della metà ha un decorso lieve, 5 volte meno spesso ha un decorso grave
Per molti, il periodo febbrile non dura più di 1 settimana
Molto spesso la temperatura è subfebbrile
nel sangue periferico: leucocitosi, aneosinfilia.
CARATTERISTICHE DEL PARATIFO
PARATIFIO A: il periodo di incubazione non supera i 14 giorni, in quasi l'80% dei pazienti l'esordio è acuto. Oltre il 50% presenta un aumento della temperatura accompagnato da brividi. La temperatura remittente è 3 volte più comune (intervallo superiore a 1 grado al giorno), lo stato tifoso si verifica raramente, le complicanze sono meno comuni e le recidive sono più comuni. Trasporto nel 13% dei casi tra i guariti. Una persona su quattro presenta sintomi di gastroenterite.
PARATYPH B: assomiglia ad una forma lieve di febbre tifoide, ad esordio acuto, raramente si verifica lo stato tifoso. I disturbi gastrointestinali sono molte volte più comuni. Il periodo febbrile non dura più di 1 settimana. Meno comunemente, sindrome epatolienale, raramente eruzione cutanea. Le ricadute e le complicanze sono meno comuni.
DIAGNOSTICA.
1. DATI CLINICI
2. DATI DI LABORATORIO: esame batteriologico urine, feci, bile, test Widal positivo dalla 2a settimana, titolo diagnostico 1/200, titolo da valutare anche nel tempo: dovrebbe esserci un aumento del titolo anticorpale.
2. Rigoroso riposo a letto durante la febbre e 10 giorni a temperatura normale (poiché la temperatura si normalizza prima dei cambiamenti nell'intestino).
3. Terapia disintossicante: vengono utilizzate soluzioni di glucosio, soluzioni polioniche, ecc.
4. Terapia etiotropica: per le forme lievi non è necessaria, per le forme moderate e gravi si usa il cloramfenicolo (farmaco di scelta) 0,5 4 volte al giorno durante tutto il periodo di febbre e 12 giorni di temperatura normale. Può essere utilizzata anche l'ampicillina.
Prescrizione di convalescenti non prima di 21 giorni di temperatura normale, in presenza di un risultato negativo di un esame batteriologico delle urine (almeno 2 volte), un test della bile e 2 test delle feci. L'esame clinico dura 3 mesi (durante questo periodo può svilupparsi una recidiva. Il SES registra il paziente per 2 anni.
Il contenuto dell'articolo
Febbre tifoide e febbri paratifoidi A e B appartengono alla salmonellosi, ma dal punto di vista epidemiologico e clinico differiscono significativamente dalle malattie causate da altri sierotipi di salmonella, quindi sono solitamente isolati. La febbre tifoide fu descritta come una forma nosologica indipendente nella prima metà del XIX secolo.Eziologia della febbre tifoide e della febbre paratifo A e B
L'agente eziologico della febbre tifoide Salmonella typhi fu scoperto da Ebert nel 1880, l'agente eziologico del paratifo A - Salmonella paratyphi A fu descritto da Gwin nel 1898, l'agente eziologico del paratifo B - Ashar e Bedsod nel 1896. Morfologicamente non differiscono e sono bastoncini corti con estremità arrotondate con molti flagelli, non formano spore, si differenziano per proprietà biochimiche e antigeniche.Gli agenti causali della febbre tifoide e della febbre paratifo hanno un gran numero di varietà: fagotipi (fagovarianti), designati con lettere maiuscole dell'alfabeto latino. La tipizzazione fagica degli agenti patogeni aiuta a stabilire collegamenti epidemiologici tra singole malattie.
La sopravvivenza dell'agente eziologico della febbre tifoide e della febbre paratifo sugli oggetti ambientali dipende dalla chimica degli oggetti, dalla temperatura, dall'umidità, dall'esposizione alla radiazione solare, ecc. Di solito persistono per diversi giorni, meno spesso - settimane e molto raramente - 2 -3 mesi. L'accumulo di agenti patogeni negli oggetti ambientali, di regola, non si verifica, ad eccezione del latte e della carne macinata, dove gli agenti patogeni possono moltiplicarsi, ma in seguito si ferma e i microbi iniziano a morire. L'agente eziologico del paratifo B persiste negli oggetti ambientali più a lungo degli agenti causali della febbre tifoide e del paratifo A. Gli agenti causali delle malattie tifo-paratifo non sono resistenti ai disinfettanti, muoiono entro pochi minuti a temperature elevate, sotto l'influenza di farmaci contenenti cloro e fenolo.
Patogenesi e quadro clinico della febbre tifoide e della febbre paratifo A e B
Gli agenti causali delle malattie tifo-paratifo entrano nel corpo con acqua o cibo. Nell'intestino tenue penetrano nei follicoli solitari e nelle placche di Peyer e successivamente nei linfonodi mesenterici. Durante il periodo di incubazione, che dura dai 7 ai 23 giorni (in media 12-14 giorni), l'agente patogeno si accumula in queste formazioni linfatiche. Successivamente si verifica la batteriemia, che coincide con l'esordio della malattia clinica. Nella seconda settimana di malattia appare un'eruzione cutanea. Attraverso il circolo sanguigno l'agente patogeno viene trasportato in vari organi e tessuti, dove possono insorgere lesioni secondarie. Da un punto di vista epidemiologico, di particolare importanza è la formazione di focolai secondari nei sistemi biliare e urinario, da cui i batteri entrano nelle feci e nelle urine e vengono espulsi dal corpo. L'agente patogeno entra anche nelle feci dalle ulcere che si verificano nel sito delle formazioni linfoidi intestinali. L'agente patogeno entra in modo particolarmente massiccio dalle ulcere durante il rigetto del tessuto necrotico alla 3-4a settimana della malattia.Insieme alle forme gravi di febbre tifoide, in cui si possono osservare sanguinamento intestinale e perforazione di ulcere formatesi nell'intestino, esistono forme lievi di infezione, trasmesse dai pazienti alle gambe, con febbre da una a due settimane, scarse eruzioni cutanee, senza una condizione di tifo. Si ritiene che la febbre paratifo sia più lieve della febbre tifoide.
Con le malattie tifo-paratifo sono possibili ricadute.
Fonti di infezione della febbre tifoide e della febbre paratifo A e B
Nella febbre tifoide e nel paratifo A la fonte dell'infezione può essere solo una persona; nel paratifo B l'infezione può essere causata anche da animali e pollame.Gli agenti patogeni si trovano occasionalmente nelle feci delle persone nel periodo di incubazione (trasporto precoce). Dall’esordio della malattia il pericolo per il paziente come fonte di infezione aumenta e raggiunge il suo massimo alla 3-4a settimana di malattia. L'agente patogeno viene escreto nelle feci e nelle urine in circa l'80% dei pazienti. Man mano che il processo infettivo si attenua, durante il periodo di convalescenza, diminuisce il numero di persone in cui vengono rilevati agenti patogeni: nelle prime settimane di convalescenza si osserva un portatore nel 15-20% di coloro che sono guariti dalla malattia; dopo 3 mesi , il loro numero si riduce al 3-5%; successivamente, coloro che sono guariti dalla malattia vengono liberati dal trasporto. avviene molto lentamente.
Le persone che diffondono agenti patogeni per più di 3 mesi sono considerate portatrici croniche; i batteri si accumulano nei loro corpi nei sistemi biliare e urinario e nel midollo osseo.
Il portatore cronico dopo la febbre paratifo si verifica più spesso che dopo la febbre tifoide. La sua durata può essere molto lunga, talvolta addirittura per tutta la vita. Spesso il trasporto è periodico (forse la periodicità del rilascio microbico è evidente e si spiega con l'insufficiente accuratezza dei metodi di ricerca esistenti). La frequenza di isolamento dei patogeni rende difficile identificare i portatori e determinare il momento del loro rilascio dai microbi, poiché anche diversi test negativi non escludono il trasporto. La diffusione degli agenti patogeni può essere molto ampia. Sono stati descritti casi in cui 1 ml di urina o 1 g di feci contenevano fino a 500 milioni di bacilli tifoidi. Di conseguenza, tali portatori possono rilasciare un numero enorme di agenti patogeni durante il giorno.
Il significato epidemiologico dei portatori cronici è molto maggiore di quello dei pazienti con forme acute di infezione. Ciò è spiegato dal fatto che il numero di portatori si accumula nel corso degli anni e, di conseguenza, il loro numero supera il numero annuale di pazienti; i portatori cronici secernono agenti patogeni per anni e i pazienti per diverse settimane; i portatori vivono in condizioni di vita normali, comunicano con un gran numero di persone sia a casa che al lavoro e i pazienti sono isolati.
Molto spesso, i portatori espellono gli agenti patogeni nelle feci; l'escrezione nelle urine è molto meno comune. Quest'ultimo è particolarmente pericoloso, poiché la minzione avviene più spesso della defecazione. È stato stabilito che ciascun “portatore urinario” infetta più persone di un portatore che espelle gli agenti patogeni nelle feci. I portatori non identificati sono i più pericolosi, poiché una volta identificati, il portatore stesso e coloro che lo circondano prendono precauzioni.
Il ruolo degli oratori è in gran parte determinato dalla loro professione. I portatori più pericolosi sono quelli che lavorano nel sistema di approvvigionamento idrico, nell'industria alimentare, nella ristorazione pubblica e negli istituti di assistenza all'infanzia.
Secondo dati generali, circa l'80% delle infezioni da febbre tifoide avvengono da portatori cronici e solo il 20% da altre fonti di infezione.
L'importanza dei portatori cronici non si limita al fatto che è da loro che si verifica la maggior parte delle infezioni. Il ruolo dei portatori risiede anche nel fatto che in natura sono un serbatoio di agenti patogeni. Infatti, se in qualsiasi località sono presenti portatori, l'infezione persiste finché vivono qui, indipendentemente dal fatto che si presentino nuove malattie. Ci sono stati casi in cui i portatori cronici hanno infettato persone del loro ambiente (o persone che consumavano cibo preparato da loro) a intervalli di diversi anni.
Il trasporto transitorio della febbre tifoide e della febbre paratifoide è raro; si riscontra in persone che hanno comunicato con fonti di infezione.
Meccanismo di trasmissione dell'infezione- fecale-orale. L’acqua e i prodotti alimentari sono coinvolti nella trasmissione dell’infezione. La contaminazione dei prodotti avviene attraverso mani infette, oggetti domestici, insetti, mosche e scarafaggi.
Una caratteristica delle epidemie e delle epidemie legate al tifo-paratifo è la difficoltà di isolare gli agenti patogeni dall'acqua contaminata. Ciò è dovuto al fatto che il periodo di incubazione delle infezioni da tifo-paratifo è lungo, per cui l'esame dell'acqua sospetta viene effettuato diverse settimane dopo che l'acqua è stata contaminata. A questo punto, gli agenti causali delle malattie tifo-paratifo potrebbero scomparire dall'acqua. Pertanto, se non è stato possibile isolare l'agente patogeno dall'acqua sospetta, ciò non esclude la natura acquatica dell'epidemia (focolaio).
Spesso, un'epidemia idrica di febbre tifoide o paratifo è preceduta da un'epidemia di malattie gastrointestinali causate dalla microflora opportunistica che è entrata nell'acqua contemporaneamente agli agenti causali delle malattie tifo-paratifoidi. Sono state descritte anche epidemie idriche combinate, come dissenteria e febbre tifoide.
Gli agenti causali delle malattie tifo-paratifo possono entrare nel corpo con vari prodotti alimentari: latte, panna acida, ricotta, ecc., Prodotti a base di carne, pesce e crostacei, frutta e verdura, prodotti da forno, succhi. Di grande importanza sono il latte e gli altri latticini di consistenza liquida o semiliquida. La centralizzazione delle forniture di latte alla popolazione e la creazione di grandi imprese alimentari hanno portato al fatto che le epidemie alimentari sono diventate più grandi negli ultimi decenni. In alcuni casi possono verificarsi epidemie da latte.
La carne e i prodotti che ne derivano sono incomparabilmente meno importanti nella diffusione delle malattie tifo-paratifo rispetto ai latticini. Tuttavia, sono note infezioni legate al consumo di prosciutto e altri prodotti a base di carne che non sono stati precedentemente cotti.
In alcuni paesi in cui i crostacei, in particolare le ostriche, sono ampiamente consumati, potrebbero svolgere un ruolo importante nella trasmissione della febbre tifoide.
Con il paratifo B è possibile la contaminazione di prodotti provenienti da animali portatori dell'agente patogeno. Sono state descritte epidemie significative in cui le uova di pollame sono state un fattore di trasmissione dell'infezione.
Quando una quantità significativa di cibo è contaminata è consuetudine parlare di trasmissione alimentare. In questo caso si verificano malattie diffuse. La contaminazione dei prodotti alimentari è possibile anche a casa, molto spesso attraverso le mani sporche di pazienti o portatori.
Piccole quantità di cibo possono essere contaminate da insetti come le mosche. Questa trasmissione dell'infezione ha una natura stagionale pronunciata. I collegamenti intermedi nella trasmissione dell'infezione possono essere oggetti domestici: stoviglie, posate, maniglie delle porte, mobili, ecc. Le malattie sono generalmente sporadiche o di piccola focale e si verificano tra persone in condizioni di vita sfavorevoli.
Pertanto, la trasmissione della febbre tifoide e delle febbri paratifoidi A e B può avvenire tramite acqua, cibo e contatto domestico. In diversi territori in tempi diversi, una determinata via di trasmissione dell'infezione si è rivelata la principale. Nel XIX e all'inizio del XX secolo, molte città furono colpite da epidemie idriche croniche e acute, comprese le epidemie idriche. Dopo la razionalizzazione del sistema di approvvigionamento idrico, le epidemie croniche si sono fermate e le epidemie acute legate all’approvvigionamento idrico sono diventate rare. Secondo l'OMS, attualmente il 60-70% della popolazione mondiale non dispone ancora di acqua di buona qualità; anche nei paesi economicamente sviluppati sono possibili epidemie locali e contaminazione da parte dell'acqua dei bacini idrici aperti.
L'importanza delle mosche nella trasmissione dell'infezione è determinata dall'organizzazione e dalla qualità della pulizia delle aree popolate e, se le loro condizioni sono antigeniche, aumenta in modo significativo. Il ruolo della trasmissione alimentare nei paesi economicamente sviluppati è in aumento. Allo stesso tempo, il ruolo del latte si riduce a causa di misure efficaci per la sua disinfezione, ma aumenta il ruolo delle insalate, delle vinaigrette e dei prodotti a base di idrobionti.
Nella trasmissione del paratifo B, i prodotti alimentari sono di grande importanza, in cui l'agente eziologico di questa malattia può persistere a lungo e in alcuni casi accumularsi. La trasmissione attraverso l'acqua del paratifo B è meno comune rispetto ad altre infezioni da tifo-paratifo.
Suscettibilità e immunità del tifo e del paratifo A e B
Affinché si verifichi una malattia clinicamente significativa, è necessaria una determinata dose infettiva, il cui valore specifico è determinato dalla patogenicità del ceppo che causa l'infezione e dallo stato del corpo umano infetto. Questa dose per il paratifo B è superiore a quella per la febbre tifoide.L'infezione lascia l'immunità, sebbene siano possibili malattie ripetute.
Caratteristiche dell'epidemiologia del tifo e del paratifo A e B
Le malattie tifo-paratifo si trovano ovunque. Il tasso di incidenza nei singoli paesi è diverso ed è determinato dalle condizioni di vita sociale della popolazione. Il tasso di incidenza più basso si registra nei paesi economicamente sviluppati. Nei paesi in via di sviluppo i tassi di incidenza sono elevati.Negli ultimi decenni si è osservata la tendenza a ridurre l’incidenza delle infezioni da tifo-paratifo, in primis la febbre tifoide. Il tasso di diminuzione dell’incidenza del paratifo B è molto più basso.
Quasi ovunque l'incidenza massima si verifica a fine estate e in autunno. In alcune località, fattori di trasmissione specifici possono alterare questa stagionalità. Le malattie tifo-paratifo colpiscono persone di qualsiasi età, ma relativamente più spesso tra bambini, adolescenti e giovani. A volte il gruppo più colpito sono gli adolescenti, il che si spiega con la loro elevata mobilità, il nuoto in luoghi proibiti e l’insufficiente rafforzamento delle loro competenze igieniche. Durante le epidemie di latte sono stati identificati anche un gran numero di bambini, i principali consumatori di latte. Di norma, non esistono caratteristiche specifiche dell'incidenza delle infezioni da tifo-paratifo per genere, ma è stata ampiamente accertata la grande influenza dei fattori sociali, che determina la maggiore o minore attività di trasmissione dell'acqua, del cibo o della famiglia e l'incidenza di diversi gruppi della popolazione. Il ruolo delle condizioni sanitarie è stato riflesso da N.F. Gamaleya: "Se Vibrio cholera è un ispettore sanitario, che effettua ispezioni periodiche e punisce severamente le omissioni sanitarie, allora il bacillo tifoide è il suo assistente attivo, stando fermo e rilevando inesorabilmente gli stessi difetti".
Prevenzione della febbre tifoide e paratifoide
La lotta contro le infezioni da tifo-paratifo prevede l'attuazione di una serie di misure mirate alle fonti di infezione, alle vie di trasmissione, nonché all'aumento della resistenza della popolazione agli agenti causali di queste malattie.Misure mirate alle fonti di infezione. I pazienti sono soggetti a ricovero ospedaliero completo e possibilmente precoce. La difficoltà di eseguire questo compito dipende dal decorso atipico della malattia, che rende difficile la diagnosi. Inoltre, l'esordio della malattia è spesso graduale e il principale segno diagnostico, l'eruzione cutanea, compare solitamente nella seconda settimana. Il medico può essere aiutato identificando il fatto che il malato comunica non solo con altri pazienti guariti dalla malattia, ma anche con i portatori. La diagnostica epidemiologica fornisce un aiuto particolarmente prezioso in caso di epidemie legate all’acqua o agli alimenti. Se è noto che l'acqua di una fonte d'acqua o qualsiasi prodotto alimentare è contaminato, il consumo di quest'acqua (prodotto) da parte della persona malata dovrebbe essere preso in considerazione quando si effettua una diagnosi.
Gli esami di laboratorio, in particolare l’isolamento degli agenti patogeni dal sangue del paziente (emocoltura), svolgono un ruolo significativo nella diagnosi della febbre tifoide e paratifoide. Questo è un metodo di diagnosi precoce, poiché l'agente patogeno appare nel sangue fin dall'inizio della malattia. Il rilevamento dell'agente patogeno nel sangue dimostra la correttezza della diagnosi. Il metodo dell'emocoltura dà i migliori risultati nella prima settimana di malattia, quando il patogeno può essere rilevato nel sangue in più del 90% dei pazienti; nei periodi successivi, la quantità del patogeno nel sangue diminuisce e per isolarlo è necessario è necessario prelevare una quantità di sangue maggiore (15-20 ml). La raccolta del materiale per la ricerca può essere effettuata non solo in ospedale, ma anche in clinica.
Per diagnosticare la febbre tifoide e la febbre paratifoide e identificare i portatori, vengono utilizzate colture di feci, urina e bile.
Nelle fasi successive della malattia vengono utilizzati metodi sierologici: la reazione di agglutinazione (reazione di Widal) e ora, più spesso, la reazione di emoagglutinazione indiretta (IRHA) con un diagnostico eritrocitario. Queste reazioni sono considerate evidenti quando i titoli anticorpali aumentano nel corso della malattia.
Identificare i portatori e prevenirne l’infezione è un compito difficile. Per risolverlo, prima della dimissione dall'ospedale, i convalescenti vengono sottoposti a un triplice esame batteriologico delle feci, delle urine (al 5°, 10° e 15° giorno di temperatura normale) e della bile (al 10-12° giorno di temperatura normale). La dimissione viene effettuata non prima del 21° giorno di temperatura normale (coloro che sono guariti dalla malattia e non hanno ricevuto antibiotici possono essere dimessi dal 14° giorno di temperatura normale).
In futuro, l'identificazione dei portatori tra coloro che sono guariti dalla malattia verrà effettuata durante l'osservazione del dispensario.
La ricerca dei portatori viene effettuata anche tra le persone che entrano a lavorare nelle imprese alimentari (e simili).
Anche le persone che hanno comunicato con i pazienti vengono sottoposte al test per la portabilità. Inoltre l'epidemiologo può ordinare l'esame di altre popolazioni per le quali esiste il sospetto di trasporto.
Il metodo di esame principale è l'esame batteriologico delle feci e delle urine (per il trasporto urinario), un esame efficace della bile (contenuto duodenale), dove gli agenti patogeni possono essere trovati circa 3 volte più spesso che nelle feci. Tuttavia, la complessità del campionamento limita la frequenza di questo studio.
La pratica a lungo termine ha dimostrato che un esame, due, tre volte in caso di risultati negativi non garantisce sempre l'assenza dell'agente patogeno, poiché può essere rilasciato periodicamente, pertanto sono indicati esami multipli.
Per aumentare l'efficienza dell'esame, sono stati proposti metodi immunologici per l'identificazione dei portatori: una reazione di emoagglutinazione passiva con l'antigene Vi, un test cutaneo con Vi-tifina, una reazione di emoagglutinazione con la determinazione degli anticorpi resistenti alla cisteina. Questa reazione viene data a coloro che fanno domanda per lavorare presso imprese alimentari (e equivalenti), alle persone che hanno comunicato con un paziente affetto da febbre tifoide tra i lavoratori del settore alimentare 2 anni dopo la malattia. La reazione si basa sul fatto che gli anticorpi presenti nei portatori cronici non vengono distrutti dalla cisteina. Il trattamento del siero con cisteina consente di determinare quali anticorpi ha la persona esaminata. In generale, i metodi immunologici dovrebbero essere considerati come guida e indicativi. Le persone con reazioni positive vengono sottoposte a molteplici test batteriologici aggiuntivi (cinque volte test delle urine e delle feci e un singolo test della bile) e possono essere considerate portatrici solo se da loro viene isolato l'agente patogeno.
Le stazioni sanitario-epidemiologiche e le cliniche mantengono un archivio dei portatori dei batteri tifo-paratifo (modulo n. 364/u). Non è stato sviluppato un metodo affidabile per la sanificazione dei portatori; in alcuni casi, una combinazione di antibiotici con agenti che stimolano i processi immunobiologici ha successo.
Attualmente, l'importanza principale è attribuita alle misure per prevenire l'infezione da parte dei portatori: non sono autorizzati a lavorare, dove potrebbero esserci opportunità di trasmissione dell'infezione da parte loro attraverso l'acqua, il cibo e il contatto domestico. Dovrebbe essere svolto un attento lavoro sanitario ed educativo con i portatori cronici. È necessario garantire che i trasportatori rispettino scrupolosamente l'igiene personale (lavarsi le mani con sapone dopo aver visitato la toilette, disinfezione quotidiana della toilette, bollire la biancheria, vietare il lavaggio degli indumenti in acque libere, ecc.). Nelle famiglie in cui vivono portatori cronici, non è consigliabile allevare mucche e altri animali da latte. Se necessario, migliorare le condizioni di vita delle famiglie in cui vivono i portatori cronici.
Misure volte a prevenire la trasmissione dell’infezione. Queste misure sono fondamentali nella lotta contro la febbre tifoide, la febbre paratifoide e altre infezioni intestinali. È necessario “bloccare” tutti i canali attraverso i quali gli agenti patogeni possono diffondersi dalla fonte dell’infezione alle persone sensibili. Tra le misure, la più importante è fornire alla popolazione acqua di buona qualità. Ciò vale non solo per le aree popolate, ma anche per i luoghi di residenza temporanea delle persone (campi, luoghi di riposo e di nuoto, viaggi turistici) L'igiene dell'approvvigionamento idrico è associata al problema della pulizia delle aree popolate. Una pulizia efficiente è anche una misura decisiva per il controllo delle mosche.
La prevenzione della diffusione alimentare delle infezioni da tifo-paratifo comprende un sistema di misure per prevenire la contaminazione dei prodotti alimentari lungo tutto il percorso dal luogo di produzione ai consumatori. Va sottolineata l'importanza di prevenire la contaminazione degli alimenti nelle fasi finali della sua distribuzione - vendita di torte, crostate, vari prodotti dolciari, gelati, impianti di saturazione, ecc.
L'impatto sul terzo anello del processo epidemico viene effettuato attraverso l'immunizzazione attiva di alcuni gruppi della popolazione. L'immunizzazione è un metodo aggiuntivo per prevenire la febbre tifoide, ma in determinate circostanze (impossibilità di attuare misure sanitarie e igieniche, ecc.) il suo ruolo aumenta.
Le vaccinazioni sono prescritte a persone di determinati gruppi professionali: coloro che lavorano nel sistema di pulizia delle aree popolate, nelle lavanderie, ad alcuni operatori sanitari, agli sfollati, nonché ai residenti di insediamenti o singole aree con alti tassi di morbilità. Un'indicazione alla vaccinazione può essere anche la scarsa condizione sanitaria del territorio, che aumenta il rischio di un'epidemia. Per la vaccinazione viene utilizzato un monovaccino antitifico alcolico corpuscolare ucciso arricchito con antigene Vi. Le vaccinazioni vengono effettuate in diverse fasce di età, possono iniziare a partire dai 7 anni (una volta); tra gli adulti sono soggette a vaccinazione le donne sotto i 55 anni e gli uomini sotto i 60 anni.
Attività negli ambiti delle malattie tifo-paratifo includere il ricovero dei pazienti e la loro notifica di emergenza. Prima del ricovero viene effettuata una disinfezione corrente e dopo il ricovero viene effettuata una disinfezione finale (in estate - disinfestazione - sterminio delle mosche). Un esame epidemiologico viene effettuato da un medico.
Le misure riguardanti le persone in contatto con il paziente comprendono: identificazione delle persone in contatto; osservazione medica con termometria per 21 giorni dal momento del ricovero del paziente, quelli in contatto vengono sottoposti ad un unico esame batteriologico delle feci e ad un test sierologico (RIGA con cisteina). Se l'agente patogeno viene isolato dalle feci o se la reazione sierologica è positiva, la bile, l'urina e le feci vengono riesaminate per determinare la natura del portatore (transitorio o cronico).
Le persone che hanno interagito con la persona malata ricevono il batteriofago. Il primo ciclo di fagizzazione viene eseguito dopo il ricovero del malato, il secondo dopo il ritorno a casa del paziente (ogni ciclo prevede l'assunzione del fagico tre volte con un intervallo di 3-4 giorni).
Durante le epidemie legate all'acqua e al cibo, non vengono vaccinati solo coloro che sono in contatto con il paziente nell'epidemia, ma anche l'intera popolazione che vive nell'area colpita dall'epidemia. In questi casi la fagizzazione viene effettuata ogni 3-4 giorni.
Prevenzione della febbre tifoide, delle febbri paratifoidi A e B e misure antiepidemiche nelle epidemie
L'indagine sull'epidemia dovrebbe iniziare con lo studio dei materiali SES. Innanzitutto è necessario stabilire se attualmente in città si registra un'incidenza sporadica o se tale esame viene effettuato durante un focolaio epidemico (di natura idrica o alimentare). Se i test vengono eseguiti durante un’epidemia, il caso potrebbe farne parte e si dovrebbe tentare di collegare la malattia a una modalità di trasmissione comune.In secondo luogo, secondo il registro dei pazienti infettivi del SES e lo schedario dei portatori, è necessario scoprire se nel luogo di residenza o di lavoro (studio) del malato sono registrati altri pazienti con febbre tifoide o portatori. Ma va tenuto presente che l'assenza di pazienti e portatori registrati nell'ambiente del malato non esclude la loro presenza nella realtà. È noto che in circa 1/3 dei pazienti la malattia è lieve senza stato tifoide con febbre a breve termine. Gli errori diagnostici in questi casi sono molto probabili. Potrebbero esserci anche media non contabilizzati.
Sulla base di queste considerazioni è necessario identificare tutte le persone dell'ambiente del malato che presentavano uno stato febbrile 15-25 giorni prima della malattia in atto. Per fare ciò, è consigliabile studiare i certificati di congedo per malattia (certificati) rilasciati nelle ultime 2-4 settimane. Per chiarire la diagnosi di malattie pregresse, queste persone devono essere esaminate clinicamente e di laboratorio (esame delle feci per la presenza di agenti patogeni, studi sierologici).
È più difficile identificare i portatori nell'ambiente del paziente, così come tra le persone coinvolte nell'acqua e nei prodotti alimentari utilizzati dal malato. Poiché i portatori cronici tra coloro che sono guariti sono più spesso persone affette da malattie del sistema biliare e urinario e varie malattie croniche generali, è tra questi contingenti che si dovrebbero cercare innanzitutto i portatori cronici non rilevati. È necessario intervistare attentamente tutte le persone attorno al malato per verificare se in passato hanno sofferto di febbre tifoide e paratifo. Coloro che si sono ripresi vengono esaminati per lo stato di portatore.
Va tuttavia tenuto presente che l'assenza di un'anamnesi positiva per infezioni da tifo-paratifo non esclude la possibilità di un portatore cronico, poiché la malattia potrebbe rimanere non diagnosticata. Pertanto, si raccomanda di condurre un esame a tutte le persone che soffrono di malattie del sistema biliare e urinario.
Se un portatore o un paziente viene identificato nell'ambiente di un paziente, il suo ruolo come fonte di infezione può essere confermato mediante la fagotipizzazione delle colture isolate da questo paziente e portatore. La coincidenza dei prodotti dei fagi è un forte argomento a favore dell'istituzione di una connessione tra la persona malata e il portatore identificato.
Per stabilire il fattore di trasmissione dell'infezione, sulla base dei dati della storia epidemiologica, vengono determinati una serie di oggetti ambientali (principalmente acqua e prodotti alimentari) che sono soggetti a test di laboratorio. I campioni raccolti vengono inviati al laboratorio.
Nel valutare i risultati dello studio, è necessario tenere conto del fatto che l'isolamento degli agenti patogeni dall'oggetto in studio testimonia il suo ruolo come fattore nella trasmissione dell'infezione. L'assenza di un agente patogeno nell'oggetto in studio non fornisce motivo per escluderlo dal numero dei possibili fattori di trasmissione dell'infezione, poiché al momento del prelievo del materiale l'agente patogeno potrebbe essere scomparso, anche se era presente in questo oggetto al momento dell'infezione. Scarsi indicatori sanitari (ad esempio un basso titolo di coli nell'acqua) possono essere considerati una prova indiretta del suo ruolo nella diffusione dell'infezione.
Per determinare l'ulteriore diffusione dell'infezione, è importante stabilire la professione del malato e il livello di igiene personale. Queste domande dovrebbero essere chiarite anche per tutti i familiari del malato. Durante l'esame, viene compilato un elenco delle persone che hanno comunicato con il paziente a casa e al lavoro e vengono individuate in particolare le persone legate all'acqua e agli oggetti alimentari. Si accerta se il malato e le persone a contatto con lui sono stati vaccinati contro la febbre tifoide e l'ora della vaccinazione.
Quando si ispeziona l'epidemia, prestare attenzione alle condizioni sanitarie, all'ubicazione delle fonti d'acqua, agli impianti di trattamento e alla presenza di mosche.
Sulla base dei dati raccolti viene elaborato un piano d’azione specifico per eliminare l’epidemia.
TIFO, PARATIFO A, B, C
Le lamentele dei pazienti. I pazienti, di regola, notano debolezza generale, mal di testa, disturbi del sonno, perdita di appetito, flatulenza, stitichezza e aumento della temperatura corporea.
Sviluppo della malattia. Dopo un periodo di incubazione da 1 a 4 settimane (in media 2-3), compaiono i primi segni della malattia: debolezza, febbre, brividi, mancanza di appetito, mal di testa. Dal 5° al 7° giorno di malattia il mal di testa si intensifica, si verificano insonnia e stitichezza. Il giorno dell'esordio della malattia non è sempre facile da scoprire perché i pazienti, pur mantenendo la capacità lavorativa, non si accorgono dell'insorgenza della malattia e continuano a lavorare. La loro salute peggiora gradualmente e sono costretti a cercare aiuto medico. Entro il 7-8° giorno di malattia, la temperatura corporea raggiunge solitamente i 39°C o più e i sintomi di intossicazione aumentano. A questo punto compaiono spesso i segni caratteristici di questa malattia: pelle pallida, placca sulla mucosa della lingua, polso lento, fegato ingrossato, flatulenza, stitichezza, eruzione cutanea roseola sulla pelle dell'addome (nell'8-10 giorno) .
Anamnesi di vita. Le malattie passate e concomitanti possono influenzare negativamente la resistenza del corpo, contribuendo così a un corso più lungo del processo, al verificarsi di esacerbazioni, ricadute e complicanze. È noto, ad esempio, che le persone che soffrono di colecistite cronica, colangite, febbre tifoide e paratifo spesso diventano portatori di batteri.
Storia epidemiologica. La fonte dell'infezione è un paziente con febbre tifoide, febbre paratifoide, che si sta riprendendo da una malattia, nonché un portatore di batteri cronico. Nelle febbri paratifo B e C la fonte dell'infezione, oltre all'uomo, possono essere anche gli animali.
L'agente patogeno viene rilasciato dal corpo umano nell'ambiente esterno attraverso le feci e la saliva. Il malato è contagioso verso gli altri, a partire dagli ultimi giorni di incubazione, durante tutto il periodo febbrile e, in alcuni casi, in tempi diversi dopo il tifo (da alcune settimane ad alcuni anni).
Il meccanismo di trasmissione delle malattie tifo-paratifo è fecale-orale. I fattori di trasmissione includono vari alimenti e acqua. Il meccanismo di contagio è facilitato dalla contaminazione di questi prodotti con le secrezioni di pazienti affetti da febbre tifoide e dal loro successivo consumo da parte di individui sani. Le mosche sono importanti a questo proposito, in quanto trasportatori meccanici (i bacilli del tifo vivono sulle loro zampe e nell'intestino per 3-4 giorni), mancanza di igiene personale, sovraffollamento, condizioni antigeniche nelle aree popolate, mancanza di controllo adeguato negli esercizi di ristorazione pubblica e altri fattori.
Ai pazienti vengono chieste la data e la natura del contatto con la sospetta fonte di infezione, le condizioni dell'unità alimentare dove il paziente mangia, la fonte di approvvigionamento idrico, la struttura sanitaria e l'osservanza dell'igiene personale da parte del paziente e di coloro che intorno a lui.
È inoltre necessario stabilire se i pazienti siano stati vaccinati negli ultimi anni contro la febbre tifoide e paratifoide. Pertanto, le vaccinazioni possono contribuire a un decorso più lieve della malattia e complicare la valutazione dei risultati degli studi sierologici.
Sintomatologia, decorso ed esiti. La febbre tifoide in passato era ondulatoria, trapezoidale, frenetica, remittente, intermittente, reversibile e di altro tipo. I più comunemente osservati erano i tipi ondulati e trapezoidali. In media, la febbre durava 4-6 settimane. Tuttavia si sono verificati anche febbri più brevi (alcuni giorni) ed estremamente duraturi (mesi) (Fig. 1).
Attualmente è spesso difficile determinare il tipo di febbre, poiché la temperatura diminuisce subito dopo l'uso di antibiotici (Fig. 2).

Si osserva un aumento costante, remittente, reversibile e talvolta subfebbrile della temperatura, che è un segno di batteriemia e della presenza di endotossine nel sangue.
La pelle è pallida, secca, appare roseola sagomata nell'addome, nel torace (fianchi) e nella schiena, a partire dall'8-9 giorno di malattia. Il meccanismo di sviluppo dell'eruzione cutanea roseola si basa sulla diffusione ematogena dei bacilli del tifo nella pelle e sulla successiva reazione allergica delle sue singole aree ai prodotti di decomposizione di questi batteri. Si osservano spesso eruzioni cutanee ripetute di roseola. La pelle dei palmi e dei piedi è gialla, causata dalla carotenemia endogena (sintomo di Filippovich). Con tifo grave e scarsa cura igienica della pelle, si verificano piaghe da decubito e ulcere. La lingua è maggiormente rivestita alla radice, i bordi e la punta sono privi di placca. La mucosa della bocca è secca a causa dell'insufficiente secrezione di saliva, che contribuisce allo sviluppo della stomatite.
Spesso si sviluppano bronchite e polmonite, il che è facilitato da disturbi della circolazione e della ventilazione polmonare e dall'ipostasi. La polmonite può essere causata da pneumococco, streptococco, nonché febbre tifoide e paratifo.
Il polso è generalmente molle, di medio riempimento, talvolta dicrotico. Nei pazienti adulti, si nota che resta indietro rispetto al livello di temperatura - bradicardia relativa. La bradicardia assoluta si osserva spesso quando la frequenza dei battiti è inferiore a 60 battiti al minuto. La pressione sanguigna è ridotta. Nelle forme gravi della malattia si sviluppano spesso stati collaptoidi. Si notano sordità dei suoni cardiaci, aumento delle sue dimensioni trasversali, cambiamenti nell'elettrocardiogramma (appiattimento dei denti, aumento della durata della sistole elettrica, disturbi del ritmo).
Nel meccanismo di sviluppo dei disturbi vascolari sono importanti l'aumento del tono della parte parasimpatica del sistema nervoso autonomo e il deflusso del sangue dalla periferia ai vasi degli organi addominali spaiati. In queste condizioni, il flusso sanguigno al cuore è ridotto, il che contribuisce al suo danno. Si sviluppano diffuse alterazioni distrofiche nel miocardio; alterazioni infiammatorie (miocardite) sono rare.
L'addome è uniformemente gonfio, si palpa il fegato di media densità, con la superficie anteriore liscia. La dimensione del fegato si normalizza con la diminuzione della temperatura. In alcuni pazienti (circa 1/3) è possibile palpare una milza ingrossata. Quando si palpa l'addome nella zona inguinale destra, si riscontrano spesso brontolii, leggero dolore e ottusità del suono della percussione, rispetto a quelli nella zona inguinale sinistra (sintomo di Padalka). Questo fenomeno è causato da un aumento dei linfonodi mesenterici.
I cambiamenti nel sistema nervoso durante la febbre tifoide e la febbre paratifo sono caratterizzati da letargia, sonnolenza, adinamia e letargia dei pazienti. Al culmine della malattia si verificano disturbi del sonno; nelle forme gravi si osservano prostrazione e disfunzione degli organi pelvici. Alcuni pazienti sviluppano meningite, encefalite, talvolta neurite e si verifica psicosi, che può comparire anche durante il recupero.
I cambiamenti nel sistema muscolo-scheletrico possono manifestarsi come debolezza muscolare, atrofia muscolare, osteite e periostite, che sono caratterizzate da un'insorgenza tardiva.
Nel sangue dei pazienti all'inizio del tifo si osserva leucocitosi e successivamente - leucopenia, linfocitosi relativa, aneosinofilia, aumento del numero di granulociti a banda e neutrofili, trombocitopenia e, se si verificano complicanze, leucocitosi neutrofila, aumento della VES , anemia.
La quantità di urina al culmine della malattia diminuisce, il contenuto proteico in essa contenuto aumenta, appaiono i globuli rossi, il che può essere spiegato da un aumento della permeabilità dell'epitelio renale.
Durante lo sviluppo della malattia, la flatulenza si intensifica, spesso contribuendo allo sviluppo di complicanze, si nota secchezza della mucosa orale e si aggiungono sintomi di bronchite o polmonite focale. La temperatura corporea rimane costantemente alta. Questa fase, dopo 5-6 giorni, viene sostituita dalla fase di massima tensione del processo patologico; in questo momento i pazienti possono sviluppare un coma: contrazioni dei muscoli facciali, tremore degli arti, incontinenza urinaria e fecale.
La durata dello stadio più alto della malattia varia, solitamente fino a 2 settimane. Questa fase è seguita da un periodo di indebolimento dei sintomi clinici. Allo stesso tempo, la temperatura corporea diminuisce, la lingua diventa umida, il sonno si normalizza, l'appetito migliora e la diuresi aumenta.
Durante la fase di convalescenza, la temperatura ritorna normale, eventuali disturbi insorti scompaiono gradualmente, ma si osserva debolezza per lungo tempo. Le dimensioni del fegato e della milza si normalizzano durante il recupero.
Se la milza rimane ingrossata, si deve considerare la possibilità di una recidiva della febbre tifoide. Le ricadute della malattia sono facilitate da vari motivi: violazione della dieta, regime, trauma mentale, carenze vitaminiche, esaurimento, malattie intercorrenti. Il decorso della recidiva è solitamente meno grave, la durata dell'ondata febbrile è più breve. In alcuni casi, le recidive sono gravi e si verificano gravi complicazioni della febbre tifoide e della febbre paratifoide (peritonite, sanguinamento), che peggiorano la prognosi. Le ricadute possono verificarsi dopo 2-5 o più giorni di temperatura normale. Sono stati descritti casi di recidive avvenuti 50 giorni dopo una diminuzione della temperatura corporea. Anche il numero di recidive può variare (1-3).
Le recidive della malattia sono apparentemente dovute a un'insufficiente irritazione antigenica e alla debolezza della risposta immunitaria del corpo. Questi stessi motivi causano la diversa durata della malattia.
In base alla gravità si distinguono forme leggere, moderate e gravi. Nel determinare il grado di gravità, vengono presi in considerazione l'altezza della febbre, la gravità dell'intossicazione, l'intensità dei segni clinici e la presenza di complicanze.
Negli ultimi anni, a causa della mutata resistenza del corpo e del trattamento precoce, il decorso “classico” della febbre tifoide e della febbre paratifoide è relativamente raro. Più spesso, si osservano casi di insorgenza relativamente acuta della malattia con un forte aumento della temperatura corporea nei primi 3 giorni e alcuni pazienti avvertono brividi. La durata della febbre, dovuta all'uso di antibiotici, si è ridotta ad una media di 2 settimane. Una diminuzione della temperatura corporea si verifica spesso come lisi abbreviata o critica. Spesso questo è seguito da una lieve febbre. La pelle pallida e secca è attualmente un fenomeno raro; a volte si nota anche iperemia facciale. L'eruzione cutanea roseola, tipica del decorso classico della febbre tifoide, si verifica in meno della metà dei pazienti e compare un po' prima.
Nei pazienti, l'intossicazione generale, il mal di testa, l'insonnia e l'adinamia sono meno pronunciati; l'appetito è spesso preservato, i cambiamenti nel sistema cardiovascolare e in altri sistemi sono relativamente rari. Una tipica condizione tifoide si osserva in circa 1/4-1/5 dei pazienti. Le complicanze più comuni in passato erano la bronchite e la polmonite; attualmente si verificano solo in alcuni pazienti. Occasionalmente, i pazienti riscontrano un aumento delle dimensioni del fegato, della milza, cambiamenti nel sangue e nelle urine. Ciò non significa però che anche oggi non possano verificarsi forme gravi di febbre tifoide con varie complicazioni, tra cui peritonite, sanguinamento intestinale, ecc.
Nei bambini, il quadro clinico della febbre tifoide è caratterizzato da alcune caratteristiche. L'esordio della malattia è spesso accompagnato da vomito e diarrea; spesso l'eruzione cutanea roseola non si esprime. Nei pazienti di età inferiore ai 2 anni non vi è bradicardia, ipotensione e perforazione intestinale a causa delle caratteristiche strutturali degli elementi linfoidi. In alcuni pazienti, la febbre tifoide è accompagnata da danni primari ai polmoni, alle meningi, al fegato, alla cistifellea e ai reni.
Le complicanze della febbre tifoide possono essere: sanguinamento intestinale, perforazione della parete dell'intestino tenue e della cistifellea seguita da peritonite, colecistite, pielocistite, polmonite focale, parotite, stomatite, piaghe da decubito, tromboflebite, artrite e altre.
Il sanguinamento intestinale si verifica più spesso nella terza settimana di malattia e successivamente. Il suo sviluppo è facilitato dalla ridotta permeabilità delle pareti vascolari dovuta a processi ulcerativi nell'area dei follicoli linfatici del gruppo, diminuzione della coagulazione del sangue e, di conseguenza, formazione più lenta di trombi, errori nella dieta, aumento della motilità intestinale, flatulenza, ipovitaminosi C Il sanguinamento intestinale è accompagnato da
diminuzione a breve termine della temperatura corporea, aumento della frequenza cardiaca (Fig. 3), pallore della pelle, comparsa di sudore freddo, indebolimento temporaneo dei sintomi di intossicazione, aumento della peristalsi, comparsa di sangue nelle feci sotto forma di coaguli o impurità (feci catramose).

In precedenza, il sanguinamento intestinale si sviluppava nel 5-6% dei pazienti, attualmente - in circa il 2%.
Come risultato di un processo ulcerativo profondo (Fig. 4), è possibile la perforazione di un'ulcera intestinale con successivo sviluppo di peritonite.

Più spesso, il sito di perforazione è localizzato nell'ileo 25-50 cm sopra la valvola ileocecale. La particolarità della peritonite tifoide è che i suoi sintomi sono mascherati da gravi manifestazioni di intossicazione da tifo, a seguito delle quali potrebbe non esserci dolore da "pugnale". Il dolore addominale non è acuto, la tensione muscolare nella parete addominale anteriore è lieve. La complicazione è preceduta dallo sviluppo del collasso, accompagnato da una diminuzione della temperatura corporea e dalla comparsa di tachicardia (“forbici”). Successivamente, la flatulenza aumenta, l'ottusità del fegato scompare o diminuisce; Compaiono nausea, vomito, ipertermia e i tratti del viso diventano più nitidi. La peritonite può verificarsi anche a causa della perforazione della parete della colecisti. Al giorno d'oggi, le perforazioni si verificano quasi con la stessa frequenza del passato.
Durante il processo di diffusione parenchimale, il bacillo tifoide può entrare nei polmoni e provocare specifiche alterazioni nel tessuto polmonare, simili a quelle dell'apparato linfatico dell'intestino tenue (proliferazione delle cellule reticoloendoteliali locali). Oltre a quelle specifiche, è possibile anche la polmonite focale secondaria, il cui sviluppo è facilitato dall'ipostasi, dall'insufficiente produzione di espettorato, dai disturbi della circolazione polmonare e della ventilazione. La frequenza della polmonite e della pleurite è ora diminuita di circa 6 volte, dal 30 al 5%.
Possono sorgere complicazioni nell'area della cistifellea e dei dotti biliari, poiché a causa delle caratteristiche anatomiche, gli agenti patogeni trovano lì le condizioni ottimali per la vita e la riproduzione. L’incidenza di queste complicazioni è ora leggermente diminuita.
Alla fine della terza settimana di malattia, alcuni pazienti sviluppano dolore al cuore, ottusità dei suoni cardiaci, scissione del primo tono, disturbi del ritmo, tachicardia, aumento delle dimensioni trasverse del cuore e cambiamenti nella l'elettrocardiogramma. Tutto ciò indica lo sviluppo di danni tossici infettivi al miocardio. Attualmente questa complicanza è diminuita dal 10-17 al 2,5%.
A volte si verificano altre complicazioni: tromboflebiti, parotite, artrite. Con un trattamento tempestivo e razionale, sono rari.
TYPHUS, COPPIA TYPHUS A E COPPIA TYPHUS.
La febbre tifoide, le febbri paratifoidi A e B sono malattie infettive acute caratterizzate da batteriemia, danni al sistema linfatico dell'intestino tenue, accompagnati da febbre caratteristica, sintomi di intossicazione generale ed epatosplenomegalia, spesso con eruzione roseola.
EZIOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA DEL TIFO
Gli agenti causali delle malattie tifo-paratifo includono:
Alla famiglia dei batteri intestinali Enterobacteriaceae,
Al genere Salmonella.
L'agente eziologico della febbre tifoide è la Salmonella typhi.
L'agente eziologico del paratifo A è la Salmonella paratyphi A (Salm. paratyphi A) o il Bacterium paratyphi A.
L'agente eziologico del paratifo B è la Salmonella paratyphi B (Salm. paratyphi B) o il Bacterium paratyphi B.
Loro hanno:
la forma di bastoncini con estremità arrotondate, la loro lunghezza varia da 1 a 3 micron e la loro larghezza da 0,5 a 0,6 micron.
flagelli, mobili
non formano spore o capsule
dipingere bene con coloranti all'anilina, Gr-.
aerobi facoltativi
crescere bene su terreni nutritivi contenenti bile.
la temperatura ottimale per la crescita è 37°C e il pH del terreno è leggermente alcalino (7,2-7,4).
IN antigenicamente I microbi del tifo contengono:
1 L'antigene O somatico è stabile al calore; può essere conservato facendo bollire la coltura per 3-5 ore.
2. L'antigene H flagellare è termolabile.
Entrambi gli antigeni, quando somministrati agli animali per via parenterale, fanno sì che formino anticorpi completamente diversi e strettamente specifici.
3 . Antigene Vi somatico termolabile di superficie.
I batteri del tifo non producono esotossina, ma contengono solo endotossina.
Nell'ambiente esterno, i batteri del tifo sono relativamente stabili. Resistono al riscaldamento fino a 50° per un'ora, ma a 100 muoiono all'istante. Rimangono nell'acqua corrente per 5-10 giorni, nell'acqua stagnante - 30 giorni o più, nel limo dei pozzi - diversi mesi, nei pozzi neri - più di un mese, su frutta e verdura - 5-10 giorni, sui piatti - 2 settimane, sott'olio, formaggio, carne - 1-3 mesi, nel pane - 1-2 mesi, nel ghiaccio - 60 giorni o più. Sotto l'influenza di soluzioni di sublimato (1:1000), fenolo, lisolo, cloramina, i batteri muoiono entro 2-3 minuti.
Epidemiologia.
La febbre tifoide e il paratifo A sono tipiche antroponosi. L'infezione da paratifo B si verifica non solo negli esseri umani, ma anche in alcuni animali e uccelli.
Quasi l'unica fonte di infezione da febbre tifoide è una persona malata o un portatore di batteri. È consuetudine distinguere tra portatori di batteri che hanno avuto una storia di malattia (portatori di batteri - convalescenti) e portatori di batteri che non sono stati malati - sani o da contatto.
La durata distingue acuto trasporto batterico con rilascio di microbi fino a 3 mesi e cronico con una durata di escrezione batterica superiore a 3 mesi. Tipicamente, i portatori di batteri cronici si formano tra i convalescenti, mentre i portatori sani o da contatto, di regola, sono portatori temporanei (transitori).
Il paziente secerne insieme i microbi della febbre tifoide, del paratifo A e del B con feci, urina e saliva. La maggior parte dei batteri viene rilasciata nel momento culminante della malattia, ma il paziente diventa contagioso fin dai primi giorni della malattia e anche negli ultimi giorni del periodo di incubazione. L'urina è più pericolosa delle feci in termini di dispersione dell'infezione, perché la minzione avviene più frequentemente della defecazione.
Meccanismo di infezione - oro-fecale, che viene implementato percorsi nutrizionali, idrici e di contatto con la famiglia. Il modo più semplice e comune di diffondere le malattie tifo-paratifo è attraverso il contagio di persone sane attraverso il contatto con persone malate. Questa è la cosiddetta via di diffusione dell'infezione da contatto domestico.
Il contatto potrebbe essere diretto quando si verifica la trasmissione diretta dell'infezione (il più delle volte attraverso le mani sporche), e indiretto quando la malattia viene trasmessa attraverso oggetti domestici (biancheria, stoviglie, maniglie delle porte, soprattutto dei bagni, ecc.). La mosca domestica svolge un ruolo importante nella trasmissione della malattia tifoide attraverso il cibo.
Si verificano prevalentemente epidemie di febbre tifoide in estate e autunno, quando la messa in sicurezza e la diffusione dell'agente patogeno è facilitata sia dalla temperatura dell'aria che dal consumo più frequente di acqua contaminata da parte della popolazione senza osservare le dovute precauzioni.
Dopo aver sofferto di febbre tifoide e paratifo, immunità persistente e di lunga durata (15-20 anni).
Patogenesi e anatomia patologica della febbre tifoide (stadi).
L'infezione da febbre tifoide si verifica a causa della penetrazione di agenti patogeni attraverso la bocca nell'intestino, perché Il punto di ingresso dell’infezione è il tratto digestivo. Se l'agente patogeno supera le prime barriere fisiologiche che lo ostacolano (l'ambiente acido del succo gastrico, la funzione barriera della mucosa intestinale intatta), la malattia si sviluppa sotto forma di una catena di fenomeni alternati e interconnessi o di un collegamento
1. fase di introduzione e deriva linfatica (1-3 settimane) agente patogeno nel corpo, corrispondente all'inizio del periodo di incubazione. La dose infettiva è di 10x7 -10x9 cellule batteriche.
Essendo penetrati nel tratto gastrointestinale insieme al cibo contaminato, i batteri del tifo-paratifo non rimangono a lungo nel lume intestinale. Alcuni di essi vengono escreti con le feci (escrezione batterica durante il periodo di incubazione). Un'altra parte dell'agente patogeno invade le formazioni linfatiche della parete dell'intestino tenue (follicoli solitari e loro grappoli, placche di Peyer) e raggiunge i linfonodi regionali più vicini (mesenterici) attraverso il tratto linfatico dell'intestino. Successivamente, l'agente eziologico della febbre tifoide penetra nei linfonodi retroperitoneali.
2. sviluppo di linfangite e linfoadenite (1-3 settimane) nell'area dell'intestino tenue - corrisponde alla fine del periodo di incubazione.
Il sistema linfatico e il tessuto linfoide hanno un tropismo speciale per gli antigeni tifoidi. Penetrando nelle formazioni linfatiche, l'agente patogeno inizia a moltiplicarsi qui intensamente. La riproduzione e l'accumulo dei batteri del tifo-paratifo nelle formazioni linfatiche dell'intestino tenue e dei suoi linfonodi regionali porta allo sviluppo di un processo infiammatorio in essi.
3. batteriemia (1a settimana di malattia) - corrisponde alla fine del periodo di incubazione e all'inizio delle prime manifestazioni cliniche della malattia.
Subito dopo l'inizio del processo infiammatorio nei linfonodi, la funzione di ritenzione di questi ultimi risulta insostenibile. Gli agenti patogeni che si moltiplicano dai linfonodi retroperitoneali penetrano nel dotto toracico linfatico comune e quindi nel flusso sanguigno.
4.intossicazione.
La circolazione dei microbi nel sangue dovuta alle proprietà battericide di questi ultimi è accompagnata dalla loro morte parziale e dal rilascio di endotossina. L'effetto generale dell'endotossina è espresso da quei sintomi clinici che sono stati a lungo associati all'intossicazione: aumento dello stato tifoide, alterazione della termoregolazione, disturbi del sistema nervoso centrale e autonomo, ridotta attività cardiovascolare, ecc.
5. diffusione parenchimale da parte dei microbi - l'altezza della malattia - 2-3 settimane di malattia
I microbi provenienti dai siti di riproduzione vengono trasportati dal flusso sanguigno in tutto il corpo e si depositano in vari organi e tessuti. Soprattutto molti di essi si registrano nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo, nel fegato e in generale dove sono presenti elementi sistemi di fagociti mononucleari (MPS)). I granulomi tifoidi si formano negli organi interni. Il verificarsi di esantema a seguito dell'introduzione dell'agente patogeno nei vasi del derma e dello sviluppo di cambiamenti produttivi-infiammatori in esso.
6. rilascio dell'agente patogeno dal corpo
Questo processo è principalmente legato alla funzionalità epatica. Il sistema dei dotti biliari e le ghiandole di Lieberkühn dell'intestino sono la via principale per l'eliminazione dei microbi. Inoltre, vengono escreti nelle urine (circa il 25%), poi nella saliva e nel latte della madre che allatta.
7. reazioni allergiche.
Un gran numero di batteri viene rilasciato dai dotti biliari e dalle ghiandole del liberkühn nel lume intestinale. Alcuni di essi vengono espulsi meccanicamente insieme alle feci, l'altra parte invade nuovamente le placche di Peyer e i follicoli solitari, già sensibilizzati dall'invasione primaria. A causa della sensibilizzazione, il processo infiammatorio acquisisce un carattere iperergico con lo sviluppo di necrosi e ulcere simili al fenomeno di Arthus.
8. formazione dell'immunità e ripristino dell'equilibrio disturbato del corpo.
Aumento della produzione di anticorpi e dell’attività fagocitaria dei macrofagi. Pulizia delle ulcere dalle masse necrotiche - il periodo delle "ulcere pulite". Normalizzazione del MC e ripristino degli organi interni f-esimi danneggiati.
Anatomia patologica.
I principali cambiamenti morfologici nelle malattie tifo-paratifo si osservano nell'apparato linfatico dell'ileo, nell'area che passa direttamente nel cieco (ileotifo).
Lo sviluppo di alterazioni patologiche nella febbre tifoide è solitamente suddiviso in cinque periodi.
1. stadio di "gonfiore cerebrale". 1a settimana
Durante questo periodo, le placche di Peyer e i follicoli solitari si gonfiano, aumentano di volume e sporgono nel lume intestinale sotto forma di letti. Quando vengono tagliate, queste formazioni hanno un colore grigio-rosso, che ricorda la sostanza del cervello di un bambino, da cui il termine.
2. fase di necrosi - 2a settimana
Le placche gonfie iniziano a necrotizzare. La loro superficie diventa grigio sporco e verde-giallastro.
3. Stadio di ulcerazione al decorso “classico” della febbre tifoide corrisponde fine della 2a e inizio della 3a settimana malattie.
4. Entro la fine della 3a inizio della 4a settimana la malattia, termina il rigetto delle masse necrotiche e inizia il quarto periodo - stadio di ulcere pulite .
5 . Quinto periodo (quinta e sesta settimana) caratterizzato da processi guarigione delle ulcere. Nella sede delle ulcere rimane una leggera pigmentazione grigio ardesia.
Specifici granulomi tifoidi, oltre all'ileo, si sviluppano nei linfonodi regionali della cavità addominale (mesentere) e spesso nei linfonodi retroperitoneali. Oltre ai linfonodi della cavità addominale, sono colpiti altri linfonodi: bronchiali, tracheali, paratracheali, mediastinici. I principali cambiamenti nella febbre tifoide si riscontrano in milza, midollo osseo(emorragie, piccoli noduli necrotici e granulomi tifoidi). IN fegato si osservano fenomeni di degenerazione proteica e grassa di vario grado.
Da fuori più nervoso del sistema C'è iperemia e gonfiore delle meningi e nella materia cerebrale sono presenti danni a piccoli vasi e noduli di elementi gliali moltiplicati. Vengono descritti i cambiamenti degenerativi nel sistema nervoso autonomo; sono colpiti i nodi simpatici e il sistema del plesso solare. I disturbi cardiovascolari osservati nella febbre tifoide sono il risultato dell'azione di endotossine e microbi sui centri che regolano le funzioni degli organi circolatori nel sistema nervoso centrale e autonomo. Come sintomi cardiovascolari, come bradicardia relativa, dicrotia del polso, ipotensione sono spiegate da danni degenerativi alle cellule gangliari dei nodi del sistema nervoso simpatico. Cambiamenti degenerativi vengono rilevati nel muscolo cardiaco.
Classificazione della febbre tifoide.
La classificazione più ampia e generalmente accettata delle forme cliniche della febbre tifoide è quella proposta da B.Ya. Padalka (1947). La febbre tifoide si divide in:
Forme tipiche
Medio-pesante;
Forme atipiche.
Abortivo
cancellato (tifo "lieve" e ambulatoriale)
non diagnosticato (apiretico o con febbricola)
mascherato, suddiviso secondo il principio del danno predominante ai singoli organi e sistemi: pneumotifo, meningotifo, colotifo, nefrotifo, forma settica (sepsi tifoide), ecc.
Clinica di una forma tipica di febbre tifoide.
Periodo di incubazione(il tempo che intercorre dal momento dell'infezione all'insorgenza della malattia) dura in media da 10 a 14 giorni, ma può essere ridotto a 7 ed esteso a 23 giorni. La durata del periodo di incubazione è determinata principalmente dalle caratteristiche individuali del corpo del paziente. Dipende anche dalla quantità di agente infettivo entrato nel corpo durante l'infezione.
Il quadro clinico della febbre tifoide è caratterizzato da una ciclicità chiaramente definita e da un decorso graduale. Si distinguono: periodi (fasi):
primo, periodo iniziale - periodo di fenomeni in aumento (stadio incrementi);
Secondo periodo - periodo di pieno sviluppo della malattia (San. fastigii);
terzo periodo - il periodo di massima tensione dei processi patologici (San. acme)
Il quarto periodo - periodo di indebolimento delle manifestazioni cliniche (San. decrementi)
quinto periodo - periodo di recupero o convalescenza (San reconvalescentiae).
Di regola, la malattia inizia gradualmente. Nei primi giorni il paziente rimane solitamente in piedi, avvertendo solo malessere generale, aumento della fatica, irritabilità, brividi, perdita di appetito e mal di testa. Alcuni medici classificano queste manifestazioni iniziali della malattia come sintomi prodromici, che si osservano nella maggior parte dei pazienti.
Successivamente, 1 viene distribuito. fase di aumento dei fenomeni(dura circa una settimana).
La salute del paziente peggiora, appare una significativa debolezza, il mal di testa si intensifica, si manifesta l'insonnia e il paziente è costretto ad andare a letto. La temperatura sale gradualmente a forma di scala e al 4-5° giorno di malattia raggiunge i 39-40*. In alcuni pazienti, la febbre tifoide potrebbe non iniziare gradualmente, ma in modo acuto.
A ricerca oggettiva nel periodo iniziale si osserva lingua patinata, flatulenza moderata, milza ingrossata e relativa bradicardia.
Nel sangue periferico, nei primi 3-4 giorni di malattia, si osserva leucocitosi, sostituita successivamente da leucopenia con relativa linfocitosi e aneosinofilia.
Da 5-7 giorni dall'inizio si verifica la malattia 2. periodo di pieno sviluppo dei fenomeni dolorosi.
Durante questo periodo è già espresso stato tifoso - adinamia, blackout, coscienza spesso stordita o stuporosa, delirio, solitamente in presenza di temperatura elevata. Mal di testa e insonnia spesso diventano dolorosi. La temperatura rimane alta e costante.
Ricerca oggettiva: il viso è pallido e un po' gonfio, le labbra sono secche, screpolate, lo sguardo è assonnato, indifferente, l'espressione del viso è povera e fiacca. Di solito il paziente non mostra alcun interesse per ciò che lo circonda; sembra “entrare nel suo mondo interiore”.
Si nota la secchezza delle mucose della cavità orale. La lingua è ricoperta da un rivestimento bianco-grigiastro, ad eccezione dei bordi e della punta, che sono di colore rosso vivo. ("lingua tifoide" ). Nei casi più gravi, la lingua diventa secca e ricoperta da una patina marrone. (“lingua fuliginosa”), soprattutto con un'igiene orale insufficiente. La lingua è ispessita, ci sono segni di denti su di essa, è difficile estenderla ("lingua fritta") e comincia a tremare quando sporge. Durante il periodo di convalescenza si libera gradualmente dalla placca e diventa rossa con papille ipertrofiche, somiglianti ad una lingua scarlatta.
Accorciamento del suono della percussione nella regione ileocicale – Segno di Padalka/Stenberg..(=> iperplasia dei linfonodi infiammatori).
Le feci solitamente vengono trattenute; in alcuni casi si possono osservare delle feci forma di zuppa di piselli. Nella faringe si notano spesso iperemia e ingrossamento delle tonsille fin dai primi giorni della malattia. I cambiamenti infiammatori nella faringe sono così pronunciati che possiamo parlare di tonsillite tifoide (la cosiddetta Angina di Duguay ).
Temperatura corporea – fino a 39-40˚.
Carattere costante: tipo Wunderlich.
![]()
Multi-onda x-r – Tipo Botkin.
![]()
Un'onda è del tipo "piano inclinato" - secondo Kildyushevskij.
Dal sistema cardiovascolare si notano bradicardia relativa, ipotensione e dilatazione del polso. Nello stesso periodo (8-10 giorni di malattia) compare un sintomo tipico della febbre tifoide: eruzione cutanea roseola. L'eruzione cutanea Roseola ha l'aspetto di macchie rosa, di forma rotonda, di 2-2,5 mm di diametro, nettamente limitate da una pelle sana e invariata. Quando la pelle viene tesa o premuta nella zona della roseola, l'eruzione cutanea scompare; dopo che lo stiramento o la pressione si fermano, l'eruzione cutanea ricompare. L'eruzione cutanea di solito appare sulla pelle dell'addome e sui lati del torace. Il numero di roseole sulla buccia è solitamente piccolo: non supera i 20-25 elementi e nella maggior parte dei casi è limitato a 4-6 elementi individuali. Dopo che l'eruzione cutanea scompare, rimane una pigmentazione della pelle appena percettibile. Quelli nuovi potrebbero apparire sullo sfondo di quelli vecchi - fenomeno dell'addormentarsi. Il sintomo di Filippovich - scolorimento itterico della pelle dei palmi e delle piante dei piedi - ipercromia carotenica della pelle.
3. La fase di massima tensione dei processi patologici. A causa del danno tossico al sistema nervoso, i pazienti durante questo periodo possono cadere in uno stato soporoso o comatoso. In questo caso si osservano spesso contrazioni convulsive dei muscoli facciali, tremori degli arti, movimenti involontari delle dita, minzione involontaria e defecazione.
Lo stadio di pieno sviluppo della malattia dura circa due settimane, quindi tutti i sintomi iniziano gradualmente a indebolirsi e scomparire: si sviluppa 4. periodo di indebolimento dei fenomeni clinici. La temperatura, prima costante, comincia a dare remissioni mattutine sempre più marcate e diminuisce a seconda del tipo di lisi. Tutti i sintomi scompaiono gradualmente. La coscienza diventa più chiara, il sonno viene ripristinato e appare l'appetito. La milza e il fegato si riducono di dimensioni, le mucose vengono idratate e la lingua viene liberata dalla placca.
Durata totale Il periodo febbrile per la febbre tifoide è di circa 4 settimane.
Con la normalizzazione della temperatura, il paziente entra nell'ultimo, ultimo periodo della malattia -
5. periodo di convalescenza. Le funzioni corporee compromesse vengono gradualmente ripristinate, ma la debolezza e la maggiore irritabilità del sistema nervoso possono persistere a lungo.
I cambiamenti degenerativi in un numero di organi parenchimali rimangono significativamente più lunghi dei sintomi clinici della malattia. Durante questo periodo possono comparire numerose complicazioni tardive (periostite, osteomielite, colecistite, tromboflebite, ecc.). In assenza di complicazioni, va tenuto presente che a volte l'apparente guarigione del paziente può essere seguita da un ritorno della malattia - una ricaduta.
La curva della temperatura riflette bene il decorso della malattia, la sua gravità e durata. È stato a lungo considerato tipico della febbre tifoide trapezoidale curva della temperatura che riflette gli stadi patogenetici della malattia (il cosiddetto Curva meravigliosa ).
S.P. Botkin considerava la caratteristica più caratteristica della febbre tifoide la sua ondulazione, alternanza di aumenti di più giorni o ondate di febbre con la loro attenuazione.
Secondo I. S. Kildyushevsky (1896), nella febbre tifoide, molto spesso non si verifica un aumento graduale della temperatura nell'arco di 4-8 giorni, ma relativamente rapido, che non dura più di 3 giorni.
Complicazioni della febbre tifoide (cause, quadro clinico, tattiche di trattamento).
Le complicanze delle malattie tifoparatifo sono suddivise in
specifico, causato dall'influenza patogena dell'agente patogeno e della sua tossina
Sanguinamento intestinale
Perforazioni intestinali
Shock infettivo-tossico
non specifico, causato dalla microflora accompagnatoria.
Polmonite
Meningite
Pielite
Parotite
Stomatite, ecc.
1. Sanguinamento si verificano a seguito di processi ulcerativi nelle placche intestinali di Peyer, quando l'integrità dei vasi viene interrotta, specialmente durante il periodo di rigetto delle masse necrotiche (di solito nella 3a settimana della malattia, ma a volte più tardi). Con un sanguinamento grave, appare un forte pallore della pelle e i tratti del viso diventano più nitidi. Aumenta la debolezza generale, compaiono vertigini. La temperatura di solito scende alla normalità o addirittura inferiore. Il polso accelera, diventa piccolo e la dicrotia scompare. Sta accadendo intersezione della temperatura e della curva del polso(così chiamato forbici ). La pressione sanguigna diminuisce. A volte si sviluppa il collasso. Durante il sanguinamento, la coscienza può diventare più chiara, il che è associato a una diminuzione della tossiemia dovuta alla perdita di sangue. Viene creato un miglioramento immaginario della condizione.
Il giorno successivo (meno spesso il giorno dell'emorragia), le feci assumono un tipico aspetto catramoso sotto forma di melena. A volte il sangue scarlatto viene rilasciato dall'intestino o parzialmente sotto forma di coaguli.
Ciò avviene nei seguenti casi: 1) se alle feci segue sanguinamento;
2) se l'emorragia è stata troppo massiccia;
3) se si è verificato un sanguinamento nel segmento inferiore dell'intestino tenue.
2. La complicanza più grave della febbre tifoide è perforazione di ulcera intestinale con successivo sviluppo di peritonite. La mortalità per perforazione è molto elevata e dipende sia dalla velocità di riconoscimento di questa formidabile complicanza, sia dai tempi dell'intervento chirurgico. Circa 1/4-1/3 dei decessi dovuti alla febbre tifoide sono causati dalla perforazione intestinale. Un'operazione eseguita entro e non oltre 6-12 ore dalla perforazione aumenta notevolmente le possibilità di recupero. La perforazione si verifica soprattutto nel momento culminante della malattia, a 3-4 settimane e molto più spesso nei casi più gravi, accompagnata da elevata flatulenza, diarrea e sanguinamento. Tuttavia, la perforazione può verificarsi in casi molto lievi e, inoltre, avvenire in modo del tutto inaspettato.
Queste caratteristiche consistono principalmente nel fatto che la peritonite tifoide ripete relativamente raramente il quadro tipico di un “addome acuto”, così comune per la perforazione delle ulcere dello stomaco, del duodeno e dell'appendice. In molti casi, il decorso della peritonite tifoide è così mascherato dai principali fenomeni tifoidi che i suoi sintomi caratteristici sono assenti. Quando si verifica una perforazione intestinale in pazienti con febbre tifoide, si avverte un dolore improvviso e grave; con cui i medici si confrontano il dolore di un “colpo di pugnale” spesso non viene notato. Pertanto, la comparsa anche di un leggero dolore addominale in un paziente con febbre tifoide dovrebbe attirare particolare attenzione. L'intensità di questi dolori può variare: da pronunciata a appena percettibile al momento dell'esame.
Il secondo segno cardinale della peritonite è contrazione locale dei muscoli della parete addominale anteriore. Nei pazienti gravemente malati con annebbiamento della coscienza, questo potrebbe essere l'unico segno. La contrazione muscolare locale, la protezione muscolare, appare sempre sopra la sede della peritonite incipiente; caratterizza lo stato di preperforazione. Sintomi meno chiari, ma anche molto importanti della peritonite perforata sono i seguenti dati (E.L. Tal):
un sintomo di movimento ritardato della parete addominale durante la respirazione, soprattutto quando il paziente non ha la polmonite al momento dell'esame;
assenza di suoni intestinali durante l'auscultazione dell'addome; va comunque sottolineato che la presenza di soffi non esclude la possibilità di peritonite;
dolore del peritoneo nella parte inferiore del bacino durante l'esame;
Sintomo di Shchetkin-Blumberg
4-6 ore dopo la perforazione, lo stomaco inizia a gonfiarsi, compaiono vomito e singhiozzo. L'ottusità epatica scompare a causa dell'elevazione verso l'alto della parte trasversale del colon. Il diaframma si alza, la respirazione si accelera, diventa superficiale e negli uomini assume un tipo toracico. Il viso è pallido, i lineamenti sono affilati, l'espressione è simile a una maschera. Appare il sudore freddo. Se la temperatura scende a causa del collasso, inizia a salire. La leucocitosi con neutrofilia appare nel sangue. Il paziente giace sulla schiena con le ginocchia e le anche piegate. Nella peritonite diffusa, se l'intervento chirurgico non viene seguito nelle prime 6-12 ore, i pazienti muoiono nel terzo o quarto giorno.
Di conseguenza, i segni classici della peritonite perforata, come diminuzione dell'ottusità epatica, flatulenza, ipo o ipertermia, leucocitosi, vomito, singhiozzo, cianosi, spesso compaiono troppo tardi. In questi casi la fattibilità dell’intervento chirurgico diventa molto problematica.
Diagnosi di laboratorio della febbre tifoide.
Il primo e il più affidabile dei metodi batteriologici per la diagnosi di laboratorio della febbre tifoide è l'emocoltura con isolamento dell'emocoltura. L'emocoltura è un segno assoluto (diagnosi decisiva) di febbre tifoide. Le emocolture dovrebbero essere sempre eseguite se si sospetta la malattia da tifoparatifo in qualsiasi giorno di malattia quando il paziente ha la febbre. Buoni ambienti per coltura del sangue sono 1 Brodo biliare allo 0% e terreno Rappoport. Il sangue per l'inoculazione viene prelevato da una vena nella prima settimana in una quantità di 10 ml, successivamente 15-20 ml e inoculato al capezzale del paziente in un mezzo nutritivo in un rapporto di 1:10. È possibile utilizzare roseocoltura, mielocoltura, coprocoltura, urinocoltura, bicoltura, ecc.
Ai fini della conferma di laboratorio della diagnosi di febbre tifoide, soprattutto nei casi in cui gli esami precedenti sono negativi, si dovrebbe utilizzare anche Reazione di aumento del titolo dei fagi (RFT) Con la necessità di una diagnosi precoce e rapida della febbre tifoide, viene utilizzato metodo di immunofluorescenza.
Il metodo di ricerca sierologica più comune è Reazione di Vidal. La reazione Widal si basa sul fatto che nel sangue del paziente si accumulano agglutinine specifiche in relazione al corrispondente agente patogeno: i microbi del tifo. Le agglutinine nei pazienti con febbre tifoide e paratifo compaiono nel sangue già entro il 4° giorno di malattia e aumentano bruscamente entro l'8-10° giorno di malattia,