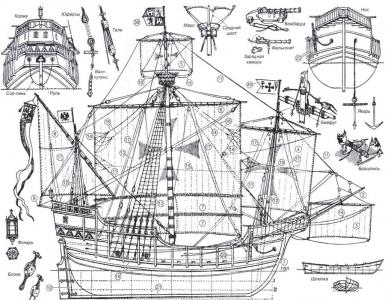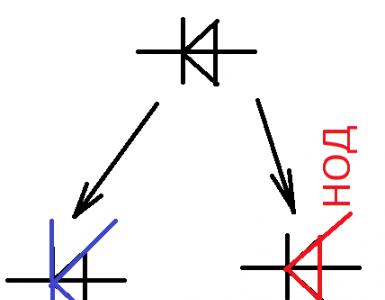Saggio: un mondo senza guerre, finzione o realtà. Un mondo senza guerra. Conflitti interstatali e interessi nazionali
È possibile nella nostra epoca un mondo senza guerre e senza sabotaggio ideologico dell’imperialismo? Se sì, quali nuove condizioni assicurano la trasformazione di questa possibilità in realtà?
I. Sidorov, Mosca
LE RISPOSTE DARANNO LA VITA
QUANDO SI RISPONDONO a queste complesse domande, si dovrebbero tenere in considerazione le dichiarazioni di M. S. Gorbaciov nel suo discorso al Plenum del Comitato Centrale del PCUS di febbraio (1988) e nel rapporto “Ottobre e Perestrojka: la Rivoluzione continua”.
La domanda è se il capitalismo sarà in grado di adattarsi alle condizioni di un mondo senza nucleare e disarmato, alle condizioni di un nuovo ed equo ordine economico, alle condizioni di un confronto onesto dei valori spirituali dei due mondi? Queste non sono domande oziose.
La vita ti darà risposte. La correttezza del programma per un mondo sicuro e libero dal nucleare sarà messa alla prova non solo dall’impeccabilità della sua giustificazione scientifica. Sarà messo alla prova dal corso degli eventi, che è soggetto all'influenza di forze molto diverse e nuove.
Nel sistema di argomentazioni a questo proposito, si richiama l'attenzione su un aspetto storico molto importante della fondatezza scientifica delle domande poste: la manifestazione di un certo modello sociologico generale o una tendenza al cambiamento nelle relazioni internazionali.
È interessante notare che il sistema delle relazioni internazionali, che rappresenta una formazione socioeconomica vecchia e superata, lascia l'arena storica molto prima che il nuovo modo di produzione si sia affermato ovunque. L’era moderna della transizione dal capitalismo al socialismo è un ovvio argomento a favore di questo processo. Ma anche nell'era del passaggio alla schiavitù, quando il primitivo sistema comunitario non aveva ancora lasciato l'arena storica ed esisteva la proprietà pubblica, tuttavia, come notò F. Engels, la guerra - le incursioni a scopo di rapina - si diffusero.
Oggi, quando la questione del disarmo come risultato degli accordi sovietico-americani è stata portata a un livello pratico, è utile ricordare ai suoi oppositori e scettici che prima delle età del bronzo e del ferro esisteva, in senso figurato, un’“età dell’oro”. , un periodo nella vita di una società in cui le armi erano specializzate per uccidere le persone, non ce n'era affatto. Vale la pena ricordarlo ancora una volta, dal momento che gli apologeti del militarismo parlano ostinatamente e in ogni modo possibile di una sorta di belligeranza primordiale e di "geni dell'aggressività" nell'uomo, "dell'eternità delle guerre e delle armi".
Le guerre divennero un compagno inevitabile dell'umanità sia sotto la schiavitù, sia sotto il feudalesimo, sia nell'era del capitalismo. Il numero delle vittime dei crimini di guerra imperialisti cresce di giorno in giorno e i fatti sono ben noti. Ma oggi, alla domanda se, nonostante la natura invariabilmente aggressiva dell’imperialismo, sia possibile garantire la pace e realizzare il disarmo, c’è motivo di dare una risposta affermativa e, soprattutto, ragionata.
I principali argomenti a favore della possibilità e della realtà di questa grande impresa sono i seguenti:
* un nuovo equilibrio di forze sulla scena internazionale a favore del progresso e del socialismo;
* iniziative di pace del PCUS e del governo sovietico;
* cambiamenti positivi nelle relazioni sovietico-americane e miglioramento del clima generale del pianeta;
* crescente coesione del movimento di protesta contro l'aggressione e la corsa agli armamenti;
* Crescente critica all'ideologia imperiale e al militarismo e a molti altri fattori.
CONTENERE LE FORZE DI AGGRESSIONE
TUTTO QUESTO È COSÌ, ma l'imperialismo è irto di guerre, come una nuvola di tempesta. Pertanto, è così importante sfatare e smascherare ideologicamente il militarismo, la politica di aggressione, il sabotaggio ideologico contro la pace e il disarmo e le false argomentazioni degli oppositori degli accordi tra URSS e USA. L’esplosione della disinformazione è particolarmente pericolosa nell’era termonucleare. Oltre ad altre conseguenze dannose, si tratta, prima di tutto, di una guerra psicologica contro i paesi socialisti, dell'organizzazione di "crociate" di campagne anticomuniste contro di loro. Il “libero flusso di informazioni”, di cui l'Occidente ama parlare, risulta essere il dettame di tre agenzie di stampa internazionali, che hanno concentrato nelle loro mani fino al 90% del volume dei messaggi. Per quanto riguarda l’informazione positiva sullo stile di vita dei paesi socialisti, vengono create molte barriere, restrizioni e divieti come parte della “tattica di silenzio”. C’è anche un’evidente distorsione a favore degli stereotipi dell’“immagine del nemico” nella guerra psicologica dei servizi segreti della NATO e del Pentagono contro la pace e il disarmo.
Per scoprire il vero significato di un fenomeno, gli scienziati spesso conducono un “esperimento mentale”. La sua essenza è generalmente semplice. Basta immaginare che questo fenomeno sia scomparso senza lasciare traccia, e poi immaginare quali conseguenze sociali comporterà questa scomparsa.
Utilizzando un metodo simile, invitiamo i lettori a immaginare un'immagine del genere. In un batter d’occhio, la disinformazione rumorosa e multivocale portata avanti dalla reazione politica, dalla propaganda militarista, dal razzismo e dal sionismo scomparirebbe. Molti giornali in Occidente avrebbero pubblicato spazi vuoti invece di articoli anticomunisti. Le voci insinuanti di chi si lascia guidare dalla ricetta: “le migliori bugie si fanno con le mezze verità” tacerebbero nell'aria. Spessi tomi multi-volume di antisovietici professionisti si ridurrebbero a quella quota di autenticità appena percettibile sotto forma di nomi di diffamatori, tuttavia, anche in questo non sono sempre reali.
In queste condizioni del nuovo ordine dell’informazione, la voce della gente comune del pianeta avrebbe un’ulteriore possibilità di essere ascoltata. Il potenziale democratico del nuovo pensiero politico acquisterebbe nuova forza e possibilità per la sua attuazione. La voce di quelle forze sane che esistono in ogni paese diventerebbe ancora più forte.
Di conseguenza, è necessario cercare e sfruttare sempre di più nuove opportunità per le forze progressiste per superare le manifestazioni negative della natura del capitalismo nel mondo moderno, frenare le forze di aggressione e di guerra e stabilire relazioni di buon vicinato e di pace che escludere l’incitamento all’ostilità e all’odio.
L’umanità ha letteralmente sofferto e portato avanti l’idea di convivenza pacifica attraverso epoche di innumerevoli guerre. La guerra e i mucchi di armi sono sempre stati nella gola della gente comune. Il “romanticismo” reazionario delle avventure militari è profondamente estraneo e ostile al lavoratore.
Recentemente, il presidente Reagan si è spesso soffermato nei suoi discorsi su episodi della lotta degli alleati contro il fascismo. Diamone uno in più. Si dice che quando, dopo l'assalto al Reichstag, un alto grado delle SS consegnò la sua arma personale - un dono del maniaco Fuhrer, disse con rabbia: "Ti abbiamo insegnato a combattere". Al che il soldato-operaio in piedi accanto all'ufficiale che ha accettato la resa ha semplicemente osservato: "E noi ti svezzeremo". La risposta – indipendentemente dal fatto che si tratti di una leggenda o di un fatto reale – ha un significato profondo, e vale la pena rifletterci.
Lo “svezzamento” dello Stato fascista dalla guerra è avvenuto a costo di incredibili sacrifici ed era già alle nostre spalle. Allora nessuno poteva nemmeno pensare che nel giro di pochi anni il fascismo avrebbe osato rialzare la testa, il complesso militare-industriale sarebbe diventato un pericolo formidabile e le sue ambizioni imperiali sarebbero aumentate. Il verbo “svezzeremo” è al futuro. K. Marx e V. I. Lenin hanno sempre notato la capacità dei lavoratori di guardare alla radice. E poi l'operaio aveva ragione. Dopo la sconfitta della Germania nazista, iniziò l’era dello “svezzamento” dell’imperialismo dalla guerra, principalmente con mezzi pacifici.
La cosa principale tra loro è il rafforzamento delle posizioni dei paesi socialisti, la loro maggiore autorità morale e politica e la capacità di difendersi in condizioni di parità strategico-militare.
È anche la forza crescente dell’opinione pubblica mondiale, la mente politica delle masse nella lotta contro la follia, lo sfatamento e il superamento dell’ideologia del militarismo, lo schiacciamento nella lotta delle idee dei pregiudizi imperialisti del militarismo e delle tendenze aggressive di reazione.
L’esempio dell’attuazione delle iniziative pacifiche del socialismo erode l’“immagine del nemico” creata dall’”imperialismo dell’informazione” durante i decenni della Guerra Fredda come un’assurdità dannosa. L’avventurismo delle ambizioni imperiali nell’era termonucleare diventa evidente a chiunque abbia un briciolo di buon senso. Oggi, sempre più persone sul nostro pianeta comprendono l'idea espressa da M. S. Gorbachev in un discorso al Plenum del Comitato Centrale del PCUS di febbraio (1988): “Senza preservare la pace, non ci sarà alcun progresso e parlare degli interessi di qualcuno è al di là della decisione, questo compito è inutile."
In una parola, i pregiudizi del militarismo e del pensiero imperiale hanno mostrato le prime profonde crepe. Tuttavia, la battaglia principale per il loro completo sfatamento e superamento ideologico è ancora da affrontare.
N. KEYZEROV, Dottore in Filosofia, prof
Saggio “Un mondo senza guerra”.
Da tempo immemorabile le persone hanno combattuto tra loro. Le ragioni erano molto diverse: dalle guerre iniziate a causa di faide, alla feroce divisione del potere e delle risorse in questo modo. Anche nell'antichità l'uomo ha dimostrato la sua superiorità, dimostrando esclusivamente il tuo livello di forma fisica e resistenza.
Sembrerebbe che nel mondo moderno, dove fin dall'infanzia vengono allevati in condizioni di tolleranza, tolleranza e sviluppano in modo completo il cittadino appena coniato per aiutarlo a diventare un degno membro della società, ci sia ancora un posto conflitti armati. Qual è la ragione di ciò adesso? Tutto è uguale: la lotta per condizioni migliori, terra, potere. Centinaia e migliaia di persone, compresi anziani, donne e bambini, partecipano inconsapevolmente alle ostilità e muoiono in numero colossale. Anche adesso ci sono diverse dozzine di guerre in corso in tutto il mondo, sia civili che di confronto aperto tra due o più stati. Qual e il punto? Tutto è uguale a diverse migliaia di anni fa: potere, terra, risorse.
Se si pensa a quanta materia prima e conoscenza vengono spese per il miglioramento e la produzione armi E equipaggiamento militare in tutto il pianeta, puoi essere inorridito. Questo basterebbe a sostenere diversi piccoli paesi per oltre dieci anni! Quante persone muoiono ogni giorno durante le operazioni militari? Molti di loro sono molto giovani e, forse, potrebbero raggiungere risultati in vari campi di attività. Alcuni diventerebbero medici intelligenti che salvano vite umane, altri diventerebbero poeti o artisti di talento il cui lavoro sarebbe ammirato dal mondo intero. Forse tra i morti c'era un potenziale scienziato che avrebbe potuto fare una svolta nel campo della scienza e della tecnologia e avrebbe cambiato la vita di tutti umanità per il meglio. E la natura? Come soffre a causa delle frequenti emissioni nell'atmosfera di prodotti trasformati o di sostanze nocive a seguito di esplosioni? Ci vorranno molti anni prima che il pianeta venga eliminato conseguenze della guerra, anche su scala più piccola.
Diventerà? mondo senza guerre Meglio? Indubbiamente! Ma purtroppo al momento possiamo cambiare poco; possiamo solo sperare nella prudenza delle persone che hanno dato inizio ai conflitti. È tempo di pensarci futuro genitori, mogli, figli, sul futuro dell’umanità. Dopotutto, se le risorse vengono spese per l'organizzazione ostilità, incanalato in una direzione pacifica, puoi raggiungere rapidamente un'elevata qualità della vita e cambiarla in meglio.
Introduzione.
1. Teorie del conflitto e della pace: concetti, approcci e metodi.
2. Conflitti ai vari livelli del sistema sociale.
2.1. Conflitto intergruppo.
2.2. Tipologia dei conflitti intergruppi.
2.3. Conflitti politici e nazionali.
2.4. Conflitti interstatali e interessi nazionali.
3. Polemiche moderne: pace e guerra.
Bibliografia.
introduzione
Il concetto di conflitto nella letteratura scientifica, così come nel giornalismo, è ambiguo. Esistono molte definizioni del termine “conflitto”. L’approccio più generale alla definizione del conflitto è definirlo attraverso la contraddizione come concetto più generale e, prima di tutto, attraverso la contraddizione sociale.
È noto che lo sviluppo di qualsiasi società è un processo complesso che si svolge sulla base dell'emergere, dello sviluppo e della risoluzione di contraddizioni oggettive. Pur sostenendo ciò a parole, la teoria marxista dominante per decenni essenzialmente non lo ha applicato alla nostra società. È noto che uno degli ideali del socialismo è l'assenza di conflitti di classe. Alla fine degli anni '30, diversi autori ebbero l'idea di uno sviluppo "privo di conflitti" di una società socialista, dell'assenza di contraddizioni antagoniste in essa. Questa idea è stata presentata in modo più completo nella tesi sulla completa corrispondenza dei rapporti di produzione nel socialismo con la natura delle forze produttive.
Successivamente, però, si è riconosciuto che questa corrispondenza si manifesta solo quando le contraddizioni sono accomunate dall'unità prevalente delle due parti contrapposte. La conformità è stata presentata come una certa fase nello sviluppo della contraddizione, quando gli opposti sono ancora uniti nel quadro dell'unità. La maggior parte dei filosofi che cercavano la principale contraddizione del socialismo la consideravano la contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione, a volte tra produzione e consumo, vecchio e nuovo, ecc.
In un modo o nell'altro, il problema delle contraddizioni è stato, in una certa misura, sviluppato nella nostra letteratura. Tuttavia, lo stesso non si può dire della teoria del conflitto; essenzialmente non le è stata prestata alcuna attenzione. Nel frattempo, contraddizioni e conflitti, da un lato, non possono essere considerati sinonimi e, dall'altro, non possono essere opposti tra loro. Contraddizioni, opposti, differenze sono condizioni necessarie ma non sufficienti per il conflitto. Gli opposti e le contraddizioni si trasformano in conflitto quando le forze che li sostengono cominciano a interagire. Pertanto, un conflitto è una manifestazione di contraddizioni oggettive o soggettive, espresse nel confronto delle parti.
È necessario aggiungere che nella società non si parla di forze astratte, né di fenomeni cosmici o altri fenomeni naturali, e soprattutto non di fenomeni immaginari (il destino, il diavolo, oggetti non identificati), ma di soggetti sociali: persone specifiche, siano esse individui, gruppi, strati sociali, partiti politici o stati.
Scopo: analizzare la teoria delle guerre, dei conflitti e della pace.
Espandere le teorie del conflitto e della pace, vari concetti, approcci e metodi;
Caratterizzare i conflitti ai vari livelli del sistema sociale (conflitti intergruppi, politici, etnici, nazionali);
Mostra polemiche nella società moderna riguardo a questioni di guerra o pace
1. Teorie del conflitto e della pace: concetti, approcci e metodi
Le teorie del conflitto, come gli studi sulla pace e sulla guerra, hanno una lunga tradizione nel pensiero politico europeo. La loro analisi risale ai primi storici greci come Tucidide e include opere eccezionali come Sulla guerra gallica di Cesare; Le teorie furono oggetto di un intenso dibattito teologico e politico nel Medioevo e fanno parte dell'Illuminismo, come evidenziato da Sulla pace perpetua di Kant. Essendo una parte importante della filosofia politica, riflettono e contribuiscono alla ricerca della felicità ideale e del benessere reale; Essi delineano così il confine tra la ricerca della pace eterna e la sicurezza reale sia dell’individuo che della società. Già negli anni '30 del XX secolo. Con l'emergere della scienza politica come scienza sui generis, compaiono studi empirici sulle guerre come il lavoro di Quincy Wright e numerose analisi storiche e politiche delle cause di entrambe le guerre mondiali.
Dagli anni '60 sono emerse sottodiscipline indipendenti, come lo studio dei conflitti e lo studio dei modi per raggiungere la pace, con proprie riviste, istituti, organizzazioni scientifiche e compiti specifici. Mentre la teoria dei conflitti si definisce una scienza tradizionalmente imparziale, gli studi sulla pace, che iniziarono a svilupparsi nei paesi scandinavi negli anni '60 e si diffusero in altri paesi europei negli anni '70, erano chiaramente orientati verso i valori, il progresso e le iniziative politiche. tradizioni teologiche e filosofiche dell’Europa e si consideravano un contributo alla causa della pace.
Le teorie del conflitto e della pace spesso erano in competizione e continuano a competere tra loro, hanno cercato e continuano a cercare la propria identità nell’isolazionismo accademico, e talvolta hanno persino tentato di creare un monopolio accademico. Pertanto, c’è stata la tendenza a trascurare la loro fondamentale relazione normativa ed empirica e, inoltre, il grado in cui le loro questioni sono intrecciate. Pertanto, la collaborazione oggettivamente – così come politicamente – necessaria tra loro, così come con altre discipline, era rara e spesso arrivava troppo tardi per influenzare la politica o contribuire alla costruzione della pace. Inoltre, i requisiti esistenti per un approccio interdisciplinare sono spesso ridotti ad un approccio cumulativo bi o multidisciplinare o semplicemente ignorati. E l’approccio legato alla politica spesso equivale a fondamentalismo critico accademico, che riduce tutte le ricerche e le proposte specifiche a un alibi politico per lo status quo o a una spiegazione apologetica con il senno di poi della necessità di una particolare politica. In generale, di fronte a tali posizioni, la politica europea e le élite politiche spesso non vedono né il motivo né la necessità di impegnarsi nel dialogo o di ricevere consigli da loro. Anche se negli anni '70 la politica di distensione e la ricerca della pace erano "alleati oggettivi", non mostravano ancora alcun desiderio di collaborare. E mentre i principali studi europei sulla pace non sono riusciti a coinvolgere governi, parlamenti e partiti, non sono riusciti nemmeno ad allearsi o almeno a impegnarsi con i movimenti pacifisti che si opponevano alla politica tradizionale alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80. Lacerati da divisioni interne, emarginati in passato e sempre più politicamente disinteressati, gli studi sulla pace hanno preso una brusca svolta. Dopo aver posto fine ai dibattiti teorici e normativi sulla natura della pace e della sicurezza, i loro autori hanno riscoperto il pragmatismo empirico e si sono concentrati su aspetti specifici, come il disarmo, il controllo degli armamenti e le misure di rafforzamento della fiducia, fornendo così alla comunità di coloro che sono interessati alle questioni di sicurezza , dati preziosi e assistenza per sostituire il suo precedente focus politico.
Al giorno d'oggi, dopo che gli studi sui conflitti e sulla pace si sono concentrati principalmente sui problemi dell'Est e dell'Ovest - e del Nord e del Sud, che costituiscono un campo completamente separato - e specialmente sulla questione nucleare durante il conflitto Est-Ovest, queste discipline hanno dovuto affrontare l'improvviso l’assenza di un volto politico, e anche il fatto che, per la prima volta negli studi sulla pace dagli anni ’70, ciò ha portato a una crisi creativa. Gli studi sulla pace sono attualmente in fase di reinvenzione, ricercando nuovi temi, ridefinendo le questioni di ricerca e cercando una nuova legittimazione. Anche il dibattito, di fondamentale importanza ma dimenticato, sulla questione se – e, in tal caso, in che misura – la pace possa essere raggiunta attraverso mezzi militari (vale a dire l’intero dibattito sul mantenimento della pace e sul mantenimento della pace applicati alle realtà della seconda guerra del Golfo, della Jugoslavia e degli eventi in Somalia), è rinato e può segnare l’inizio di nuove scoperte teoriche e normative.
Per comprendere la natura degli studi sui conflitti e sulla pace, il dibattito intra-accademico su questo riorientamento e il dibattito tra accademici e politici sul ruolo futuro di tali discipline per le società di cui fanno parte, è necessario sottolineare quattro punti generali. .
In primo luogo, come accennato in precedenza, la ricerca attuale o gli studi sui conflitti attuali dovrebbero essere arricchiti, da un lato, da dati storici sui conflitti sia in Europa che altrove, e dall’altro, da idee e risultati provenienti dallo studio del passato, compresi quelli che talvolta vengono considerati prescientifici. Gli scritti degli antichi autori greci e romani, così come i trattati sui dibattiti teologici nel Medioevo, potrebbero ampliare il focus analitico e aiutare a superare la tradizionale fissazione sullo stato-nazione se imparassimo dall’esperienza dell’Impero Romano, il Santo Impero Romano, Monarchia Asburgica come affrontare la risoluzione dei conflitti all'interno e tra le società. Questa rivalutazione della storia e delle lezioni del passato aiuta a evitare pregiudizi nascosti nella moderna scienza dei conflitti (conflittologia), o almeno stimola a rifletterci. Il pregiudizio appare, ad esempio, nelle argomentazioni secondo cui le società dovrebbero essere organizzate in stati-nazione definiti dalla territorialità, o nelle tesi più comuni secondo cui, dopo la fine del conflitto Est-Ovest, gli stati-nazione nell’Europa orientale dovrebbero essere preservati in garantire una maggiore stabilità all’Occidente.
In secondo luogo, e ciò diventa evidente nell’applicazione pratica delle idee di cui sopra, la ricerca sul conflitto e sulla pace in particolare riflette due tradizioni socio-filosofiche fondamentali – realista e idealista – nel pensiero europeo, che erano in competizione tra loro, si sovrapponevano e si rafforzavano a vicenda. . Da un lato, la visione realista cercava di comprendere l’aspetto di potere dei conflitti, così come gli ordini e le strutture che li vincolano; d'altra parte, la visione idealistica si concentrava sull'aspetto valoriale dei conflitti e del cambiamento graduale. Considerando queste due linee di pensiero come in un intreccio dialettico, si dovrebbe stabilire una relazione tra le idee di Machiavelli sul metodo di governo dello Stato e il modello utopico dell’ideale di Campanella. Ciò significa, ad esempio, che un ordine europeo moderno politicamente efficace non deve solo riconoscere l’esistenza del conflitto, ma anche combinarlo con le esigenze di pace e sicurezza.
In terzo luogo, lo sviluppo di queste discipline non è solo orientato verso l’interno, vale a dire guidato da criteri o modelli scientifici e accademici, ma associato al dibattito pubblico, alle preoccupazioni politiche della società e ai processi di educazione delle masse e delle élite. Questa connessione tra gli studi sui conflitti e sulla pace e gli sviluppi politici nel mondo “esterno” diventa chiara quando si guarda allo sviluppo degli studi sulla pace negli anni ’60 e ’70. Sia che la ricerca sulla pace sia riuscita o meno a influenzare la politica, oggettivamente essa ha costituito un certo complemento alle attività politiche. I loro autori non solo affrontavano i costi e i rischi del conflitto militare tra Est e Ovest, ma volevano anche utilizzare la distensione per risolvere questi problemi – o almeno per controllarli meglio. L’attuale crisi di identità e legittimità della ricerca consolidata sulla pace riflette accuratamente i problemi delle attuali élite politiche in Europa e la ristrutturazione del loro pensiero dopo la fine del conflitto tra Est e Ovest.
In quarto luogo, la ricerca sul conflitto e sulla pace deve essere chiaramente collegata all’idea generale di sviluppo sociale. Ancora una volta, i realisti spesso considerano il conflitto, l’uso della forza militare e il ruolo dominante dello stato-nazione come “naturali”, cioè essenzialmente immutabili. I sostenitori di visioni estreme definiscono il ruolo dei conflitti e della guerra in uno spirito darwiniano, cioè come detergente salutare, mezzo legittimo di cambiamento, necessario per lo sviluppo storico. Gli idealisti, tuttavia, presuppongono che le società siano in linea di principio capaci di apprendere e, come passo importante in tale processo di apprendimento storico, possano imparare a utilizzare meccanismi non violenti come mezzo per sostituire le guerre e altri tipi di conflitti militari. Ancora una volta, tale appello ad una profonda comprensione della società è importante sia per l’analisi che per le azioni politiche. L’introduzione di modelli di integrazione dell’UE al fine di modificare le strutture politiche inter e intrastatali e i modelli di conflitto sulla strada verso un ordine paneuropeo si basa proprio su questo concetto: che anche nell’Europa orientale, ora rinazionalizzante, l’integrazione, l’unificazione e la - allo stesso tempo. Di conseguenza, la pacificazione è in linea di principio realizzabile.
Uno dei processi di apprendimento intellettuale dell’era nucleare e in particolare della politica di distensione è che la pace non è solo un prodotto del pensiero normativo o di un buon augurio, ma uno stato che corrisponde agli interessi fondamentali sia delle singole società che della comunità mondiale. Questo rapporto tra moralità e interessi non è cambiato dalla fine dello scontro nucleare tra Est e Ovest. È chiaro – anche per quanto riguarda l’instabilità politica nell’ex Unione Sovietica – che dalla fine del conflitto Est-Ovest, il pericolo di uno scambio intenzionale o accidentale di attacchi nucleari è notevolmente diminuito, ma continua ad esistere, e se pensiamo agli scenari peggiori per la proliferazione delle armi nucleari, che può diventare ancora maggiore che durante il periodo di egemonia nucleare di USA e URSS. E ancora: siamo sostenitori dell’approccio di Rousseau o di Hobbes, cioè? la questione non è se la pace sia desiderabile o possibile, ma come realizzarla.
2. Conflitti ai vari livelli del sistema sociale 2.1. Conflitto intergruppo
Tutta la storia umana è una storia di conflitti tra gruppi: politici, nazionali, religiosi, ecc. È impossibile persino immaginare una storia senza conflitti. La fantasia fallisce. Pertanto, il nostro buon senso conclude che i conflitti sono inevitabili. Sono un modo di sviluppo umano. Ma ecco una domanda interessante: quando ci sono stati più conflitti - nei vecchi tempi barbarici e crudeli o nel moderno mondo civilizzato? Logicamente, la risposta può essere una sola: ovviamente, nel mondo di oggi dovrebbero esserci più conflitti. In primo luogo perché quasi tutte le società attuali sono molto più eterogenee e differenziate rispetto al passato. La struttura sociale basata sulla divisione del lavoro diventa più complessa, si formano molti più gruppi sociali diversi e, quindi, la probabilità di conflitti tra loro, puramente matematicamente, dovrebbe aumentare. In secondo luogo, e probabilmente questa è la cosa principale, la popolazione della Terra è in costante crescita e la quantità di risorse biologiche necessarie per la nostra esistenza è limitata: la biosfera non è di gomma. Pertanto, la competizione per le risorse scarse aumenta inevitabilmente, moltiplicando il numero dei conflitti.
D’altra parte, poiché l’umanità nel suo insieme sta progredendo, insieme all’aumento del numero dei conflitti, anche i metodi per regolarli devono essere perfezionati e tecnologicamente avanzati. In teoria, dovrebbero diventare più civili e razionali. Il grado di perfezione dei metodi di risoluzione dei conflitti può essere giudicato dalle loro conseguenze. Ma la cosa strana è che se prendiamo i conflitti tra gruppi più acuti (militari), allora in termini di numero di vittime il secolo scorso non ha eguali nella storia. Le persone si stanno distruggendo a vicenda con un entusiasmo senza precedenti e non possono fermarsi. E ciò che è più sconcertante è che non vi sia alcun senso razionale in tutto ciò. L'uomo sembra essere un essere razionale. Perché la sua storia oggi sembra così folle?
Dall'Illuminismo (secoli XVII-XVIII), ci siamo abituati a credere che, in condizioni sociali favorevoli e un'educazione adeguata, una persona sia una creatura completamente ragionevole e gentile. Ma allora chi è responsabile di tutte le atrocità della storia? Di norma, si tratta di alcuni "altri" anonimi: lo stato, i tiranni, i despoti, il totalitarismo, il sistema di comando amministrativo, gli oligarchi, ecc. La maggior parte delle persone sono completamente senza peccato e non sono responsabili delle innumerevoli vittime della repressione, delle guerre, delle crisi economiche, del degrado ambientale, ecc. Ma poi, a proposito, si scopre che la maggior parte di noi sono adulti così sciocchi che semplicemente non sanno cosa loro stanno facendo. E tutta la storia è gestita dalle cosiddette “personalità forti”, per lo più cattivi. È improbabile che saremo d’accordo con una valutazione così dispregiativa delle nostre capacità. Ma poi dovremo ammettere la presenza di alcuni fattori, modelli, motivazioni nascosti e non ovvi del nostro comportamento che “aggiungere benzina” al fuoco dei conflitti sociali.
La ricerca di tali modelli nel 20° secolo. la psicologia sociale è stata attivamente coinvolta. Riuscì a scoprire una serie di interessanti fenomeni di interazione tra gruppi, con l'aiuto dei quali la natura dei conflitti tra gruppi è stata significativamente chiarita.
Gli interessi dei gruppi sociali si scontrano su tre “campi” problematici che sono:
Risorse sociali (economiche - finanziarie, attrezzature, tecnologia, cibo, energia, informazione, ecc.);
Status sociale (uguale - disuguale, superiore - inferiore, centrale - periferico, principale - marginale);
Valori socioculturali (religiosi, morali, conservatori, liberali, etnici, ecc.).
Queste tre “mele della contesa” costituiscono l’oggetto dei conflitti intergruppi.
La distribuzione delle risorse, la relazione di status, l'impegno verso determinati valori sono elementi molto commoventi dell'organizzazione sociale della vita. Il loro stato momentaneo è determinato dall'equilibrio delle forze dei gruppi sociali interessati. E se qualche gruppo si rende conto di essere svantaggiato da uno di questi parametri, significa che è “pronto al conflitto”.
Nella dinamica dello sviluppo del conflitto intergruppo si possono distinguere diverse fasi, ad esempio le seguenti (secondo L. Kriesberg):
1) relazioni oggettive che costituiscono la base del conflitto (situazione conflittuale);
2) consapevolezza degli obiettivi come incompatibili (l'emergere del conflitto);
3) scegliere le modalità per raggiungere gli obiettivi di ciascuna parte;
4) interazione diretta del conflitto (escalation e de-escalation del conflitto);
5) porre fine al conflitto.
In sostanza, lo stato della società in ogni momento rappresenta un certo risultato intermedio dei conflitti intergruppi risolti. La loro vasta rete nel suo insieme è determinata dalla differenziazione sociale della società, ma è mutevole. Di conseguenza, la configurazione del “campo di conflitto” dovrebbe cambiare.
Ad esempio, fino alla fine del XIX secolo. l'elemento dominante della stratificazione sociale era la classe. Tuttavia, la trasformazione nel 20 ° secolo. la società industriale in quella postindustriale (e oggi in quella dell’informazione) ha “sfocato” la polarizzazione di classe, subordinandola ad altri ordini di stratificazione. A metà del 20 ° secolo. l'ordine di stratificazione dominante si basava non sulle classi e sulla proprietà privata nella sfera della produzione, ma sullo Stato e sui vari sistemi organizzativi (aziendale, professionale, comunale, ecc.). La natura delle relazioni intergruppo è cambiata di conseguenza.
conflitti: sono diventati, per così dire, “più piccoli”, ma più diversi e persino “eterogenei”. Oggetto dei conflitti sono sempre più non solo i gruppi “sociali”, cioè quelli creati sulla base dell'appartenenza a qualche categoria socio-professionale, ma anche “obiettivo” o “iniziativa”, cioè unire le persone secondo uno specifico compito che risolvono (ambiente, consumatori, diritti umani). Lo sviluppo sociale ineguale del mondo moderno aggiunge anche diversità al tessuto dei conflitti tra gruppi: in alcuni paesi prevalgono conflitti di tipo tradizionale, determinati da strutture di classe e persino tribali; in altri, più avanzati, nuovi movimenti sociali danno il tono.
Pertanto, il mondo moderno mostra una tendenza a complicare il quadro generale dei conflitti tra gruppi, aumentandone la diversità e l’intreccio,
In sintesi, evidenziamo le principali posizioni della visione sociologica dei meccanismi di emersione dei conflitti intergruppi:
La base comune del conflitto tra gruppi è la differenziazione sociale della società, il cui tipo principale è dichiarato essere la divisione del lavoro;
L'inevitabilità fondamentale dei conflitti tra gruppi è determinata da un tipo specifico di progresso storico, portato avanti secondo il principio: “una parte perde, il tutto vince”;
Molti conflitti tra gruppi sono un modo per mantenere l’equilibrio sociale, l’equilibrio degli interessi di gruppo;
La principale fonte di conflitti tra gruppi sono i bisogni insoddisfatti dei gruppi sociali;
L'oggetto dei conflitti tra gruppi sono le risorse sociali, gli status; valori;
La totalità dei conflitti tra gruppi tende a diventare più complessa e diversificata.
2.2. Tipologia dei conflitti intergruppi
Non è ancora emersa un'unica modalità di classificazione dei conflitti, poiché ci sono troppe ragioni per la loro divisione, ognuna delle quali ha la propria ragione.
Per i conflitti intergruppi, due criteri per la loro differenziazione sembrano essere i più semplici e razionali: 1) per soggetto e 2) per oggetto del conflitto. Dopotutto, qualsiasi conflitto, compreso quello tra gruppi, è principalmente una relazione tra le parti in conflitto. Ed è esattamente così che le relazioni sociali vengono classificate nelle scienze sociali: per soggetto (chi entra nella relazione) e per oggetto (su cosa nasce questa relazione).
Inoltre, le due serie di relazioni indicate, pur essendo diverse, poiché distinte per ragioni diverse, possono anche intersecarsi tra loro. Le relazioni di classe, ad esempio, ci rimandano chiaramente alla prima base: chi, quali gruppi sociali sono imparentati. Ma se ti interessi all’essenza dei rapporti di classe e ti chiedi di che tipo siano questi rapporti – economici, politici o ideologici – la risposta sarà complessa – entrambi. Dopotutto, i rapporti tra le classi si sviluppano riguardo alla proprietà dei mezzi di produzione (economica), alla conquista del potere statale (politica) e in termini di difesa dei valori ideologici. O le relazioni nazionali. Ricevono il nome dal soggetto (si riferiscono alle nazioni) e il contenuto dall'oggetto, cioè da ciò su cui sono formati. Se i gruppi nazionali condividono risorse materiali, i rapporti tra loro diventano economici, se - potere e territorio - politici, ecc.
La stessa storia si applica ai conflitti tra gruppi. Possono essere formalmente suddivisi in base ai soggetti delle relazioni conflittuali. Chi, infatti, è in conflitto: classi, ceti, nazioni, gruppi professionali, settoriali, territoriali, elitari, demografici, ecc. Il risultato è un corrispondente raggruppamento di conflitti: classe, ceti, nazionali, territoriali, socio-professionali, elitari , generazionali (padri e figli), tribali o di clan, ecc.
1) socioeconomico (le risorse sono condivise);
2) politico e giuridico (potere e influenza sono condivisi);
3) spirituale e ideologico (si impongono i propri valori). All’interno di ciascuno di questi tipi di conflitti, le gradazioni interne possono essere ulteriormente distinte in base a una serie di motivi:
Per grado di manifestazione (esplicito e nascosto);
A seconda del grado di consapevolezza (adeguatamente o non adeguatamente consapevole);
Dalla natura degli obiettivi (costruttivi e distruttivi);
In base ai risultati per ciascuna delle parti (conflitti con una “somma zero” - vittoria - perdita, o con una “somma diversa da zero” - vittoria - vittoria);
In base al grado di omogeneità dei partecipanti (omogenei ed eterogenei);
Dal grado di struttura e istituzionalizzazione (in tutto o in parte);
Attraverso modalità di regolamentazione (controllo, coordinamento, risoluzione), ecc.
Esistono moltissimi motivi per differenziare i conflitti. Non è nemmeno possibile descriverli tutti brevemente qui. Pertanto, caratterizzeremo solo i due tipi più fondamentali e rilevanti di conflitti tra gruppi oggi: politico e nazionale. Tale scelta può essere giustificata dalle seguenti considerazioni.
2.3. Conflitti politici e nazionali
Nonostante tutta la diversità dei moderni conflitti tra gruppi, la maggior parte di essi tende a convergere, per così dire, verso un punto: al centro del potere politico e statale. Se il conflitto tra qualsiasi gruppo sociale è abbastanza serio, prima o poi "raggiunge le dimensioni" di un conflitto politico. La struttura e l'organizzazione sociale della società odierna sono così complesse e stravaganti che lo Stato semplicemente non può fare a meno di regolare i processi economici, sociali (medicina, istruzione, l'intera “vita sociale e culturale”) e persino spirituali. I “gruppi di interesse” emergenti in questi ambiti, non senza ragione, vedono nelle istituzioni politiche il mezzo più efficace e affidabile per risolvere i loro problemi.
Recentemente sono venuti alla ribalta anche i conflitti nazionali (interetnici), anche se sembrerebbe che il processo di formazione delle nazioni sia in gran parte completato da molto tempo. Conflitti di questo tipo (identificati dai soggetti delle relazioni conflittuali) su basi sistemiche sembrano essere scomposti in componenti tradizionali: economica, politica e valoriale-spirituale. Inoltre, quello principale, di regola, risulta essere politico: l'acquisizione da parte di un gruppo etnico della propria statualità.
Tuttavia, la questione è complicata dal fatto che in tali conflitti (a differenza dei conflitti di classe o socio-professionali) viene in primo piano uno dei tipi di bisogni fondamentali del gruppo: il bisogno di identità, cioè di preservare l'integrità e la specificità del gruppo (gruppo etnico) stesso. E a volte è difficile capire dove sia l’obiettivo e dove siano i mezzi nei conflitti nazionali. O gli slogan nazionali vengono utilizzati solo come mezzo per ridistribuire le risorse economiche e il potere politico, o viceversa: il gruppo ha bisogno di risorse e potere esclusivamente come mezzo per affermare l'identità nazionale. In un modo o nell'altro, i conflitti nazionali si manifestano alla fine del XX e all'inizio del XXI secolo. una chiara tendenza all’aggravamento, che rende estremamente rilevante la sezione della conflittologia ad essi dedicata, e ci costringe a riconsiderare molte previsioni tradizionali sull’evoluzione delle relazioni nazionali.
Lo scopo principale dello Stato è garantire l’integrità della società regolando le relazioni tra gruppi sociali e individui. Tuttavia, sarebbe ingenuo considerare lo Stato come una sorta di arbitro o arbitro neutrale nelle infinite controversie di gruppi sociali combattivi. Se lo Stato è un arbitro, è tutt’altro che imparziale. Il fatto è che in una società divisa in gruppi opposti semplicemente non esiste una “terza” parte disinteressata. Le istituzioni statali (governi, parlamenti, tribunali) sono piene di persone appartenenti all'uno o all'altro gruppo sociale. E, naturalmente, non a nessuno, ma a quello che si è rivelato più forte in questo momento. Quindi, per illustrare l'essenza dello stato, è più adatta un'analogia non con l'arbitro di una competizione sportiva, ma con il gioco per bambini del “re della collina”: chi spinge tutti i rivali dall'alto ha ragione. Può sembrare scortese, ma è più vicino alla verità.
L’essenza del processo politico è in definitiva la lotta di vari gruppi sociali per la conquista e l’uso del potere statale. Intorno ad esso si svolgono tutti i conflitti politici.
Il conflitto politico è uno scontro tra soggetti politici nel loro reciproco desiderio di realizzare i propri interessi e obiettivi, principalmente legati al raggiungimento del potere o alla sua ridistribuzione, nonché: cambiamenti nel loro status politico nella società.
La fonte dei conflitti politici è universale: è la stessa soddisfazione dei bisogni fondamentali dei gruppi sociali e degli individui, che in una società strutturata in modo complesso non può essere garantita senza il coordinamento e il coordinamento centralizzato degli sforzi, che è ciò che fa il potere statale.
In generale, il potere politico per un gruppo non è fine a se stesso, ma un mezzo per garantire la soddisfazione dei bisogni fondamentali. Tuttavia, all’interno della sfera politica stessa, a volte si verifica un peculiare spostamento di obiettivi: per un politico professionista o anche per un’intera organizzazione politica, il potere diventa un valore indipendente che subordina tutto il resto. Il principale motivo trainante di tali persone e gruppi (e, ovviamente, la fonte di ulteriori conflitti) è la “sete di potere”. Tale sostituzione degli obiettivi è spesso etichettata come priva di principi o egoistica. Ma forse invano. Questo non è solo un fenomeno politico. Per cosa, diciamo, combatte un pugile sul ring: per diventare il numero uno al mondo o per provvedere alla sua famiglia? Succede che il primo è più importante per lui. Dicono che queste siano le qualità che creano grandi atleti. Qualcosa di simile accade in politica: un desiderio di potere “puro” è naturale per un politico. Questa è una delle caratteristiche del “gioco politico”.
L'oggetto dei conflitti politici è una risorsa sociale specifica: il potere statale, nonché lo status politico dei gruppi sociali (il grado di vicinanza o distanza dalle leve del potere, la capacità di influenzare l'adozione di decisioni vincolanti per l'intera società) e valori politici (patriottismo, cittadinanza, diritti e libertà ecc.).
I soggetti dei conflitti politici sono solitamente riconosciuti come gruppi sociali o istituzioni politiche che li rappresentano. Qui sta un problema che non è stato ancora del tutto risolto; chi dovrebbe essere considerato reale e chi dovrebbe essere considerato un soggetto nominale di conflitto politico? Naturalmente, dietro l’azione delle istituzioni politiche (governo, parlamento, tribunali) ci sono gli interessi dei gruppi sociali. Ma le decisioni politiche, comprese quelle cosiddette “fatidiche”, vengono ancora prese da istituzioni politiche che godono di una certa autonomia nelle loro azioni dai gruppi sociali che le sostengono.
La specificità dell'oggetto e dei soggetti dei conflitti politici conferisce loro una serie di caratteristiche che distinguono questo tipo di conflitti intergruppi da tutti gli altri.
1) Carattere prevalentemente aperto, elevata manifestazione di conflitto di interessi. La politica è una sfera di lotta socialmente consentita, un modo per allentare la tensione sociale disinnescando le emozioni nella competizione politica. Da qui la propensione agli effetti esterni, la nota teatralità della vita politica.
2) Pubblicità indispensabile. Questa caratteristica significa, in primo luogo, che la politica è ormai professionalizzata e viene portata avanti da un gruppo speciale di persone. non coincide con la massa della popolazione. E, in secondo luogo, ciò significa che qualsiasi conflitto in questo ambiente veramente professionale presuppone un appello alle masse (non professionisti), la loro mobilitazione attiva per sostenere una parte o l’altra.
3) Aumento della frequenza. Oggi ci sono molti più conflitti nella sfera politica che in altri. E non solo perché il conflitto è, per così dire, il principale metodo di azione, modo di pensare e comportamento dei politici. Ma soprattutto perché molti conflitti nella sfera non politica della vita delle persone (che comunemente viene chiamata società civile), senza trovare una soluzione pacifica, si riversano nella sfera politica, cioè richiedono l’intervento del governo per la risoluzione.
4) Significato universale. Non importa quanto privato o locale possa essere un conflitto politico, si conclude con l’adozione di una decisione a livello statale ed è obbligatorio per tutti i membri della società. Pertanto, quasi tutti i conflitti politici colpiscono inevitabilmente ciascuno di noi.
5) “Dominanza - sottomissione” come principio assiale. Poiché i conflitti politici si svolgono in uno spazio sociale in cui l’asse dominante è la verticale del potere statale, il loro obiettivo principale diventa inevitabilmente l’instaurazione del dominio politico della parte più forte.
6) La capacità di utilizzare le risorse energetiche come mezzo di risoluzione dei conflitti. Di tutti i tipi di potere presenti nella società, solo lo Stato ha il diritto di usare legalmente la forza. Poiché lo Stato come istituzione politica è un partecipante indispensabile in quasi tutti i conflitti politici, c’è sempre una grande tentazione di usare la forza come ultimo argomento e su basi del tutto legali. Ciò rende i conflitti politici potenzialmente più pericolosi e distruttivi nelle loro conseguenze.
A causa della complessità e della natura multistrato della sfera politica, la classificazione dei suoi conflitti inerenti non può che essere multidimensionale. Tradizionalmente, i motivi più generali per distinguere i conflitti politici di diverso tipo sono:
Ambito di distribuzione;
Tipo di sistema politico;
La natura dell'oggetto del conflitto.
Sulla prima base si distinguono i conflitti politici interni e quelli politici esteri (interstatali).
Secondo il secondo, i conflitti tra sistemi politici totalitari e democratici.
Secondo il terzo: conflitti di interessi, status e ruolo, nonché conflitti di valori e identificazione.
Poiché le ragioni per identificare tutti questi tipi di conflitti politici sono diverse, allora, naturalmente, la portata dei concetti che li denotano coincidono parzialmente. Ad esempio, un conflitto interstatale può essere allo stesso tempo espressione dell’incompatibilità di diversi sistemi politici (totalitari e democratici), nonché degli interessi e dei valori da questi difesi.
2.4. Conflitti interstatali e interessi nazionali
Il significato di dividere i conflitti politici in politica interna ed estera è più che ovvio. In quest’ultimo, gli stati (o le coalizioni di stati) agiscono come soggetti di conflitto. I rapporti tra loro sono sempre stati caratterizzati dalla reciproca competizione, che con triste frequenza ha assunto le forme più acute (militari). È generalmente accettato che gli stati siano guidati dai cosiddetti interessi nazionali. Si basano sui bisogni più importanti per l'esistenza del popolo-nazione: sicurezza, controllo e utilizzo delle risorse naturali, preservazione dell'integrità culturale e della specificità nazionale. Le limitazioni naturali agli interessi dello stato nazionale sono le risorse limitate e gli interessi nazionali di altri paesi.
Le realtà del 20° secolo hanno portato al fatto che il concetto apparentemente abbastanza chiaro di “interesse nazionale” ha subito una metamorfosi significativa. Questo interesse (soprattutto per le superpotenze) cominciò a crescere in modo allarmante e raggiunse proporzioni planetarie. La globalizzazione dei mercati, delle tecnologie, delle comunicazioni e dei flussi di informazioni ha portato al fatto che gli “interessi nazionali” hanno cominciato a manifestarsi ben oltre i territori degli stati nazionali. Se, ad esempio, il normale funzionamento dell'economia anche di un paese così potente come gli Stati Uniti dipende dalle forniture di petrolio del Medio Oriente, allora questa regione viene dichiarata una zona di "interessi vitali" dei nordamericani. Se i leader dell’ex Unione Sovietica consideravano la crescita dell’influenza occidentale in Afghanistan come una minaccia alla loro sicurezza nazionale, non hanno pensato a lungo a come sarebbe stato più facile difendere il loro “interesse nazionale”.
A quanto pare, il mondo moderno si è avvicinato alla necessità di creare un nuovo ordine mondiale, che si baserà sulla priorità degli interessi internazionali comuni a tutta l'umanità. Ma questo non sta ancora accadendo. Gli stati attuali continuano ostinatamente ad attuare l’idea di tutelare gli “interessi nazionali”, che, dato l’esaurimento delle risorse non rinnovabili, porterà inevitabilmente ad un aumento del numero di conflitti interstatali.
I mezzi attualmente conosciuti per contrastare questa tendenza sono pochi, ma la loro importanza è ancora più importante:
1) processi di integrazione nell'economia (l'esempio più eclatante è la dinamica abbastanza favorevole dello sviluppo dell'Unione Europea, che si sta lentamente spostando dall'integrazione economica a quella politica);
2) rafforzare il ruolo di mantenimento della pace delle organizzazioni internazionali (ONU, OSCE, OAS (Organizzazione degli Stati Americani), OAU (Organizzazione dell'Unità Africana), ecc.;
3) ridurre il livello dello scontro militare sotto controllo reciproco;
4) l'abitudine a rispettare le norme del diritto internazionale;
5) ogni possibile espansione della comunicazione tra i popoli;
6) democratizzazione degli ordini politici interni negli stati nazionali.
L’ultimo punto di questo elenco è particolarmente importante perché, come dimostra la triste esperienza del XX secolo, la più grande minaccia di trasformare i conflitti interstatali in scontri militari proviene dai regimi politici totalitari.
L’essenza dei conflitti politici interni è in gran parte determinata dalla natura dei sistemi politici. Ciò che dà ai sistemi politici la loro originalità sono i regimi politici, cioè un insieme di metodi specifici per esercitare il potere politico da parte di un determinato gruppo sociale. Le scienze politiche sono solite distinguere tre di questi “aggregati”: 1) totalitarismo, 2) autoritarismo e 3) democrazia. Poiché un regime autoritario rappresenta una sorta di compromesso tra gli altri due, prenderemo in considerazione solo forme estreme e “pure” di regimi politici.
Il totalitarismo (dal latino totalis - completo, intero) è un regime politico caratterizzato dal controllo globale sui cittadini da parte dello Stato, dalla completa subordinazione dell'individuo e della società civile al potere politico. Le sue caratteristiche distintive sono la politicizzazione generale e l'ideologizzazione della vita pubblica, la presenza di un potente apparato di controllo sociale e di coercizione, la statalizzazione (nazionalizzazione) di tutta la vita economica e anche privata, la limitazione o l'eliminazione della proprietà privata, l'eliminazione della concorrenza, le relazioni di mercato , sistema di pianificazione centralizzata e gestione comando-amministrativa.
La democrazia è una sorta di antipode al regime totalitario. È (idealmente) caratterizzato dal controllo della società civile sul potere politico. I suoi principi fondamentali includono il riconoscimento giuridico e l’espressione istituzionale del potere supremo del popolo, l’elezione periodica degli organi governativi, l’uguaglianza dei diritti dei cittadini a partecipare alla gestione della società, il rispetto incondizionato di tutti i diritti e le libertà individuali, ecc.
Con un simile confronto, può sembrare che il totalitarismo sia il fulcro di tutti i vizi politici e che la democrazia, al contrario, sia il luminoso ideale di tutta l'umanità. Questo, ovviamente, non è del tutto vero. I regimi politici totalitari non nascono per la cattiva volontà dei Fuhrer o dei Segretari Generali. Sono l’espressione del disperato desiderio delle masse di riorganizzare rapidamente ed efficacemente la società sulla base della giustizia sociale. Quest'ultima è intesa principalmente come uguaglianza. E non solo davanti alla legge, ma in tutte le sfere della vita umana. Ma l’economia di mercato genera continuamente disuguaglianze. Ciò significa che occorre trasformarla, sostituendo la proprietà privata con quella pubblica, e i meccanismi di regolazione del mercato della domanda e dell'offerta con una pianificazione centralizzata: del resto, non è affatto difficile calcolare quanto di certi beni la società richiede.
1. Conflitti di regimi totalitari. In una società di questo tipo, dove tutte le normali proporzioni tra economia, politica e cultura sono distorte, i conflitti politici acquisiscono una serie di tratti caratteristici:
1) Tra tutti i possibili tipi di conflitti politici (interessi, status, valori), vengono in primo piano i conflitti di status e di ruolo associati alla vicinanza o alla distanza dal potere politico.
2) Poiché le differenze negli interessi dei gruppi professionali, etnici e di altri gruppi sociali non possono essere eliminate, e le autorità politiche non vogliono riconoscere la natura conflittuale delle loro relazioni in una società esteriormente unificata e mobilitata, la maggior parte dei conflitti reali vengono nascosti e soppressi. Numerosi gruppi sociali essenzialmente non hanno la possibilità di esprimere e quindi di comprendere chiaramente i propri interessi, che sono nascosti nel regno dell'irrazionale. Ecco perché il crollo dei regimi totalitari in molti casi porta a scoppi di violenza, a una seria minaccia di guerra civile: si tratta di conflitti repressi che emergono in superficie.
3) I conflitti politici in una società totalitaria sono estremamente ideologici. L’ideologia (che è solo una versione teoricamente significativa della ricostruzione sociale, sviluppata da qualche gruppo sociale) si trasforma nella “vacca sacra” del regime totalitario, un valore indiscutibile che non è soggetto ad alcuna critica. È, naturalmente, “l’unico vero” e universalmente vincolante. Il dissenso è un crimine politico.
4) L'ipertrofia della sfera politica della vita in una società totalitaria porta al fatto che in essa anche i conflitti più lontani dalla politica sono elevati al rango di conflitti politici.
5) In tali condizioni, la maggior parte dei conflitti sono artificiali, imposti. Questa caratteristica è pienamente soddisfatta anche dai conflitti che nascono come risultato dei tentativi delle autorità di indirizzare il malcontento della popolazione alla ricerca di un nemico (sabotatori, cosmopoliti, dissidenti) a cui imputare i propri fallimenti. Non meno artificiale e falso nella sua essenza è il conflitto associato all'idea di superiorità sociale di qualsiasi gruppo sociale (la razza ariana, la classe operaia, ecc.), indispensabile per l'ideologia totalitaria.
6) I regimi politici totalitari sono caratterizzati anche da una tendenza a internazionalizzare i conflitti politici. L’ideologia universale alla base di essi ci consente di interpretare tutti gli eventi mondiali come, ad esempio, uno scontro di interessi della classe operaia e della borghesia.
2 Conflitti di una società democratica. I sistemi democratici probabilmente non sono meno tormentati dai conflitti. Tuttavia, la natura di questi conflitti è significativamente diversa.
1) Innanzitutto sono aperti, espliciti, riconosciuti dalla società e dallo Stato come un fenomeno normale derivante dalla natura competitiva delle relazioni nella maggior parte degli ambiti della vita pubblica.
2) Nelle società democratiche, i conflitti politici sono localizzati nella sfera politica stessa. Non si applicano alla vita privata dei cittadini, non subordinano lo sviluppo dell’economia e non determinano “le regole per il funzionamento della sfera spirituale.
3) Poiché tutti i gruppi sociali hanno molti modi per articolare i propri interessi, unirsi in varie organizzazioni per fare pressione sulle autorità, ecc., Le situazioni di conflitto sono caratterizzate da meno tensione. C’è meno pericolo di “esplosioni” di indignazione sociale e di risoluzione violenta dei conflitti.
4) Poiché la democrazia si basa sul pluralismo di opinioni, credenze, ideologie ed è in grado di esplorare situazioni di conflitto attraverso una discussione razionale e libera, è in grado di trovare modi molto più accettabili per risolvere i conflitti politici.
5) I conflitti politici legati allo status nei regimi democratici sono relativamente meno importanti dei conflitti di interessi e valori.
6) Poiché il potere politico in un regime democratico non è concentrato in un solo corpo o in una sola mano, ma è disperso, distribuito tra vari centri di influenza, e inoltre ciascuno dei gruppi sociali può difendere liberamente i propri interessi, allora, naturalmente, più si registrano conflitti politici aperti rispetto a una società totalitaria.
7) La forza della democrazia è anche lo sviluppo di procedure chiare, regole per localizzare e regolare i conflitti politici.
3. Controversia moderna: pace e guerra
Sebbene gli studi sul conflitto e sulla pace affrontino le stesse questioni, i loro approcci specializzati e diversi hanno portato a risultati diversi ma complementari sulla questione della definizione sottostante di conflitto e pace. Pertanto, la seguente discussione sul concetto di conflitto può attingere in larga misura agli studi sui conflitti, mentre il concetto di pace può essere spiegato con riferimento agli studi sulla pace. Tuttavia, l’ipotesi di fondo di questi articoli è che sia necessario un approccio più completo per raggiungere nuove dinamiche innovative nella ricerca sui conflitti e sulla pace, e che all’interno di questa sintesi sia necessario sviluppare una visione più completa, vale a dire. per connettere tra loro sia gli approcci della disciplina sulla pace sia gli approcci della conflittologia, dovremmo toccare anche altre tre relazioni che spesso sono state trascurate in passato.
In primo luogo, sia il conflitto che la pace come stati di interconnessione tra unità politiche come gli stati-nazione possono essere spiegati e risolti solo se la tradizionale divisione tra politica interna ed estera viene sostituita da un concetto in cui sono interconnessi anche diversi livelli di analisi, compresi vari settori della società. Ciò è particolarmente vero in relazione alla crescente interdipendenza internazionale, regionalizzazione e globalizzazione, insieme alla crescente “mediaizzazione” – l’ampliamento e l’approfondimento del ruolo dei mass media nelle dinamiche dei conflitti.
In secondo luogo, è altrettanto pericoloso separare le politiche estere, economiche e militari. I conflitti di natura “puramente” politica, economica, militare o di altro tipo sono rari; nella maggior parte dei casi troviamo un mix di cause. L’idea che la pace e la sicurezza abbiano un significato politico, economico, militare, socioculturale, ecc. La "dimensione" dovrebbe ispirare l'analista a cercare le relazioni tra queste dimensioni. In particolare, se si analizza la dinamica dei conflitti, sia in termini di escalation che di risoluzione, si può spesso riscontrare un caratteristico effetto di alimentazione tra, ad esempio, la dimensione economica e quella militare: le guerre non sono caratterizzate solo da azioni militari, ma hanno anche enormi conseguenze politiche ed economiche, sia attese che impreviste.
In terzo luogo, nella politica reale si verifica molto raramente, come spesso si immagina, un antagonismo tra conflitti e cooperazione nelle relazioni tra società o all’interno di una società. Nella maggior parte dei casi – e anche nei conflitti ad alta escalation – c’è sia conflitto che cooperazione; in alcuni casi, i conflitti danno origine a un consenso, per quanto limitato possa essere. Ciò significa che l’analisi dei conflitti deve esaminare la relazione tra cooperazione e conflitto, e che la risoluzione dei conflitti e la costruzione della pace devono trarre vantaggio dal consenso aperto o tacito esistente tra le parti in conflitto.
La fine del conflitto tra Est e Ovest fornisce un esempio di come operano questi tre imperativi. In primo luogo, la distensione e le politiche dell’OSCE collegavano chiaramente la politica estera e il cambiamento interno, con l’obiettivo di ridurre le minacce esterne e incoraggiare le riforme interne. In secondo luogo, il concetto e la realtà della distensione e delle politiche dell’OSCE si fondavano su un’ampia strategia che collegava la sicurezza alla cooperazione politica ed economica. È stata la riscoperta dei mezzi politici ed economici per raggiungere gli obiettivi di sicurezza a garantire il successo della distensione e a rappresentare il primo passo nel processo di risoluzione del conflitto Est-Ovest. E in terzo luogo, la combinazione di iniziative e sanzioni caratteristiche della distensione – dalla costruzione di gasdotti alla decisione della NATO su una “strada a doppio senso” – così come la specifica divisione del lavoro tra gli Stati Uniti e gli europei occidentali in materia della distensione stimolò il processo di apprendimento delle élite sovietiche.
La questione della guerra e della pace evoca molte risposte contrastanti. Per gli ideologi e i funzionari civili, la “pace” può essere raggiunta consolidando il dominio del mondo, il che a sua volta implica guerre costanti in tutto il mondo. Per gli ideologi e i rappresentanti politici delle multinazionali (MNC), la pace e la prosperità possono essere assicurate da operazioni di libero mercato combinate con l’uso selettivo del potere imperiale in speciali circostanze “strategiche”. Per i popoli e le nazioni oppresse del Terzo Mondo, solo l’autodeterminazione e la giustizia sociale porteranno alla pace, alla scomparsa dello sfruttamento imperiale e dell’ingerenza straniera, all’instaurazione di una democrazia partecipativa basata sulla giustizia sociale. Per molte forze progressiste in Europa e negli Stati Uniti, un sistema di istituzioni internazionali e leggi vincolanti per tutte le nazioni può promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, regolare il comportamento delle multinazionali e difendere l’autodeterminazione dei popoli.
Ognuna di queste prospettive presenta gravi carenze. La dottrina militaristica di raggiungere la pace attraverso il dominio del mondo si è rivelata, negli ultimi 3mila anni, e soprattutto nel presente, come una formula di guerra, come evidenziato dalle rivolte anticoloniali passate e presenti e dalle guerre popolari in Asia, Africa e America Latina. La combinazione del potere di mercato con l’uso selettivo della forza per garantire la pace ha deluso molti, in particolare i popoli del Terzo Mondo. Le rivolte popolari che negli ultimi vent'anni hanno portato al rovesciamento dei clienti del "libero mercato elettivo" dell'Impero euro-americano in America Latina dimostrano la sua continua vulnerabilità.
Dove hanno vinto, i movimenti antimperialisti hanno in molti casi sostituito una forma di imperialismo, cioè il governo diretto, con un’altra, diventando vittime dell’economia “di mercato”. Inoltre, nel periodo postcoloniale emersero conflitti di classe ed etnici, quando i “nazionalisti” e i rivoluzionari socialisti emersero come nuove élite privilegiate.
In definitiva, il percorso istituzionale e legale verso la pace soffre di disuguaglianza, poiché le disuguaglianze nel potere socio-politico si riproducono nelle istituzioni internazionali e nel loro personale critico. Pertanto, mentre nella forma sono internazionali, nel contenuto le loro regole e la loro metodologia, mettendo a tacere o viceversa, la selezione e la copertura degli atti criminali e dei loro autori, riflette l'interesse politico del potere imperiale. La soluzione che propongo è andare oltre l’antimperialismo, combinando la lotta per l’autodeterminazione con l’emancipazione di classe. Dobbiamo parlare apertamente, discutere e lottare per un nuovo equilibrio delle forze socio-politiche al fine di dare alle istituzioni internazionali e al personale che lavora in esse una direzione che vada a beneficio delle nazioni oppresse e delle classi sfruttate. E questo significa sostenere le tendenze democratiche, laiche e socialiste all’interno dei movimenti antimperialisti, sostenere le strutture istituzionali internazionali con una costante e forte enfasi sul loro contenuto di classe e nazionale. In definitiva, è necessario considerare non solo i potenziali disaccordi e conflitti tra imperialisti militari e imperialisti di mercato per ragioni tattiche (e per la creazione di alleanze fugaci), ma è anche importante tenere in considerazione i loro obiettivi strategici generali (costruzione di un impero), anche se a prima vista i loro metodi differiscono l'uno dall'altro.
Ritirare
Da tutto quanto sopra possiamo trarre le seguenti conclusioni.
Sia il conflitto che la pace come stati di interconnessione tra unità politiche come gli stati-nazione possono essere spiegati e risolti solo se la tradizionale divisione tra politica interna ed estera viene sostituita da un concetto in cui sono interconnessi anche diversi livelli di analisi, compresi diversi settori. società.
È pericoloso separare le politiche estere, economiche e militari le une dalle altre. I conflitti di natura “puramente” politica, economica, militare o di altro tipo sono rari; nella maggior parte dei casi troviamo un mix di cause. L’idea che la pace e la sicurezza abbiano un significato politico, economico, militare, socioculturale, ecc. La "dimensione" dovrebbe ispirare l'analista a cercare le relazioni tra queste dimensioni. Soprattutto se si analizza la dinamica dei conflitti, sia in termini di escalation che in termini di risoluzione, si può spesso trovare un caratteristico effetto di alimentazione tra: le guerre non sono solo caratterizzate da ostilità, ma hanno anche enormi conseguenze politiche e conseguenze economiche, sia attese che inattese.
Nella politica reale, l’antagonismo tra conflitto e cooperazione nelle relazioni tra società o all’interno di una società si manifesta molto raramente, come spesso si immagina. Nella maggior parte dei casi – e anche nei conflitti ad alta escalation – c’è sia conflitto che cooperazione; in alcuni casi, i conflitti danno origine a un consenso, per quanto limitato possa essere. Ciò significa che l’analisi dei conflitti deve esaminare la relazione tra cooperazione e conflitto, e che la risoluzione dei conflitti e la costruzione della pace devono trarre vantaggio dal consenso aperto o tacito esistente tra le parti in conflitto.
Bibliografia
1. Andreev V.I. Conflittologia: l'arte della disputa, della negoziazione, della risoluzione dei conflitti: monografia. - Kazan: Ditta "SKAM", 1992. - 138, p.
- Conflittologia di Dmitriev A.V.: libro di testo. aiuti per gli studenti università - M.: Gardariki, 2000. - 318, p.
- Conflitti nella Russia moderna (problemi di analisi e regolamentazione) / Ed. E.I.Stepanova. -Ed. 2°. - M.: Editoriale URSS, 2000. - 344 p.
- Conflittologia: manuale di base. - K.: KNEU, 2005. - 315, pag.
- Kremenjuk V.A. Sulla probabilità di un nuovo conflitto europeo // Cosmopolis-1999. - M.: Polis, 1999. - P.142-148
- Lezhenina T.V. Conflitti interpaesi nell'Asia orientale negli anni '90 del XX secolo // Riforme ieri, oggi, domani: Bollettino scientifico. informazione. - 2000. - N 8. - P.30-46
- Orlyansky V. S. Conflittologia: Navch. Manuale per le università. - K.: Centro di Letteratura Educativa, 2007. - 159, p.
- Primush M.V. Conflittologia: Capo. Manuale per le università. - Kiev: Casa Vidavnichy "Professional", 2006. - 282, p.
- Pronina E., Pronin E. Archetipi della guerra totale in un conflitto locale // Stato. servizio. - 2001. - N 4(14) (dicembre 2001 / gennaio 2002). - P.18-29
- Pryakhin V.F. Conflitti regionali nello spazio post-sovietico (Abkhazia, Ossezia del Sud, Transnistria, Tagikistan). - M.: Casa editrice GNOM e D, 2000. - 344 p.
- Skibitska L.I. Conflittologia: manuale di base per gli studenti. Maggiori mutui iniziali. - K.: Centro di Letteratura Educativa, 2007. - 383 p.
- Shishov A.V. Russia e Giappone. Storia dei conflitti militari. - M.: Veche, 2001. - 576 p.
Saggio su un argomento libero (voto 10)
"Un mondo senza guerre"
Sono passati molti decenni dalla fine della Grande Guerra Patriottica. Molte persone morirono allora. Ma sono morti tutti per una giusta causa. Fino ad ora abbiamo un cielo sereno sopra le nostre teste.
I nostri nonni e bisnonni, per alcuni già trisnonni, versano il loro sangue per sconfiggere un nemico insidioso e potente. Questa era la Grande Guerra. Una guerra santa per tutto il nostro popolo. Non sorprende che oggi vengano girati molti film sulla Grande Guerra Patriottica. Ciò indica quanto fortemente la guerra sia impressa nella memoria del nostro popolo. Quanto dolore e sfortuna ha portato.
A volte, guardando tutti questi film, sembra che la guerra sia finita non settant'anni fa, ma un anno o due fa. I ricordi della guerra sono così vivi nell'anima della nostra gente. Sembra che ci sia una guerra e i suoi ricordi vengono trasmessi a livello genetico.
Le generazioni più giovani non dovrebbero dimenticare l'impresa dei loro antenati. Ricorda, preserva la memoria degli eroi e ciò che hanno fatto per noi, i loro discendenti. La guerra fu terribile e crudele. Molti non credevano nemmeno che sarebbe mai finita. Ma tutto finì e arrivò la pace.
È vero, il mondo non è molto affidabile. La nostra Patria ha ancora oggi molti nemici che vogliono cancellare il nostro bellissimo Paese dalla faccia della terra. Ma non permetteremo che i nostri nemici lo facciano.
Noi, eredi degli eroi della Grande Guerra Patriottica, faremo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere la nostra Patria dai nemici moderni. Sono tecnologicamente più avanzati. Ma abbiamo anche molte armi moderne. Il nostro esercito e la nostra marina sono più forti che mai.
Il mondo ha bisogno di essere protetto. E lo proteggeremo in ogni modo possibile. La pace è la cosa principale che ha una persona. Non ci sarà pace, non ci sarà nulla. Non ci saranno Internet, né social network, né uffici né supermercati. Tutto ciò a cui siamo abituati scomparirà. Il modo stesso della nostra vita scomparirà. Faremo quindi tutto il possibile affinché i cieli del nostro Paese non siano illuminati dai lampi di proiettili e dalle esplosioni di razzi.
È vero, non tutti vogliono e sono pronti a difendere la propria patria. Ma ce ne sono meno. La maggior parte dei giovani è pronta ad andare in guerra in qualsiasi momento e a combattere per ogni cinque delle loro terre sacre. Non abbiamo mai ceduto la nostra terra al nemico e mai lo faremo. Combatteremo fino al nostro ultimo respiro.
Abbiamo un esercito forte, una marina, un'aviazione moderna e un esercito invincibile di cui tutti hanno paura. Siamo pronti a combattere qualsiasi nemico che decida di attaccarci. Non abbiamo paura di nessuno. Dopotutto, chiunque venga da noi con una spada morirà a causa di essa. Siamo degni eredi degli eroi della Grande Guerra Patriottica.