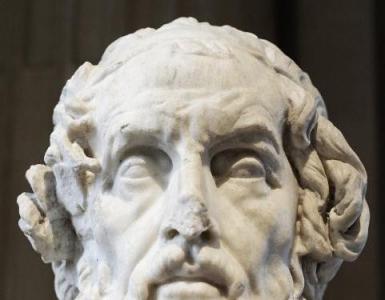Le ghiandole endocrine sono strutturalmente... Lo studio delle ghiandole endocrine - endocrinologia. Tiroide e ghiandole paratiroidi del sistema endocrino
Il concetto di ghiandole endocrine e le loro caratteristiche.
Classificazione delle ghiandole endocrine.
Caratteristiche dei singoli gruppi di ghiandole:
1. Il concetto di ghiandole endocrine e le loro caratteristiche.
Le ghiandole endocrine o ghiandole endocrine (di seguito abbreviate come ESG) sono organi costituiti da cellule specifiche ghiandolari specializzate nella formazione e nel rilascio nell'ambiente interno del corpo di speciali sostanze biologicamente attive - ormoni coinvolti nella regolazione e integrazione delle funzioni corporee.
Caratteristiche morfologiche delle ghiandole endocrine:
le ghiandole endocrine sono prive di dotto escretore
le ghiandole secernono le loro secrezioni nel sangue o nella linfa
Nonostante il loro enorme significato funzionale, i VVS sono di piccole dimensioni
man mano che gli ormoni entrano nel sangue, le ghiandole ricevono un abbondante apporto di sangue da diverse fonti
la rete vascolare delle ghiandole è rappresentata da capillari sanguigni che hanno una struttura specifica - sinusoidi (capillari dilatati in modo irregolare, la cui parete endoteliale è direttamente adiacente alle cellule epiteliali della ghiandola)
Le ghiandole endocrine producono ormoni in quantità estremamente piccole, ma la cui attività biologica è piuttosto elevata.
I VVS ricevono una ricca innervazione autonomica.
Il segreto delle ghiandole endocrine - ormoni - sostanze organiche biologicamente attive prodotte da alcuni gruppi cellulari del corpo e che regolano il funzionamento del corpo.
2. Classificazione delle ghiandole endocrine:
A seconda della loro provenienza da vari primordi embrionali, le ghiandole endocrine si dividono nei seguenti gruppi:
1. Ghiandole di origine endodermica:
a) gruppo branchiogenico: tiroide e paratiroidi, timo
b) derivati dell'endoderma intestinale: l'apparato insulare del pancreas
2. Ghiandole di origine mesodermica: corteccia surrenale, parte endocrina delle gonadi
3. Ghiandole di origine ectodermica:
a) gruppo neurogenico: ghiandola pituitaria, ghiandola pineale
b) gruppo surrenale: midollo surrenale, paragangli (corpi cromaffini).
Caratteristiche dei singoli gruppi di ghiandole: ghiandola pituitaria.
La ghiandola pituitaria è un organo spaiato a forma di fagiolo. Come parte del diencefalo, la ghiandola pituitaria è collegata a varie parti del sistema nervoso centrale.
La ghiandola pituitaria ha due lobi:
anteriore (adenoipofisi): parte tubercolare e parte intermedia;
posteriore (neuroipofisi).
Ormoni della ghiandola pituitaria anteriore.
Ormone somatotropo (STH) stimola la crescita e lo sviluppo dei tessuti corporei, influenza il metabolismo dei carboidrati, delle proteine, dei grassi e dei minerali.
Ormone adrenocorticotropo (ACTH) attiva la corteccia surrenale, aumenta il tasso di sintesi degli ormoni corticosteroidi.
Ormone stimolante la tiroide (TSH) stimola l'attività della ghiandola tiroidea, la crescita delle cellule epiteliali dei follicoli tiroidei, accelera il tasso di sintesi degli ormoni tiroidei, attiva l'accumulo di iodio nella ghiandola tiroidea, aumenta il flusso degli ormoni tiroidei nel sangue.
Ormone follicolo stimolante (FSH)) stimola la crescita e lo sviluppo dei follicoli nelle ovaie (nelle donne), attiva la spermatogenesi (negli uomini), controlla la produzione di estrogeni.
Ormone luteinizzante (LH) stimola la biosintesi e la secrezione dell'ormone sessuale maschile (testosterone) (negli uomini); nella donna determina l'inizio dell'ovulazione e la formazione del corpo luteo nelle ovaie, stimola la produzione dell'ormone sessuale: il progesterone.
Prolattina, ormone lattotropico (LTH) stimola la formazione del latte nelle ghiandole mammarie durante la gravidanza, stimola la formazione di progesterone.
Ghiandole endocrine Sono chiamati così perché non hanno dotti escretori e secernono la secrezione che producono direttamente nel sangue o nella linfa. Questi includono:
- ipofisi,
- tiroide,
- ghiandola pineale
- ghiandole paratiroidi,
- ghiandole surrenali,
- pancreas,
- timo.
- gonadi.
P O stomaco e gonadi Appartengono alle ghiandole a secrezione mista, perché alcune delle cellule che le compongono svolgono funzione esocrina.
I prodotti di scarto delle ghiandole endocrine sono ormoni, che sono sostanze biologicamente attive che regolano i processi vitali del corpo, la crescita e lo sviluppo delle cellule e dell'intero organismo. Il centro di interazione tra il sistema nervoso e quello umorale è ipotalamo , parte del diencefalo. Si trova verso il basso dal talamo sotto il solco ipotalamico ed è un insieme di cellule di conduzione nervosa e neurosecretrici. L'ipotalamo lo è il centro più alto per la regolazione delle funzioni vegetative del corpo.
Le cellule neurosecretrici dell'ipotalamo e i loro cluster (nuclei) producono neuroormoni, vasopressina, ossitocina, ecc. Centri nervosi dell'ipotalamo regolare:
- metabolismo, in particolare metabolismo del sale marino,
- termoregolazione,
- regolazione della pressione sanguigna, della respirazione, del sonno, della saturazione della fame.
L’ipotalamo controlla:
- funzioni di riproduzione,
- allattamento,
- costanza dell'ambiente interno del corpo.,
- partecipa all'attuazione delle reazioni protettive e adattative del corpo nel suo insieme.
L'ipotalamo insieme alla ghiandola pituitaria formano un unico complesso morfofunzionale - sistema ipotalamo-ipofisario e agiscono come un regolatore endocrino sottocorticale superiore.
Pituitaria - Questa è la principale ghiandola endocrina negli esseri umani e nei vertebrati. Gli ormoni di questa ghiandola influenzano la crescita, il metabolismo e la funzione riproduttiva. La ghiandola pituitaria è una piccola formazione situata alla base del cervello. La massa della ghiandola pituitaria in un adulto è 0,55–0,65 g; in un neonato – 0,1–0,15 g.
La ghiandola pituitaria è composta da tre lobi:
- anteriore (adenoipofisi),
- intermedio,
- posteriore (neuroipofisi).
Anteriore e intermedio i lobi sono costituiti da tessuto ghiandolare. Posteriore Il lobo della ghiandola pituitaria è costituito da tessuto nervoso. L'adenoipofisi costituisce i 2/3 della massa della ghiandola. Le sue cellule producono ormoni proteico-peptidici (tropici) che regolano l'attività delle ghiandole endocrine periferiche:
La ghiandola pituitaria produce somatotropico cosiddetto ormone un ormone della crescita, che colpisce direttamente l'intero corpo. Accelera i processi di crescita mantenendo le proporzioni corporee, poiché stimola la biosintesi delle proteine nelle cellule e nei tessuti di un organismo in crescita (aumenta la sintesi dell'RNA, migliora il trasporto degli aminoacidi dal sangue alle cellule e ai tessuti del corpo). Il metabolismo nel suo insieme è associato alla secrezione di somatotropina e l'interruzione della sua funzione porta a cambiamenti estremamente complessi sia nell'organismo in crescita che in quello maturo. Questo ormone viene prodotto solo di notte.
La più grande delle ghiandole endocrine è tiroide . Si trova sul collo nella zona delle cartilagini laringee. Il suo peso in un neonato è di 1 g, in un adulto il peso della ghiandola è di 30-50 g, con l'età la struttura della ghiandola cambia, soprattutto durante la pubertà. Con la vecchiaia, la massa della ghiandola diminuisce maggiormente negli uomini. La ghiandola tiroidea è composta da due lobi collegati da un istmo. La ghiandola è un regolatore del metabolismo delle proteine. I suoi ormoni aumentano l'attività degli enzimi proteolitici, regolano la crescita e lo sviluppo del corpo, migliorano l'immunità e aumentano la produzione di calore. La ghiandola tiroidea è innervata sistema nervoso simpatico.
La ghiandola tiroidea produce ormoni tirocalcitonina, regolatore del metabolismo del calcio. Questo ormone è una sorta di deposito di calcio nel tessuto osseo; sotto la sua influenza, il livello di calcio nel sangue diminuisce.
Ghiandole surrenali – ghiandole endocrine pari situate sopra i poli superiori dei reni a livello delle XI vertebre toraciche – I vertebre lombari, retroperitoneali. La ghiandola surrenale destra è di forma triangolare, la sinistra è lunata; Le basi concave delle ghiandole surrenali sono adiacenti ai poli convessi dei reni. I reni e le ghiandole surrenali sono racchiusi in una capsula grassa e ricoperti dalla fascia renale. Il peso medio di entrambe le ghiandole surrenali è di 10-14 g, più nelle donne che negli uomini.
Situato nelle ghiandole surrenali corteccia, che rappresenta circa 2/3 della massa totale della ghiandola surrenale, e midollo.
La corteccia è divisa in:
- glomerulare (esterno),
- raggio (medio),
- zona reticolare (interna).
È ricco di lipidi. Ormoni corticali corticosteroidi sintetizzato nei mitocondri delle cellule secretorie da colesterolo.
IN glomerulare zona ( mineralcorticoidi) viene sintetizzata la sostanza corticale aldosterone, coinvolto nella regolazione del metabolismo del sale marino. I mineralcorticoidi regolano il metabolismo dell’acqua e dei minerali.
IN trave zona ( glucocorticoidi) è sintetizzato prevalentemente cortisone, influenzando il metabolismo delle proteine, dei grassi e dei carboidrati e il metabolismo degli acidi nucleici. I glucocorticoidi regolano il metabolismo dei carboidrati. Gli ormoni steroidei corticali stimolano le prestazioni fisiche e riducono anche l’affaticamento dei muscoli scheletrici.
IN maglia si formano zone ormoni sessuali:
- androgeni,
- estrogeni,
- progesterone.
Il lobo reticolare delle ghiandole surrenali è una fonte di ormoni sessuali durante l'infanzia, quando la funzione delle gonadi è quasi assente. Dopo l'inizio della menopausa, la zona reticolare delle ghiandole surrenali rimane l'unico luogo in cui si formano gli ormoni sessuali.
Gli ormoni della corteccia surrenale sono coinvolti nelle reazioni protettive dell'organismo contro forti effetti avversi (dolore, freddo, mancanza di ossigeno, attività fisica, ecc.), che causano fatica. Nella prima fase dello stress, la secrezione di glucocorticoidi aumenta notevolmente. Nel secondo aumenta anche la secrezione di altri ormoni della corteccia surrenale e cresce, e nel terzo la secrezione si esaurisce. L'allenamento muscolare aumenta la secrezione di ormoni dalla corteccia surrenale, che aumenta le difese dell'organismo.
Cellule ghiandolari secernere il midollo catecolamine (adrenalina, norepinefrina e dopamina). L’adrenalina è talvolta chiamata “l’ormone della paura”, che aumenta le contrazioni cardiache, accelera il polso e aumenta la pressione sanguigna; rilassa la muscolatura liscia dei bronchi e dell'intestino; dilata i vasi sanguigni dei muscoli e del cuore; restringe i vasi sanguigni nella pelle, nelle mucose e nella cavità addominale; favorisce la contrazione dei muscoli dell'utero e della milza; gioca un ruolo importante nella risposta del corpo alle situazioni stressanti. La norepinefrina aumenta la pressione sanguigna. Le catecolamine controllano il metabolismo dei carboidrati e dei grassi, regolano il funzionamento del sistema cardiovascolare e influenzano la coagulazione del sangue. L'aumento della secrezione di adrenalina e norepinefrina stimola la sintesi degli ormoni steroidei.
Pancreas si riferisce alla ghiandola dell'apparato digerente. Produce succo pancreatico e contemporaneamente ha una funzione endocrina. Il pancreas si trova nella parte superiore dell'addome, nello spazio retroperitoneale a livello delle vertebre lombari I-II e ha la forma di una corda appiattita, in cui si distinguono testa, corpo e coda. La maggior parte del parenchima pancreatico secerne gli enzimi necessari per la digestione. Questi enzimi entrano nel dotto pancreatico che, fondendosi nella parte finale con il dotto biliare comune, si apre nel duodeno discendente. La parte più piccola del parenchima (parte endocrina) è raggruppata sotto forma di minuscole isole e intervallata dal parenchima della parte esocrina della ghiandola. Le isole sono di forma rotonda, ciascuna diversa per dimensione e frequenza di distribuzione nel suo tessuto.
Ormoni pancreas sono:
- insulina,
- glucagone,
- lipocaina.
Insulina aumenta la capacità delle membrane cellulari di passare i carboidrati. Diminuisce il contenuto di zuccheri liberi nel sangue; essi vengono depositati sotto forma di glicogeno o utilizzati nei processi energetici ossidativi del metabolismo cellulare. L'insulina aumenta l'attività degli enzimi ossidativi - glucochinasi e stimola la secrezione del succo gastrico.
Glucagone ha un effetto mobilizzante sul glicogeno immagazzinato, mentre aumenta la quantità di zucchero nel sangue (iperglicemia). Quantità eccessive vengono eliminate nelle urine (glicosuria). Somatostatina inibisce la secrezione di insulina e glucagone.
Lipocaina partecipa alla regolazione del metabolismo dei fosfolipidi, prevenendo il fegato grasso, stimolando la formazione di lecitina.
Timo(timo) è situato nella parte superiore del mediastino anteriore, regola la formazione e il funzionamento del sistema immunitario. I suoi lobi destro e sinistro non hanno la stessa dimensione. La ghiandola del timo lo è organo parenchimale, avente una struttura lobulare. Dalla membrana comune del tessuto connettivo, la capsula, si estendono setti (setti) che dividono il parenchima in lobuli di diverse dimensioni. Ogni lobo è costituito da corticale e cerebrale sostanze. La corteccia assomiglia ad una rete costituita da cellule epiteliali stellate; nei circuiti di questa rete sono linfociti(timociti), simili ai piccoli linfociti del sangue. La ghiandola del timo subisce cambiamenti legati all'età, ma anche nella vecchiaia conserva il tessuto parenchimale.
Funzione principale La ghiandola del timo è la regolazione della differenziazione dei linfociti. Qui avviene la trasformazione delle cellule staminali emopoietiche in linfociti T. La ghiandola del timo è coinvolta nella regolazione dell'immunità sia cellulare che umorale (formazione di anticorpi). Da estratti di tessuto del timo sono stati ottenuti preparati biologicamente attivi che stimolano le risposte immunitarie cellulari.

Riso. 2.16.Opzioni per l'organizzazione della ghiandola endocrina. A. - isole, B. - follicoli.
La ghiandola endocrina è costituita da gruppi di cellule endocrine circondate da tessuto connettivo con numerosi capillari sanguigni. Esistono due possibili opzioni per l'organizzazione della ghiandola endocrina. Nel caso (A) – isole, in (B) – follicoli. In quest'ultimo caso, gli ormoni provenienti dalle cellule endocrine entrano nel lume del follicolo, dove vengono immagazzinati e da lì trasportati nel sangue.
Gli ormoni secreti dalle ghiandole endocrine vengono trasportati dal sangue e dalla linfa in tutto il corpo e regolano i processi che si verificano in altri organi e tessuti, compresi i processi di crescita, sviluppo, metabolismo, ecc. Le ghiandole endocrine comprendono l'ipofisi, la ghiandola pineale, la tiroide e le paratiroidi, il timo, le ghiandole surrenali, le isole pancreatiche e le gonadi. Tutti formano il sistema endocrino o umorale del corpo.
Le ghiandole esocrine sono coinvolte nelle funzioni svolte dagli organi che includono queste ghiandole. Ad esempio, le ghiandole del tratto digestivo sono coinvolte nei processi di digestione. La stragrande maggioranza delle ghiandole esocrine sono formazioni multicellulari.
Secrezione.
Un processo complesso in cui si distinguono 4 fasi: assorbimento dei prodotti per la secrezione, sintesi e accumulo della secrezione, rilascio della secrezione e ripristino della struttura delle cellule ghiandolari. Il rilascio della secrezione avviene periodicamente, quindi sono visibili cambiamenti che si ripetono naturalmente nelle cellule ghiandolari . Tutti i cambiamenti nelle cellule ghiandolari associati alla secrezione costituiscono il loro ciclo secretorio.
1a fase. Dal sangue e dalla linfa, vari composti inorganici, acqua e sostanze organiche a basso peso molecolare: aminoacidi, monosaccaridi, acidi grassi, ecc. entrano nelle cellule ghiandolari dalla loro superficie basale.
Fase 2. Dalle sostanze in arrivo, i composti organici complessi vengono sintetizzati nel reticolo citoplasmatico delle cellule ghiandolari. Queste connessioni tra le membrane del reticolo citoplasmatico si spostano nella zona del complesso lamellare, dove gradualmente si accumulano e si formano in granuli.
Fase 3. Aree del complesso lamellare contenenti granuli si staccano e si trasformano in grandi vacuoli pieni di secrezione. Successivamente, la secrezione formata nelle cellule viene rilasciata nel lume delle sezioni terminali della ghiandola.
Fase 4. Caratterizzato dal ripristino delle dimensioni e della struttura originali delle cellule ghiandolari. Nelle ghiandole che secernono secondo il tipo olocrino, ciò avviene a causa di speciali cellule scarsamente differenziate che si moltiplicano intensamente e si trasformano in cellule ghiandolari.
Diversi tipi di secrezione:
In base al metodo di secrezione dalla cellula, le ghiandole si dividono in tre tipi: merocrine, apocrine e olocrine. Durante la secrezione merocrina, le cellule ghiandolari non vengono distrutte. Le ghiandole merocrine comprendono: ghiandole salivari, pancreas, la maggior parte delle ghiandole sudoripare, ecc. La secrezione apocrina si divide in secrezione macroapocrina, quando la parte apicale della cellula ghiandolare viene separata e convertita in secrezione, e secrezione microapocrina, quando le parti apicali della cellula i microvilli sono separati. Esempi di ghiandole apocrine sono le ghiandole mammarie e sudoripare delle zone ascellari. Con la secrezione olocrina l'intera cellula viene distrutta. In questo caso, la ghiandola contiene costantemente uno strato di cellule ghiandolari scarsamente differenziate che si moltiplicano costantemente, le cellule accumulano secrezioni e le cellule collassano. Un esempio di ghiandola olocrina è la ghiandola sebacea della pelle. In base alla composizione chimica della secrezione, le ghiandole si distinguono in mucose, proteiche, sudoripare, sebacee e altre.
Tavolo. 2.2.
Tipi di secrezione
Le cellule secretorie possono essere ghiandole singole o formare ghiandole multicellulari. L'unico tipo di ghiandole esocrine unicellulari presenti nel corpo umano sono le cellule caliciformi.

Riso. 2.17. Microfotografia di una cellula secretoria.
Una cellula secretoria è una ghiandola unicellulare. Le cellule mucose si trovano singolarmente nell'epitelio e sono ghiandole unicellulari (di colore bordeaux) poiché queste ghiandole si trovano nello strato epiteliale e non si estendono oltre i suoi confini, sono chiamate endoepiteliali.
Ghiandole
Esistono due gruppi di ghiandole: ghiandole endocrine, o ghiandole endocrine, e ghiandole esocrine, o ghiandole esocrine. Le ghiandole endocrine producono secrezioni che vengono rilasciate nell'ambiente interno, cioè entrano direttamente nel sangue, quindi le ghiandole endocrine sono costituite solo da cellule ghiandolari e non hanno dotti escretori. Le ghiandole esocrine producono secrezioni che vengono rilasciate nell'ambiente esterno, cioè sulla superficie della pelle o nel lume degli organi cavi. A questo proposito, sono costituiti da due sezioni: la sezione terminale (secretoria) e il dotto escretore (Fig. 2.18.)
Ogni cellula del corpo e la sostanza vivente intercellulare del tessuto connettivo, nel processo di scambio, forma nuove sostanze e prodotti di scarto che penetrano nei tessuti circostanti, nei vasi sanguigni e linfatici. Molte di queste sostanze svolgono un ruolo enorme nel mantenimento dei normali processi fisiologici. In varie parti del corpo ci sono ghiandole endocrine, prive di dotti escretori, adatte alla produzione di sostanze speciali - ormoni, in quantità relativamente piccole provenienti dalle cellule delle ghiandole direttamente nel sangue e nella linfa. Essendo nei tessuti, nel sangue e nella linfa, gli ormoni si diffondono rapidamente in tutto il corpo e influenzano la velocità di vari tipi di metabolismo, accelerano o rallentano la crescita cellulare, esercitando così un'influenza formativa sullo sviluppo del corpo. La regolazione delle funzioni corporee è effettuata dal sistema nervoso e dagli ormoni endocrini. Gli ormoni sono prodotti da organi endocrini e paragangli che, come tutti gli altri organi, sono sotto il controllo del sistema nervoso e sono funzionalmente collegati tra loro. Gli organi endocrini si trovano solo nei vertebrati, negli artropodi e nei cefalopodi. Il sistema nervoso regola così direttamente il metabolismo, inviando impulsi non solo alle cellule dei vari organi; ma anche alle ghiandole endocrine. Di conseguenza, la regolazione nervosa e la correzione chimica con l’aiuto degli ormoni si stratificano nel corpo e la correzione chimica con gli ormoni richiede più tempo. A loro volta, gli ormoni stimolano o inibiscono i processi metabolici nel tessuto nervoso, stimolano o inibiscono reciprocamente la funzione delle ghiandole endocrine. Di conseguenza, con le malattie endocrine, si verifica una complessa catena di fenomeni quando non solo molte ghiandole, ma anche il sistema nervoso sono coinvolte nel processo. In connessione con questa complessità e la mancanza di metodi di ricerca oggettivi nella scienza all'inizio del XIX secolo, sorsero idee sull'importanza principale delle ghiandole endocrine nel corpo. Solo la ricerca di I.M. Sechenov ha confermato la dottrina dell'influenza normativa sul corpo del sistema nervoso centrale, comprese le ghiandole endocrine.
Tutte le ghiandole endocrine sono piccole; l'unica eccezione è la ghiandola tiroidea, la cui massa raggiunge i 40-50 g, ciò è dovuto al fatto che la sintesi dell'ormone diiodotirosina richiede l'amminoacido tiroxina, che contiene il microelemento iodio. C'è una piccola quantità di iodio nell'ambiente esterno e nel corpo. Per catturare tutte le molecole di iodio che circolano nel sangue, la ghiandola tiroidea è aumentata fino a raggiungere una dimensione così ottimale che una grande massa di sangue scorre attraverso il suo sistema vascolare ben sviluppato nell'unità di tempo.
Tutte le ghiandole sono caratterizzate da un intenso flusso sanguigno e drenaggio linfatico. I capillari nelle ghiandole hanno caratteristiche strutturali per il riassorbimento degli ormoni. La regolazione rapida e fine della funzione ghiandolare viene effettuata con l'aiuto di un sistema nervoso autonomo ben sviluppato.
Tutti gli organi endocrini e i paragangli in base al loro sviluppo embrionale sono divisi nei seguenti gruppi.
| 1. Ghiandole endodermiche: | Il loro sviluppo |
| a) tiroide | Dalla parete della gola |
| b) ghiandole paratiroidi c) ghiandola del timo |
Dalle tasche branchiali |
| d) apparato insulare del pancreas | Dall'epitelio del tubo intestinale |
| 2. Ghiandole mesodermiche. | |
| a) corteccia surrenale | |
| b) parte endocrina del testicolo c) parte endocrina della ghiandola prostatica d) parte endocrina dell'ovaio e) parte endocrina dell'utero |
Dall'epitelio della cavità corporea secondaria |
| 3. Ghiandole ectodermiche: | |
| a) ghiandola pituitaria b) corpo pineale |
Derivato dall'epitelio del diencefalo e della baia orale |
| c) midollo surrenale d) paragangli (corpi cromaffini) |
Derivato delle pieghe paragangliari del tubo neurale |
Il sistema endocrino, insieme al sistema nervoso, partecipa alla regolazione delle funzioni vitali del corpo, mentre gli influssi ormonali svolgono un ruolo di primo piano nella regolazione delle funzioni generali del corpo come il metabolismo, la crescita somatica e le funzioni riproduttive. L'eccesso o la carenza di ormoni può causare gravi malattie umane.
Nel corpo umano, il sistema endocrino è rappresentato dai nuclei secretori dell'ipotalamo, dell'ipofisi, della ghiandola pineale (epifisi), della tiroide, delle ghiandole paratiroidi, delle ghiandole surrenali, delle parti endocrine del pancreas e delle gonadi, nonché da singole cellule ghiandolari situate in altri organi e tessuti (Fig. 133 ).
Secondo le concezioni moderne, basate sulle caratteristiche strutturali e funzionali delle ghiandole endocrine, l'anello centrale del sistema endocrino (ipotalamo, ghiandola pituitaria, corpo pineale) e il suo anello periferico, rappresentato da ghiandole dipendenti dall'ipofisi anteriore (tiroide , corteccia surrenale - corpo pineale) si distinguono ; 2 - ghiandole neurosecretrici, gonadi). Secretario
nuclei tor dell'ipotalamo; 3 - ghiandola pituitaria; nuclei dell'ipotalamo e della ghiandola pineale ob-4 - la tiroide e le ghiandole paratiroidi formano il gruppo neuroendocrino
PS; 5 - ghiandola del timo; 6 - interruttori surrenali, ad es. con abbassamento; 7 - pancreas; 8 - uova - con il potere dei loro ormoni trasferiscono -
Nick; 9 - testicolo,
cattura le informazioni in arrivo
nel sistema nervoso centrale, alla ghiandola pituitaria, che a sua volta rilascia il necessario
la quantità di ormoni che stimolano la funzione periferica
ghiandole endocrine.
Riso. 133. Disposizione delle ghiandole endocrine:
La ghiandola pituitaria (ipofisi) è una formazione spaiata, allungata e di forma rotonda. Rivestito esternamente con dura madre. Il suo lobo anteriore ha una tinta rossastra, il lobo posteriore è giallo pallido. Dimensioni dell'organo: verticale - da 6 a 7 mm, trasversale - da 12 a 14 mm, peso - da 0,3 a 0,7 g È racchiuso in una densa membrana di tessuto connettivo situata nella “sella turcica”. La ghiandola pituitaria è costituita da una parte anteriore, intermedia e posteriore (lobo).
Il lobo anteriore (adenoipofisi) è costituito da cellule epiteliali. È abbondantemente fornito di vasi sanguigni, che determinano il colore rosso-marrone dell'adenoipofisi.
Il lobo anteriore della ghiandola pituitaria produce ormoni somatotropici, adrenocorticotropi, tireotropi e gonadotropici. Nella parte intermedia si forma l'ormone stimolante i melanociti, che controlla la formazione dei pigmenti - melanine - nel corpo.
Il lobo intermedio è costituito da tessuto epiteliale.
Il lobo posteriore (neuroipofisi) è di colore giallo-grigiastro, per la presenza di un pigmento bruno-giallastro. È costituito da tessuto neurogliale e da un piccolo numero di cellule ependimali. Gli ormoni vasopressina e ossitocina prodotti dai nuclei dell'ipotalamo vengono trasportati al lobo posteriore della ghiandola pituitaria. La vasopressina ha un effetto vasocostrittore e antidiuretico. L'ossitocina stimola le contrazioni miometriali e inibisce lo sviluppo e la funzione del corpo luteo.
La ghiandola tiroidea (glan-dula tiroidea) è spaiata, la più grande di tutte le ghiandole (Fig. 134). Situato nella parte anteriore del collo, davanti e lateralmente alla trachea. Ha una forma a ferro di cavallo convessa ed è costituito da due lobi laterali di dimensioni disuguali, collegati da un istmo. A volte manca l'istmo. Il peso della ghiandola va da 30 a 60 g, la dimensione longitudinale è di 6 cm, la dimensione trasversale è di 4 cm, lo spessore è di 2 cm, il colore è rosa-giallastro. Coperto con 2 (interno ed esterno)

Riso. 134. Tiroide, paratiroidi e timo: A - vista posteriore, B - vista frontale, 1 - tiroide, 2 - paratiroidi superiori, 3 - paratiroidi inferiori, 4 - laringe, 5 - trachea, 6 - polmone, 7 - ghiandola del timo, 8 - pericardio
sacche di tessuto connettivo. È costituito da epitelio, ricoperto da sacche glia (capsule) interne ed esterne. Tra queste membrane nello spazio a fessura si trovano tessuti sciolti e grassi. I fasci di tessuto connettivo che si estendono dalla sacca esterna collegano la ghiandola alla cartilagine della laringe, della trachea e dei muscoli. Produce gli ormoni triiodotironina, tetraiodotironina (tiroxina), tirocalcitonina.
Ghiandole paratiroidi (glandulae paratiroideae) - accoppiate
corpi rotondi o ovoidali di colore bruno-giallastro. Peso - 0,05-0,09 g, dimensione longitudinale - 4-8 mm, dimensione trasversale - 3-4 mm. Situato sulla superficie posteriore dei lobi laterali della ghiandola tiroidea. Esistono due paia di ghiandole: due paratiroidi superiori e due paratiroidi inferiori. Ciascuna ghiandola paratiroidea è ricoperta da una capsula di tessuto connettivo. Il parenchima delle ghiandole è costituito da cellule epiteliali, tra le quali si trovano strati di tessuto connettivo.
Le ghiandole surrenali sono organi pari che hanno la forma di un cono appiattito dalla parte anteriore a quella posteriore. Il colore è giallastro, la lunghezza è di 4-6 cm, il peso varia da 12 a 20 g.Il surrene destro ha forma di triangolo, mentre l'apice di quella sinistra è levigato, a forma di mezzaluna. Le ghiandole surrenali si trovano a livello delle vertebre toraciche X1-X11, direttamente sopra l'estremità superiore del rene corrispondente (Fig. 135).

Riso. Ida. Jupografia delle ghiandole surrenali:
1 - diaframma; 2 - ghiandola surrenale; 3 - rene; 4 - aorta; 5 - vena cava inferiore; 6 - uretere
All'esterno, le ghiandole surrenali sono ricoperte da una capsula fibrosa, strettamente fusa con il parenchima e che si estende numerose trabecole di collegamento in profondità nell'organo. Le ghiandole surrenali sono costituite da una corteccia e da un midollo, che hanno origini diverse. La corteccia è adiacente alla capsula fibrosa dall'interno ed è divisa in tre zone.
La zona glomerulosa si trova più vicino alla capsula fibrosa. Segue la zona fascicolata mediana e, al confine con il midollo, la zona reticolare. Morfologicamente ciascuna zona è costituita da cellule ghiandolari e tessuto connettivo; Le zone sono separate l'una dall'altra poiché producono ormoni diversi. Gli ormoni della corteccia surrenale sono chiamati corticosteroidi. La zona glomerulosa produce mineralcorticoidi (aldosterone, desossicorticosterone, ecc.), la zona fascicolata produce glucocorticoidi (idrocortisone, corticosterone, desossicorticosterone, ecc.), la zona reticolare produce ormoni sessuali (androgeni ed estrogeni).
Al centro della ghiandola surrenale si trova il midollo (rosso-brunastro), formato da grandi cellule giallo-marroni. Esistono due gruppi di cellule: gli epinefrociti, che producono adrenalina, e i norepinefrociti, che producono norepinefrina.
Parte endocrina delle gonadi
Gonadi: ghiandole seminali maschili (testicoli) e gonadi femminili (ovaie).
La ghiandola seminale, testicolo (testicolo) è un bagno turco, situato nella parte inferiore dello scroto. Il testicolo è un organo appiattito lateralmente. La sua lunghezza è 4,5 cm, larghezza - 3 cm, spessore - 2 cm, peso - 25-30 g È sospeso al cordone spermatico. L'epididimo si trova sul bordo posteriore del testicolo. Il testicolo è formato da un parenchima racchiuso in una densa tunica albuginea di tessuto connettivo. Dalla tunica albuginea allo spessore del testicolo si trovano i setti testicolari, che dividono la ghiandola in 250-300 segmenti a forma di estremità del testicolo. I lobuli contengono tubuli contorti, dove vengono prodotti gli elementi seminiferi, dai quali si sviluppano gli spermatozoi.
Il testicolo e il suo epididimo sono racchiusi nella tunica vaginale, che forma attorno ad essi una membrana sierosa chiusa. Il testicolo è innervato dai plessi celiaco, renale e addominale, l'afflusso di sangue avviene dall'aorta addominale attraverso vasi arteriosi, le vene confluiscono nella vena cava inferiore. Producono ormoni: androgeni.
Il testicolo negli uomini e l'ovaio nelle donne, oltre alle cellule germinali, producono e rilasciano nel sangue ormoni sessuali, sotto l'influenza dei quali si formano i caratteri sessuali secondari.
La funzione endocrina nel testicolo è posseduta dalle cellule interstizio-ghiandolari (cellule di Leydig), che si trovano nel tessuto connettivo lasso tra i segmenti dei tubuli contorti, accanto ai capillari sanguigni e linfatici. Queste cellule producono l’ormone sessuale maschile testosterone.
L'ovaio (ovario) è una ghiandola femminile accoppiata di forma ovoidale, appiattita in direzione anteroposteriore. Il colore dell'ovaio è rosato, peso - 5-8 g, lunghezza - 2,5-4 cm, larghezza - 1,5-3 cm Nella sua posizione quasi verticale, l'organo è tenuto grazie al proprio legamento e al legamento che sospende l'ovaio ovaio alla piega del peritoneo. Il parenchima ovarico è rappresentato dal midollo e dalla sostanza corticale (ghiandolare). La corteccia contiene follicoli ovarici vescicolari.
Nell'ovaio, lo strato granulare dei follicoli in maturazione e le cellule dell'interstizio ovarico producono gli ormoni sessuali estrogeni e progesterone. La crescita dei follicoli avviene sotto l'influenza degli ormoni follicolo-stimolanti e luteinizzanti della ghiandola pituitaria. L'ormone luteinizzante provoca l'ovulazione e la formazione del corpo luteo, le cui cellule producono progesterone. Il progesterone inibisce la crescita dei follicoli riproduttivi e prepara la mucosa uterina a ricevere un ovulo fecondato.
Domande per l'autocontrollo
1. Parlaci della classificazione delle ghiandole endocrine e del loro ruolo in un organismo vivente.
2. Spiegare la relazione tra il sistema endocrino e il sistema nervoso.
3. Nomina i nuclei neurosecretori dell'ipotalamo, i loro ormoni e descrivi la loro connessione con la ghiandola pituitaria.
4. Elencare i nuclei dell'ipotalamo anteriore. Spiegare il loro ruolo nel corpo.
5. Qual è il significato funzionale dei nuclei dell'ipotalamo medio?
6. Descrivi la struttura della ghiandola pituitaria, la sua connessione con altre ghiandole endocrine.
7. Spiegare il ruolo della ghiandola pituitaria anteriore.
8. Quali sono le caratteristiche funzionali del lobo posteriore della ghiandola pituitaria? 216
9. Qual è la struttura della ghiandola pineale e il suo ruolo nel corpo?
10. Descrivere la struttura e le caratteristiche funzionali della ghiandola tiroidea.
11. Descrivi la struttura e il ruolo delle ghiandole paratiroidi nel corpo, la loro posizione.
12. Qual è la struttura e la posizione delle ghiandole surrenali?
13. Quali sono le caratteristiche strutturali e le funzioni della corteccia surrenale?
14. Che ruolo svolge la midollare del surrene nel corpo?
15. Raccontaci della parte endocrina del pancreas. Dai un nome alle sue cellule e al loro significato funzionale.
16. Quali sono le funzioni endocrine delle gonadi?
17. Descrivi le funzioni del testicolo.
18. Quali sono le caratteristiche della struttura e del funzionamento della parte endocrina delle ovaie?