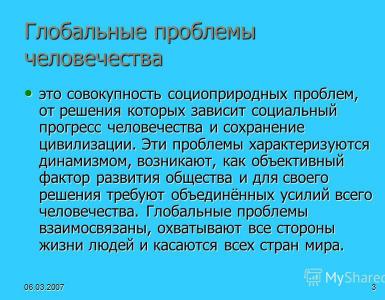Biografia di innocenti 3. Biografia. Politica orientale I
I secoli XII e XIII furono l'apice del potere ecclesiastico, politico e spirituale del papato. Ma il potere papale raggiunse il suo apice durante il pontificato di Innocenzo III. La storia della Chiesa considera chiaramente Innocenzo III il papa più eccezionale del Medioevo. Il papato raggiunse l'apice del potere come risultato dello stesso processo storico di sviluppo che, durante il periodo del feudalesimo avanzato, portò al rafforzamento del potere regio centralizzato.
Innocenzo III riuscì a stabilizzare la sua posizione anche perché il potere dell'imperatore cominciava a declinare. In Italia il potere dell'imperatore era di fatto finito, ma un altro potere feudale non aveva ancora potuto prendere il suo posto. Durante il pontificato di Innocenzo III, un tempo sembrava che il sogno di Gregorio VII di dominio del mondo da parte del papa si stesse realizzando. Il primato del papato si realizzava sotto tutti gli aspetti; Il pontificato di Innocenzo è una concreta conferma di questo postulato. Superò i suoi predecessori nell'esercizio pratico del potere politico del papato. Come statista lasciò molto indietro Gregorio VII, ma non godette affatto della gloria di un santo. Con la sua politica realistica, Innocenzo III avvicinò il più possibile alla realizzazione l'idea di Gregorio VII di una teocrazia universale.
Innocenzo III, salito al soglio pontificio nel 1198, era figlio del conte di Treismondo, rampollo dell'antica celebre famiglia dei Conti (di Anagni). Fu un dotto teologo e avvocato. A Parigi imparò il metodo dialettico e a Bologna ricevette un'educazione in diritto romano. Nel 1189, suo zio Clemente III elevò il conte 29enne al rango di cardinale. Sotto Celestino III il nipote dell'ex papa dovette lasciare la curia. Non aveva ancora 38 anni quando i cardinali lo elessero papa all'unanimità, il giorno della morte di Celestino III.
Innocenzo capì bene che i suoi disegni di dominio del mondo avrebbero potuto realizzarsi solo quando fosse diventato il sovrano assoluto, prima di Roma e dello Stato della Chiesa, e poi della Chiesa universale. Egli partiva dal fatto che la libertà illimitata della Chiesa - se con questo intendiamo la supremazia del papa - si basa sul forte potere del papa sullo stato secolare indipendente. Pertanto, la creazione dello Stato Pontificio è una precondizione per la creazione del potere politico universale, al quale Innocenzo III si avvicinò di più nella storia del papato.
Innanzitutto Innocenzo III riformò la corte pontificia. Creò un sistema burocratico di lavoro d'ufficio ben funzionante e di larghe vedute, dando così un esempio dell'organizzazione degli stati burocratici contemporanei. Innocenzo III è considerato a buon diritto il secondo fondatore dello Stato Pontificio. Sotto di lui il Patrimonium di San Pietro divenne un vero e proprio Stato, una monarchia assoluta, dove i sudditi non erano altro che funzionari, ed erano sotto l'autorità di un unico monarca, sotto il potere illimitato del papa. Dapprima si assicurò un posto fisso a Roma. Costrinse l'allora prefetto della città, rappresentante dell'imperatore, a dimettersi dalle sue funzioni di capo dell'istituzione, e riacquistò la sua posizione solo quando, il giorno dell'incoronazione del papa, gli consegnò il giuramento di fedeltà. Innocenzo costrinse alle dimissioni il senatore eletto dal popolo di Roma. Al suo posto il papa nominò un senatore obbediente, che si dichiarò anche vassallo. Allo stesso modo, Innocenzo III pretese dall'élite aristocratica dello Stato Pontificio un giuramento di vassallo, cosa che riuscì a ottenere.
Con la morte di Enrico VI nel 1197, il dominio tedesco in Italia crollò. Ciò significò per Innocenzo III, insieme alla restituzione delle province perdute da parte dello Stato della Chiesa, anche la possibilità di espansione territoriale dei suoi possedimenti. Avendo usato con successo i sentimenti antitedeschi degli italiani per questi scopi, Innocenzo ripristinò il suo potere sulla Romagna (restituendo a se stesso Ravenna), e prese nuovamente possesso di Ancona (Marca). In seguito all'inclusione del Ducato di Spoleto (Umbria), il territorio dello Stato Pontificio divenne molto più compatto. Alla fine Innocenzo riuscì a mettere le mani sull’eredità a lungo contesa di Matilda. Il Papa esercitò con successo i suoi diritti di sovranità nei confronti della Sicilia e dell'Italia meridionale. La sua influenza si rafforzò soprattutto sotto la regina vedova Costanza. Quando la regina morì nel 1198, lasciò un testamento, secondo il quale Innocenzo III divenne reggente della Sicilia e tutore del neonato Federico II. Durante il pontificato di Innocenzo III, il papato si assicurò saldamente, insieme al Patrimonium di San Pietro, le terre di Ancona, Spoleto e Radicofano (la cosiddetta eredità matildica). Nemmeno lui però poté trattenere a lungo i territori della Romagna, di Bologna e della Pentapoli, sebbene questi territori fossero considerati appartenenti allo Stato della Chiesa.
Innocenzo si considerava non solo il vicario di Cristo, ma anche il capo del mondo cristiano. Intervenne in ogni evento importante della sua epoca, assumendo il ruolo di arbitro onnipotente per la preservazione o il ripristino dell'ordine dato da Dio. Innocenzo III sosteneva: a capo di ogni singolo paese ci sono dei re, ma sopra ciascuno di essi siede sul trono San Pietro e il suo viceré, il papa, il quale, essendo sovrano, concede l'imperatore. Papà riuscì più facilmente a realizzare le sue aspirazioni di questo tipo in Germania, dove infuriava la guerra civile. Nel 1198 i principi elessero addirittura due re: Filippo II (di Svevia) e Ottone IV (Hohenstaufen). Il Papa sostenne Ottone, poiché da lui ricevette le più ampie promesse di rispettare i privilegi papali. Dopo l'assassinio di Filippo, nell'arena rimase solo Ottone, che il papa incoronò imperatore nel 1209. Ma dopo che Ottone IV violò l'accordo concluso con il papa, Innocenzo lo scomunicò dalla chiesa nel 1210. Sotto l'influenza dei sonori papi dorati, i principi deposero anche Ottone, e il suo posto fu preso nel 1212 dal figlio sedicenne di Enrico VI, che era sotto la tutela di papa Federico II.
Innocenzo III interferiva negli affari interni di altri paesi. I suoi tentativi di stabilire legami feudali con l'Inghilterra furono coronati dal successo. Il re inglese Giovanni il Senza Terra, coinvolto in una guerra senza speranza con i francesi, aspettava l'aiuto del papa nella lotta contro i francesi e i suoi stessi nobili per salvare il suo trono. Innocenzo assunse questo ruolo, in cambio del quale il re inglese nel 1213 dichiarò il suo paese feudo pontificio e si impegnò a pagare una tassa di 1.000 marchi all'anno.
Innocenzo operò con maggiore o minore successo in tutta Europa per diffondere il potere feudale dei papi, ma soprattutto in Aragona, Portogallo, Danimarca, Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria. Innocenzo III intervenne più di una volta nella lotta per il trono dei re ungheresi della casa di Arpad. Quando il futuro re Andras II era ancora duca, il papa, sotto minaccia di scomunica, lo obbligò a condurre una crociata in Terra Santa. Quando il re Imre conquistò la Serbia, il papa sostenne l'espansione ungherese nei Balcani perché si aspettava che Imre eliminasse lì le eresie (Bogomili e Pataren).
Il Papa ha giustificato la sua supremazia sull'Europa cristiana con la necessità di concentrare le forze del cristianesimo per restituire la Terra Santa, cosa che, secondo lui, era possibile solo sotto la guida della Chiesa. Tuttavia, la IV Crociata (1204), ispirata dal papa più potente del Medioevo, non era diretta contro i pagani, ma contro i cristiani dissidenti. L'ingannevole involucro ideologico delle guerre di conquista si sta gradualmente staccando. L'obiettivo della IV Crociata era inizialmente, ovviamente, la riconquista della Terra Santa. Ma al tempo di Innocenzo venne alla ribalta anche la questione dell'attuazione dell'unione con la Chiesa greco-orientale. In un'atmosfera simile non era difficile rivolgere un esercito di crociati in cerca di saccheggio contro gli scismatici. Venezia divenne la molla dietro le quinte della nuova campagna aggressiva. La ricca città-repubblica commerciale era ancora formalmente sotto il dominio di Bisanzio. Per Venezia, Bisanzio era un rivale commerciale nel Mediterraneo. Per eliminare un tale rivale e garantire l'egemonia di Venezia nella parte orientale del Mediterraneo, il doge veneziano Enrico Dandolo decise di rivolgere l'esercito crociato in marcia su Gerusalemme verso le città ungheresi della Dalmazia (Zara), e poi contro Bisanzio. . Dopo un lungo assedio, nel 1204, i crociati occuparono la millenaria roccaforte della cultura greca e, in tre giorni di saccheggi e omicidi, distrussero quasi completamente la città. L'impero bizantino si ritrovò respinto in una stretta striscia dell'Asia Minore e stretto tra i cavalieri cristiani latini e i turchi. I cavalieri ladri crearono l'Impero latino, che fornì i mezzi per il saccheggio sistematico dei Balcani per mezzo secolo. La Chiesa e il Papa potevano rallegrarsi: il nuovo Patriarca latino di Costantinopoli è tornato in seno alla Chiesa cattolica. E Venezia conquistò un enorme bottino di guerra.
La crociata contro i cristiani mostrò quanto nel corso di un secolo si fosse distorta un'idea motivata da sentimenti religiosi apparentemente sinceri. Forse il momento più poco attraente del pontificato di Innocenzo III va considerato l'organizzazione nel 1212, non da parte di cavalieri ladri, ma di folli fanatici della crociata dei bambini. Questo non era altro che un mezzo estremamente crudele per sbarazzarsi della sovrappopolazione. I bambini condannati sono già morti a migliaia lungo la strada. Alcuni bambini furono caricati sulle navi, presumibilmente per essere trasportati in Terra Santa, ma gli organizzatori della campagna li consegnarono ai pirati del mare, che li vendettero come schiavi. Papà è riuscito a riportare a casa parte dell’esercito di bambini che correva dalla Germania all’Italia.
Innocenzo III conferì al papato un potere illimitato nell'amministrazione della chiesa. Ciò fu dimostrato dal Concilio Ecumenico Lateranense IV (11-30 novembre 1215), che divenne l’apice e il risultato del regno di Innocenzo. Al Palazzo del Laterano arrivarono circa 500 vescovi, 800 abati e rappresentanti dei sovrani. Tra i partecipanti c'erano anche i Patriarchi di Gerusalemme e Costantinopoli. L'incontro è stato presieduto personalmente dal papa stesso. Il Concilio Ecumenico ha sviluppato 70 canoni, principalmente sulla riforma della vita ecclesiastica, su questioni di fede, diritto ecclesiastico e disciplina ecclesiastica, sulla Santa Messa e sull'assoluzione. È stata inoltre presa la decisione di vietare la creazione di nuovi ordini monastici. Fu adottata una risoluzione per combattere le eresie che si erano diffuse nei Balcani, nel Nord Italia e nel Sud della Francia, con i Bogomili, i Patareni, gli Albigesi e i Valdesi. Nel 3° canone, insieme al sostegno alle crociate contro gli eretici, gli ordini papali per la creazione dell'Inquisizione furono elevati a diritto ecclesiastico. E infine, il concilio ha invitato a lottare per il ritorno della Terra Santa creando un'alleanza (unione) tra cristiani e dichiarando una nuova crociata.
La lotta contro gli eretici era uno dei compiti principali del papato medievale: dopo tutto, minacciavano l'unità della Chiesa. Il Terzo Concilio Ecumenico Lateranense del 1179 condannò le eresie valdesi e albigesi, ma misure estreme contro di esse furono prese solo sotto Innocenzo III. Le radici delle eresie medievali risalgono ai tempi delle riforme gregoriane, quando anche all'interno della Chiesa apparvero i germi radicali di un movimento di riforma diretto contro la gerarchia ecclesiastica. Il radicalismo apparso nell'XI secolo potrebbe ancora essere collegato con successo all'attuazione del programma del papato riformato.
Vari movimenti ereticali assunsero carattere di massa solo a partire dalla seconda metà del XII secolo, quando lo sviluppo della borghesia urbana permise di agire con maggiore decisione contro i feudatari e la chiesa. Ora nell'eresia, il cui contenuto è cambiato nel corso della storia, è apparso un nuovo elemento: lo sviluppo delle città, che ha causato anche lo sviluppo delle scienze secolari, formando un nuovo terreno fertile per le eresie successive. I capi delle sette eretiche provenivano solitamente da un ambiente semi-istruito ed erano fortemente influenzati dallo spiritualismo e dal misticismo; Credevano fanaticamente che se avessero purificato la loro anima, avrebbero potuto conoscere direttamente Dio e ricevere la sua misericordia. Pertanto, non vedevano la necessità di una mediazione organizzata tra l'uomo e Dio - nel clero, nella chiesa e nei sacramenti che monopolizzavano, perché un vero credente è in grado di ricevere misericordia da solo. (Va notato che antiche eresie occidentali come il donatismo e il pelagianesimo sorsero sulla questione della misericordia, della grazia e sul rapporto tra Dio e l'uomo.)
Pertanto, le eresie si opposero agli insegnamenti della chiesa ufficiale. Nuove tendenze sorsero nel quadro della società feudale e furono un riflesso ideologico dello sviluppo borghese nelle città e delle tensioni sociali nelle campagne. Poiché la Chiesa veniva identificata con il feudalesimo, anche i movimenti sociali che combattevano il feudalesimo erano di natura anti-chiesa. Le eresie antifeudali portarono ai movimenti Pataren e Bogomil nei Balcani, in Lombardia - agli Umiliani (dal latino humilis - umiliato, insignificante, umile), e nel sud della Francia - ai Catari e ai Valdesi. Con alcune differenze, proclamavano e volevano una cosa: la realizzazione di una vita evangelica perfetta. Consideravano superflua la mediazione della chiesa per ricevere la grazia divina e non avevano bisogno della chiesa stessa. Pertanto, hanno messo in dubbio la necessità dell'esistenza di un'organizzazione ecclesiastica, di una chiesa feudale e quindi di un sistema feudale. I loro programmi sollevavano sempre più la questione del cambiamento della società.
Il movimento di massa più significativo fu il movimento cataro, che si sviluppò nel sud della Francia a partire dagli anni Quaranta del XII secolo. La fonte di questo movimento fu l'eresia Bogomil, colorata dal manicheismo, che sorse in Oriente. Questa eresia si diffuse dapprima nei Balcani, da lì penetrò nella Francia meridionale, e poi nella valle del Reno, nell'Italia settentrionale e persino nelle Fiandre (gli aderenti all'eresia erano solitamente chiamati Albigesi, dalla città di Albi, che era una delle loro centri). Il fatto che l'eresia catara sia penetrata più profondamente nella società provenzale conferma il suo legame con lo sviluppo borghese della società. Infatti, nel XII secolo, la Provenza era la parte d'Europa più prospera e istruita. I membri di questo movimento dal 1163 si chiamavano Catari, puri. I Catari negavano i santi sacramenti. Santissima Trinità, si condannarono all'ascetismo, obbligando i membri della setta a rinunciare al matrimonio e ai beni personali. Il movimento, che ha avuto origine nell'idea sociale della chiesa paleocristiana, l'idea di povertà, si è diffuso molto rapidamente. Il Concilio Lateranense III (1179), con il suo canone 27, anatemizzò i sostenitori di questa eresia. Divenne universale la convinzione che gli eretici dovessero essere sterminati con il fuoco e la spada. Papa Innocenzo III dichiarò una crociata contro di loro. Questa campagna, condotta tra il 1209 e il 1229, fu guidata dal conte Simone di Montfort, che si distinse per la sua crudeltà disumana. Nonostante questa guerra di sterminio portò alla sconfitta della Provenza, i Catari scomparvero definitivamente solo nel secolo successivo.
Inizialmente, indipendentemente dai catari, l’eresia valdese sorse nel sud della Francia. Era un movimento secolare guidato da un ricco mercante lionese di nome Pierre Waldo, che distribuì le sue proprietà ai poveri e iniziò a predicare. Basandosi sul Vangelo, predicò la povertà apostolica e chiamò a seguire Cristo, opponendosi sempre più al ricco clero. Nel 1184 papa Lucio III dichiarò eretico il movimento Waldo. Da questo momento in poi i Valdesi si avvicinarono sempre più ai Catari; rifiutarono la gerarchia ecclesiastica, i santi sacramenti, l'assoluzione, le decime, negarono il servizio militare e condussero una vita morale rigorosa. Dopo lo sterminio degli Albigesi, nel XIII secolo l'eresia valdea si diffuse in quasi tutta l'Europa. Invece della struttura di classe della società feudale, i Valdesi implementarono l’uguaglianza nello spirito della chiesa paleocristiana. Nelle loro comunità riconoscevano la Bibbia come unica legge. L'eresia valdese si diffuse dalle città ai villaggi.
Alla fine del XIII secolo sorse in Lombardia un movimento dei cosiddetti Umiliani, un movimento per metà di natura monastica e per metà eretico-ascetica. Anche Lucio III li dichiarò eretici.
Le autorità secolari offrirono volentieri il loro aiuto armato alla Chiesa papale per affrontare gli eretici. Durante il pontificato di Innocenzo III si diffuse l'identificazione degli eretici e la loro condanna da parte del tribunale ecclesiastico, ma con l'ausilio delle autorità secolari. In linea di principio, l'Inquisizione è sempre esistita nella chiesa. Inizialmente non significava altro che preservare la purezza dei dogmi della fede ed escludere dalla Chiesa coloro che peccavano contro di essi. Questa pratica si consolidò a partire dal XIII secolo. Poiché nel Medioevo la Chiesa e la religione divennero fattori sociali, gli attacchi contro di esse furono considerati allo stesso tempo attacchi allo Stato e all'ordine sociale. I principi giuridici e organizzativi dell'Inquisizione medievale furono sviluppati da papa Alessandro III nei concili di Montpellier del 1162 e di Type del 1163 e stabiliti in un documento che specificava come dovevano essere trattati gli eretici. Fino al Medioevo il principio era che gli eretici non dovevano essere sterminati, ma convinti. Da quel momento in poi gli ecclesiastici dovettero pronunciarsi contro gli eretici, anche senza muovere accuse ufficiali contro di loro. (d'ufficio). Teologi e giuristi hanno sviluppato il principio secondo cui l'eresia è identica a un insulto a un'autorità superiore (lesa maestà) ed è quindi soggetta a punizione da parte dello Stato. Nel 1184, al Concilio di Verona, Lucio III emanò un decreto che cominciava con le parole "Ad abolendam" diretto contro gli eretici. Il clero aveva il compito non solo di sporgere denuncia di eresia nei casi di cui veniva a conoscenza, ma anche di svolgere un processo di indagine (inquisitio). L'imperatore Federico I, presente al concilio, elevò a legge imperiale la maledizione della chiesa sugli eretici; Pertanto, gli eretici erano soggetti a persecuzione da parte dello Stato. Il potere secolare si unì all'inquisizione della chiesa contro un nemico comune. L'indagine è stata condotta dal clero, anche i processi contro gli eretici sono stati organizzati dalla chiesa, ma gli interrogatori e l'esecuzione delle sentenze - lavoro sporco - sono stati affidati alle autorità secolari.
Per la prima volta, in conformità al codice di leggi del 1197, il re Pedro II d'Aragona stabilì che gli eretici dovessero essere bruciati sul rogo. E Innocenzo III, confermando il già citato decreto di papa Lucio nel 1199, lo integrò con le parole che l'eresia, secondo il diritto romano, è identica alla lesa maestà e, come tale, è punibile con la morte sul rogo. Secondo un'altra spiegazione, l'eretico fu bruciato sul rogo perché inizialmente l'eresia fu paragonata a una peste. L'eresia è una piaga dell'anima, nemica mortale della vera fede, e si diffonde con la stessa rapidità di una vera piaga. Si riteneva che l'unico modo per fermare la peste e prevenire ulteriori infezioni fosse bruciare i cadaveri dei morti di peste e i loro averi. Pertanto, questo era l'unico metodo di guarigione contro l'eresia. Nel 3° canone del Concilio Ecumenico Lateranense IV, il decreto di Innocenzo fu canonizzato e l'imperatore Federico II lo rese legge imperiale nel 1224.
L'Inquisizione Papale prese forma nella sua forma definitiva nel 1200. Sotto papa Gregorio IX le leggi in materia subirono ulteriori modifiche e infine nel 1231 fu emanata una costituzione pontificia che inizia con le parole “Excommunicamus”. Ora, insieme alle inquisizioni episcopali, agivano anche gli inquisitori papali; Il Papa affidò la conduzione dell'Inquisizione ai nuovi ordini mendicanti. Le disposizioni sull'Inquisizione furono sviluppate in modo particolarmente dettagliato dai domenicani. L'espansione dell'Inquisizione pontificia fu accelerata soprattutto dalla costituzione di Innocenzo IV del 1252, che iniziava con le parole “Ad extirpande”. In questo documento il papa prevedeva l'uso di una camera di tortura durante gli interrogatori. La creazione del primo tribunale papale dell'Inquisizione avvenne sotto Nicola IV alla fine del XIII secolo. L'Inquisizione fu spietata. Gli eretici – fino alla seconda generazione – erano privati dei diritti civili e politici, era loro vietata la sepoltura, non avevano diritto di appello né di difesa, i loro beni erano soggetti a confisca e chi li denunciava veniva premiato. In questo, le istituzioni ecclesiastiche hanno agito insieme alle autorità secolari. Durante l'era del terrore dell'Inquisizione, che si trasformò in persecuzione di massa, con l'aiuto dei falò accesi nelle piazze delle città, cercarono di intimidire le persone e di dissuaderle da qualsiasi protesta contro il sistema esistente.
L'emergere di movimenti ereticali di massa rifletteva anche una crisi nella visione del mondo della Chiesa. Gli ordini mendicanti accorsero in aiuto della scossa autorità della Chiesa. I francescani (minoranze - fratelli minori) e i domenicani differivano dai precedenti ordini monastici (monastici) in quanto non vivevano fuori dalle mura del monastero e non a scapito dei suoi beni, limitandosi a svolgere un tranquillo lavoro monastico e la preghiera comunitaria , ma si assunsero il compito dell'insegnamento pubblico e della predicazione fuori dei monasteri, sopravvivendo con le elemosine raccolte nel mondo (da qui il nome “ordine mendicante”). Il fatto che abbiano fatto voto di povertà si esprimeva anche negli attributi esterni. Gli ordini mendicanti furono creati sotto l'influenza dei movimenti eretici (e ne adottarono molto), ma in una certa misura - per strangolarli. Ecco perché l'alto clero inizialmente li guardava con diffidenza (questo può spiegare il fatto che al Concilio Lateranense IV fu vietata la creazione di nuovi ordini). Tuttavia i papi si resero presto conto delle grandi opportunità offerte dagli ordini mendicanti. Vestiti con “abiti eretici” e apparendo nei posti giusti, i fratelli seppero diffondere e difendere tra i cittadini e le masse povere gli insegnamenti della chiesa ufficiale con più successo dei ricchi ordini monastici e del clero “bianco” che si adattò a le autorità.
La chiesa medievale era un'istituzione ricca e influente in cui i titoli episcopali e abbaziali venivano assegnati ai membri della nobiltà feudale. Allo stesso tempo, una caratteristica importante dei movimenti filosofici spirituali era l'idealizzazione della povertà, e il più ardente predicatore della povertà era il seguace di Bernardo di Chiaravalle, San Francesco d'Assisi. L'ideale vitale delle aspirazioni borghesi che si opponevano alla società feudale era, se non il desiderio di povertà, allora, senza dubbio, il desiderio di semplicità, di razionalismo. Ciò si manifestava nei movimenti che predicavano la povertà: da un lato, nei movimenti ereticali che si sviluppavano al di fuori della Chiesa; d'altra parte, all'interno della chiesa - negli ordini mendicanti.
Francesco d'Assisi (1182-1226) fu un uomo di mondo colto e socialmente consapevole che sentì la sua vocazione nella predicazione della povertà. Francesco, insieme ad undici suoi compagni, si presentò al potente papa Innocenzo III con la richiesta di poter predicare la spiritualità apostolica. Innocenzo III promise solo verbalmente il sostegno al loro statuto. (Probabilmente lo stesso Francesco non voleva creare un ordine che obbedisse a regole rigorosamente definite.) L'Ordine dei Minoriti, o Francescani, che iniziò le sue attività a metà del XII secolo, era impegnato in attività pastorali, scienze teologiche e predicazione in un linguaggio comprensibile alla gente comune.
La Carta dell'Ordine Minore (Ordo Fratres Minorum), basata su principi centralisti, fu approvata nel 1223 da Papa Onorio III.
La lotta contro l'eresia catara rese necessaria la creazione dell'Ordine Domenicano, o Ordine dei Frati Predicatori. Il nome fu poi spiegato così: i monaci si consideravano Domini canes - cani del Signore. Il fondatore dell'Ordine dei Frati Predicatori (Ordo Fratrum Praedicatorum) fu San Domenico (c. 1170-1221), che fu canonico, ma, rinunciato al suo incarico, fece voto di povertà e dedicò la sua vita alla lotta contro eretici. Innocenzo III si oppose ancora al rafforzamento dell'ordine, ma il papa successivo lo approvò nel 1216. L'attività teologica dei domenicani servì non da ultimo agli obiettivi pragmatici della discussione con l'eresia. L'Ordine sviluppò non solo argomenti teologici per l'Inquisizione, ma anche ingegnose disposizioni giuridiche. L'Inquisizione Pontificia era quasi esclusivamente nelle mani dell'Ordine Domenicano.
Non c'è dubbio però che gli ordini mendicanti devono la loro fioritura non solo all'Inquisizione e alla lotta contro gli eretici. I monaci mendicanti furono i primi educatori in Europa: insegnavano, educavano e curavano. Oltre all'attività culturale e sociale che svolgevano tra la gente, caratteristica soprattutto dei francescani, li troviamo alla guida delle università e dei dipartimenti educativi europei (soprattutto domenicani).
Sotto l'influenza di due grandi ordini mendicanti, il monachesimo conobbe una nuova rinascita. Un cavaliere crociato formò l'ordine mendicante dei Carmelitani, approvato dal papa nel 1226. L'Ordine dei Servi si costituì nel 1233 a Firenze come società laica. Nel 1255 papa Alessandro IV ne approvò lo status, ma solo nel XV secolo quest'ordine divenne ordine mendicante.
L'ascesa delle università medievali spiega anche l'ascesa degli ordini monastici nel XIII secolo e lo sviluppo delle città. La più famosa fu l'Università di Parigi, il cui statuto e autonomia furono riconosciuti nel 1213 da Innocenzo III. La seconda più importante era l'Università di Bologna, che forniva principalmente istruzione giuridica. Il maestro più famoso fu il monaco camaldulico Graziano, considerato il creatore della scienza giuridica ecclesiastica. Graziano († 1179) fu autore di una raccolta di diritto canonico che ebbe una grande influenza sullo sviluppo del diritto ecclesiastico. Questa raccolta, intitolata "Concordantia discordantium canonum", fu pubblicata probabilmente intorno al 1140 e fu arricchita dall'opera di eminenti giuristi della chiesa sul soglio pontificio, come Alessandro III, Innocenzo III e Gregorio IX.
All’epoca “romanica” (secoli X-XIII) è associata anche la fioritura della cultura cavalleresca. La più bella poesia cavalleresca è nata nella Valle della Loira e della Garonna. La figura più significativa della poesia trovadorica provenzale fu il duca Guglielmo IX d'Aquitania. I rappresentanti più importanti della cosiddetta poesia Minnesinger (“canzoni d'amore estatico”) in Germania furono Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach (“Parsifal”) e Gottfried di Strasburgo (autore di “Tristano e Isotta”).
Ma se l'ideale dell'era cavalleresca era un eroe con una croce sul mantello, nel XIII secolo gli appelli del papa che chiedevano una crociata furono accolti con completa indifferenza. Gli ampi progetti del Concilio Lateranense IV non hanno portato i risultati attesi in questo ambito. Il re ungherese Andras II, il re francese Luigi IX e poi Federico II guidarono le crociate, ma senza molto successo. Andrea II prese parte alla crociata in Palestina, alla guida di un esercito di 15.000 persone. Durante la sua assenza pose il Paese sotto la protezione del papa e ne affidò l'amministrazione all'arcivescovo di Esztergom. L'esercito fu trasportato dai Veneziani via mare; Come compenso András rinunciò in loro favore alla città di Zara. La crociata ungherese all'inizio del 1218 si concluse senza risultati.
Il trionfo della Chiesa cattolica nella lotta contro gli albigesi fu facilitato soprattutto dalla personalità dell'uomo che la guidò. Quando il papato era in pericolo mortale, attraverso l'arte di questo leader acquistò improvvisamente una forza interna ed esterna senza precedenti. Un brillante statista, era come se fosse stato deliberatamente chiamato sulla scena storica in un momento critico. L'eccellente sistema cominciò ad essere gestito da un uomo il cui nome segna un'intera epoca. Era papa Innocenzo III.
È lui la figura principale del dramma che presto ci occuperà, e quindi è necessario innanzitutto studiare quest'uomo dal momento in cui diventa capo della Chiesa cattolica? 2 .
Aveva allora trentotto anni. Raramente un sommo sacerdote ha indossato la tiara così presto, e raramente è salito sul palcoscenico storico più pronto per questo.
Innocenzo III portò con sé sul soglio pontificio un'idea grandiosa, che, è vero, fu sviluppata dai suoi predecessori, ma in lui trovò il suo pieno e migliore esponente. Fu chiamato a completare e creare il maestoso, anche se non del tutto puro, edificio del cattolicesimo, e quindi le sue simpatie ricadevano negli ideali del passato. L'obiettivo di Innocenzo III era consolidare il dominio dei papi sull'Europa.
A quel tempo l'autorità dei sommi sacerdoti cadde anche nel loro stato? 1 . I papi degli ultimi decenni del XII secolo erano impotenti nella propria capitale e dipendevano dai partiti aristocratici della città. Strettamente associati a loro, non furono in grado di pacificare la città. Tale impotenza suscitò ancora più rabbia perché la loro forza sembrava così formidabile all’intero Occidente. I predecessori di Innocenzo III furono quasi sempre eletti sommi sacerdoti in età avanzata; erano forti non come individui, ma come rappresentanti della politica ereditaria della Curia romana;
Tale non era l’uomo che salì al soglio pontificio nel 1198. Innocenzo III proveniva dall'antica famiglia romana dei Conti Conti, la cui fama risale a tempi favolosi. Genealogisti audaci contano dodici secoli di continuità di questa famiglia2. Il famoso papa era considerato un discendente del primo duca di Spoleto, che ricevette i suoi possedimenti dal re longobardo Grimoaldo nel VII secolo? 2 . È più attendibile del famoso prefetto di Roma Crescenzi? 3 era il suo antenato. Contrariamente alla genealogia, i possedimenti ereditari dei Conti di Conti non diedero loro né particolare gloria né sufficiente ricchezza3. Nelle fila dell'antica aristocrazia, il conte Frasimundo, padre del futuro papa, non ebbe particolare rilievo; fu relegato in secondo piano dalle famiglie romane che influenzarono le elezioni dei papi: Orsini, Colonna, Frangipani, Savelli;
La famiglia Conti era destinata ad elevare Giovanni Lotario (poi Innocenzo III). Nacque intorno al 1161. Sua madre gli diede l'opportunità di studiare presso la scuola di San Giovanni in Laterano, che a quel tempo era un centro di formazione per predicatori cattolici. Continuò la sua formazione presso le Università di Parigi e di Bologna, dove si immerse nella filosofia moderna, 4 ma dai suoi scritti risulta chiaro che studiò bene anche i classici. Parigi era famosa per la teologia e la scolastica, Bologna per il diritto: questi erano i centri più famosi della cultura medievale. A Parigi, molti politici e poeti successivamente famosi (ad esempio, il famoso minnesinger tedesco Walter von der Vogelweide) ricevettero la loro educazione insieme a Conti. Qui Giovanni-Lotario strinse amicizia intima con il futuro cardinale Stephen Langton e molti altri. Decenni dopo, i compagni d’infanzia servirono come strumenti per realizzare i piani di vasta portata di Innocenzo III.
Ritornò a Roma sotto papa Lucio III, che gli affidò diversi importanti incarichi, che furono portati a termine con successo, segnando l'inizio di una brillante carriera. Papa Gregorio VIII lo nomina, ancora giovane, suddiacono (1187). Giovanni-Lotario Conti si fa avanti grazie ad alcuni legami familiari, ma soprattutto per le sue capacità. C'è stato un tempo di Riccardo Cuor di Leone e di Saladino, e ci fu una terza crociata guidata dal Barbarossa? 1 , la cancelleria romana era piena di preoccupazioni.
Clemente III, zio di Giovanni Lotario, lo nominò cardinale diacono nel 1190, titolo equivalente a segretario di stato; il futuro papà aveva allora 29 anni. Questa nomina suscitò gioia generale nella chiesa e tra il popolo, “sollevando grandi speranze” 5, il che indica la popolarità che Giovanni-Lotario aveva già acquisito. Il giovane cardinale ne aveva abbastanza di tutto, faceva progetti grandiosi e non perdeva di vista nessuna piccola cosa.
Nel 1191 regnò sul soglio pontificio Celestino III degli Orsini, ostile ai Conti, e spodestò Giovanni Lotario dal suo incarico. Il futuro successore di Celestino III approfittò dell'ozio forzato per sviluppare in solitudine le sue forze spirituali, sia nel pensiero che nelle attività letterarie. In questi sei anni ha maturato quei disegni teocratici e quella politica multilaterale che possono suscitare protesta, ma che, per quanto utili per quel tempo, hanno diritto ad un significato storico. Nelle opere scritte in questo periodo, il futuro portatore di tiarion langue in pace, cerca pace e solitudine, sebbene fosse più capace di attività di chiunque altro. Mentre lui, circondato solo dai libri, viveva ad Anagni, rinunciando al mondo, questo mondo stava già facendo dei nodi, che poi avrebbe dovuto sciogliere.
L'imperatore di Germania, Enrico VI, cercò di acquisire il regno delle Due Sicilie. Celestino III accettò di approvarlo per lui solo a condizioni umilianti per Enrico, poiché questo regno era stato a lungo sotto la protezione della chiesa: era considerato un vassallaggio romano ed era più coerente con questo nome di tutti gli altri feudi apostolici immaginari. Dopo una seconda campagna nel sud dell'Italia, Enrico conquistò l'ambito regno, sterminò i membri dell'antica dinastia normanna e represse la rivolta dei baroni normanni con tale crudeltà da suscitare l'indignazione di tutta l'Europa cavalleresca. Celestino III avvertì ripetutamente Henry e gli chiese di fermare le sue atrocità. Il Papa alla fine scomunicò l'Imperatore dalla Chiesa? 1 . Enrico VI morì nel settembre del 1197, ancora maturo e pieno di progetti di vendetta su Roma e di sogni di un impero unificato. Lasciò al re romano di quattro anni Federico Ruggero (dopo famoso come Federico II), un odio generale per la sua memoria e faide inter-dinastiche per il trono in Germania.
Il papa aveva fretta di agire per non perdere le sue vecchie acquisizioni nell'imminente confusione e anarchia. Acquisizione di entrambe le Sicilie da parte degli Hohenstaufen? 2 sembrava una sfida minacciosa per Roma. I papi potrebbero essere spremuti da due fronti: dalla Germania e dal Sud Italia. Roma voleva a tutti i costi rompere questo legame, questa forza formidabile, o almeno sminuirla, con cui i papi lottarono costantemente per tutta la prima metà del XIII secolo. Dovevano mantenere il vassallaggio sulla Sicilia, influenzare la questione della successione tedesca al trono e allo stesso tempo mantenere l'autorità romana nella disputa iniziata con il re francese per il divorzio da Ingeborg? 3 .
Allo stesso tempo, in Europa si stava preparando una nuova crociata, e allo stesso tempo gli statisti romani iniziarono a sentire voci minacciose dalla Francia meridionale sulla rapida diffusione dell'eresia e sul fallimento di tutte le decisioni del consiglio prese contro di essa. E a Roma cominciarono a pensare seriamente a due crociate simultanee: una avrebbe dovuto essere in Asia contro gli infedeli, l'altra contro i liberi pensatori ribelli, i ricchi e allegri abitanti della Garonna, del Rodano e della Durance? 1 .
Erano necessarie rapidità e ponderazione nelle azioni soprattutto perché il fallimento delle precedenti crociate indeboliva lo zelo religioso dei cattolici. Voci sullo sviluppo positivo di varie eresie provenivano da diversi luoghi d'Europa. L'eresia si spostò da est a ovest e si radicò saldamente nelle terre cattoliche.
A Roma si era ben consapevoli dell'importanza del momento presente e l'ostilità dei partiti tacque. La Curia cardinalizia nutrì sempre grandi speranze per il conte Conti, tanto che fu chiamato in causa alla morte di Celestino III.
Morendo, papà continuò ad additare l'amico Colonna, ma non lo ascoltarono. Celestino III morì l'8 gennaio 1198. La mattina successiva, dopo un breve incontro, il cardinale diacono Giovanni Lotario Conti fu eletto papa quasi all'unanimità. Ha resistito alla riunione del consiglio: ha implorato, ha pianto, ha parlato della sua giovinezza. Il maggiore dei cardinali gli si avvicinò e gli diede il nome di Innocenzo III. Giovanni Lotario non era ancora vescovo; non era nemmeno stato ordinato. Per lui è stata fatta una eccezione così rara; ha accettato il sacerdozio solo dopo.
Sembrava molto giovane per il soglio pontificio, che non passò inosservato. La solenne incoronazione attirò molte persone, tra le quali il neoeletto era molto popolare. Roma era in fiamme e fiori cadevano sul corteo papale. Nella sua prima omelia il papa si è rivolto al popolo, come se lo chiamasse alla consacrazione dei suoi progetti; lusingò la folla e ben presto ricevette significativi segni del suo favore.
L'aristocrazia, al contrario, interferiva con la libertà d'azione del sommo sacerdote, abituata ad essere governata dal potere popolare; A Roma governavano i nobili, il prefetto imperiale era il loro strumento; trasferiva i suoi diritti al Senato, il quale, spesso andando contro la volontà del popolo, agiva legalmente in suo nome, essendo indipendente dal papa.
Fin dai primi giorni Innocenzo soggiogò tutti gli elementi a lui ostili e in guerra tra loro. Il prefetto giurò di servirlo incondizionatamente e di rendere pienamente conto di tutte le questioni: la spada imperiale fu sostituita dalla coppa papale. Le pretese straniere, seppure nominali, furono completamente distrutte: la città divenne papale. Le persone hanno sostenuto questo inizio, proveniente da una persona così popolare. Il Senato cominciò ad agire non per conto del popolo, ma per conto del papa: il primo senatore prestò giuramento di proteggere la persona del papa. Il principio monarchico trionfò. Dopo aver consolidato il suo potere nella capitale, Innocenzo si dedicò agli affari in Italia. I baroni tedeschi insediati da Enrico VI furono costretti a lasciare lo Stato pontificio. Le città fiorentine organizzarono una propria unione, ma anche lì furono forti le simpatie papali. Era trascorso meno di un anno da quando lo Stato pontificio aveva raggiunto i suoi limiti estremi e in Italia il sentimento nazionale era ravvivato. Ma rafforzando le sue risorse materiali, Innocenzo III dimostrò così che nel suo sistema teocratico avrebbe aderito a una linea d'azione decisiva. Quell'ambizione era insita in lui, lo dichiarò fin dai primi giorni, ma il suo egoismo era l'egoismo di un'anima grande: lavorava non per interessi personali, ma in nome del trionfo della sua fede; non ha promesso la pace con la sua politica, anche se si è battuto per ottenerla. Il papa mise in pratica il suo sistema con il fervore di un uomo sopraffatto dall'ambizione secolare.
Innocenzo III, come altri papi, abusò della religione per raggiungere i suoi obiettivi. Seguendo la politica romana e perdendosi nell'entusiasmo, deviò talvolta dalla retta via, ma il concetto di giustizia suprema non venne mai meno in lui. Nei primissimi giorni del suo pontificato, espresse così la sua dottrina politica:
“Siamo responsabili della prosperità della chiesa. Sia la nostra vita che la nostra morte saranno dedicate alla causa della giustizia. Sappiamo che il nostro primo dovere è difendere i diritti di tutti, e nulla ci costringerà a deviare da questa strada... Abbiamo davanti a noi una grande abbondanza di lavoro, preoccupazioni quotidiane per il bene di tutte le Chiese, quindi lo siamo; niente più che servi dei servi di Dio, secondo il nostro titolo. Ma noi crediamo che per volontà di Dio siamo stati elevati da insignificanti a questo trono, dal quale effettueremo il vero giudizio sia sui principi, sia anche su quelli che sono più in alto di loro” 6.
Innocente ha mantenuto la sua promessa. Dopo Ildebrando fu la figura più audace sul soglio pontificio, ma fu molto più felice di Gregorio VII. Insieme alla determinazione e al coraggio, possedeva una rara purezza di motivazioni, estranea alle aspirazioni e all'ambizione personali. I grandi personaggi storici che mettono in pratica le loro idee e i loro sistemi politici non sono timidi nel modo in cui raggiungono i loro obiettivi e adempiono ai ruoli assegnati, sono ispirati da un pensiero: trasformare i loro ideali in realtà; È un bene per quei politici che hanno unito l’impeccabilità della sua attuazione con la brillantezza delle loro imprese, ma non si può incolpare coloro che non sono riusciti a trovare altri mezzi senza abbandonare le condizioni del nostro tempo. Innocenzo III non fa eccezione tra i grandi uomini della storia. La purezza morale del suo carattere personale è fuori dubbio, gli ha conferito un'elevata autorità spirituale e ha contribuito al successo dei suoi piani teocratici.
A quel tempo, per realizzare gli scopi del potere papale, era proprio necessario un politico con il talento di Innocenzo, la cui mente copriva l'intera enorme arena di attività: dall'Islanda all'Eufrate, dalla Palestina alla Scandinavia. Ciò che era l'oggetto dei pensieri profondi di Ildebrando fu realizzato da Innocenzo III. Durante i suoi diciotto anni di regno, non ci fu un fatto della storia europea che non subì direttamente o indirettamente l'influenza del papa.
L'occhio onniveggente del sommo sacerdote penetrava sia nel palazzo dell'imperatore che nella casa di un timido cittadino ai margini dell'Europa. Pertanto, la corrispondenza di Innocenzo funge da fonte principale per lo studio della storia del suo tempo; è impossibile ignorare questa fonte, che ha la dignità di atti statali, qualunque sia il Paese di cui si tratta. Per Innocenzo, in tutto l'Occidente non c'era uomo troppo povero, troppo insignificante e, al contrario, nessun sovrano troppo influente. Il potere del papa nella maggior parte dei casi si basava sul potere dell'autorità spirituale e solo nella materia che servirà da oggetto di questo saggio era sostenuto dalla forza delle armi.
Questo fu l'uomo con cui dovettero combattere gli albigesi e che giocò un ruolo importante nella loro storia.
Avendo conosciuto Innocenzo III, faremo, nel modo più breve possibile, un excursus sui rapporti da lui instaurati con i sovrani europei.
Lotario dei Conti di Segninei primi anni
Lotario ricevette la sua prima educazione a Roma, probabilmente presso l'Abbazia benedettina di Sant'Andrea. Studiò teologia all'Università di Parigi, diritto canonico (sotto Uguzio di Pisa) all'Università di Bologna. Subito dopo la morte di papa Alessandro III (30 agosto 1181), Lotario ritornò a Roma e ricoprì diversi incarichi ecclesiastici durante i regni di Lucio III, Urbano III, Gregorio VIII e Clemente III. Quest'ultimo lo nominò cardinale nel settembre 1190.
Come il cardinale Lotario scrisse l'opera “De Miseria Humanae conditionis” (“Verso la povertà umana”). L'opera fu molto popolare per secoli e sopravvive in oltre 700 manoscritti.
Elezione
L'8 gennaio 1198 morì papa Celestino III. Prima di morire invitò il Collegio cardinalizio a eleggere Giovanni Colonna come suo successore, ma i cardinali non lo ascoltarono e lo stesso giorno elessero al soglio pontificio Lotario de Conti. Accettò con riluttanza la tiara e divenne papa Innocenzo III. A quel tempo aveva solo trentasette anni.
Ripristinare l'importanza del trono papale
Dopo aver ricevuto i suoi poteri, Innocenzo iniziò ad attuare le sue opinioni sul ruolo del trono papale. Descrisse la cattura di Gerusalemme da parte dei musulmani nel 1187 come una punizione divina per le debolezze morali dei principi cristiani. Era anche determinato a proteggere quella che chiamava "la libertà della Chiesa" dagli attacchi delle autorità secolari. Questo concetto significava, tra le altre cose, che i principi non dovevano essere coinvolti nell'elezione dei vescovi e che questa doveva essere concentrata nelle mani del papa e del suo "Patrimonium" - lo Stato Pontificio. I possedimenti del papa furono minacciati dagli Hohenstaufen, re tedeschi che si posizionarono come successori degli imperatori romani. L'imperatore del Sacro Romano Impero Enrico VI aveva ormai unito sotto il suo controllo la Germania, l'Italia e la Sicilia, il che rendeva la posizione del Patrimonium estremamente vulnerabile.
La morte prematura di Enrico VI lasciò il figlio Federico II di 4 anni nello status di re. Costanza di Sicilia, vedova di Enrico VI, governò la Sicilia per conto del figlio neonato finché questi non raggiunse la maggiore età. Costanza non voleva trasferire la Sicilia in potere dei tedeschi, che erano vicini a Innocenzo III. Prima della sua morte nel 1198, nominò Innocenzo tutore di Federico. In cambio Innocenzo ottenne la restaurazione dei diritti papali in Sicilia, ai quali papa Adriano IV aveva rinunciato poco prima. Il Papa incoronò il giovane Federico II Re di Sicilia nel novembre 1198. Facilitò anche il suo matrimonio con la vedova del re Imre d'Ungheria nel 1209.
Trono di Sicilia ed espansione dello Stato Pontificio
Guardiano di Federico II di Svevia, che ereditò il trono di Sicilia, dal 1198 il papa soggiogò temporaneamente il Regno di Sicilia. A causa della prima infanzia di Federico, iniziarono i disordini nell'impero: i sostenitori degli Hohenstaufen elessero re il fratello di Enrico, Filippo di Svevia, e un sostenitore dei Guelfi elesse Ottone di Brunswick. Il re Filippo II Augusto di Francia sostenne le richieste di Filippo, mentre il re Riccardo I Cuor di Leone sostenne suo nipote Ottone.
Papa Innocenzo era determinato a impedire un'ulteriore unificazione della Sicilia e del Sacro Romano Impero sotto un unico monarca e colse l'occasione per espandere la sua influenza. Nel 1201 il papa sostenne apertamente Ottone IV. Approfittando delle turbolenze dell'impero, il papa realizzò la massima espansione dello Stato Pontificio annettendo terre precedentemente appartenute all'impero (ma non elencate nella donazione di Carlo Magno): Ancona (Marco), il Ducato di Spoleto (Umbria), Radicofani, temporaneamente Romagna. Tuttavia, non poteva tenere Bologna e Pentapoli.
Affari del Sacro Romano Impero
Quando Federico II venne a Roma per accettare la corona, il papa rifiutò di incoronarlo, temendo il suo potere e sperando di espellerlo dall'Italia, come prima Ottone. Indignato, Federico marciò in Germania e sconfisse Ottone. Ma Innocenzo III ormai era morto
Espansione dell’influenza nell’Europa orientale
Ha patrocinato la creazione dell'Ordine Teutonico in Palestina nel 1198 e ha sostenuto il suo primo Gran Maestro, Henry Walpot.
Nel 1200 confermò la bolla del suo predecessore Celestino III sulla crociata di Livonia, autorizzando il suo inviato, il vescovo Alberto, a reclutare pellegrini per conquistare le terre baltiche.
Per estendere la propria influenza nell'Europa orientale, Innocenzo III autorizzò la fondazione dell'Ordine della Spada nel 1202.
Nel 1204 Innocenzo III offrì senza successo la corona reale a Roman Mstislavovich di Volinia e Galizia.
Nel 1215 organizzò una crociata di cavalieri tedeschi contro i prussiani.
Rapporti con l'Inghilterra
Quarta crociata
Innocenzo decretò l'inizio della Quarta Crociata nel 1198, progettando di riprendere il controllo della Terra Santa. Gran parte del suo pontificato fu dedicato alla preparazione di questa campagna. A differenza dei suoi predecessori, Innocenzo III mostrò una partecipazione personale all'organizzazione della campagna e non si limitò ad agitare i leader secolari per questo.
Il primo passo di Innocenzo III nell'organizzare la crociata fu l'invio di missionari in tutti gli stati cattolici. Innocenzo III inviò Pietro di Capua ai re di Francia e Inghilterra con istruzioni dettagliate per convincerli a risolvere le loro divergenze. Di conseguenza, nel 1199, Innocenzo ottenne una tregua di cinque anni tra i due paesi. Per guidare l'esercito, Innocenzo inviò le sue lettere ai cavalieri e ai nobili d'Europa. Molti feudatari risposero alla chiamata del papa, tra cui due futuri capi dell'esercito, Thibault di Champagne e Bonifacio I di Monferrato. Allo stesso tempo, in Inghilterra e Germania gli appelli del papa non hanno avuto effetto. Per questo motivo la Quarta Crociata fu principalmente un’iniziativa francese.
La Quarta Crociata fu un affare costoso. Innocenzo III decise di iniziare a raccogliere fondi, cosa che nessuno dei suoi predecessori aveva fatto. Ha costretto l'intero clero sotto la sua guida a donare 1/40 delle proprie entrate a sostegno della crociata. Questa è stata la prima volta che è stata introdotta un'imposta diretta sul clero. Il Papa dovette affrontare numerose difficoltà nel riscuotere questa tassa, inclusa la corruzione dei suoi funzionari e l'incuria da parte dei suoi subordinati in Inghilterra. Continuò i suoi sforzi per raccogliere fondi per la crociata, inviando inviati al re Giovanni il Senza Terra e al re Filippo Augusto. Entrambi hanno promesso di contribuire con 1/40 del ricavato. John ha anche affermato che la tassa sarebbe stata riscossa in tutta l'Inghilterra. Un'altra fonte di fondi per la crociata erano gli stessi crociati. Innocenzo affermò che coloro che avevano fatto voto di diventare crociato ma non potevano mantenerlo potevano essere sciolti dal voto dietro pagamento di un contributo in denaro.
Inizialmente fu scelto l'Egitto come luogo di sbarco dei crociati. Fu stipulato un accordo tra i crociati francesi e i veneziani per il trasporto degli eserciti. I veneziani dovevano fornire navi e cibo in cambio di un pagamento in contanti di 85.000 marchi. Innocent ha dato la sua approvazione a questo accordo a due condizioni. In primo luogo, un rappresentante del papa doveva accompagnare la crociata e, in secondo luogo, gli attacchi contro i cristiani erano severamente vietati. I francesi non riuscirono a raccogliere fondi sufficienti per pagare i servizi dei veneziani. Di conseguenza, i crociati dovettero soddisfare la richiesta dei veneziani e assediare la città commerciale cristiana rivale di Zara. Queste azioni furono intraprese senza il consenso di Innocenzo III, che minacciò di scomunica tutti coloro che presero parte all'attentato. La maggior parte dei francesi ignorò la minaccia, attaccò Zara e fu scomunicata dal papa, ma fu presto perdonata e poté continuare la crociata. La situazione si ripeté quando i crociati conquistarono Costantinopoli, la capitale dell'Impero bizantino, nel 1204: il papa lo venne a sapere solo quando la città era già stata catturata.
Nel 1212 ebbe luogo la semi-leggendaria Crociata dei Bambini.
Concilio Lateranense IV
Il 15 novembre 1215 Innocenzo aprì il Concilio Ecumenico Lateranense XII, nel quale prese molte decisioni importanti. Di conseguenza furono elaborati settanta decreti di riforma. Il concilio stabilì, tra l'altro, la creazione di scuole e l'incremento della formazione del clero. Proibì al clero di partecipare alle prove giudiziarie. Di fatto, ciò ha portato alla scomparsa delle prove dalla pratica giudiziaria. Infine, in questo concilio il clero ha legiferato sull'inammissibilità della subordinazione dei cristiani agli ebrei. Il canone 69 proibiva agli ebrei di prestare servizio negli uffici governativi, poiché ciò dava loro l’opportunità di “esprimere la loro rabbia contro i cristiani”. Il canone 69 stabiliva che gli ebrei crocifissero Cristo, e quindi sarebbe "troppo assurdo per un bestemmiatore di Cristo esercitare autorità sui cristiani", e quindi gli ebrei non dovrebbero essere nominati a cariche pubbliche.
Morte ed eredità
Tuttavia, il 16 luglio 1216, Innocenzo III morì improvvisamente a Perugia. Fu sepolto nella Cattedrale di Perugia finché Papa Leone XIII trasferì le sue ceneri nel Palazzo del Laterano nel dicembre 1891.
Si credeva che l'anima di Innocenzo III fosse entrata in purgatorio. Santa Lutgarda del monastero del Brabante raccontò che uno spirito avvolto dalle fiamme le apparve e le disse: “Sono Papa Innocenzo”. Disse che era in purgatorio a causa di tre errori commessi nella vita, e chiese a Lutgarde di venire in suo aiuto, dicendo: “Ahimè! È orribile; e durerà per molti secoli se tu non verrai in mio aiuto”. In quel momento scomparve e Lutgarde informò immediatamente le sorelle di ciò che aveva visto.
Appunti
- Jane Sayers, "Innocenzo III: Leader d'Europa 1199-1216" Londra 1994, p.16
- Jane Sayers, "Innocenzo III: Leader d'Europa 1199-1216" Londra 1994, p.17
- Jane Sayers, "Innocenzo III: Leader d'Europa 1199-1216" Londra 1994, p.21
- I Cardinali di Santa Romana Chiesa - Cardinali del XII secolo
- Innocenzo III, papa, 1160 o ... Apri Biblioteca (non definito) . Apri Biblioteca. Estratto il 23 agosto 2012. John C. Moore, " De Miseria Humanae Conditionis: UN Speculum curiae? Rassegna storica cattolica 67 (1981), 553-564.
- LOTARIO DEI CONTI DEI SEGNI In latino, manoscritto su pergamena probabilmente Italia, ca. 1250] (non definito) . LES ENLUMINURES, LTD (2006). Estratto il 13 gennaio 2011.
- Enciclopedia Cattolica: Papa Innocenzo III (non definito) . Newadvent.org (1 ottobre 1910).
- Chesterton (1924), pp. 107-108
Innocenzo III (Innocentius) (1160 o 1161 - 07.1216), papa dal 1198. Lottò per la supremazia dei papi sul potere secolare; costrinse il re inglese e alcuni altri monarchi a riconoscersi come suoi vassalli. Iniziatore della IV Crociata e della campagna contro gli Albigesi.
Innocenzo III è papa dal 1198. Lottò per la supremazia dei papi sul potere secolare; costrinse il re inglese e alcuni altri monarchi a riconoscersi come suoi vassalli. Iniziatore della Quarta Crociata e della campagna contro gli Albigesi. Innocenzo III salì al trono papale nel gennaio 1198, quando l'influenza del potere papale fu nuovamente notevolmente indebolita. Anche a Roma il prefetto era il protetto dell'imperatore. Di solito venivano scelti come papi uomini molto anziani che non vivevano bene nel mondo da molto tempo. Innocenzo III aveva solo 37 anni. Nacque ad Anagni e appartenne alla illustre famiglia dei Conti di Segni del Lazio. Innocenzo ricevette un'ottima educazione: giuridica a Bologna, teologica a Parigi e fu elevato a cardinale dallo zio Clemente III. Il nuovo papa si distingueva per un carattere freddo, padrone di sé, prudenza e cautela. Sapeva, quando le circostanze lo richiedevano, cedere e poi passare nuovamente all'offensiva; in una parola, era un diplomatico. Gran parte delle sue convinzioni e azioni possono essere attribuite alla natura dell'educazione ricevuta. Innocenzo III sosteneva le sue affermazioni con riferimenti a raccolte giuridiche in cui i sostenitori del papato raccoglievano documenti che parlavano a suo favore. Come la maggior parte dei politici del suo tempo, era convinto della necessità di sottomettere la cristianità all'autorità papale. “Il potere reale”, scrive Innocenzo III, “è subordinato al potere papale. Il primo governa solo sulla terra e sui corpi, il secondo - in cielo e sulle anime. Il potere dei re si estende solo a certe regioni, il potere di Pietro copre tutti i regni, perché è il rappresentante di Colui al quale appartiene l'universo." Altrove si esprime ancora più chiaramente: «Il Signore ha dato a Pietro potere non solo sulla Chiesa universale, ma su tutto il mondo». A suo avviso, la “libertà della chiesa” è assicurata solo laddove “la Chiesa romana gode di un potere illimitato sia negli affari spirituali che secolari”. Quindi, il compito principale di Innocenzo III, come Gregorio VII, era rafforzare il potere papale. Nel febbraio 1198, cioè un mese dopo l'elezione, Innocenzo III prestò giuramento di fedeltà al prefetto e gli conferì l'investitura. Nello stesso anno soggiogò il comune, guidato dal “supremo senatore”. Il Papa ottenne il diritto di nominare un maestro. Il comune venne mantenuto, ma era ora soggetto alla suprema autorità del papa. Innocenzo rivolse ad alcuni comuni e regioni italiani un messaggio in cui parlava di una razza “brutale” (“germanica”) che aspirava al dominio sull'Italia. Il Papa ha descritto in modo particolarmente dettagliato le atrocità di Enrico VI in Sicilia, dove, come sosteneva, non c'era una sola famiglia che "non sarebbe diventata vittima di questo tiranno". Volendo mostrare la crudeltà raggiunta da questo imperatore, il papa radunò a Roma quei siciliani e gli italiani del nord a cui furono cavati gli occhi e le orecchie tagliate per ordine di Enrico. La vista degli sfortunati avrebbe dovuto scoraggiare gli italiani dal tornare sotto la protezione del Sacro Romano Impero. Innocenzo III vi riuscì. Tuttavia, i comuni italiani rifiutarono non solo il potere imperiale, ma anche quello papale. Innocenzo classificò questo movimento come un'eresia pericolosa per la fede cattolica. Fu dichiarata guerra a diverse città, e se in Italia non ebbe proporzioni vaste, fu solo perché il papa temeva che queste città si sarebbero rivolte all'imperatore per chiedere aiuto. Nel frattempo Firenze, Siena, Lucca, Volterra, Arezzo, Prato e altre città formarono una lega amica del papato e ostile all'impero nel 1197. Innocente lo approvò; riconquistò quei domini che erano appartenuti alla contessa Matilde in queste zone, ne organizzò l'amministrazione e ne assicurò la protezione. Dopo che i tedeschi furono espulsi dal sud della Sicilia con l'aiuto del papa, Costanza, vedova di Enrico VI ed erede del Regno di Sicilia, affidò nel novembre 1198 a Innocenzo III la tutela del suo giovane figlio Federico. Per assicurare a quest'ultimo la corona siciliana, rinunciò in suo favore ai diritti sulla Germania e sul Sacro Romano Impero. Il papa giocò un gioco diplomatico altrettanto abile durante la lotta per il trono imperiale tra gli Hohenstaufen e gli Welves, che si svolse nel 1198-1209. Due partiti si contendevano il trono: l'uno eletto Filippo di Svevia, fratello di Enrico VI, l'altro eletto Guelfo Ottone di Brunswick, figlio di Enrico il Leone. Dalla parte di Filippo di Svevia c'erano i ricordi dei suoi antenati-imperatori, i loro possedimenti, il sostegno della maggior parte dei principi e del re francese Filippo Augusto. Tra gli influenti mecenati di Ottone c'era solo suo zio Riccardo Cuor di Leone, quindi cercò di ottenere il favore del papa. Il Papa ha deciso di agire come giudice in questa controversia. Chi consacra l'imperatore, scriveva ai principi tedeschi, ha il diritto di disporre della corona imperiale. Innocenti "liberarono" principi, vescovi e persino singoli cittadini dal giuramento fatto all'imperatore e invitarono tutti a sostenere solo il candidato che riconosceva il diritto del papato di approvare e persino eleggere l'imperatore tedesco. Innocenzo si oppose a Filippo di Svevia con il pretesto della preoccupazione del papato per la "libertà" del popolo tedesco. Se Filippo diventasse imperatore, sosteneva Innocenzo, la dinastia degli Hohenstaufen si rafforzerebbe in Germania e la “libertà della Germania”, che consiste nel diritto dei principi di eleggere un imperatore di loro libera volontà, perirebbe e cederebbe il posto a una successione ereditaria. monarchia, che sarà un colpo fatale per la libertà tedesca. Nel marzo 1201, Innocenzo chiese che Ottone di Brunswick fosse riconosciuto come imperatore e liberò i seguaci di Filippo dal giuramento di fedeltà. Ottone rispose promettendo di preservare intatti “i beni, le insegne e i diritti della Chiesa romana”, compresa l’eredità di Matilde. Tuttavia, Filippo continuò a combattere e nel 1206 riuscì a riconquistare la sua capitale, Colonia, da Ottone di Brunswick. Innocenzo III fu costretto ad avviare trattative con Filippo di Svevia e a riconoscergli i diritti al trono. Ma già nel giugno 1208 Filippo morì a Bamberga per mano del conte palatino Ottone di Wittelsbach, al quale rifiutò la mano della figlia. Innocenzo III si trovò in una situazione difficile, dalla quale Ottone di Brunswick lo aiutò a uscire. Per conquistare gli Hohenstaufen, Ottone sposò la figlia di Filippo di Svevia, Beatrice; e per soddisfare Innocenzo III accettò il titolo di imperatore «per grazia di Dio e del papa». Nell'ottobre 1209 Ottone fu incoronato a Roma. Sentendosi forte, dimenticò rapidamente tutte le sue promesse e i suoi giuramenti. Ottone prese possesso delle terre della margravia Matilde e attaccò i possedimenti della corona siciliana nell'Italia meridionale. L'ingannato Innocenzo III scrisse: “Molti ora mi insultano; dicono che merito ciò che sopporto, che ho forgiato con le mie stesse mani una spada che ora mi ferisce così crudelmente Lascia che l'Onnipotente, chi conosce la purezza della mia anima e chi una volta disse di se stesso: "Mi pento di aver creato l'uomo". Privato dei suoi beni secolari, Innocenzo III si rivolse al re francese Filippo Augusto e stipulò un'alleanza con lui. Nel novembre 1210 il papa scomunicò Ottone dalla chiesa e liberò i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà. Con la stessa energia con cui difese Ottone diversi anni fa, ora creò una coalizione contro di lui. La sua vasta corrispondenza può servire come prova della flessibilità diplomatica e dell'instancabilità di Innocenzo III come politico intraprendente che non disdegnava alcun mezzo nell'attività diplomatica solo per raggiungere il suo obiettivo, intimidendo alcuni con punizioni celesti e terrene, instillando false speranze in altri, stipulando accordi segreti con altri, aprì la strada alla creazione di. la supremazia del papato non solo nell'impero tedesco. Innocenzo III adempì coscienziosamente i suoi doveri di tutore di Federico. Combattè con Markvald Anweiler, che, diretto a sud, cercò di proclamarsi re di Sicilia; in seguito non permise a Ottone di prendere possedimenti da Federico. Nel settembre del 1211, il re di Boemia, i duchi d'Austria e di Baviera, il langravio di Turingia e altri principi, riuniti a Norimberga, elessero Federico imperatore di Germania. Innocenzo approvò questa scelta, sebbene in precedenza si fosse opposto alla Sicilia e alla Germania che finissero nelle stesse mani. Tuttavia, il comportamento provocatorio di Otto gli fece dimenticare l'interesse immediato della Santa Sede. Nel marzo 1212 Federico arrivò a Roma; giurò fedeltà a Innocenzo III per il Regno di Sicilia. Accettò quindi la corona di Germania il 9 dicembre 1212. Tuttavia, Innocenzo riuscì comunque ad assicurarsi il trono papale ricevendo da Federico un giuramento di fedeltà alla Sicilia. Federico dovette cedere anche il papato e una serie di privilegi in violazione del Concordato di Worms. D'ora in poi il papa potrebbe dichiarare che in Germania l'elezione dei vescovi avviene “esclusivamente liberamente”, cioè senza l'ingerenza delle autorità secolari. Nel frattempo, i vescovi rappresentavano una forza enorme in Germania: non erano meno potenti dei principi più potenti. Nelle loro terre di Magonza, Colonia, Treviri, Salisburgo, Würzburg c'erano centinaia e migliaia di vassalli e centinaia di migliaia di servi e contadini dipendenti. A quei tempi la terra “serviva” e le risorse materiali e le forze militari venivano messe a disposizione dei principi spirituali. Vaste terre arcivescovili e monastiche caddero fuori dal controllo dell’imperatore sia militarmente che finanziariamente. Pertanto, concedere al papa il diritto di nominare principi spirituali equivaleva a minare il potere imperiale e creare un formidabile pericolo all'interno dell'impero da parte dei prelati della chiesa dipendente dal papa. Innocenzo III approfittò della lotta tra Capetingi e Plantageneti per sottomettere l'Inghilterra. Quando l'arcivescovado di Canterbury divenne vacante, Innocenzo III, nonostante l'opposizione di Giovanni il Senza Terra, lo diede a Stefano Langton (1206), poi impose l'interdetto all'Inghilterra, scomunicò il re, lo dichiarò deposto e offrì la corona inglese a Filippo Augusto. Costretto a cedere, Giovanni il Senza Terra donò l'Inghilterra e l'Irlanda alla Chiesa Romana e le riprese in feudo (1213). Ma l’Inghilterra non voleva condividere l’umiliazione con il suo re. Durante la sua lotta con i baroni e il popolo, costretto a firmare la Grande Carta (1215), Giovanni il Senza Terra si rivolse al papa per chiedere aiuto. Innocenzo III lo difese: “Nel nome di Dio onnipotente, nel nome dei Santi Pietro e Paolo e per il potere che ci appartiene, condanniamo e malediciamo totalmente questa Carta e, sotto pena di anatema, proibiamo la il re per adempierlo, e i baroni per esigerne l’esecuzione”. Scomunicò i prelati e i baroni che resistettero al re, ma quest'ultimo continuò a persistere, la guerra civile rovinò l'Inghilterra e gli inglesi considerarono il papa il colpevole dei loro disastri. “Il sommo sacerdote”, scrive Matteo di Parigi, “che avrebbe dovuto essere la fonte della santità, lo specchio della pietà, il custode della giustizia e il difensore della verità, protegge una persona simile. Perché lo sostiene? l’abisso dell’avidità romana può inghiottire la ricchezza dell’Inghilterra”. L'Inghilterra fu per lungo tempo trasformata in uno stato vassallo del trono romano. Una delle direzioni più importanti della politica internazionale di Innocenzo III fu l'organizzazione di nuove crociate, ora non solo contro i musulmani "infedeli", ma anche contro i "pagani" - i popoli baltici e gli slavi dell'Europa orientale, nonché contro gli eretici che non riconoscevano l'autorità papale. Le raccolte monetarie effettuate con pii pretesti (per finanziare le crociate) arricchirono di fatto il tesoro papale; la predicazione di queste campagne servì a rafforzare l'autorità papale; Il vero scopo delle crociate agli occhi del papa era lo schiacciamento dei suoi nemici e la sottomissione di nuovi popoli e regioni al potere della Curia romana. Su iniziativa di Innocenzo III fu organizzata la Quarta Crociata in Oriente (1202-1204). Intorno a questa campagna c'erano molti intrighi diplomatici, in cui il primo ruolo spettava alla principale potenza commerciale d'Europa: Venezia. Venezia, che fornì la flotta ai guerrieri crociati, voleva usarla per schiacciare la sua rivale commerciale, Costantinopoli. Filippo di Svevia sperava, agendo attraverso il capo dei crociati, suo parente marchese di Monferrato, di rafforzare la posizione della Germania nell'impero bizantino: il deposto imperatore bizantino Isacco II Angelo, la cui figlia Irene aveva sposato Filippo, si rivolse a lui per chiedere aiuto. Innocenzo III, dal canto suo, vide nella campagna l'occasione per realizzare gli antichi progetti antibizantini della curia pontificia; sperava, creando una minaccia per Costantinopoli, di ottenere la subordinazione della Chiesa greca alla Roma cattolica. Gli astuti intrighi di Venezia, non senza la partecipazione della diplomazia segreta di Innocenzo III, portarono questa campagna a risultati del tutto “inaspettati”: al posto dell’Egitto, che era l’obiettivo ufficiale della campagna, i Cavalieri della Croce, “deviando da il cammino”, sconfisse prima la città dalmata di Zara, per poi dirigersi verso la capitale bizantina. Innocenzo III, se non formalmente, nella sostanza approvò il cambio di direzione della spedizione crociata. Per motivi di decenza, tuttavia, il papa minacciò i crociati di misure ecclesiastiche se avessero alzato la spada contro la cristiana Costantinopoli. Nel 1204, i Cavalieri della Croce conquistarono e saccheggiarono brutalmente la capitale dell'Impero bizantino. Qui si formò un nuovo stato crociato: l'Impero latino. Il papa dichiarò immediatamente la presa di Costantinopoli un “miracolo di Dio”. I mercanti veneziani beneficiarono maggiormente della sconfitta dell'Impero bizantino, poiché infersero un colpo irreparabile al loro rivale commerciale. Le speranze di Innocenzo III di sottomettere la Chiesa greca non erano giustificate. Né con la predicazione né con la forza il papato riuscì a imporre un'unione alla popolazione greca dell'odiato Impero latino. Innocenzo III fu anche l'iniziatore della crociata contro gli eretici della Francia meridionale, gli albigesi, che si concluse con la terribile sconfitta del sud della Francia. Lo stesso papa invitò il cavalierato tedesco a condurre una campagna contro i pagani livoni e istituì l'ordine cavalleresco spirituale degli spadaccini nel Baltico orientale per convertire i pagani baltici al cristianesimo. Predicò una crociata contro i mori musulmani in Spagna, segnata dai pogrom contro gli ebrei e dalla vittoria sui mori a Las Navas de Tolosa (1212). Parlando degli strumenti della diplomazia di Innocenzo III, non bisogna dimenticare le più influenti organizzazioni di carattere internazionale poste al servizio del papato, gli ordini mendicanti creati per combattere l'“eresia”: domenicani e francescani. Si infiltrarono rapidamente in tutti i paesi europei e costruirono i loro nidi nelle università. La ricerca dell'eresia e i terribili tribunali dell'Inquisizione erano nelle mani del papa i più importanti mezzi di pressione nelle questioni di politica europea. I successi della politica internazionale di Innocenzo III, che lo rese praticamente l'arbitro politico d'Europa, furono sostenuti dal potere finanziario del papato: la Curia romana divenne in questo momento la forza finanziaria più potente d'Europa. Pompando fondi da tutto il mondo cattolico, il papato è strettamente associato alle case bancarie di vari paesi europei. Altro strumento della diplomazia pontificia era il diritto della Curia Romana, fermamente sostenuto da Innocenzo III, di decidere in ultima istanza tutte le questioni giudiziarie della chiesa. Poiché la gamma degli affari ecclesiastici era insolitamente ampia e vaga, ciò diede al papa l'opportunità di intervenire costantemente negli affari interni di qualsiasi stato, che giocò un certo ruolo nello sviluppo degli affari delle ambasciate in Europa. Per proteggere i propri interessi nella curia papale, i governi inviavano rappresentanti - "procuratori" - a Roma. Con l'aumento del numero delle cause presso la curia pontificia, i procuratori dovettero soggiornare a Roma per lunghi periodi, e talvolta la loro posizione assunse il carattere di una rappresentanza permanente presso la corte papale. Tra gli stati non così potenti, Innocenzo III godeva di un'enorme autorità. Il papa divenne il signore supremo di un certo numero di re che si riconobbero come suoi vassalli. Il Regno di Sicilia, Svezia e Danimarca divennero possedimenti vassalli del papa. Il Portogallo aveva riconosciuto il vassallaggio al soglio pontificio già prima (1144) e aveva rinnovato il giuramento feudale sotto Innocenzo III. Nel 1204 il re aragonese Pedro divenne vassallo del papa e nel 1207 il re polacco. I re di Bulgaria e Serbia cercarono il patronato di Innocenzo, promettendogli in cambio l'unione con la Chiesa cattolica. Anche la lontana Armenia riconobbe la dipendenza vassallo dal papa. I sovrani che si piegarono così umilmente a Innocenzo III o erano deboli o avevano bisogno di lui. Anche la lotta di Innocenzo III con il re Filippo II di Francia, astuto intrigante e diplomatico, ebbe successo. Filippo II, avendo sposato la principessa danese Ingeborg, la allontanò presto da sé e decise di sposare Agnese di Merano. Il papa ricattò il re, rendendogli difficile il divorzio da Ingeborg. La conclusione e lo scioglimento dei matrimoni tra teste coronate a quei tempi era una delle tecniche diplomatiche più efficaci. Tuttavia, Filippo II era un politico coraggioso e deciso, quindi Innocenzo III preferì usarlo come alleato. L'ultimo atto importante del regno di Innocenzo III fu la convocazione del Concilio Ecumenico Lateranense nel novembre 1215. Al concilio parteciparono 412 vescovi e 800 abati o priori. Il Consiglio ha adottato 70 risoluzioni (canoni). Molti di questi decreti testimoniano la mente sublime e coraggiosa di Innocenzo III, un'alta idea dell'influenza della chiesa sulla società, un sincero desiderio di migliorare il clero e renderlo degno del suo ruolo nella pietà, nell'illuminazione e nella purezza dei costumi. Il consiglio ha sviluppato le istruzioni per l'imminente crociata. I crociati sarebbero partiti nel maggio 1217; Erano già stati individuati i punti di raccolta dei singoli distaccamenti, e il papa aveva promesso di benedirli personalmente. Ma non fece in tempo a farlo: mentre era in giro per l'Italia, morì improvvisamente a Perugia nel luglio 1216, all'età di 56 anni.
Innocenzo III, papa
Innocenzo III
Frammento di affresco nel monastero di San Benedetto
Innocenzo III, papa

Stemma dei Conti di Senja
Lotario proveniva dalla famiglia dei Conti di Segna ed era nipote del Papa. Ricevette gli studi primari a Roma, studiò teologia a Parigi e giurisprudenza a Bologna, divenendo uno dei più famosi esperti di teologia e diritto del suo tempo. Subito dopo la sua morte, Lotario ritornò a Roma, ricoprendo vari incarichi spirituali sotto i papi successivi. lo fece suddiacono e cardinale diacono. Durante il pontificato degli Orsini, i peggiori nemici di Segna, il cardinale Lotario fu in esilio. Visse ad Anagni, impegnato nella riflessione e nella creatività letteraria. Tuttavia, prima di morire, convinse i cardinali a eleggere il 37enne Lotario come nuovo papa. Senza apparente desiderio, accettò la tiara e prese il nome di Innocenzo III.
Approfittando dell'indebolimento del potere imperiale dopo la sua morte, Innocenzo iniziò a restaurare energicamente il potere papale. Il prefetto di Roma, che governava la città per conto dell'imperatore, e il senatore, che difendeva i diritti dei cittadini, giurarono fedeltà al papa. Restaurata la sovranità papale su Roma, Innocenzo cominciò a riportare all'obbedienza le regioni circostanti: Romagna, Ancona, Spoleto, Assisi e Sora. Ben presto, una vedova, incapace di difendere il trono siciliano per un minore, si rivolse a Innocenzo per chiedere aiuto. Innocenzo le chiese di confermare la sovranità papale e di rinunciare ai privilegi concessi ai Normanni. A metà novembre 1198 Innocenzo emise una bolla nella quale fu solennemente proclamato re. Prima che il toro raggiungesse la Sicilia, ella morì, nominando tutore Innocenzo. Anche i nemici del papato ammettono che per nove anni Innocenzo aiutò altruisticamente il giovane re, governando abilmente e coscienziosamente. Nel 1209 fu incoraggiato a sposare Costanza, vedova.

Contemporaneamente al problema tedesco, Innocent ha risolto i problemi in e. Nel gennaio 1198 il legato Pietro di Capua, sotto minaccia di scomunica, obbligò a firmare una tregua quinquennale. Nel 1199 Innocenzo impose un interdetto di nove mesi per aver abbandonato la legittima moglie Ingeborg per la sua amante Agnese. Nel 1205 scoppiò un conflitto per l'elezione dell'arcivescovo di Canterbury. Dopo aver rifiutato tremila marchi per l'approvazione del candidato reale, il papa raccomandò al dipartimento Stephen Langton, rettore dell'Università di Parigi, che fu dedicato il 17 giugno 1207 a Viterbo. si oppose all'ingresso di Langton in , insistendo sul suo candidato John de Gray, e rovinò molti monasteri che si rifiutarono di riconoscerlo. Nel 1208 Innocenzo impose un interdetto, lo scomunicò nel 1209 e nel 1212 dichiarò formalmente deposto il re. Solo rifiutandosi, sotto la minaccia di un'invasione francese, accettò di riconoscere l'arcivescovo Langton. Inoltre, il 13 maggio 1213, lo riconobbe feudo pontificio, promettendo di pagare un tributo annuo di 1.000 marchi. Il 20 luglio, il papa revocò la punizione al re e, dopo aver restituito alla chiesa le terre di ricchezza confiscate, il 29 giugno 1214, il papa revocò l'interdetto. Tuttavia, i baroni furono indignati da questo atto del re e dalla violazione dei loro privilegi. Hanno costretto a firmare la Magna Carta, che non è stata riconosciuta dal papa.
Come i suoi predecessori, Innocenzo III era zelante nella liberazione della Terra Santa. Organizzò la Quarta Crociata, ma i pellegrini, invece di combattere per il Santo Sepolcro, furono coinvolti nelle lotte bizantine e saccheggiarono Costantinopoli nel 1204. È stata fondata sul posto, guidata da. È stata annunciata anche la riunificazione delle Chiese d'Occidente e d'Oriente. Innocent era sconvolto dal fatto che i crociati si fossero discostati dal loro obiettivo originale, ma non era più in suo potere cambiare nulla.
Innocenzo combatté anche con zelo contro varie eresie. I suoi principali oppositori erano gli albigesi, membri di una grande setta del sud. Non solo professavano dottrine eretiche, ma cercavano anche di diffonderle con la forza. Nel 1208 gli albigesi uccisero uno dei missionari inviati dal papa a predicare la vera fede. Innocenzo impose un interdetto a diverse città e invitò il re a intraprendere una guerra contro gli eretici, che presto si trasformò da religiosa in ordinaria di conquista.
In generale, non c'era quasi un paese in Europa nei cui affari Innocent non interferisse. Annullò i matrimoni dei re e riconobbe la Svezia come suo vassallo e tentò di ristabilire l'unità con la Chiesa orientale. Innocenzo fondò università a Parigi e Oxford e approvò la creazione di ordini mendicanti secondo le regole di San Francesco e San Domenico. In un'attività così frenetica, il papa si avvalse di un apparato amministrativo e fiscale ben organizzato. Uno staff di consiglieri curiali e legati inviati in tutti i paesi europei supervisionò l'attuazione dei decreti papali. Come risultato delle attività di Innocenzo III, la capitale apostolica, sfruttando il progresso economico e il rilancio degli scambi commerciali tra le città in via di sviluppo d'Europa, si trasformò nel più potente magnate finanziario d'Europa. Subordinato al papato grazie ai francescani, il “movimento dei poveri” neutralizzò la minaccia dei movimenti socio-religiosi che indebolivano l’autorità della gerarchia ecclesiastica. Va aggiunto che i piani politici dell'universalismo papale nel programma di Innocenzo III erano strettamente legati agli obiettivi religiosi. Egli attuò con coerenza i principi teocratici della riforma, che partivano dal fatto che all'intera società cristiana doveva essere imposta la mediazione di una gerarchia subordinata all'autorità papale.
Alla fine della sua vita, Innocenzo organizzò il Concilio Lateranense IV, che si aprì il 15 novembre 1215. Fu la più importante delle cattedrali del Medioevo. Adottò 70 canoni, che costituirono il fondamento della nuova legislazione ecclesiastica. Il Concilio condannò tutte le dottrine religiose e sociali propagate dai Catari e dai Valdesi, eretici che combattevano per i diritti dei poveri. I padri conciliari invitarono il popolo di Dio a correggere i costumi, condannarono la corruzione e l'immoralità del clero e inasprirono l'obbligo per i sacerdoti di osservare il celibato. I credenti erano obbligati a confessarsi solo dal proprio parroco e a ricevere la comunione almeno una volta all'anno, durante la Quaresima. I confessori erano tenuti a mantenere il segreto della confessione. In campo dottrinale, il Concilio ha formulato gli aspetti teologici della dottrina dei sacramenti nello spirito della scolastica medievale. Al concilio si parlò molto delle decime della chiesa. Il concilio richiedeva agli ebrei di indossare abiti speciali che li distinguessero dai cristiani e proibiva loro di uscire durante la Settimana Santa. Il Consiglio si espresse anche a favore della costruzione di quartieri separati (i cosiddetti ghetti) per gli ebrei.
Innocenzo III morì a Perugia durante uno dei suoi viaggi apostolici. Il suo corpo, vestito con abiti papali, fu esposto su un carro funebre nella cattedrale locale. Di notte, i ladri sono entrati nella cattedrale e hanno rubato i segni dell'autorità papale. Quando il giorno successivo i cardinali si riunirono per celebrare il servizio funebre, videro nella bara solo i resti nudi di colui che aveva dominato il mondo cristiano per 18 anni. Innocenzo fu sepolto in questa cattedrale e solo nel dicembre 1891 le sue spoglie furono trasferite nella Cattedrale del Laterano a Roma.