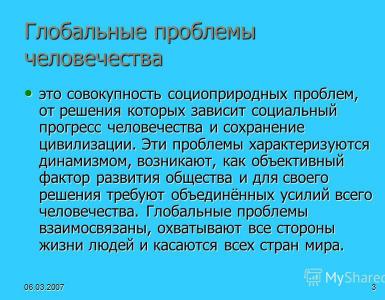Complessi sintomatici di danno a varie parti del midollo spinale. Lesioni del midollo spinale: cause, segni, sintomi, trattamento
Danni minori al corpo vertebrale (fratture), spesso inosservati, possono successivamente diventare fonte di gravi malattie della colonna vertebrale. Dopo un decorso iniziale lieve e breve e un successivo periodo lungo (diversi mesi o più) di apparente recupero, la mobilità della colonna vertebrale è limitata, compaiono dolore alla cintura, curvatura cifotica locale e talvolta sintomi di compressione cerebrale. Questi fenomeni dipendono dal cedimento della vertebra, avvenuto a seguito del rammollimento secondario della sostanza ossea danneggiata del corpo vertebrale. La radiografia mostra un appiattimento a forma di cuneo di una vertebra (fig. 105). Nessuna osteoporosi. Le cartilagini intervertebrali non sono appiattite.
In caso di spondilosi traumatica viene applicato per diversi mesi un cerotto e poi un corsetto di cuoio oppure viene eseguita la fissazione osteoplastica della colonna vertebrale secondo Albee o Vreden.
La capacità lavorativa viene ripristinata dopo 3-4 mesi.
LESIONI DEL MIDOLLO SPINALE
Il midollo spinale viene danneggiato sia con lesioni spinali chiuse che aperte, cioè con distorsioni, contusioni, lussazioni, fratture e ferite di vario tipo. Il danno cerebrale è possibile senza compromettere l'integrità della colonna vertebrale. Le lesioni del midollo spinale vanno dai cambiamenti molecolari alla rottura completa del cervello.
Viene fatta una distinzione tra commozione cerebrale, compressione, contusione, ematomielia, rottura parziale dell'integrità e rottura trasversale completa del cervello. Anche le radici del midollo spinale sono soggette a compressione e rottura.
Commozione cerebrale(shock spinale) è associato a diverse lesioni: contusione aerea dovuta a esplosioni o esplosioni di armi da fuoco (le vibrazioni delle onde d'aria vengono trasmesse al cervello attraverso il liquido cerebrospinale), un colpo alla schiena, ferite e danni alle vertebre e il contenuto del canale spinale senza danni diretti al cervello. I cambiamenti anatomici che si verificano nel tessuto cerebrale durante una commozione cerebrale sono insignificanti e consistono in gonfiore del cervello, edema del cervello e della pia madre, le più grandi emorragie puntiformi e lesioni necrotiche che possono essere aperte al microscopio.
La sindrome da commozione cerebrale del midollo spinale è costituita da disturbi motori e sensoriali che compaiono immediatamente dopo la lesione e tendono a scomparire presto. I disturbi del movimento assumono la forma di paraplegia o paraparesi. Con la paraplegia e la paraparesi, i movimenti iniziano rapidamente a essere ripristinati nelle prossime settimane o addirittura giorni e il paziente si riprende presto. Tuttavia, il recupero non è sempre completo. La natura lenta della paraplegia, la disfunzione degli organi pelvici e la comparsa di piaghe da decubito indicano un grave danno organico al cervello. Nello shock spinale, se si esclude il coinvolgimento del midollo allungato o del cervello, il paziente non perde conoscenza. I sintomi di una commozione cerebrale sono una componente molto importante e, inoltre, quasi obbligatoria del quadro clinico di tutti i tipi di lesioni del midollo spinale.
Con una contusione del midollo spinale si verificano diversi gradi di danno al tessuto cerebrale, da emorragie puntuali a ematomi significativi. La contusione cerebrale è possibile senza danni alla dura madre.
La compressione del midollo spinale è causata da un frammento di un arco vertebrale rotto, da un corpo vertebrale spostato, da un corpo estraneo o da una raccolta di sangue. Il sanguinamento nel canale spinale proviene dal plesso venoso situato extraduralmente o dalle vene dell’aracnoide, e talvolta da entrambi. Il sangue che fuoriesce dai vasi danneggiati non incontra molta resistenza nel tessuto extradurale lasso e nello spazio intradurale e scorre verso il basso, talvolta scendendo fino al fondo del sacco della dura madre. A volte il sangue si accumula nel canale spinale sotto forma di ematoma e comprime il midollo spinale e le sue radici.
Clinicamente, la compressione traumatica del midollo spinale si manifesta come paraplegia spastica con lievi disturbi degli organi pelvici e si manifesta senza piaghe da decubito. La paraplegia completa dovuta alla compressione causata dall'emorragia spesso non si sviluppa immediatamente dopo la lesione, ma gradualmente, man mano che il sangue si accumula.
Ematomielia- emorragia nella sostanza cerebrale - complica lesioni sia chiuse che aperte della colonna vertebrale e del midollo spinale. Il sangue scorre dai piccoli vasi sanguigni del cervello, si diffonde principalmente attraverso la materia grigia e, scendendo lungo il cervello nei suoi tessuti, a volte si diffonde in diversi segmenti del cervello, comprimendo e distruggendo i suoi elementi.
Il quadro clinico dell'ematomielia, a causa della diversa localizzazione e della diversa distribuzione dell'emorragia sia lungo che attraverso il cervello, è molto vario. I disturbi del movimento consistono in paraplegia o paralisi di alcuni gruppi muscolari, disturbi della sensibilità (sotto forma di alterazione della temperatura e della sensibilità al dolore pur mantenendo la sensibilità tattile). Questi disturbi nervosi compaiono immediatamente dopo l'infortunio o si sviluppano gradualmente, aumentando man mano che il sangue penetra nel tessuto cerebrale. Il sangue che permea il midollo può essere riassorbito, dopodiché ritorna la funzione perduta. In altri casi, l’area del cervello imbevuta di sangue si ammorbidisce, viene sostituita da una cicatrice o da una ciste e la sua funzione viene completamente persa. La previsione dell'ematomielia dipende dal grado di distruzione della materia cerebrale e dalle dimensioni dell'area interessata.
La violazione dell'integrità del midollo spinale da parte di un corpo estraneo inserito nel canale spinale, un frammento osseo o una vertebra spostata, nella maggior parte dei casi è parziale. Le lesioni parziali del midollo spinale, a seconda della localizzazione e dell'entità del danno, danno un quadro clinico molto diversificato.
In connessione con commozione cerebrale, contusione cerebrale, ematomielia che accompagna qualsiasi violazione dell'integrità del midollo spinale, anche con un danno parziale ad esso, all'inizio c'è quasi sempre un'immagine di una rottura completa del midollo spinale. In futuro, con queste lesioni, la paralisi si diffonde solo a determinati gruppi muscolari e si verifica una parziale perdita di sensibilità. Il ripristino parziale di funzioni apparentemente completamente perdute conferma retroattivamente la natura parziale del danno.
Una rottura di una metà del midollo spinale dà il quadro classico della paralisi di Brown-Sequard, cioè paralisi sul lato della lesione e perdita di sensibilità sul lato opposto. In tempo di pace, la paralisi di Brown-Séquard si osserva con coltellate alla schiena. Il coltello penetra tra le arcate nel canale spinale e taglia metà del cervello. In tempo di guerra, danni cerebrali simili si verificano con ferite da arma da fuoco alla colonna vertebrale.
Con un'interruzione traumatica completa del midollo spinale, si verifica immediatamente una paralisi flaccida, che successivamente si trasforma in paralisi spastica. Inoltre, un'interruzione completa del midollo spinale è caratterizzata dall'assenza di riflessi tendinei, segno di Babinski positivo, incontinenza urinaria e fecale, comparsa precoce e rapido aumento delle piaghe da decubito e completa perdita di sensibilità, il cui limite superiore non cambia .
Raramente si verifica un'interruzione anatomica completa del midollo spinale, ad esempio in caso di lussazioni delle vertebre cervicali, in caso di fratture della colonna vertebrale con spostamento significativo o in caso di ferite da arma da fuoco. Molto più comune è una rottura fisiologica e funzionale, causata da compressione, contusione, edema cerebrale, ematomielia o shock spinale. In entrambi i tipi di interruzione il quadro clinico è inizialmente lo stesso, ma successivamente, a volte presto, con una interruzione fisiologica, inizia il ripristino parziale delle funzioni perdute; il recupero potrebbe essere completo. La paralisi completa durante una pausa fisiologica non avviene sempre immediatamente.
Il quadro clinico delle lesioni del midollo spinale, oltre alla forma e al grado dei disturbi anatomici, dipende anche dal livello del danno. Quanto più in alto è localizzato il danno, tanto più estesa è l'area interessata e tanto più gravi sono il quadro clinico e il decorso (Fig. 107).
Quando il cervello viene danneggiato nell'area delle vertebre cervicali inferiori, la paralisi si verifica sotto forma di quadriplegia e anestesia dell'intero corpo tranne la testa. Se si verifica un danno nell'area delle vertebre cervicali superiori, questo è accompagnato da paralisi del diaframma ( n. frenico), che comporta quasi sempre la morte della vittima.
Con danno cerebrale a livello delle vertebre toraciche e L 1, la paraplegia si verifica con disfunzione degli organi pelvici; Quando il cervello è danneggiato nella zona delle vertebre toraciche superiori, la paraplegia con disfunzione degli organi pelvici è accompagnata dalla paralisi dei muscoli addominali e della maggior parte dei muscoli intercostali con problemi respiratori.
Il danno cerebrale al livello L 2 e inferiore fornisce il quadro di un danno alla cauda equina. La cauda equina è composta da nervi periferici, quindi la paralisi è flaccida. La paralisi si estende ai nervi del plesso sacrale, talvolta limitandosi al nervo sciatico. La perdita di sensibilità o dolore è localizzata nell'ano, nelle natiche, ecc. (Fig. 108).

I tipi descritti di lesioni del midollo spinale e le sindromi che li caratterizzano rappresentano solo modelli che nella vita raramente si trovano nella loro forma pura, ma di solito sono combinati tra loro. Pertanto, i quadri clinici osservati nella realtà non coincidono completamente con gli schemi descritti, ma sono incomparabilmente più complessi.
Nel riconoscere le lesioni del midollo spinale, la radiografia gioca un ruolo enorme, con l'aiuto della quale il medico può determinare la natura del danno osseo e la presenza di corpi estranei e frammenti ossei nel canale spinale. Nei casi dubbi si consiglia di ricorrere ad una laminectomia di prova.
Le lesioni del midollo spinale hanno un alto tasso di mortalità. Subito dopo l'infortunio, la morte avviene a causa della gravità della lesione; in un prossimo futuro, a seguito di un'infezione della ferita complicata successivamente da meningite, a seguito di un'infezione del tratto urinario ascendente e di piaghe da decubito; La maggior parte di coloro che sopravvivono presentano disfunzioni e dolore irreparabili. In generale, la prognosi per le lesioni del midollo spinale è tanto peggiore quanto maggiore è la gravità della lesione.
Il metodo di trattamento per le lesioni chiuse del midollo spinale dipende dalla natura e dall'entità della lesione. Per lesioni minori, commozioni cerebrali, contusioni ed ematomielia è indicato un trattamento conservativo. Per lesioni più gravi, è indicato un intervento chirurgico precoce sotto forma di apertura del canale spinale con rimozione dell'arco vertebrale, soprattutto se studi clinici e radiologici indicano un danno al cervello da parte di un frammento osseo o una compressione da parte di una vertebra spostata. Il trattamento di solito inizia con il riallineamento della colonna vertebrale. Se la riduzione non ha successo o i sintomi del midollo spinale peggiorano, la laminectomia diventa obbligatoria. Se il midollo spinale è completamente interrotto, l’intervento chirurgico è controindicato.
In caso di ritenzione urinaria viene applicata una fistola urinaria sovrapubica.
Nella fase avanzata, l'intervento chirurgico viene eseguito quando il midollo spinale o le sue radici vengono compressi da un osso, una cicatrice o una cisti aracnoidea.
Ogni anno nel mondo si registrano circa 6 milioni di infortuni che coinvolgono il sistema nervoso, che rappresentano circa il 6-8% di tutta la morbilità neurologica. Le lesioni del midollo spinale hanno una quota relativamente bassa nella struttura complessiva delle lesioni del sistema nervoso - circa il 12%. Dall'80% al 100% dei pazienti affetti da questa patologia diventano disabili o muoiono.
Le lesioni del midollo spinale sono solitamente associate a danni alla colonna vertebrale. Molto spesso vengono ferite la colonna cervicale inferiore, quella toracica inferiore e quella lombare.
Classificazione. Le lesioni del midollo spinale si dividono in aperte e chiuse, penetranti e non penetranti, con e senza danno alla colonna vertebrale.
Le lesioni aperte includono quelle in cui si forma una connessione tra il canale spinale e l'ambiente esterno attraverso tessuti molli, vertebre e dura madre danneggiati.
Le principali forme cliniche di lesioni chiuse del midollo spinale sono: commozione cerebrale, contusione, compressione, ematomielia (sanguinamento nella sostanza cerebrale) ed ematorahi (sanguinamento nelle membrane).
Nello sviluppo della malattia traumatica del midollo spinale si distinguono periodi acuti, intermedi o di recupero e tardivi. Il periodo acuto dura circa 1-2 mesi dopo l'infortunio ed è caratterizzato dalla necrosi dei neuroni spinali e dei loro processi in luoghi di impatto traumatico diretto, nonché dallo sviluppo della diaschisi (shock spinale). Shock spinaleè una reazione non specifica delle cellule nervose e dei conduttori del midollo spinale in risposta a una lesione, manifestata sotto forma di limitazione delle loro funzioni nell'ambito del mantenimento dei processi di supporto vitale di base con blocco reversibile di altre proprietà del tessuto nervoso (eccitabilità, conduttività ).
Il periodo di recupero, che dura fino a un anno dal momento dell'infortunio, è caratterizzato dal sollievo dello shock spinale, dall'inizio della formazione di una cicatrice post-traumatica e dallo sviluppo di processi rigenerativi e riparativi. Durante questo periodo viene determinata la reale estensione della lesione del midollo spinale e la possibilità di ripristinare il difetto morfofunzionale esistente.
Nel periodo tardivo, viene alla ribalta la formazione di necrosi secondaria, cisti, fusione edematosa del tessuto nervoso, si formano cicatrici ruvide di collagene, si verifica la degenerazione ascendente e discendente dei conduttori spinali e si sviluppano complicazioni infettive-trofiche.
Eziologia e patogenesi . Le lesioni del midollo spinale si verificano a casa, sul lavoro, in incidenti stradali, durante lo sport e in seguito a influenze iatrogene. L'aumento del numero degli infortuni è facilitato dalla crescente meccanizzazione del lavoro e della vita, dal mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, dal costante aumento del numero di veicoli unito all'indisciplina di conducenti e pedoni, da un ritmo di vita elevato portando allo sviluppo di affaticamento fisico e stress neuropsichico, alcolismo e tossicodipendenza.
Fattori meccanici e vascolari svolgono un ruolo di primo piano nella patogenesi delle lesioni del midollo spinale. Per fattore meccanico si intendono i cambiamenti morfologici e funzionali nei tessuti del midollo spinale direttamente correlati alla direzione e all'intensità dell'impatto traumatico sotto forma di necrosi delle cellule nervose e dei conduttori, cambiamenti nella struttura intracellulare con violazione della velocità dei processi metabolici, ecc. I disturbi dell'afflusso di sangue e il gonfiore che si verificano nel sito della lesione e nelle aree circostanti sono fattori decisivi per il successivo sviluppo della tubercolosi del midollo spinale.
Clinica . Il danno al midollo spinale si manifesta clinicamente con un complesso di sintomi di disturbi motori, sensoriali e autonomi. Alcuni di essi sono causati dalla morte delle strutture spinali, altri sono dovuti a vari gradi di danno a queste strutture e alla loro inferiorità funzionale. Una variante comune del difetto morfofunzionale reversibile è shock spinale, che è tipico del periodo acuto di lesione del midollo spinale di qualsiasi gravità. Clinicamente si manifesta con paralisi degli arti e anestesia al di sotto del livello della lesione, ritenzione della minzione e della defecazione. I fenomeni di shock spinale si osservano per diverse ore e talvolta per diverse settimane, dopo di che il quadro clinico della lesione del midollo spinale è determinato da disturbi neurologici di varia gravità a seconda della gravità della lesione.
Commozione cerebrale– la forma più lieve di lesioni traumatiche, che si manifesta prevalentemente come disturbi sensoriali di tipo conduzione al di sotto del livello di danno, il più delle volte sotto forma di ipoestesia e parestesia. Dolore nel sito della lesione, intorpidimento. I disturbi motori sono rappresentati da lieve debolezza delle braccia e/o delle gambe, a seconda della sede della lesione. A volte i disturbi pelvici vengono rilevati sotto forma di stitichezza, ritenzione urinaria o aumento della frequenza. Tutte le manifestazioni cliniche regrediscono senza lasciare traccia entro 2-3 settimane.
Contusione del midollo spinale accompagnato da disturbi neurologici più gravi. Con questa forma si osservano spesso fratture dei corpi vertebrali e degli archi con spostamento nel canale spinale e compressione del midollo spinale. Quando i fenomeni di shock spinale regrediscono, si determinano disturbi motori pronunciati sotto forma di paresi o paralisi centrale e periferica. Al di sotto del sito della lesione si osservano disturbi sensoriali di tipo conduttivo sotto forma di ipoestesia e anestesia. Quando le radici sono danneggiate, le vittime lamentano dolori lancinanti nelle aree corrispondenti. Gravi disturbi delle funzioni degli organi pelvici, principalmente la minzione, sono determinati dal tipo periferico o centrale. Dopo alcune settimane si formano piaghe da decubito sull'osso sacro, sui talloni, sulle creste iliache e in altre aree dove i tessuti molli possono essere compressi dalle protuberanze ossee. L'infezione delle piaghe da decubito porta spesso alla sepsi e alla morte. Anche l'urosepsi e la polmonite sono fatali. Il recupero delle funzioni dopo una lesione del midollo spinale avviene lentamente nel corso di un anno e non è mai completo.
Compressione del midollo spinale causato da frammenti ossei delle vertebre, frammenti di legamenti e dischi, ematoma intravertebrale, edema-gonfiore e una combinazione di questi motivi.
La compressione del midollo spinale, che si verifica in modo acuto, si verifica molto spesso a causa di frammenti delle vertebre e di un disco prolassato e si sviluppa al momento della lesione. Al di sotto del livello di danno si verificano disturbi motori e sensoriali e si verifica una disfunzione degli organi pelvici. Un graduale aumento dei sintomi neurologici è caratteristico di un ematoma epidurale dovuto al danneggiamento delle vene epidurali. Un ematoma può svilupparsi 2-3 settimane dopo l'infortunio come emorragia traumatica tardiva. In questo caso, le vittime sviluppano dolore radicolare, tensione muscolare riflessa nell'area di proiezione dell'ematoma e disturbi nella statica e nella dinamica della colonna vertebrale.
Nei casi di completa interruzione del midollo spinale, già nei primi giorni si riscontrano disturbi trofici (estese piaghe da decubito, forte gonfiore delle gambe). La presenza nel periodo acuto di almeno un riflesso con areflessia completa, la comparsa precoce del sintomo di Babinski e la conservazione della sensibilità nell'area perineale permettono di escludere una rottura completa del midollo spinale.
Ematomielia- emorragia nel midollo spinale.
Il quadro clinico è determinato dalla sede dell'emorragia. Molto spesso, la materia grigia del midollo spinale è colpita nell'area degli ingrandimenti cervicali e lombari. Nelle zone di innervazione dei segmenti colpiti, subito dopo la lesione, si determinano paresi flaccide e disturbi dissociati della sensibilità superficiale mentre si conserva la sensibilità profonda. Con massicce emorragie, la sostanza bianca del midollo spinale è coinvolta nel processo patologico, che si manifesta con disturbi della conduzione moderatamente pronunciati - paresi spastica, disturbi degli organi pelvici. L'esito della lesione dipende dal volume e dalla posizione dell'emorragia, ma la morte dei neuroni nella materia grigia del midollo spinale predetermina il recupero incompleto delle funzioni.
Hematorahis– emorragia nelle membrane del midollo spinale, si verifica con lesioni traumatiche alle vertebre.
Quadro clinico dell'emorragia subaracnoidea come nelle malattie vascolari del sistema nervoso centrale. I sintomi neurologici con ematoma epidurale si verificano dopo un breve intervallo "leggero" (diverse ore). Successivamente si verificano disturbi della conduzione sotto la lesione sotto forma di paresi, disturbi della sensibilità e delle funzioni degli organi pelvici. I sintomi clinici aumentano nel tempo. Nella posizione dell'ematoma, viene rilevato dolore quando si toccano i processi spinosi delle vertebre, la tensione riflessa dei muscoli paravertebrali e la fissazione patologica dei segmenti motori vicini.
Diagnostica: spondilografia, positiva e pneumomielografia, TC, RM. Puntura lombare.
Trattamento . Cure urgenti: - immobilizzazione della colonna vertebrale: la vittima viene posta su una tavola piana, che, se necessario, può essere sostituita con mezzi improvvisati (rami di alberi, assi, ecc.);
Trasportare solo in posizione supina;
Se c'è una ferita aperta, viene applicata una benda, vengono iniettati per via intramuscolare 1 milione di unità di sale sodico o potassico della benzilpenicillina;
Alle vittime con sindrome del dolore vengono prescritti analgesici (analgin, promedolo);
Il cateterismo vescicale è obbligatorio.
Cure qualificate: trattamento chirurgico primario della ferita. L'indicazione per un intervento chirurgico urgente è la compressione del midollo spinale da parte di una vertebra spostata, un ematoma o un corpo estraneo.
Trattamento conservativo: enzimi, corticosteroidi; farmaci che impediscono la maturazione del tessuto connettivo: pirogenico, lidasi, ribonucleasi, vitreo, aloe. Immunomodulatori (pentossilo, metiluracile, 6-mercaptopurina, metotrexato) e stimolatori della sintesi degli acidi nucleici e proteici (vitamine del gruppo B, acido folico e orotico, alfa-tocoferolo, Keltican).
Per commozioni cerebrali e contusioni vengono utilizzati trental, agapurin e cavinton.
Fin dai primi giorni viene attribuita grande importanza alla prevenzione dello sviluppo di piaghe da decubito, urosepsi e polmonite.
La paresi intestinale viene trattata con lassativi, clisteri a sifone, farmaci anticolinesterasici (prozerina, galantamina).
Stimolazione elettrica della vescica e dell'intestino.
Per prevenire la polmonite vengono prescritti esercizi di respirazione (gonfiaggio di palloncini, esercizi con respirazione forzata), terapia fisica - un elemento importante della quale è dare al corpo una posizione verticale, che aumenta l'escursione del torace, normalizza il funzionamento del cuore e dell'intestino . L'allenamento intensivo è di grande importanza nelle fasi iniziali dello sviluppo della malattia, ma non perde la sua rilevanza nel periodo tardivo delle lesioni del midollo spinale.
Per la correzione dei disturbi del movimento sono importanti le procedure fisioterapeutiche, i massaggi e la stimolazione elettrica del midollo spinale e delle sue radici.
Domande di controllo:
1.Qual è la patogenesi di un tumore al cervello?
2. Elencare i sintomi focali caratteristici dei tumori dei lobi frontale, temporale, parietale e occipitale.
3. Dai un nome ai sintomi dell'ipertensione.
16.2. Lesioni alla colonna vertebrale e al midollo spinale. Chirurgia
Il danno al midollo spinale e alle sue radici è la complicanza più pericolosa della lesione spinale. Si osserva nel 10-15% di coloro che hanno subito una lesione spinale: il 30-50% delle vittime muore per complicazioni causate dalla lesione del midollo spinale. La maggior parte dei sopravvissuti diventa disabile con gravi disturbi del movimento, disfunzione degli organi pelvici e sindromi dolorose che persistono per molti anni, spesso per tutta la vita. Le lesioni alla colonna vertebrale e al midollo spinale sono suddivise in aprire, in cui l'integrità della pelle e dei tessuti molli sottostanti è compromessa, e Chiuso, in cui tali danni sono assenti. In tempo di pace, il trauma chiuso è il tipo predominante di lesione alla colonna vertebrale e al midollo spinale.
Vengono chiamate lesioni spinali accompagnate da danni al midollo spinale e alle sue radici complicato .
16.2.1. Lesioni chiuse della colonna vertebrale e del midollo spinale
Lesioni spinali. Le lesioni spinali chiuse si verificano sotto l'influenza di flessione, rotazione, estensione e compressione assiale. In alcuni casi è possibile una combinazione di questi effetti (ad esempio, con il cosiddetto colpo di frusta della colonna cervicale, quando alla flessione della colonna vertebrale segue la sua estensione).
Come risultato dell'influenza di queste forze meccaniche, sono possibili vari cambiamenti nella colonna vertebrale:
– distorsione e rottura dei legamenti;
– danni ai dischi intervertebrali;
– sublussazioni, lussazioni delle vertebre;
– fratture vertebrali;
– fratture-lussazioni.
Si distinguono i seguenti tipi di fratture vertebrali:
– fratture di corpi vertebrali (da compressione, scheggiate, esplosive);
– fratture del semianello posteriore;
– combinato con frattura simultanea dei corpi, degli archi, dei processi articolari e trasversali;
– fratture isolate dei processi trasversali e spinosi.
Lo stato di stabilità della colonna vertebrale è di particolare importanza. La sua instabilità è caratterizzata dalla mobilità patologica dei suoi singoli elementi. L’instabilità spinale può causare ulteriori gravi lesioni al midollo spinale e alle sue radici.
È più facile comprendere le cause dell’instabilità spinale se ci rivolgiamo al concetto di Denis, che individua 3 sistemi di sostegno (colonne) della colonna vertebrale: il complesso di sostegno anteriore (colonna) comprende il legamento longitudinale anteriore e il segmento anteriore del corpo vertebrale; la colonna centrale unisce il legamento longitudinale posteriore e il segmento posteriore del corpo vertebrale, e la colonna posteriore - i processi articolari, gli archi con i legamenti gialli e i processi spinosi con il loro apparato legamentoso. La violazione dell'integrità di due dei suddetti complessi di supporto (pilastri), di regola, porta all'instabilità della colonna vertebrale.
Lesioni del midollo spinale. Le cause che portano al danno del midollo spinale a causa di una lesione del midollo spinale sono molteplici. Possono essere lesioni al midollo spinale e alle sue radici causate da un frammento osseo, una vertebra lussata a seguito di una lussazione, un disco intervertebrale prolasso, un ematoma formatosi nel sito della frattura, ecc.
Un trauma può provocare la rottura della dura madre e una lesione diretta al midollo spinale a causa di un frammento osseo.
Similmente alla lesione cerebrale traumatica, la lesione traumatica del midollo spinale comprende commozione cerebrale, contusione e compressione. La forma più grave di danno locale al midollo spinale è la sua completa rottura anatomica con diastasi delle estremità nel sito del danno.
Patomorfologia. Nella patogenesi della lesione del midollo spinale, i disturbi circolatori che si verificano durante la lesione sono di grande importanza. Può trattarsi di ischemia di vaste aree del midollo spinale dovuta alla compressione o alla rottura delle arterie radicolari, l'arteria anteriore del midollo spinale. Sono possibili emorragie nella sostanza del midollo spinale stesso (ematomielia) o la formazione di ematomi meningei.
Una conseguenza comune e pericolosa della lesione del midollo spinale è il gonfiore. Un aumento del volume del midollo spinale a causa dell'edema può portare ad una maggiore compressione, disturbi circolatori secondari e si verifica un circolo vizioso di reazioni patologiche che possono portare a danni irreversibili in tutto il diametro del midollo spinale.
Oltre ai cambiamenti strutturali morfologici elencati. Si verificano anche gravi disturbi funzionali, che nella fase acuta della lesione possono portare alla completa cessazione dell'attività motoria e dell'attività riflessa, perdita di sensibilità - shock spinale.
I sintomi dello shock spinale possono persistere per settimane o addirittura mesi.
Manifestazioni cliniche del danno del midollo spinale nel trauma spinale. I sintomi clinici di una frattura spinale complicata sono determinati da una serie di ragioni, principalmente dal livello e dall'entità del danno al midollo spinale.
Esistono sindromi di lesioni trasversali del midollo spinale complete e parziali.
A sindrome del midollo spinale trasverso completo a partire dal livello della lesione, sono assenti tutti i movimenti volontari, si osserva paralisi flaccida, non sono evocati riflessi tendinei e cutanei, sono assenti tutti i tipi di sensibilità, è perso il controllo sulle funzioni degli organi pelvici (minzione involontaria, disturbi della defecazione , priapismo), l'innervazione autonomica soffre (sudorazione, regolazione della temperatura sono compromesse). Nel corso del tempo, la paralisi muscolare flaccida può essere sostituita da spasticità, iperreflessia e spesso si formano automatismi nelle funzioni degli organi pelvici.
Le caratteristiche delle manifestazioni cliniche della lesione del midollo spinale dipendono dal livello del danno. Se la parte cervicale superiore del midollo spinale è danneggiata (CI-IV a livello delle vertebre cervicali I-IV), si sviluppa tetraparesi o tetraplegia spastica con la perdita di tutti i tipi di sensibilità dal livello corrispondente. Se vi è un danno concomitante al tronco cerebrale, compaiono disturbi bulbari (disfagia, afonia, disturbi respiratori e cardiovascolari).
Il danno all'allargamento cervicale del midollo spinale (CV – ThI – a livello delle vertebre cervicali V-VII) porta alla paraparesi periferica degli arti superiori e alla paraplegia spastica degli arti inferiori. I disturbi della conduzione di tutti i tipi di sensibilità si verificano al di sotto del livello della lesione. Potrebbe esserci dolore radicolare alle braccia. Il danno al centro ciliospinale provoca la comparsa del sintomo di Bernard-Horner, una diminuzione della pressione sanguigna e un polso rallentato.
La lesione della parte toracica del midollo spinale (ThII-XII a livello delle vertebre toraciche I-IX) porta a paraplegia spastica inferiore con assenza di tutti i tipi di sensibilità, perdita dei riflessi addominali: superiore (ThVII - ThVIII), medio (ThIX - ThX) e inferiore (ThXI - ТhXII).
Se l'ispessimento lombare (LI-SII a livello delle vertebre toraciche X-CP e I lombari) è danneggiato, si verifica la paralisi periferica degli arti inferiori, si verifica l'anestesia del perineo e delle gambe verso il basso dal legamento inguinale (pupart) e il riflesso cremasterico cade.
In caso di lesione del midollo spinale del cono (SIII-V a livello delle I-II vertebre lombari), si effettua un'anestesia “a sella” nella zona perineale.
Il danno alla cauda equina è caratterizzato da paralisi periferica degli arti inferiori, anestesia di tutti i tipi nel perineo e nelle gambe e dolore radicolare acuto in essi.
Le lesioni del midollo spinale a tutti i livelli sono accompagnate da disturbi della minzione, della defecazione e della funzione sessuale. Con un danno trasversale al midollo spinale nelle parti cervicale e toracica, si verifica una disfunzione degli organi pelvici, come la sindrome della "vescica neurogena iperriflesso". Inizialmente dopo l'infortunio si verifica la ritenzione urinaria, che può durare per un periodo molto lungo (mesi). La sensibilità della vescica è persa. Poi, quando l'apparato segmentale del midollo spinale si disinibisce, la ritenzione urinaria viene sostituita dall'automaticità spinale della minzione. Con una vescica iperriflessiva, la minzione involontaria si verifica quando vi è un leggero accumulo di urina al suo interno. Quando il cono del midollo spinale e le radici della cauda equina vengono danneggiati, l'apparato segmentale del midollo spinale soffre e si sviluppa la sindrome della “vescica neurogena iporeflessiva”. È caratterizzata da ritenzione urinaria con sintomi di ischuria paradossa. I disturbi della defecazione sotto forma di ritenzione di feci o incontinenza fecale si sviluppano solitamente parallelamente ai disturbi della minzione.
Il danno al midollo spinale in qualsiasi parte è accompagnato da piaghe da decubito che si verificano in aree con innervazione compromessa, dove si trovano protuberanze ossee sotto i tessuti molli (sacro, creste iliache, talloni). Le piaghe da decubito si sviluppano particolarmente precocemente e rapidamente con gravi danni (trasversali) al midollo spinale a livello delle regioni cervicale e toracica. Le piaghe da decubito si infettano rapidamente e causano lo sviluppo della sepsi.
Quando si determina l'entità del danno al midollo spinale, è necessario tenere conto della posizione relativa delle vertebre e dei segmenti spinali. È più facile confrontare la posizione dei segmenti del midollo spinale con i processi spinosi delle vertebre (ad eccezione della regione toracica inferiore). Per determinare il segmento, aggiungere 2 al numero vertebrale (così, a livello del processo spinoso della terza vertebra toracica si troverà il quinto segmento toracico).
Questo schema scompare nelle regioni toracica inferiore e lombare superiore, dove a livello ThXI-XII – LI sono presenti 11 segmenti del midollo spinale (5 lombari, 5 sacrali e 1 coccigeo).
Esistono diverse sindromi di danno parziale del midollo spinale.
Sindrome del mezzo midollo spinale(Sindrome di Brown-Séquard) - paralisi degli arti e compromissione della sensibilità profonda sul lato affetto con perdita del dolore e della sensibilità alla temperatura sul lato opposto. Va sottolineato che questa sindrome è rara nella sua forma “pura” e di solito vengono identificati i suoi singoli elementi;
Sindrome spinale anteriore– paraplegia bilaterale associata a diminuzione del dolore e della sensibilità alla temperatura. La ragione per lo sviluppo di questa sindrome è una violazione del flusso sanguigno nell'arteria spinale anteriore, danneggiata da un frammento osseo o da un disco prolassato.
Sindrome del midollo spinale centrale(più spesso si verifica con una forte iperestensione della colonna vertebrale). È caratterizzata principalmente da paresi delle braccia, debolezza meno pronunciata alle gambe, disturbi della sensibilità di vario grado al di sotto del livello della lesione e ritenzione urinaria.
In alcuni casi, principalmente con traumi accompagnati da forte flessione della colonna vertebrale, sindrome del midollo dorsale– perdita di sensibilità profonde.
Il danno al midollo spinale (soprattutto quando il suo diametro è completamente danneggiato) è caratterizzato da disturbi nella regolazione delle funzioni di vari organi interni: disturbi respiratori con danno cervicale, paresi intestinale, disfunzione degli organi pelvici, disturbi trofici con rapido sviluppo di piaghe da decubito.
Nella fase acuta della lesione si osservano spesso disturbi dell'attività cardiovascolare e un calo della pressione sanguigna. In caso di frattura vertebrale, un esame esterno del paziente e l'identificazione di cambiamenti come danno concomitante dei tessuti molli, tensione muscolare riflessa, dolore acuto quando si preme sulle vertebre e, infine, deformazione esterna della colonna vertebrale (ad esempio, cifosi con una frattura da compressione nella regione toracica) può avere una certa importanza per riconoscerla).
Commozione cerebrale. È caratterizzata da danni al midollo spinale di tipo funzionale in assenza di evidenti danni strutturali. Macro e microscopicamente vengono solitamente rilevati gonfiore della sostanza del cervello e delle sue membrane ed emorragie a punto singolo. Le manifestazioni cliniche sono causate da cambiamenti neurodinamici e disturbi transitori dell'emo e della liquorodinamica. Si osservano paresi a breve termine, lievemente espresse, parestesie, disturbi sensoriali e disfunzione degli organi pelvici. Il liquido cerebrospinale non viene modificato, la pervietà dello spazio subaracnoideo non viene compromessa. Le commozioni cerebrali del midollo spinale sono rare. Una lesione molto più comune e grave è la contusione del midollo spinale.
Contusione del midollo spinale. Il tipo più comune di lesione nelle lesioni del midollo spinale chiuse e non penetranti. Un livido si verifica quando una vertebra viene fratturata con il suo spostamento, prolasso del disco intervertebrale o sublussazione vertebrale. Con una contusione del midollo spinale si verificano sempre cambiamenti strutturali nella sostanza del cervello, delle radici, delle membrane e dei vasi (necrosi focale, rammollimento, emorragie). Il danno al tessuto cerebrale è accompagnato da shock spinale. La natura dei disturbi motori e sensoriali è determinata dalla posizione e dall'entità della lesione. Come risultato di una contusione del midollo spinale si sviluppano paralisi, disturbi della sensibilità, delle funzioni degli organi pelvici e delle funzioni autonomiche. Il trauma spesso porta alla comparsa non di una, ma di diverse aree di lesione. I fenomeni circolatori secondari possono causare lo sviluppo di focolai di mielomalacia diverse ore o addirittura giorni dopo l'infortunio. Le contusioni del midollo spinale sono spesso accompagnate da emorragia subaracnoidea. In questo caso, viene rilevata una miscela di sangue nel liquido cerebrospinale. La pervietà dello spazio subaracnoideo solitamente non è compromessa.
A seconda della gravità della lesione, il ripristino delle funzioni compromesse avviene entro 3-8 settimane. Tuttavia, con gravi contusioni con rottura anatomica completa del midollo spinale, le funzioni perdute non vengono ripristinate.
Compressione del midollo spinale. Si verifica quando una vertebra si frattura con mescolamento di frammenti o quando si verifica una lussazione o un'ernia di un disco intervertebrale. Il quadro clinico della compressione del midollo spinale può verificarsi immediatamente dopo la lesione o essere dinamico (aumentando con i movimenti della colonna vertebrale) se è instabile e sono presenti frammenti ossei in movimento.
C'è un cosiddetto lesione da iperestensione del rachide cervicale(colpo di frusta), che si verifica in incidenti stradali, tuffi, cadute dall'alto. Il meccanismo di questa lesione del midollo spinale è una forte iperestensione del collo, che supera le capacità anatomiche e funzionali di questa sezione e porta ad un forte restringimento del canale spinale con lo sviluppo di ischemia o compressione del midollo spinale. Clinicamente, la lesione da iperestensione si manifesta con sindromi da lesione del midollo spinale di varia gravità: disfunzione radicolare, parziale del midollo spinale, lesione trasversale completa, sindrome dell'arteria spinale anteriore.
Emorragia nel midollo spinale. Molto spesso, l'emorragia si verifica quando i vasi sanguigni si rompono nell'area del canale centrale e delle corna posteriori a livello degli ispessimenti lombari e cervicali. Le manifestazioni cliniche dell'ematomielia sono causate dalla compressione delle corna posteriori del midollo spinale mediante versamento di sangue, che si diffonde in 3-4 segmenti. In conformità con ciò, si verificano acutamente disturbi segmentali dissociati della sensibilità (temperatura e dolore), localizzati sul corpo sotto forma di giacca o mezza giacca. Quando il sangue si diffonde nell'area delle corna anteriori, viene rilevata la paresi flaccida periferica con atrofia. Quando sono colpite le corna laterali si osservano disturbi vegetativo-trofici. Molto spesso, nel periodo acuto, si osservano non solo disturbi segmentali, ma anche disturbi della sensibilità di conduzione, sintomi piramidali dovuti alla pressione sulle corde laterali del midollo spinale. Con estese emorragie si sviluppa un quadro di lesione trasversale completa del midollo spinale. Il liquido cerebrospinale può contenere sangue.
L'ematomielia è caratterizzata da un decorso regressivo. I sintomi neurologici iniziano a diminuire dopo 7-10 giorni. Il recupero delle funzioni compromesse può essere completo, ma più spesso permangono disturbi neurologici.
Emorragia negli spazi che circondano il midollo spinale. Può essere epidurale o subaracnoideo. Come risultato delle emorragie epidurali (dai plessi venosi), si forma un ematoma epidurale che comprime gradualmente il midollo spinale. Gli ematomi epidurali sono rari.
Manifestazioni cliniche. Gli ematomi epidurali sono caratterizzati da un periodo asintomatico dopo l'infortunio. Alcune ore dopo, si verifica dolore radicolare con irradiazione variabile a seconda della posizione dell'ematoma. Quindi compaiono i sintomi della compressione trasversale del midollo spinale e iniziano ad aumentare.
Il quadro clinico dell'emorragia intratecale (subaracnoidea) nella lesione del midollo spinale è caratterizzato dallo sviluppo acuto di sintomi di irritazione delle membrane e delle radici spinali. Compaiono intensi dolori alla schiena e agli arti, rigidità dei muscoli del collo e i sintomi di Kernig e Brudzinski. Molto spesso questi sintomi sono accompagnati da paresi degli arti, disturbi della conduzione della sensibilità e disturbi pelvici dovuti a danno o compressione del midollo spinale a causa del sangue che sgorga. La diagnosi di emorragia viene verificata mediante puntura lombare: il liquido cerebrospinale è intensamente colorato di sangue o xantocromico. Il decorso dell'emorragia è regressivo e spesso si verifica un recupero completo. Tuttavia, l'emorragia nella zona della cauda equina può essere complicata dallo sviluppo di aracnoidite adesiva o cistica.
Diagnostica. I metodi di esame a raggi X, inclusa la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica, sono fondamentali per determinare la natura della lesione alla colonna vertebrale e al midollo spinale e scegliere un metodo di trattamento adeguato. Questi studi devono essere eseguiti con una certa cautela per non causare ulteriori lesioni al midollo spinale.
Se si sospetta una frattura della 1a e della 2a vertebra, vengono scattate fotografie con una posizione speciale del paziente - fotografie attraverso la bocca.
Per identificare l’instabilità spinale, viene scattata una serie di immagini con flessione ed estensione graduale (5-10°), che consente di identificare i primi segni di instabilità e di non causare un peggioramento delle condizioni del paziente.
La tomografia computerizzata, eseguita specificamente a livello della sospetta lesione, fornisce informazioni più complete sui danni alle strutture ossee, ai dischi intervertebrali e sullo stato del midollo spinale e delle sue radici.
In alcuni casi viene utilizzata la mielografia con contrasto idrosolubile, che consente di chiarire la natura del danno al midollo spinale e alle sue radici e determinare la presenza di un blocco nello spazio subaracnoideo. Nella fase acuta della lesione, questo studio deve essere eseguito con grande cautela, poiché l'introduzione del contrasto può aumentare la compressione del midollo spinale nell'area del blocco.
In questi casi è preferibile utilizzare la risonanza magnetica, che fornisce le informazioni più complete sullo stato del midollo spinale e delle strutture spinali.
Trattamento. Tutte le vittime che hanno subito traumi gravi devono essere trattate come se soffrissero di possibili danni al midollo spinale e alla colonna vertebrale, soprattutto in caso di disturbi della coscienza. se sono presenti segni di difficoltà respiratoria o sintomi caratteristici di danno spinale (paresi degli arti, disturbi sensoriali, priapismo, deformità della colonna vertebrale, ecc.).
Pronto soccorso sul posto consiste principalmente nell'immobilizzare la colonna vertebrale: un collare cervicale, uno scudo. È necessaria particolare attenzione durante lo spostamento e il trasporto del paziente.
In caso di lesioni gravi, viene eseguita una serie di misure di terapia intensiva volte a mantenere la pressione sanguigna e normalizzare la respirazione (se necessario, ventilazione artificiale).
I pazienti con danni alla colonna vertebrale e al midollo spinale dovrebbero, se possibile, essere ricoverati in ospedali specializzati.
In ospedale continua la terapia intensiva anti-shock. Fino a quando non viene chiarita la natura della lesione e selezionato un metodo di trattamento adeguato, l'immobilizzazione viene mantenuta.
La varietà dei meccanismi fisiopatologici e delle manifestazioni cliniche della lesione del midollo spinale determina l'approccio da adottare terapia farmacologica, che dipende dalla natura e dal livello del danno.
Il periodo acuto può essere accompagnato (oltre ai sintomi di danno al midollo spinale) da reazioni di shock con calo della pressione sanguigna e compromissione della microcircolazione, che richiede una terapia anti-shock sotto il controllo del livello di elettroliti, emoglobina, ematocrito e sangue proteine.
Per prevenire cambiamenti secondari nel midollo spinale causati dallo sviluppo di edema e disturbi circolatori nel periodo acuto, alcuni autori ritengono giustificato l'uso di grandi dosi di ormoni glucocorticoidi (desametasone, metilprednisolone).
Il danno al midollo spinale a livello dei segmenti ThII – ThVII può causare aritmia cardiaca, diminuzione della capacità funzionale del miocardio e alterazioni dell’ECG. In questi casi è indicata la somministrazione di glicosidi cardiaci.
Per migliorare la microcircolazione, prevenire la trombosi e ridurre la permeabilità vascolare, vengono prescritti angioprotettori, anticoagulanti e vasodilatatori.
Per i disturbi del metabolismo proteico, la cachessia e la scarsa guarigione delle ferite, è indicato l'uso di ormoni anabolizzanti. A tutte le vittime vengono prescritti nootropi, soprattutto nel periodo acuto della lesione.
La prevenzione e il trattamento delle complicanze infiammatorie vengono effettuati introducendo agenti antibatterici, tenendo conto della sensibilità della microflora.
Sia nei periodi acuti che in quelli successivi, ai pazienti devono essere prescritti farmaci sedativi, tranquillanti e antipsicotici.
Prevenzione delle complicanze. La disfunzione degli organi gassosi è una delle complicanze più comuni della lesione del midollo spinale.
Con una lesione trasversale completa del midollo spinale nel periodo acuto (in condizioni di sviluppo di shock spinale), si notano paralisi del detrusore, spasmo dello sfintere della vescica e assenza della sua attività riflessa. La conseguenza di ciò è la ritenzione urinaria (atonia e sovradistensione della vescica).
Per prevenzione della disfunzione degli organi pelvici Fin dalle prime ore di degenza ospedaliera, è necessario determinare chiaramente lo stato della minzione e stabilire un'adeguata escrezione di urina. Nelle prime settimane dopo l'infortunio è necessario inserire un catetere permanente. Successivamente, viene effettuato il cateterismo periodico 4 volte della vescica con risciacquo simultaneo con soluzioni asettiche. Le manipolazioni devono essere accompagnate dal rigoroso rispetto delle regole di asepsi e antisettici.
Quando i fenomeni di shock spinale passano, l'attività riflessa della vescica viene ripristinata: si svuota automaticamente quando è piena.
Disturbi urinari più gravi con assenza o soppressione della sua attività riflessa e incontinenza urinaria possono essere osservati con danni ai centri spinali degli organi pelvici (ThXII - LI) o con danni alle radici della cauda equina. In questi casi, in presenza di una grande quantità di urina residua, è indicato il cateterismo periodico della vescica.
Uno dei compiti principali nel trattamento dei pazienti con lesioni del midollo spinale è lo sviluppo di meccanismi riflessi che garantiscano lo svuotamento automatico della vescica quando è piena. L’uso della stimolazione elettrica della vescica può aiutare a raggiungere questo obiettivo.
Il disturbo della defecazione, che si sviluppa sempre con una lesione del midollo spinale, può causare febbricola e intossicazione. Per ripristinare la funzione rettale, si consiglia di prescrivere una dieta, vari lassativi, supposte e in alcuni casi un clistere purificante.
Per la riabilitazione tempestiva ed efficace dei pazienti, la prevenzione delle piaghe da decubito nella zona del sacro, delle tuberosità ischiatiche, dei grandi trocanteri del femore e dei talloni è della massima importanza. È necessario scegliere una posizione razionale per il paziente, utilizzando la posizione sullo stomaco e sui fianchi. Condizioni indispensabili sono la manutenzione igienica del letto, la rotazione delicata (ogni 2 ore), la pulizia della pelle con alcool etilico, canfora o salicilico. I materassi speciali sono efficaci. fornendo una ridistribuzione automatica della pressione sulla superficie del corpo. Sono consigliabili diversi cuscinetti per garantire una posizione fisiologica o necessaria al busto e agli arti in un caso particolare.
Per prevenzione delle contratture degli arti Di grande importanza sono l'ossificazione paraarticolare e paraossea, il corretto posizionamento degli arti, il massaggio e gli esercizi terapeutici.
Nei periodi acuti e precoci, soprattutto con lesioni del midollo spinale cervicale, diventa di grande importanza prevenzione delle complicanze infiammatorie polmonari. È necessario normalizzare le funzioni della respirazione esterna e aspirare le secrezioni dalle vie respiratorie. Sono utili le inalazioni aerosoliche di farmaci, la ginnastica attiva e passiva. In assenza di lesioni al torace e ai polmoni, si consigliano coppettazione e cerotti di senape. Vengono prescritti il vibromassaggio, l'irradiazione ultravioletta e la stimolazione elettrica del diaframma.
Per prevenire le piaghe da decubito, viene utilizzata l'irradiazione ultravioletta della parte bassa della schiena, dell'osso sacro, dei glutei e dei talloni in dosi suberitematiche.
In presenza di sindrome del dolore, vengono utilizzate correnti diadinamiche (DCT), correnti modulate sinusoidalmente (SMC), ozocerite o applicazioni di fango in combinazione con elettroforesi di farmaci analgesici, terapia fisica e massaggio.
Il trattamento dei pazienti con lesione del midollo spinale o delle sue conseguenze dovrebbe sempre essere completo. Condizioni importanti per aumentare l'efficacia del trattamento per questi pazienti sono un'adeguata riabilitazione e un trattamento sanatorio.
Trattamento per fratture vertebrali complicate. Gli obiettivi principali che vengono perseguiti quando si presta assistenza ai pazienti con una frattura spinale complicata sono l'eliminazione della compressione del midollo spinale e delle sue radici e la stabilizzazione della colonna vertebrale.
A seconda della natura della lesione, questo obiettivo può essere raggiunto in diversi modi:
Metodo chirurgico;
Mediante immobilizzazione esterna e riposizionamento della colonna vertebrale (trazioni, collari cervicali, corsetti, dispositivi di fissaggio speciali).
Immobilizzazione spinale. Previene la possibile dislocazione delle vertebre e ulteriori danni al midollo spinale; crea le condizioni per eliminare la deformazione spinale esistente e la guarigione dei tessuti danneggiati in una posizione vicina alla normalità.
Uno dei principali metodi per immobilizzare la colonna vertebrale ed eliminarne la deformazione è la trazione, che è più efficace in caso di traumi cervicali.
La trazione viene effettuata utilizzando uno speciale dispositivo costituito da una staffa fissata al cranio e da un sistema di blocchi che effettuano la trazione.
Il morsetto Crutchfield viene fissato alle tuberosità parietali mediante due viti a punta tagliente. La trazione mediante pesi viene effettuata lungo l'asse della colonna vertebrale. La trazione inizia solitamente con un carico piccolo (3–4 kg) e aumenta gradualmente fino a 8–12 kg (in alcuni casi di più). I cambiamenti nella deformazione spinale sotto l'influenza della trazione vengono monitorati utilizzando ripetuti raggi X.
Se la colonna cervicale è danneggiata, l'immobilizzazione della colonna vertebrale può essere effettuata utilizzando un dispositivo speciale costituito da uno speciale corsetto a giubbotto, un cerchio metallico fissato rigidamente alla testa del paziente e aste che collegano il cerchio al giubbotto (alone veste). Nei casi in cui non è richiesta l'immobilizzazione completa per lesioni al rachide cervicale, vengono utilizzati collari morbidi e rigidi. Corsetti dal design speciale vengono utilizzati anche per le fratture della colonna vertebrale toracica e lombare.
Quando si utilizzano metodi di immobilizzazione esterna (trazione, corsetti), è necessario molto tempo (mesi) per eliminare la deformità della colonna vertebrale e guarire le strutture danneggiate nella posizione richiesta.
In molti casi questo metodo di trattamento è inaccettabile, soprattutto quando è necessario alleviare immediatamente la compressione del midollo spinale. In una situazione del genere, è necessario un intervento chirurgico.
Lo scopo dell'operazione è eliminare la compressione del midollo spinale, correggere la deformità della colonna vertebrale e stabilizzarla in modo affidabile.
Chirurgia. Si utilizzano vari tipi di interventi: con avvicinamento al midollo spinale da dietro tramite laminectomia, laterale o frontale con resezione dei corpi vertebrali. Per stabilizzare la colonna vertebrale vengono utilizzate una varietà di placche metalliche, viti ossee e fili. I frammenti vertebrali resecati vengono sostituiti con frammenti ossei prelevati dall'ileo o dalla tibia del paziente, speciali protesi metalliche e ceramiche e ossa prelevate da un cadavere.
Indicazioni per la chirurgia per lesioni della colonna vertebrale e del midollo spinale.
Nel determinare le indicazioni chirurgiche è necessario tenere conto del fatto che le lesioni più pericolose del midollo spinale si verificano immediatamente al momento della lesione e molte di queste lesioni sono irreversibili. Quindi, se la vittima subito dopo l'infortunio ha un quadro clinico di una lesione trasversale completa del midollo spinale, allora non c'è praticamente alcuna speranza per un'operazione urgente che possa cambiare la situazione. A questo proposito, molti chirurghi ritengono che l'intervento chirurgico in questi casi sia ingiustificato.
Un'eccezione può essere la presenza di sintomi di una completa interruzione delle radici del midollo spinale. Nonostante la gravità del danno, in questi casi l'intervento chirurgico è giustificato principalmente dal fatto che è possibile ripristinare la conduzione lungo le radici danneggiate e, in caso di rottura, cosa rara, si può ottenere un risultato positivo mediante sutura microchirurgica delle radici estremità delle radici danneggiate.
Se sono presenti anche i più lievi segni di conservazione di alcune funzioni del midollo spinale (leggero movimento delle dita, capacità di determinare un cambiamento nella posizione di un arto, percezione di forti stimoli dolorifici) e allo stesso tempo vi sono segni di compressione del midollo spinale (presenza di un blocco, spostamento delle vertebre, frammenti ossei nel canale spinale, ecc.), allora è indicato l'intervento.
Nel periodo tardivo della lesione, l'intervento chirurgico è giustificato se la compressione del midollo spinale persiste e i sintomi del danno progrediscono.
L'intervento è indicato anche in caso di grave deformazione e instabilità della colonna vertebrale, anche in caso di lesione trasversale completa del midollo spinale. Lo scopo dell'operazione in questo caso è normalizzare la funzione di supporto della colonna vertebrale, che è una condizione importante per una riabilitazione più efficace del paziente.
La scelta del metodo di trattamento più adeguato - trazione, fissazione esterna, chirurgia, una combinazione di questi metodi è in gran parte determinata dalla posizione e dalla natura della lesione.
A questo proposito, è consigliabile considerare separatamente i tipi più tipici di lesioni alla colonna vertebrale e al midollo spinale.
Lesione della colonna vertebrale cervicale. La colonna cervicale è la più suscettibile ai danni e la più vulnerabile. Circa il 40-60% di tutte le lesioni spinali si verificano nella regione cervicale e sono particolarmente comuni nei bambini, il che può essere spiegato dalla debolezza dei muscoli del collo, dalla significativa estensibilità dei legamenti e dalle grandi dimensioni della testa;
Va notato che il trauma alle vertebre cervicali è più spesso accompagnato da danni al midollo spinale rispetto ad altre parti della colonna vertebrale (40-60% dei casi).
Il danno alla colonna cervicale porta alle complicazioni più gravi e, più spesso che alle lesioni ad altre parti della colonna vertebrale, alla morte del paziente: 25-40% delle vittime con lesioni localizzate a livello delle tre vertebre cervicali superiori morire sul luogo dell'incidente.
La struttura unica e il significato funzionale della 1a e della 2a vertebra cervicale rendono necessario considerare separatamente il loro danno. La prima vertebra cervicale (atlante) può essere danneggiata da sola o insieme alla seconda vertebra (40% dei casi). Molto spesso, a seguito di un infortunio, l'anello dell'Atlante si rompe nelle sue diverse parti. Quando la seconda vertebra cervicale è danneggiata (epistrofia), di solito si verifica una frattura e uno spostamento del processo odontoideo. Negli impiccati si osserva una peculiare frattura della seconda vertebra a livello dei processi articolari (“frattura del boia”).
Le vertebre CV‑ThI rappresentano oltre il 70% delle lesioni: fratture e lussazioni con concomitante danno grave, spesso irreversibile, al midollo spinale.
Per le fratture della prima vertebra cervicale, viene solitamente utilizzata con successo la trazione mediante stabilizzazione esterna rigida con halo vest seguita dall'uso di collari cervicali. Per le fratture combinate della 1a e 2a vertebra cervicale, oltre a queste metodiche, viene utilizzata la stabilizzazione chirurgica delle vertebre, che può essere ottenuta stringendo gli archi e i processi spinosi delle prime tre vertebre con filo o fissandoli con viti nella parte zona dei processi articolari.
In alcuni casi, per eliminare la compressione del midollo spinale e del midollo allungato da parte di un dente rotto della seconda vertebra cervicale, è possibile utilizzare l'accesso anteriore attraverso la cavità orale.
La fissazione chirurgica è indicata per fratture-lussazioni delle vertebre CIII-ThI. A seconda delle caratteristiche della lesione, può essere eseguito tramite un approccio posteriore con fissazione delle vertebre tramite filo o altre strutture metalliche in corrispondenza degli archi e dei processi spinosi. In caso di compressione anteriore del midollo spinale da parte di frammenti di una vertebra schiacciata, prolasso del disco o ematoma, è consigliabile utilizzare un approccio anteriore con resezione dei corpi vertebrali interessati e stabilizzazione della colonna vertebrale mediante innesto osseo. La tecnica chirurgica è simile a quella utilizzata per il prolasso dei dischi cervicali mediani.
Trauma alla colonna vertebrale toracica e lombare. Con lesioni alla colonna vertebrale toracica e lombare, spesso si verificano fratture da compressione con la formazione di un cuneo urbano. Più spesso, queste fratture non sono accompagnate da instabilità spinale e non richiedono un intervento chirurgico.
Con le fratture comminute è possibile la compressione del midollo spinale e delle sue radici. In questo caso possono sorgere indicazioni per un intervento chirurgico. Possono essere necessari approcci laterali e anterolaterali complessi, compresi gli approcci transpleurici, per alleviare la compressione e stabilizzare la colonna vertebrale.
Trattamento di pazienti con conseguenze di lesioni del midollo spinale. Una delle conseguenze più comuni delle lesioni del midollo spinale è un forte aumento del tono dei muscoli delle gambe e del busto, che spesso complica il trattamento riabilitativo.
Per eliminare la spasticità muscolare quando il trattamento farmacologico è inefficace, in alcuni casi è necessario eseguire un intervento chirurgico sul midollo spinale (mielotomia), il cui scopo è quello di separare le corna anteriori e posteriori del midollo spinale a livello dei segmenti LI - SI (mielotomia secondo Bischof, Rothballer, ecc.).
In caso di sindromi dolorose persistenti, che più spesso si manifestano con danno alle radici e sviluppo di aderenze, possono sorgere indicazioni all'intervento chirurgico sulle vie di afferenza del dolore.
Quando compaiono piaghe da decubito, il tessuto morto viene asportato e vengono utilizzati farmaci per favorire una rapida pulizia e guarigione della ferita (solcoseryl). L'irradiazione locale ultravioletta o laser è efficace.
Capacità lavorativa. La prognosi clinica e professionale dipende dal livello e dall'entità del danno al midollo spinale. Pertanto, tutti i pazienti sopravvissuti con una rottura anatomica completa del midollo spinale a qualsiasi livello appartengono al gruppo di disabili I, ma a volte possono lavorare in condizioni create individualmente. In caso di commozione cerebrale del midollo spinale, gli operatori mentali ricevono un'invalidità temporanea per 3-4 settimane. Le persone impegnate in lavori manuali necessitano di un periodo di esenzione dal lavoro per almeno 5-8 settimane, seguito da un periodo di esenzione dal sollevamento di carichi pesanti per un massimo di 3 mesi. Quest'ultimo è dovuto al fatto che la lesione del midollo spinale si verifica nella maggior parte dei casi quando le vertebre vengono spostate e ciò implica una rottura o uno stiramento dell'apparato legamentoso.
In caso di lieve contusione del midollo spinale, il congedo per malattia viene prolungato fino al ripristino della funzione, meno spesso è consigliabile che il paziente venga trasferito al gruppo di disabilità III;
In caso di lesione moderata, è auspicabile estendere l'invalidità temporanea e quindi trasferirla al gruppo di disabilità III, ma non al II, poiché ciò non stimolerà la riabilitazione clinica e lavorativa del paziente.
In caso di gravi contusioni, compressione ed ematomielia, necrosi ischemica del midollo spinale, è più razionale trasferire i pazienti alla disabilità e continuare il trattamento e la riabilitazione con successivo riesame tenendo conto del deficit neurologico.
Di particolare importanza sono i problemi della riabilitazione medica e sociale. Compito del medico è insegnare al paziente a sfruttare al massimo le capacità motorie rimanenti per compensare i difetti che si sono sviluppati dopo l’infortunio. Ad esempio, è possibile utilizzare un sistema per allenare i muscoli del tronco e del cingolo scapolare in pazienti con paraparesi inferiore. Molti pazienti necessitano della supervisione di psicologi che li aiutino a trovare nuovi stimoli nella vita. Un compito difficile è riportare i pazienti al lavoro: questo di solito richiede la riqualificazione dei pazienti, la creazione di condizioni speciali per loro e il sostegno alla società.
16.2. Lesioni alla colonna vertebrale e al midollo spinale. Chirurgia16.2.2. Lesioni aperte alla colonna vertebrale e al midollo spinale
16.2.1. Lesioni chiuse della colonna vertebrale e del midollo spinale
Lesioni spinali. Le lesioni spinali chiuse si verificano sotto l'influenza di flessione, rotazione, estensione e compressione assiale. In alcuni casi è possibile una combinazione di questi effetti (ad esempio, con il cosiddetto colpo di frusta della colonna cervicale, quando alla flessione della colonna vertebrale segue la sua estensione).
Come risultato dell'influenza di queste forze meccaniche, sono possibili vari cambiamenti nella colonna vertebrale:
Distorsione e rottura dei legamenti;
Danni ai dischi intervertebrali;
Sublussazioni, lussazioni delle vertebre;
Fratture vertebrali;
Fratture-lussazioni.
Si distinguono i seguenti tipi di fratture vertebrali:
Fratture di corpi vertebrali (da compressione, sminuzzate, esplosive);
Fratture del semianello posteriore;
Combinato con frattura simultanea di corpi, archi, processi articolari e trasversali;
Fratture isolate dei processi trasversali e spinosi.
Lo stato di stabilità della colonna vertebrale è di particolare importanza. La sua instabilità è caratterizzata dalla mobilità patologica dei suoi singoli elementi. L’instabilità spinale può causare ulteriori gravi lesioni al midollo spinale e alle sue radici.
È più facile comprendere le cause dell’instabilità spinale se ci rivolgiamo al concetto di Denis, che individua 3 sistemi di sostegno (colonne) della colonna vertebrale: il complesso di sostegno anteriore (colonna) comprende il legamento longitudinale anteriore e il segmento anteriore del corpo vertebrale; la colonna centrale unisce il legamento longitudinale posteriore e il segmento posteriore del corpo vertebrale, e la colonna posteriore - i processi articolari, gli archi con i legamenti gialli e i processi spinosi con il loro apparato legamentoso. La violazione dell'integrità di due dei suddetti complessi di supporto (pilastri), di regola, porta all'instabilità della colonna vertebrale.
Lesioni del midollo spinale. Le cause che portano al danno del midollo spinale a causa di una lesione del midollo spinale sono molteplici. Possono essere lesioni al midollo spinale e alle sue radici causate da un frammento osseo, una vertebra lussata a seguito di una lussazione, un disco intervertebrale prolasso, un ematoma formatosi nel sito della frattura, ecc.
Un trauma può provocare la rottura della dura madre e una lesione diretta al midollo spinale a causa di un frammento osseo.
Similmente alla lesione cerebrale traumatica, la lesione traumatica del midollo spinale comprende commozione cerebrale, contusione e compressione. La forma più grave di danno locale al midollo spinale è la sua completa rottura anatomica con diastasi delle estremità nel sito del danno.
Patomorfologia. Nella patogenesi della lesione del midollo spinale, i disturbi circolatori che si verificano durante la lesione sono di grande importanza. Può trattarsi di ischemia di vaste aree del midollo spinale dovuta alla compressione o alla rottura delle arterie radicolari, l'arteria anteriore del midollo spinale. Sono possibili emorragie nella sostanza del midollo spinale stesso (ematomielia) o la formazione di ematomi meningei.
Una conseguenza comune e pericolosa della lesione del midollo spinale è il gonfiore. Un aumento del volume del midollo spinale a causa dell'edema può portare ad una maggiore compressione, disturbi circolatori secondari e si verifica un circolo vizioso di reazioni patologiche che possono portare a danni irreversibili in tutto il diametro del midollo spinale.
Oltre ai cambiamenti strutturali morfologici elencati. Si verificano anche gravi disturbi funzionali, che nella fase acuta della lesione possono portare alla completa cessazione dell'attività motoria e dell'attività riflessa, perdita di sensibilità - shock spinale.
I sintomi dello shock spinale possono persistere per settimane o addirittura mesi.
Manifestazioni cliniche del danno del midollo spinale nel trauma spinale. I sintomi clinici di una frattura spinale complicata sono determinati da una serie di ragioni, principalmente dal livello e dall'entità del danno al midollo spinale.
Esistono sindromi di lesioni trasversali del midollo spinale complete e parziali.
A sindrome del midollo spinale trasverso completo a partire dal livello della lesione, sono assenti tutti i movimenti volontari, si osserva paralisi flaccida, non sono evocati riflessi tendinei e cutanei, sono assenti tutti i tipi di sensibilità, è perso il controllo sulle funzioni degli organi pelvici (minzione involontaria, disturbi della defecazione , priapismo), l'innervazione autonomica soffre (sudorazione, regolazione della temperatura sono compromesse). Nel corso del tempo, la paralisi muscolare flaccida può essere sostituita da spasticità, iperreflessia e spesso si formano automatismi nelle funzioni degli organi pelvici.
Le caratteristiche delle manifestazioni cliniche della lesione del midollo spinale dipendono dal livello del danno. Se la parte cervicale superiore del midollo spinale è danneggiata (CI-IV a livello delle vertebre cervicali I-IV), si sviluppa tetraparesi o tetraplegia spastica con la perdita di tutti i tipi di sensibilità dal livello corrispondente. Se vi è un danno concomitante al tronco cerebrale, compaiono disturbi bulbari (disfagia, afonia, disturbi respiratori e cardiovascolari).
Il danno all'ispessimento cervicale del midollo spinale (CV - ThI - a livello delle vertebre cervicali V-VII) porta alla paraparesi periferica degli arti superiori e alla paraplegia spastica di quelli inferiori. I disturbi della conduzione di tutti i tipi di sensibilità si verificano al di sotto del livello della lesione. Potrebbe esserci dolore radicolare alle braccia. Il danno al centro ciliospinale provoca la comparsa del sintomo di Bernard-Horner, diminuzione della pressione sanguigna e rallentamento del polso.
La lesione alla parte toracica del midollo spinale (ThII-XII a livello delle vertebre toraciche I-IX) porta a paraplegia spastica inferiore con assenza di tutti i tipi di sensibilità, perdita dei riflessi addominali: superiore (ThVII - ThVIII), medio (ThIX - ThX) e inferiore (ThXI - ТhXII).
Se l'ispessimento lombare (LI-SII a livello delle vertebre toraciche X-CP e I lombari) è danneggiato, si verifica la paralisi periferica degli arti inferiori, si verifica l'anestesia del perineo e delle gambe verso il basso dal legamento inguinale (pupart) e il riflesso cremasterico cade.
In caso di lesione del cono del midollo spinale (SIII-V a livello delle I-II vertebre lombari), si effettua un'anestesia “a sella” nella zona perineale.
Il danno alla cauda equina è caratterizzato da paralisi periferica degli arti inferiori, anestesia di tutti i tipi nel perineo e nelle gambe e dolore radicolare acuto in essi.
Le lesioni del midollo spinale a tutti i livelli sono accompagnate da disturbi della minzione, della defecazione e della funzione sessuale. Con un danno trasversale al midollo spinale nelle parti cervicale e toracica, si verifica una disfunzione degli organi pelvici, come la sindrome della "vescica neurogena iperriflesso". Inizialmente dopo l'infortunio si verifica la ritenzione urinaria, che può durare per un periodo molto lungo (mesi). La sensibilità della vescica è persa. Poi, quando l'apparato segmentale del midollo spinale si disinibisce, la ritenzione urinaria viene sostituita dall'automaticità spinale della minzione. Con una vescica iperriflessiva, la minzione involontaria si verifica quando vi è un leggero accumulo di urina al suo interno. Quando il cono del midollo spinale e le radici della cauda equina vengono danneggiati, l'apparato segmentale del midollo spinale soffre e si sviluppa la sindrome della “vescica neurogena iporeflessiva”. È caratterizzata da ritenzione urinaria con sintomi di ischuria paradossa. I disturbi della defecazione sotto forma di ritenzione di feci o incontinenza fecale si sviluppano solitamente parallelamente ai disturbi della minzione.
Il danno al midollo spinale in qualsiasi parte è accompagnato da piaghe da decubito che si verificano in aree con innervazione compromessa, dove si trovano protuberanze ossee sotto i tessuti molli (sacro, creste iliache, talloni). Le piaghe da decubito si sviluppano particolarmente precocemente e rapidamente con gravi danni (trasversali) al midollo spinale a livello delle regioni cervicale e toracica. Le piaghe da decubito si infettano rapidamente e causano lo sviluppo della sepsi.
Quando si determina l'entità del danno al midollo spinale, è necessario tenere conto della posizione relativa delle vertebre e dei segmenti spinali. È più facile confrontare la posizione dei segmenti del midollo spinale con i processi spinosi delle vertebre (ad eccezione della regione toracica inferiore). Per determinare il segmento, aggiungere 2 al numero vertebrale (così, a livello del processo spinoso della terza vertebra toracica si troverà il quinto segmento toracico).
Questo schema scompare nelle regioni toracica inferiore e lombare superiore, dove a livello di ThXI-XII - LI si trovano 11 segmenti del midollo spinale (5 lombari, 5 sacrali e 1 coccigeo).
Esistono diverse sindromi di danno parziale del midollo spinale.
Sindrome del mezzo midollo spinale(Sindrome di Brown-Séquard) - paralisi degli arti e compromissione della sensibilità profonda sul lato affetto con perdita del dolore e della sensibilità alla temperatura sul lato opposto. Va sottolineato che questa sindrome è rara nella sua forma “pura” e di solito vengono identificati i suoi singoli elementi;
Sindrome spinale anteriore- paraplegia bilaterale associata a diminuzione del dolore e della sensibilità alla temperatura. La ragione per lo sviluppo di questa sindrome è una violazione del flusso sanguigno nell'arteria spinale anteriore, danneggiata da un frammento osseo o da un disco prolassato.
Sindrome del midollo spinale centrale(più spesso si verifica con una forte iperestensione della colonna vertebrale). È caratterizzata principalmente da paresi delle braccia, debolezza meno pronunciata alle gambe, disturbi della sensibilità di vario grado al di sotto del livello della lesione e ritenzione urinaria.
In alcuni casi, principalmente con traumi accompagnati da forte flessione della colonna vertebrale, sindrome del midollo dorsale- perdita di sensibilità profonde.
Il danno al midollo spinale (soprattutto quando il suo diametro è completamente danneggiato) è caratterizzato da disturbi nella regolazione delle funzioni di vari organi interni: disturbi respiratori con danno cervicale, paresi intestinale, disfunzione degli organi pelvici, disturbi trofici con rapido sviluppo di piaghe da decubito.
Nella fase acuta della lesione si osservano spesso disturbi dell'attività cardiovascolare e un calo della pressione sanguigna. In caso di frattura vertebrale, un esame esterno del paziente e l'identificazione di cambiamenti come danno concomitante dei tessuti molli, tensione muscolare riflessa, dolore acuto quando si preme sulle vertebre e, infine, deformazione esterna della colonna vertebrale (ad esempio, cifosi con una frattura da compressione nella regione toracica) può avere una certa importanza per riconoscerla).
Commozione cerebrale. È caratterizzata da danni al midollo spinale di tipo funzionale in assenza di evidenti danni strutturali. Macro e microscopicamente vengono solitamente rilevati gonfiore della sostanza del cervello e delle sue membrane ed emorragie a punto singolo. Le manifestazioni cliniche sono causate da cambiamenti neurodinamici e disturbi transitori della dinamica del fluido emo e cerebrospinale. Si osservano paresi a breve termine, lievemente espresse, parestesie, disturbi sensoriali e disfunzione degli organi pelvici. Il liquido cerebrospinale non viene modificato, la pervietà dello spazio subaracnoideo non viene compromessa. Le commozioni cerebrali del midollo spinale sono rare. Una lesione molto più comune e grave è la contusione del midollo spinale.
Contusione del midollo spinale. Il tipo più comune di lesione nelle lesioni del midollo spinale chiuse e non penetranti. Un livido si verifica quando una vertebra viene fratturata con il suo spostamento, prolasso del disco intervertebrale o sublussazione vertebrale. Con una contusione del midollo spinale si verificano sempre cambiamenti strutturali nella sostanza del cervello, delle radici, delle membrane e dei vasi (necrosi focale, rammollimento, emorragie). Il danno al tessuto cerebrale è accompagnato da shock spinale. La natura dei disturbi motori e sensoriali è determinata dalla posizione e dall'entità della lesione. Come risultato di una contusione del midollo spinale si sviluppano paralisi, disturbi della sensibilità, delle funzioni degli organi pelvici e delle funzioni autonomiche. Il trauma spesso porta alla comparsa non di una, ma di diverse aree di lesione. I fenomeni circolatori secondari possono causare lo sviluppo di focolai di mielomalacia diverse ore o addirittura giorni dopo l'infortunio. Le contusioni del midollo spinale sono spesso accompagnate da emorragia subaracnoidea. In questo caso, viene rilevata una miscela di sangue nel liquido cerebrospinale. La pervietà dello spazio subaracnoideo solitamente non è compromessa.
A seconda della gravità della lesione, il ripristino delle funzioni compromesse avviene entro 3-8 settimane. Tuttavia, con gravi contusioni con rottura anatomica completa del midollo spinale, le funzioni perdute non vengono ripristinate.
Compressione del midollo spinale. Si verifica quando una vertebra si frattura con mescolamento di frammenti o quando si verifica una lussazione o un'ernia di un disco intervertebrale. Il quadro clinico della compressione del midollo spinale può verificarsi immediatamente dopo la lesione o essere dinamico (aumentando con i movimenti della colonna vertebrale) se è instabile e sono presenti frammenti ossei in movimento.
C'è un cosiddetto lesione da iperestensione del rachide cervicale(colpo di frusta), che si verifica in incidenti stradali, tuffi, cadute dall'alto. Il meccanismo di questa lesione del midollo spinale è una forte iperestensione del collo, che supera le capacità anatomiche e funzionali di questa sezione e porta ad un forte restringimento del canale spinale con lo sviluppo di ischemia o compressione del midollo spinale. Clinicamente, la lesione da iperestensione si manifesta con sindromi da lesione del midollo spinale di varia gravità: disfunzione radicolare, parziale del midollo spinale, lesione trasversale completa, sindrome dell'arteria spinale anteriore.
Emorragia nel midollo spinale. Molto spesso, l'emorragia si verifica quando i vasi sanguigni si rompono nell'area del canale centrale e delle corna posteriori a livello degli ispessimenti lombari e cervicali. Le manifestazioni cliniche dell'ematomielia sono causate dalla compressione delle corna posteriori del midollo spinale da parte del sangue che sgorga, diffondendosi in 3-4 segmenti. In conformità con ciò, si verificano acutamente disturbi segmentali dissociati della sensibilità (temperatura e dolore), localizzati sul corpo sotto forma di giacca o mezza giacca. Quando il sangue si diffonde nell'area delle corna anteriori, viene rilevata la paresi flaccida periferica con atrofia. Quando sono colpite le corna laterali si osservano disturbi vegetativo-trofici. Molto spesso, nel periodo acuto, si osservano non solo disturbi segmentali, ma anche disturbi della sensibilità di conduzione, sintomi piramidali dovuti alla pressione sulle corde laterali del midollo spinale. Con estese emorragie si sviluppa un quadro di lesione trasversale completa del midollo spinale. Il liquido cerebrospinale può contenere sangue.
L'ematomielia è caratterizzata da un decorso regressivo. I sintomi neurologici iniziano a diminuire dopo 7-10 giorni. Il recupero delle funzioni compromesse può essere completo, ma più spesso permangono disturbi neurologici.
Emorragia negli spazi che circondano il midollo spinale. Può essere epidurale o subaracnoideo. Come risultato delle emorragie epidurali (dai plessi venosi), si forma un ematoma epidurale che comprime gradualmente il midollo spinale. Gli ematomi epidurali sono rari.
Manifestazioni cliniche. Gli ematomi epidurali sono caratterizzati da un periodo asintomatico dopo l'infortunio. Alcune ore dopo, si verifica dolore radicolare con irradiazione variabile a seconda della posizione dell'ematoma. Quindi compaiono i sintomi della compressione trasversale del midollo spinale e iniziano ad aumentare.
Il quadro clinico dell'emorragia intratecale (subaracnoidea) nella lesione del midollo spinale è caratterizzato dallo sviluppo acuto di sintomi di irritazione delle membrane e delle radici spinali. Compaiono intensi dolori alla schiena e agli arti, rigidità dei muscoli del collo e i sintomi di Kernig e Brudzinski. Molto spesso questi sintomi sono accompagnati da paresi degli arti, disturbi della conduzione della sensibilità e disturbi pelvici dovuti a danno o compressione del midollo spinale a causa del sangue che sgorga. La diagnosi di emorragia viene verificata mediante puntura lombare: il liquido cerebrospinale è intensamente colorato di sangue o xantocromico. Il decorso dell'emorragia è regressivo e spesso si verifica un recupero completo. Tuttavia, l'emorragia nella zona della cauda equina può essere complicata dallo sviluppo di aracnoidite adesiva o cistica.
Diagnostica. I metodi di esame a raggi X, inclusa la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica, sono fondamentali per determinare la natura della lesione alla colonna vertebrale e al midollo spinale e scegliere un metodo di trattamento adeguato. Questi studi devono essere eseguiti con una certa cautela per non causare ulteriori lesioni al midollo spinale.
Se si sospetta una frattura della 1a e della 2a vertebra, vengono scattate fotografie con una posizione speciale del paziente - fotografie attraverso la bocca.
Per identificare l’instabilità della colonna vertebrale, viene scattata una serie di immagini con flessione ed estensione graduale (5-10°), che consente di identificare i primi segni di instabilità e di non causare un peggioramento delle condizioni del paziente.
TAC, mirato al livello della presunta lesione, fornisce informazioni più complete sui danni alle strutture ossee, ai dischi intervertebrali e sullo stato del midollo spinale e delle sue radici.
In alcuni casi viene utilizzata la mielografia con contrasto idrosolubile, che consente di chiarire la natura del danno al midollo spinale e alle sue radici e determinare la presenza di un blocco nello spazio subaracnoideo. Nella fase acuta della lesione, questo studio deve essere eseguito con grande cautela, poiché l'introduzione del contrasto può aumentare la compressione del midollo spinale nell'area del blocco.
In questi casi è preferibile utilizzare la risonanza magnetica, che fornisce le informazioni più complete sullo stato del midollo spinale e delle strutture spinali.
Trattamento. Tutte le vittime che hanno subito traumi gravi devono essere trattate come se soffrissero di possibili danni al midollo spinale e alla colonna vertebrale, soprattutto in caso di disturbi della coscienza. se sono presenti segni di difficoltà respiratoria o sintomi caratteristici di danno spinale (paresi degli arti, disturbi sensoriali, priapismo, deformità della colonna vertebrale, ecc.).
Pronto soccorso sul posto consiste principalmente nell'immobilizzare la colonna vertebrale: un collare cervicale, uno scudo. È necessaria particolare attenzione durante lo spostamento e il trasporto del paziente.
In caso di lesioni gravi, viene eseguita una serie di misure di terapia intensiva volte a mantenere la pressione sanguigna e normalizzare la respirazione (se necessario, ventilazione artificiale).
I pazienti con danni alla colonna vertebrale e al midollo spinale dovrebbero, se possibile, essere ricoverati in ospedali specializzati.
In ospedale prosegue la terapia intensiva antishock. Fino a quando non viene chiarita la natura della lesione e selezionato un metodo di trattamento adeguato, l'immobilizzazione viene mantenuta.
La varietà dei meccanismi fisiopatologici e delle manifestazioni cliniche della lesione del midollo spinale determina l'approccio da adottare terapia farmacologica, che dipende dalla natura e dal livello del danno.
Il periodo acuto può essere accompagnato (oltre ai sintomi di danno al midollo spinale) da reazioni di shock con calo della pressione sanguigna e compromissione della microcircolazione, che richiede una terapia anti-shock sotto il controllo del livello di elettroliti, emoglobina, ematocrito e sangue proteine.
Per prevenire cambiamenti secondari nel midollo spinale causati dallo sviluppo di edema e disturbi circolatori nel periodo acuto, alcuni autori ritengono giustificato l'uso di grandi dosi di ormoni glucocorticoidi (desametasone, metilprednisolone).
Il danno al midollo spinale a livello dei segmenti ThII - ThVII può causare aritmia cardiaca, diminuzione della capacità funzionale del miocardio e alterazioni dell'ECG. In questi casi è indicata la somministrazione di glicosidi cardiaci.
Per migliorare la microcircolazione, prevenire la trombosi e ridurre la permeabilità vascolare, vengono prescritti angioprotettori, anticoagulanti e vasodilatatori.
Per i disturbi del metabolismo proteico, la cachessia e la scarsa guarigione delle ferite, è indicato l'uso di ormoni anabolizzanti. A tutte le vittime vengono prescritti nootropi, soprattutto nel periodo acuto della lesione.
La prevenzione e il trattamento delle complicanze infiammatorie vengono effettuati introducendo agenti antibatterici, tenendo conto della sensibilità della microflora.
Sia nei periodi acuti che in quelli successivi, ai pazienti devono essere prescritti farmaci sedativi, tranquillanti e antipsicotici.
Prevenzione delle complicanze. La disfunzione degli organi gassosi è una delle complicanze più comuni della lesione del midollo spinale.
Con una lesione trasversale completa del midollo spinale nel periodo acuto (in condizioni di sviluppo di shock spinale), si notano paralisi del detrusore, spasmo dello sfintere della vescica e assenza della sua attività riflessa. La conseguenza di ciò è la ritenzione urinaria (atonia e sovradistensione della vescica).
Per prevenzione della disfunzione degli organi pelvici Fin dalle prime ore di degenza ospedaliera, è necessario determinare chiaramente lo stato della minzione e stabilire un'adeguata escrezione di urina. Nelle prime settimane dopo l'infortunio è necessario inserire un catetere permanente. Successivamente, viene effettuato 4 volte il cateterismo periodico della vescica con simultaneo risciacquo con soluzioni asettiche. Le manipolazioni devono essere accompagnate dal rigoroso rispetto delle regole di asepsi e antisettici.
Quando i fenomeni di shock spinale passano, l'attività riflessa della vescica viene ripristinata: si svuota automaticamente quando è piena.
Disturbi urinari più gravi con assenza o soppressione della sua attività riflessa e incontinenza urinaria possono essere osservati con danni ai centri spinali degli organi pelvici (ThXII - LI) o con danni alle radici della cauda equina. In questi casi, in presenza di una grande quantità di urina residua, è indicato il cateterismo periodico della vescica.
Uno dei compiti principali nel trattamento dei pazienti con lesioni del midollo spinale è lo sviluppo di meccanismi riflessi che garantiscano lo svuotamento automatico della vescica quando è piena. L’uso della stimolazione elettrica della vescica può aiutare a raggiungere questo obiettivo.
Il disturbo della defecazione, che si sviluppa sempre con una lesione del midollo spinale, può causare febbricola e intossicazione. Per ripristinare la funzione rettale, si consiglia di prescrivere una dieta, vari lassativi, supposte e in alcuni casi un clistere purificante.
Per la riabilitazione tempestiva ed efficace dei pazienti, la prevenzione delle piaghe da decubito nella zona del sacro, delle tuberosità ischiatiche, dei grandi trocanteri del femore e dei talloni è della massima importanza. È necessario scegliere una posizione razionale per il paziente, utilizzando la posizione sullo stomaco e sui fianchi. Condizioni indispensabili sono la manutenzione igienica del letto, la rotazione delicata (ogni 2 ore), la pulizia della pelle con alcool etilico, canfora o salicilico. I materassi speciali sono efficaci. fornendo una ridistribuzione automatica della pressione sulla superficie del corpo. Sono consigliabili diversi cuscinetti per garantire una posizione fisiologica o necessaria al busto e agli arti in un caso particolare.
Per prevenzione delle contratture degli arti Di grande importanza sono l'ossificazione paraarticolare e paraossea, il corretto posizionamento degli arti, il massaggio e gli esercizi terapeutici.
Nei periodi acuti e precoci, soprattutto con lesioni del midollo spinale cervicale, diventa di grande importanza prevenzione delle complicanze infiammatorie polmonari. È necessario normalizzare le funzioni della respirazione esterna e aspirare le secrezioni dalle vie respiratorie. Sono utili le inalazioni aerosoliche di farmaci, la ginnastica attiva e passiva. In assenza di lesioni al torace e ai polmoni, si consigliano coppettazione e cerotti di senape. Vengono prescritti il vibromassaggio, l'irradiazione ultravioletta e la stimolazione elettrica del diaframma.
Per prevenire le piaghe da decubito, viene utilizzata l'irradiazione ultravioletta della parte bassa della schiena, dell'osso sacro, dei glutei e dei talloni in dosi suberitematiche.
In presenza di sindrome dolorosa, si utilizzano correnti diadinamiche (DDT), correnti modulate sinusoidalmente (SMT), ozocerite o applicazioni di fango in combinazione con elettroforesi di farmaci analgesici, terapia fisica e massaggio.
Il trattamento dei pazienti con lesione del midollo spinale o delle sue conseguenze dovrebbe sempre essere completo. Condizioni importanti per aumentare l'efficacia del trattamento per questi pazienti sono un'adeguata riabilitazione e un trattamento sanatorio.
Trattamento per fratture vertebrali complicate. Gli obiettivi principali che vengono perseguiti quando si presta assistenza ai pazienti con una frattura spinale complicata sono l'eliminazione della compressione del midollo spinale e delle sue radici e la stabilizzazione della colonna vertebrale.
A seconda della natura della lesione, questo obiettivo può essere raggiunto in diversi modi:
. metodo chirurgico;
Mediante immobilizzazione esterna e riposizionamento della colonna vertebrale (trazioni, collari cervicali, corsetti, dispositivi di fissaggio speciali).
Immobilizzazione spinale. Previene la possibile dislocazione delle vertebre e ulteriori danni al midollo spinale; crea le condizioni per eliminare la deformazione spinale esistente e la guarigione dei tessuti danneggiati in una posizione vicina alla normalità.
Uno dei principali metodi per immobilizzare la colonna vertebrale ed eliminarne la deformazione è la trazione, che è più efficace in caso di traumi cervicali.
La trazione viene effettuata utilizzando uno speciale dispositivo costituito da una staffa fissata al cranio e da un sistema di blocchi che effettuano la trazione.
Il morsetto Crutchfield viene fissato alle tuberosità parietali mediante due viti a punta tagliente. La trazione mediante pesi viene effettuata lungo l'asse della colonna vertebrale. La trazione inizia solitamente con un carico piccolo (3-4 kg) e aumenta gradualmente fino a 8-12 kg (in alcuni casi di più). I cambiamenti nella deformazione spinale sotto l'influenza della trazione vengono monitorati utilizzando ripetuti raggi X.
Se la colonna cervicale è danneggiata, l'immobilizzazione della colonna vertebrale può essere effettuata utilizzando un dispositivo speciale costituito da uno speciale corsetto a giubbotto, un cerchio metallico fissato rigidamente alla testa del paziente e aste che collegano il cerchio al giubbotto (alone veste). Nei casi in cui non è richiesta l'immobilizzazione completa per lesioni al rachide cervicale, vengono utilizzati collari morbidi e rigidi. Corsetti dal design speciale vengono utilizzati anche per le fratture della colonna vertebrale toracica e lombare.
Quando si utilizzano metodi di immobilizzazione esterna (trazione, corsetti), è necessario molto tempo (mesi) per eliminare la deformità della colonna vertebrale e guarire le strutture danneggiate nella posizione richiesta.
In molti casi questo metodo di trattamento è inaccettabile, soprattutto quando è necessario alleviare immediatamente la compressione del midollo spinale. In una situazione del genere, è necessario un intervento chirurgico.
Lo scopo dell'operazione è eliminare la compressione del midollo spinale, correggere la deformità della colonna vertebrale e stabilizzarla in modo affidabile.
Chirurgia. Si utilizzano vari tipi di interventi: con avvicinamento al midollo spinale da dietro tramite laminectomia, laterale o frontale con resezione dei corpi vertebrali. Per stabilizzare la colonna vertebrale vengono utilizzate una varietà di placche metalliche, viti ossee e fili. I frammenti vertebrali resecati vengono sostituiti con frammenti ossei prelevati dall'ileo o dalla tibia del paziente, speciali protesi metalliche e ceramiche e ossa prelevate da un cadavere.
Indicazioni per la chirurgia per lesioni della colonna vertebrale e del midollo spinale.
Nel determinare le indicazioni chirurgiche è necessario tenere conto del fatto che le lesioni più pericolose del midollo spinale si verificano immediatamente al momento della lesione e molte di queste lesioni sono irreversibili. Quindi, se la vittima subito dopo l'infortunio ha un quadro clinico di una lesione trasversale completa del midollo spinale, allora non c'è praticamente alcuna speranza per un'operazione urgente che possa cambiare la situazione. A questo proposito, molti chirurghi ritengono che l'intervento chirurgico in questi casi sia ingiustificato.
Un'eccezione può essere la presenza di sintomi di una completa interruzione delle radici del midollo spinale. Nonostante la gravità del danno, in questi casi l'intervento chirurgico è giustificato principalmente dal fatto che è possibile ripristinare la conduzione lungo le radici danneggiate e, in caso di rottura, cosa rara, si può ottenere un risultato positivo mediante sutura microchirurgica delle radici estremità delle radici danneggiate.
Se sono presenti anche i più lievi segni di conservazione di alcune funzioni del midollo spinale (leggero movimento delle dita, capacità di determinare un cambiamento nella posizione di un arto, percezione di forti stimoli dolorifici) e allo stesso tempo vi sono segni di compressione del midollo spinale (presenza di un blocco, spostamento delle vertebre, frammenti ossei nel canale spinale, ecc.), allora è indicato l'intervento.
Nel periodo tardivo della lesione, l'intervento chirurgico è giustificato se la compressione del midollo spinale persiste e i sintomi del danno progrediscono.
L'intervento è indicato anche in caso di grave deformazione e instabilità della colonna vertebrale, anche in caso di lesione trasversale completa del midollo spinale. Lo scopo dell'operazione in questo caso è normalizzare la funzione di supporto della colonna vertebrale, che è una condizione importante per una riabilitazione più efficace del paziente.
La scelta del metodo di trattamento più adeguato - trazione, fissazione esterna, chirurgia, una combinazione di questi metodi è in gran parte determinata dalla posizione e dalla natura della lesione.
A questo proposito, è consigliabile considerare separatamente i tipi più tipici di lesioni alla colonna vertebrale e al midollo spinale.
Lesione della colonna vertebrale cervicale. La colonna cervicale è la più suscettibile ai danni e la più vulnerabile. Circa il 40-60% di tutte le lesioni spinali si verificano nella regione cervicale e sono particolarmente comuni nei bambini, il che può essere spiegato dalla debolezza dei muscoli del collo, dalla significativa estensibilità dei legamenti e dalle grandi dimensioni della testa;
Va notato che il trauma alle vertebre cervicali è più spesso accompagnato da danni al midollo spinale rispetto ad altre parti della colonna vertebrale (40-60% dei casi).
Il danno alla colonna cervicale porta alle complicanze più gravi e, più spesso che alle lesioni ad altre parti della colonna vertebrale, alla morte del paziente: 25-40% delle vittime con lesioni localizzate a livello delle tre vertebre cervicali superiori morire sul luogo dell'incidente.
La struttura unica e il significato funzionale della 1a e della 2a vertebra cervicale rendono necessario considerare separatamente il loro danno. La prima vertebra cervicale (atlante) può essere danneggiata da sola o insieme alla seconda vertebra (40% dei casi). Molto spesso, a seguito di un infortunio, l'anello dell'Atlante si rompe nelle sue diverse parti. Quando la seconda vertebra cervicale è danneggiata (epistrofia), di solito si verifica una frattura e uno spostamento del processo odontoideo. Negli impiccati si osserva una peculiare frattura della seconda vertebra a livello dei processi articolari (“frattura del boia”).
Le vertebre CV-ThI rappresentano oltre il 70% delle lesioni: fratture e lussazioni con conseguenti danni gravi, spesso irreversibili, al midollo spinale.
Per le fratture della prima vertebra cervicale, viene solitamente utilizzata con successo la trazione mediante stabilizzazione esterna rigida con halo vest seguita dall'uso di collari cervicali. Per le fratture combinate della 1a e 2a vertebra cervicale, oltre a queste metodiche, viene utilizzata la stabilizzazione chirurgica delle vertebre, che può essere ottenuta stringendo gli archi e i processi spinosi delle prime tre vertebre con filo o fissandoli con viti nella parte zona dei processi articolari.
In alcuni casi, per eliminare la compressione del midollo spinale e del midollo allungato da parte di un dente rotto della seconda vertebra cervicale, è possibile utilizzare l'accesso anteriore attraverso la cavità orale.
La fissazione chirurgica è indicata per fratture-lussazioni delle vertebre CIII-ThI. A seconda delle caratteristiche della lesione, può essere eseguito tramite un approccio posteriore con fissazione delle vertebre tramite filo o altre strutture metalliche in corrispondenza degli archi e dei processi spinosi. In caso di compressione anteriore del midollo spinale da parte di frammenti di una vertebra schiacciata, prolasso del disco o ematoma, è consigliabile utilizzare un approccio anteriore con resezione dei corpi vertebrali interessati e stabilizzazione della colonna vertebrale mediante innesto osseo. La tecnica chirurgica è simile a quella utilizzata per il prolasso dei dischi cervicali mediani.
Trauma alla colonna vertebrale toracica e lombare. Con lesioni alla colonna vertebrale toracica e lombare, spesso si verificano fratture da compressione con la formazione di un cuneo urbano. Più spesso, queste fratture non sono accompagnate da instabilità spinale e non richiedono un intervento chirurgico.
Con le fratture comminute è possibile la compressione del midollo spinale e delle sue radici. In questo caso possono sorgere indicazioni per un intervento chirurgico. Possono essere necessari approcci laterali e anterolaterali complessi, compresi gli approcci transpleurici, per alleviare la compressione e stabilizzare la colonna vertebrale.
Trattamento di pazienti con conseguenze di lesioni del midollo spinale. Una delle conseguenze più comuni delle lesioni del midollo spinale è un forte aumento del tono dei muscoli delle gambe e del busto, che spesso complica il trattamento riabilitativo.
Per eliminare la spasticità muscolare quando il trattamento farmacologico è inefficace, in alcuni casi è necessario eseguire un intervento chirurgico sul midollo spinale (mielotomia), il cui scopo è quello di separare le corna anteriori e posteriori del midollo spinale a livello dei segmenti LI - SI (mielotomia secondo Bischof, Rothballer, ecc.).
In caso di sindromi dolorose persistenti, che più spesso si manifestano con danno alle radici e sviluppo di aderenze, possono sorgere indicazioni all'intervento chirurgico sulle vie di afferenza del dolore.
Quando compaiono piaghe da decubito, il tessuto morto viene asportato e vengono utilizzati farmaci per favorire una rapida pulizia e guarigione della ferita (solcoseryl). L'irradiazione locale ultravioletta o laser è efficace.
Capacità lavorativa. La prognosi clinica e professionale dipende dal livello e dall'entità del danno al midollo spinale. Pertanto, tutti i pazienti sopravvissuti con una rottura anatomica completa del midollo spinale a qualsiasi livello appartengono al gruppo di disabili I, ma a volte possono lavorare in condizioni create individualmente. In caso di commozione cerebrale del midollo spinale, gli operatori mentali ricevono un'invalidità temporanea per 3-4 settimane. Le persone impegnate in lavori fisici necessitano di un periodo di esenzione dal lavoro per almeno 5-8 settimane, seguito da un periodo di esenzione dal sollevamento di carichi pesanti per un massimo di 3 mesi. Quest'ultimo è dovuto al fatto che la lesione del midollo spinale si verifica nella maggior parte dei casi quando le vertebre vengono spostate e ciò implica una rottura o uno stiramento dell'apparato legamentoso.
In caso di lieve contusione del midollo spinale, il congedo per malattia viene prolungato fino al ripristino della funzione, meno spesso è consigliabile che il paziente venga trasferito al gruppo di disabilità III;
In caso di lesione moderata, è auspicabile estendere l'invalidità temporanea e quindi trasferirla al gruppo di disabilità III, ma non al II, poiché ciò non stimolerà la riabilitazione clinica e lavorativa del paziente.
In caso di gravi contusioni, compressione ed ematomielia, necrosi ischemica del midollo spinale, è più razionale trasferire i pazienti alla disabilità e continuare il trattamento e la riabilitazione con successivo riesame tenendo conto del deficit neurologico.
Di particolare importanza sono i problemi della riabilitazione medica e sociale. Compito del medico è insegnare al paziente a sfruttare al massimo le capacità motorie rimanenti per compensare i difetti che si sono sviluppati dopo l’infortunio. Ad esempio, è possibile utilizzare un sistema per allenare i muscoli del tronco e del cingolo scapolare in pazienti con paraparesi inferiore. Molti pazienti necessitano della supervisione di psicologi
Con l’aumento della velocità e della potenza dei veicoli, aumenta l’incidenza delle lesioni del midollo spinale. Negli Stati Uniti d'America ogni anno vengono registrati 8.000-10.000 casi di questo tipo di lesioni (Villanueva, 1994), in Ucraina - 1.500-2.000 casi di lesioni del midollo spinale all'anno.
La genesi delle lesioni traumatiche del midollo spinale varia e può essere causata dai seguenti fattori (Quencer, 1992):
a) frammenti ossei o estranei penetrati nel canale spinale;
b) l'effetto delle forze di compressione sul midollo spinale o;
c) meccanismi di eccessivo allungamento del midollo spinale;
d) disturbi ischemici che causano danni secondari al midollo spinale.
Tra le lesioni traumatiche del midollo spinale stesso si distinguono le seguenti forme cliniche:
1. Commozione cerebrale.
3. Lesione da schiacciamento con parziale distruzione dell'integrità anatomica o con rottura del midollo spinale.
4. Ematomielia.
5. Emorragie epidurali, subdurali e subaracnoidee.
6. Radicolite traumatica.
Con una lesione del midollo spinale, sia il midollo spinale che le sue membrane vengono danneggiati. Il danno al guscio nelle lesioni spinali chiuse è possibile principalmente a causa di frammenti di archi rotti. Con una lesione del midollo spinale, le radici non rimangono intatte. Spesso presentano ecchimosi, aree di necrosi causate da disturbi circolatori o addirittura rotture.
Deficit neurologici si verificano nel 25% delle vittime con lesioni ossee della colonna vertebrale. Le aree di maggiore mobilità della colonna vertebrale sono quelle più frequentemente ferite. In più della metà dei casi, la lesione completa del midollo spinale coincide con la lesione del rachide cervicale medio e inferiore (Levi, 1993). Poco meno della metà dei casi di lesione completa del midollo spinale si verificano con lesioni della colonna toracolombare. Tuttavia, la maggior parte delle lesioni spinali si verificano senza alcun difetto neurologico (Wilcox, 1972).
Durante l'autopsia, le lesioni del midollo spinale vengono rilevate non solo a livello della lesione, ma anche in punti che si trovano 2-3 segmenti sopra e sotto la lesione. I cambiamenti traumatici nel midollo spinale sono divisi in precoci e tardivi.
I primi cambiamenti visibili includono:
1. Rottura del midollo spinale o parziale interruzione della sua integrità.
2. Schiacciamento del midollo spinale.
3. Edema del midollo spinale.
4. Rammollimento post-traumatico acuto del midollo spinale.
5. Cambiamento parziale nella struttura del cervello.
6. Emorragia intracerebrale, subaracnoidea.
Quando si chiarisce l'una o l'altra forma di lesione del midollo spinale, è necessario tenere presente che nel decorso clinico delle lesioni alla colonna vertebrale e al midollo spinale si distinguono quattro periodi (A.V. Livshits, 1990; Duh, 1994): acuto, precoce , intermedio e tardivo.
Il periodo acuto dura 2-3 giorni. Le manifestazioni di vari gradi di lesione del midollo spinale possono essere simili durante questo periodo, poiché il quadro clinico nel periodo acuto può essere dovuto allo shock spinale.
Il primo periodo dura per le successive 2-3 settimane. Durante questo periodo, come nel periodo acuto, con lesioni del midollo spinale di vario grado, si può osservare una sindrome di completa interruzione della conduzione del midollo spinale dovuta a shock spinale, disturbi nella dinamica del sangue e del liquor, edema e gonfiore del midollo spinale ( Albino, 1985).
Il periodo intermedio dura fino a 2-3 mesi. All'inizio di questo periodo (entro 5-6 settimane dopo l'infortunio), i fenomeni di shock spinale e di edema del midollo spinale scompaiono e viene rivelata la vera natura e l'entità del danno: contusione del midollo spinale, compromissione parziale o completa delle funzioni neurologiche al di sotto della soglia livello della lesione (Tator, 1991).
Il periodo tardivo dura dal 3-4 mese a 2-3 anni dopo l'infortunio. In questo momento, le funzioni del midollo spinale vengono ripristinate, a seconda della gravità del danno. Le funzioni del midollo spinale vengono ripristinate entro 5-10 anni dalla lesione. Durante questo periodo, è possibile un peggioramento a lungo termine dei sintomi neurologici a causa dello sviluppo di un processo cicatriziale, della formazione di cisti, della comparsa di siringimielia post-traumatica, della progressione della deformità spinale cifotica e di fenomeni di instabilità con compressione tardiva del il midollo spinale (Villanueva, 1994).
La patogenesi della lesione del midollo spinale è caratterizzata da una combinazione unica e da uno sviluppo dinamico di fattori fisiopatologici e dipende in gran parte da disturbi morfologici, il cui grado varia (Klose, 1980; Guttmann, 1973; Green, 1991). Macroscopicamente il midollo spinale può apparire rigonfio, con o senza elementi di emorragia, contusione, rottura. L'interruzione della conduttività del midollo spinale e delle sue funzioni segmentali è causata non solo dal danno anatomico agli assoni e ai neuroni, ma anche da fattori patologici che iniziano a influenzare durante il periodo acuto della lesione. A causa della presenza di questi fattori, il grado dei disturbi morfologici nel midollo spinale spesso non corrisponde al grado dei disturbi funzionali (neurologici). Uno dei fattori più importanti che si attivano durante il periodo acuto della lesione è il gonfiore del midollo spinale (Green, 1993).
L'edema del midollo spinale può essere così esteso da interessare diversi segmenti, diffondendosi in direzione craniale e caudale. Ciò è accompagnato dalla perdita di autoregolazione del flusso sanguigno. I disturbi vascolari post-traumatici di tipo ischemico o emorragico svolgono un ruolo enorme nella patogenesi delle lesioni spinali. Anche una lieve compressione del midollo spinale provoca una significativa diminuzione del flusso sanguigno spinale, che può essere compensata da meccanismi di vasodilatazione o dalla formazione di collaterali arteriosi a livello della lesione. Nei segmenti adiacenti che non ricevono un flusso sanguigno sufficiente in queste condizioni, continua una diminuzione del flusso sanguigno spinale. Se la compressione del midollo spinale aumenta, il flusso sanguigno diminuisce significativamente a livello di compressione, cioè nella lesione. Quando la compressione viene eliminata, si osserva iperemia reattiva. In condizioni patologiche, con gonfiore o compressione del midollo spinale, l'autoregolazione emodinamica viene interrotta o scompare e il flusso sanguigno diventa dipendente principalmente dalla pressione sistemica. L'accumulo di metaboliti acidi e di anidride carbonica nell'area danneggiata provoca vasodilatazione, che non viene alleviata dagli agenti terapeutici. L'aggiunta di un fattore vascolare spiega la frequente discrepanza tra il livello del danno vertebrale e i sintomi clinici del danno del midollo spinale (Green, 1987, 1989; Geisler, 1991). Il focus di ammorbidimento che si verifica durante il danno si diffonde verso l'alto e verso il basso dal sito della lesione. Dopo la lesione del midollo spinale, i processi autodistruttivi portano ad un aumento della necrosi dei tessuti. Oltre a emorragie, ischemia, edema, neuronofagia, perdita di calcio extracellulare e potassio intracellulare, si verificano perossidazione lipidica indotta da trauma e idrolisi nelle membrane cellulari, che, a loro volta, danneggiano direttamente le membrane cellulari, e l'idrolisi, inoltre, porta alla formazione di prostaglandine biologicamente attive (Fagan, 1986; Faden, 1988). Come risulta dal lavoro di D. Anderson (1985), i disturbi del livello dei lipidi di membrana dovuti a cambiamenti nell'azione degli antiossidanti nelle lesioni del midollo spinale indicano che l'ischemia post-traumatica, l'edema e i disturbi elettrolitici sono il risultato di reazioni della perossidasi di membrana e lipolisi con formazione di prostaglandine vasoattive ed emoattive (Demediuk, 1985).
Il danno al midollo spinale provoca disturbi nei processi energetici e una transizione verso la glicolisi anaerobica, che impoverisce il cervello di composti ad alta energia (adenosina trifosfato e fosfocreatinina) e porta ad un aumento significativo del contenuto di lattato (Braughler, 1984). In caso di lesione al midollo spinale, si verificano cambiamenti nella tensione dell'ossigeno, cambiamenti nella concentrazione di sodio e potassio secondari a necrosi ed edema tissutale, rilascio di enzimi lisosomiali coinvolti nello sviluppo della lesione e aumento della concentrazione di adrenalina nel midollo spinale. materia grigia del midollo spinale lesionato (Bracken, 1992). Recentemente è stato discusso in letteratura il ruolo degli eucanoidi nella patogenesi delle lesioni spinali (Hsu, 1985, 1986, 1988; Kiwak, 1985; Mitsuhashi, 1994; Sharma, 1993; Tempel, 1992; Winkler, 1993). Gli eucasanoidi includono metaboliti dell'acido arachidonico - trombossano A2, prostaglandina 12. La rottura delle guaine mieliniche e la ridotta perossidazione lipidica portano al rilascio locale di una grande quantità di eucasanoidi. Il ruolo più importante del trombossano A2 e della prostaglandina 12 nella patogenesi delle lesioni spinali è il loro effetto sulla regolazione vascolare. Il trombossano porta alla vasocostrizione, mentre le prostaglandine svolgono il ruolo opposto. In caso di lesioni spinali è stato riscontrato un aumento del contenuto di eucanoidi sia nel liquido cerebrospinale che nell'area della lesione traumatica del midollo spinale. Esiste una correlazione tra la gravità della lesione e il contenuto di eucanoidi nel liquido cerebrospinale. I cambiamenti fisiopatologici (biochimici) nella lesione del midollo spinale si riflettono nel seguente diagramma:
Studi microangiografici su lesioni e compressioni sperimentali del midollo spinale rivelano necrosi della sostanza grigia centrale dopo 4 ore, contemporaneamente si determina un picco dei livelli di adrenalina e gonfiore della sostanza bianca circostante. La degenerazione assonale e neuronale compare entro l'ottava ora. I cambiamenti necrotici nella sostanza bianca si verificano un po' più tardi e questo apre prospettive per prevenire ulteriori danni con tattiche di trattamento attivo nelle prime ore dopo l'infortunio (Griffiths, 1975; Tator, 1991).
Durante il periodo acuto, che copre i primi 2~3 giorni. si verifica una necrosi traumatica primaria, causata sia da un danno diretto che da un gonfiore del midollo spinale, e da un disturbo della circolazione liquorale e sanguigna. Nelle lesioni del midollo spinale cervicale, l’edema è una delle principali cause di morte.
La necrosi primaria si diffonde maggiormente lungo il diametro del midollo spinale che lungo la sua lunghezza. Nonostante il fatto che i cambiamenti morfologici non vengano rilevati durante l'intervento chirurgico, gli studi patologici e anatomici spesso determinano una rottura anatomica completa del midollo spinale (Villanueva, 1994). Durante una rottura anatomica, le estremità del midollo spinale sono ammorbidite, con bordi irregolari e possono trovarsi a diversi centimetri di distanza l'una dall'altra. La combinazione di necrosi primaria e secondaria determina la prevalenza di alterazioni necrotiche nel midollo spinale che vanno ben oltre l'impatto traumatico immediato. Come dimostrato da studi morfologici condotti sui cani (G.N. Krivitskaya et al., 1980), con la sezione completa del midollo spinale, la necrosi e il decadimento dei tessuti nell'area della lesione vengono rilevati dopo 8-10 giorni. Allo stesso tempo, si nota una reazione proliferativa con nuova formazione di vasi sanguigni, nonché di fibre del tessuto connettivo argirofilico e collagene. Negli animali, 14-21 giorni dopo la transezione, si osservano nuove formazioni vascolari, ipertrofia e iperplasia di tutti i tipi di glia attorno al sito di transezione. Alle estremità delle fibre nervose del tratto piramidale (3-4 segmenti sopra la sezione) si rileva un aumento significativo delle fibre nervose con fiaschi di crescita e palline di irritazione. Si forma una delicata cicatrice glio-fibrosa. Al di sotto del sito di sezione del midollo spinale nel tratto piramidale si osserva la demielinizzazione totale delle fibre nervose. Durante questo periodo si può notare l'organizzazione dei focolai di danno al midollo spinale, una diminuzione dei disturbi circolatori e l'edema. 1-2 mesi dopo la sezione del midollo spinale, si forma una cicatrice ruvida del tessuto connettivo, situata nella direzione trasversale rispetto alle fibre discendenti e ascendenti del midollo spinale. La degenerazione e la morte delle fibre nervose e dei neuroni si osservano in diversi segmenti sopra e sotto la cicatrice, ma la maggior parte di essi in queste sezioni conserva la propria struttura. Alcune fibre mostravano un tipico pattern di degenerazione retrograda (in entrambi i segmenti). Alle estremità delle fibre nervose si rivelano fiaschi di crescita, fibre nervose sottili con piccoli depositi tra fibre alterate, deformate e frammentate di orientamento simile.
3 mesi dopo la sezione del midollo spinale, al confine della lesione si sviluppa tessuto di granulazione con la formazione di palline granulari mesenchimali. Le fonti più comuni di proliferazione sono la materia grigia e la pia madre. Allo stesso tempo vengono rilevati fenomeni di degenerazione secondaria. L'organizzazione del focus della lesione del midollo spinale termina con una cicatrice del tessuto connettivo. Dopo 3-4 mesi, sopra e sotto il sito di resezione, la zona danneggiata diminuisce e viene tesa da una cicatrice di tessuto connettivo denso o lasso lungo il percorso delle fibre del midollo spinale. Dopo 4,5-5,5 mesi, nella sezione del midollo spinale situata sopra la cicatrice, i neuroni non presentano segni di degenerazione retrograda, sono leggermente ipertrofizzati, ipercromici, alcuni di essi sono binucleati. I corpi delle cellule nervose talvolta mostrano singole sinapsi ipertrofiche. Le fibre nervose del tratto piramidale al di sotto del sito di resezione sono deformate e frammentate. Sopra e sotto il sito della lesione si osservano fibre sottili con fiaschi di crescita. Alcune fibre si avvicinano alla cicatrice e hanno 2~3 rami. Alcune fibre nervose che terminano vicino alla cicatrice non presentano ispessimenti o striature. Nelle sezioni longitudinali è riconoscibile solo il tratto piramidale. 6-9 mesi dopo la resezione completa, si trova una densa cicatrice di collagene che attraversa il midollo spinale. Le fibre immerse nel rumine non hanno fiaschi di crescita. Le cellule nervose sopra e sotto la cicatrice sono occasionalmente ipertrofiche, alcune di esse contengono grumi allargati o giganti di granulazione basofila nel citoplasma. Molte cellule con ipercromatosi sono circondate da un gran numero di nuclei oligodendrogliali. Nelle sezioni trasversali sopra la cicatrice nei tratti piramidali si osservano cilindri assiali ipertrofici, diversi per volume e forma da quelli situati nelle vicinanze. I cilindri assiali ipertrofizzati hanno un bordo mielinico ispessito, anch'esso colorato in modo non uniforme e spesso deformato (T.N. Krivitskaya et al., 1980). Dopo 2 anni, sopra il sito della lesione, con danno parziale al midollo spinale, si trovano fasci di fibre nervose degenerate, nonché fibre ispessite iperimpregnate e localizzate caoticamente, formando escrescenze, fibre nervose sottili. Di grande interesse sono la comparsa di fibre nervose sottili nella lesione e l'aumento del loro numero in proporzione al tempo di esistenza della lesione. Un aumento delle fibre nervose, soprattutto con la mezza transezione, è accompagnato da un miglioramento delle funzioni motorie. Tuttavia, la zona di distruzione non è mai completamente riempita di fibre di piccolo calibro, anche se col tempo diminuisce drasticamente.
Studi morfologici del midollo spinale umano danneggiato hanno dimostrato che la materia grigia delle regioni centrali del midollo spinale è più vulnerabile. I cambiamenti necrotici sono il più delle volte asimmetrici e si diffondono rostralmente e caudalmente senza espansione degli spazi extracellulari e distruzione della sostanza bianca.
La necrosi centrale progressiva della sostanza grigia con alterazioni cistiche e vacuolizzazione si estende ulteriormente alla sostanza bianca. La reazione dei tessuti marginali e distanti ai prodotti di decadimento tissutale e ai corpi estranei, i processi circolatori e autodistruttivi si manifestano in necrosi secondaria, fusione edematosa, mielite non purulenta, leptomeningite, reazioni gliali diffuse e limitate, degenerazioni ascendenti e discendenti, degenerazione adesiva cicatriziale .
Confronti anatomici e clinici delle lesioni traumatiche del midollo spinale negli esseri umani hanno rivelato una mancanza di correlazione tra la profondità del danno anatomico al midollo spinale e la gravità del deficit neurologico. Una scoperta interessante è stata che, nonostante la regressione del deficit neurologico, la gravità dei disturbi morfologici del midollo spinale può peggiorare durante la prima settimana dopo l'infortunio. È stato anche rivelato che, indipendentemente dal meccanismo della lesione, i maggiori cambiamenti nel midollo spinale vengono inizialmente rilevati nella sua parte centrale. Ciò si manifesta con un'emorragia nella materia grigia, seguita da edema e necrosi. In un periodo successivo il processo si estende alla sostanza bianca e inizia la sua demielinizzazione. Di conseguenza, nel processo è coinvolto l’intero diametro del midollo spinale. Gli autori hanno trovato una relazione tra la gravità della lesione e la forza della lesione applicata: con una lesione minima viene danneggiata solo la sostanza grigia, con una lesione più grave vengono danneggiate la sostanza grigia e le sezioni adiacenti della sostanza bianca, con lesione grave, l'intero diametro del midollo spinale è interessato. Il danno assonale secondario può essere causato da un rigonfiamento acuto della sostanza grigia e dalla sua pressione sugli assoni circostanti nella sostanza bianca, o dall'estensione dell'emorragia dalla sostanza grigia alla sostanza bianca (Quencer, 1992).
La profondità dei disturbi vascolari del midollo spinale non è la stessa. La materia grigia è più sensibile al danno vascolare (Tator, 1991). In esso si osservano più spesso piccoli focolai di emorragia. Rotture vascolari, trombosi vascolari, stravasi emorragici sono le lesioni vascolari più comunemente rilevate. L'angiografia spinale in pazienti con lesioni vertebrali ha rivelato trombosi dei vasi segmentali, nonché spasmo dei vasi vertebrali e flusso sanguigno alterato nei vasi del midollo spinale cervicale e persino nelle arterie cerebrali posteriori, il che è stato confermato dai dati ecografici. Ahmann (1975) riporta diversi casi di profondi deficit neurologici successivi a traumi minori. Gli studi istologici hanno rivelato un infarto del midollo spinale dovuto a trombosi vascolare.
Nel periodo tardivo traumatico, i cambiamenti morfologici si manifestano sotto forma di degenerazione cistica del midollo spinale, la sua degenerazione fibrosa, la formazione di lacune vascolari, la formazione di cicatrici perimedollari, causando una grave compressione del midollo spinale (A.V. Livshits, 1990) .
La degenerazione cistica remota del midollo spinale porta alla formazione di siringomielia post-traumatica, che si manifesta come un peggioramento dei disturbi neurologici nel periodo di lesione a lungo termine. Di solito la cisti si trova centromidollare su una vasta area, superando significativamente le dimensioni del sito della lesione, ed è una trasformazione dell'ematomielia centromidollare. Studi di risonanza magnetica dinamica in periodi diversi dopo l'infortunio forniscono un quadro più completo dell'ematomielia post-traumatica.
È noto che la formazione di cicatrici perimedollari e la degenerazione fibrosa del midollo spinale sono le cause più comuni di peggioramento tardivo dei deficit neurologici nei pazienti con trauma.
Nuovi dati della letteratura e le nostre osservazioni sulla fisiopatologia e sulla morfologia delle lesioni del midollo spinale forniscono motivi per riconsiderare la periodizzazione di questo tipo di lesione. La definizione dei periodi durante una malattia traumatica del midollo spinale si basa sui seguenti criteri: clinici (shock spinale, corporeo, spinale, disturbi radicolari e loro dinamica), fisiopatologici (edema, gonfiore, vascolare, neurofisiologico, neurotrasmettitore, ormonale disturbi) e morfologico (substrato morfologico, dinamica della sua riorganizzazione e organizzazione).
A questo proposito, è opportuno distinguere tre periodi principali di malattia traumatica del midollo spinale: acuto, intermedio e remoto.
La base del periodo acuto è determinata dalle interazioni del substrato traumatico, del danno e delle reazioni di difesa. Il periodo intermedio dovrebbe garantire il riassorbimento e l'organizzazione delle aree danneggiate, l'implementazione di processi compensativi e adattativi. Nel lungo periodo si completano i processi locali e distanti distruttivi, distrofici e riparativi-rigenerativi e si formano le condizioni per la loro coesistenza. Con un decorso favorevole della malattia, si osserva un bilanciamento clinico dei cambiamenti causati dalla lesione del midollo spinale. Se il suo decorso è sfavorevole, si notano manifestazioni cliniche di processi cicatriziali adesivi indotti da traumi, disturbi autoimmuni e autonomici.
Considerando quanto sopra, è necessario riconsiderare la durata dei periodi di malattia traumatica del midollo spinale. La base di ciò è il decorso clinico delle lesioni del midollo spinale. Il periodo acuto della lesione del midollo spinale può durare da 1 a 8-10 settimane: con una commozione cerebrale - da 1 a 2 settimane; con un livido, la durata del periodo acuto varia da 1 a 8-10 settimane. Un segno della durata del periodo acuto può essere la durata dello shock spinale. La comparsa di automatismi spinali nelle lesioni gravi del midollo spinale indica la fine del periodo acuto e l'inizio del periodo intermedio. La durata del periodo intermedio per lesioni lievi dura fino a 2 mesi, per lesioni moderate fino a 4 mesi, per lesioni gravi fino a 1 anno. Il periodo di recupero clinico a lungo termine dura fino a 2 anni in presenza di disturbi di conduzione, trofici o nel decorso progressivo di una malattia traumatica, la sua durata non è limitata;
Questa divisione del decorso della malattia traumatica del midollo spinale in periodi è in gran parte giustificata non solo dai cambiamenti patomorfologici e clinici in essa contenuti, ma anche dalle peculiarità delle tattiche terapeutiche e dell'esame delle lesioni spinali.
Le anomalie neurologiche nella lesione del midollo spinale sono complesse e spesso non sono correlate con le anomalie morfologiche del midollo spinale. È consuetudine distinguere tra danno neurologico completo e incompleto. Si ritiene che i pazienti con mancanza di sensibilità e movimento al di sotto del livello della lesione abbiano un deficit neurologico completo. Il deficit neurologico incompleto viene diagnosticato quando la sensibilità e il movimento sono presenti al di sotto del livello della lesione. Secondo l’American Spinal Injury Statistical Center, più della metà dei pazienti con lesioni del midollo spinale presentano una lesione incompleta. L'importanza concettuale di questa divisione è dovuta al fatto che i pazienti con danno funzionale completo raramente sperimentano un recupero neurologico. Allo stesso tempo, i pazienti con deficit neurologico incompleto spesso sperimentano un miglioramento.
Il quadro neurologico della lesione spinale è caratterizzato da fasi. Nel periodo acuto, la gravità del deficit neurologico è dovuta ai fenomeni di shock spinale. Nel periodo intermedio dopo l'eliminazione dello shock spinale, viene alla ribalta un vero e proprio difetto neurologico causato da un danno anatomico e fisiologico al midollo spinale. Successivamente si osserva una parziale regressione dei sintomi neurologici. A lungo termine rimangono sintomi neurologici residui. A causa di cambiamenti secondari a lungo termine nel midollo spinale, i sintomi neurologici possono peggiorare.
Un profondo deficit neurologico nel periodo acuto può essere causato non solo dallo shock spinale, ma anche dalla contusione del midollo spinale. Successivamente è possibile una significativa regressione dei sintomi neurologici. In questi casi sorgono difficoltà nella diagnosi differenziale tra shock spinale e contusione del midollo spinale. La contusione del midollo spinale comporta grossi cambiamenti morfologici nel midollo spinale, accompagnati da un grave danno neurologico. Pertanto, in caso di regressione significativa dei sintomi neurologici inizialmente gravi, dovrebbe essere diagnosticato lo shock spinale piuttosto che la contusione del midollo spinale.
Shock spinale- una condizione fisiopatologica caratterizzata da una violazione delle funzioni motorie, sensoriali e riflesse del midollo spinale al di sotto del sito della lesione. Lo shock è caratterizzato da plegia flaccida degli arti. Lo shock spinale si risolve entro ore, giorni, a volte settimane dopo l'infortunio. Lo shock si verifica con lesioni al tronco encefalico, lesioni alla colonna cervicale e toracica superiore. Il meccanismo dello shock è un'interruzione delle influenze regolatrici da parte dei centri autonomi superiori delle regioni cervicale e toracica superiore. Bradicardia, ipotensione, ipotermia sono le principali manifestazioni cliniche autonomiche dello shock spinale. La peristalsi viene interrotta e si verifica il gonfiore delle mucose. A volte si verifica la sindrome di Horner. La perdita del tono vasomotorio si manifesta con iperemia della pelle e degli organi interni, che aggrava la manifestazione dell'ipotensione (Ruge, 1977). La risoluzione dello shock si manifesta con il ripristino delle funzioni autonomiche e dell'attività riflessa. È difficile valutare la profondità del deficit neurologico nei pazienti in shock. Da un punto di vista fisiopatologico, lo shock spinale è uno stato di inibizione temporanea dell’attività riflessa del midollo spinale, indotto da un trauma. Lo shock spinale è stato descritto in vari tipi di lesioni sperimentali del midollo spinale. Secondo Goltz lo shock spinale è il risultato di una sovrastimolazione traumatica del midollo spinale, cosa che, a suo avviso, è dimostrata dalla grande profondità dello shock durante le grandi sezioni del midollo spinale. Sherrington (1948) ritiene che lo shock spinale sia una conseguenza del fatto che la sezione del midollo spinale interrompe il flusso verso di esso di influenze rinforzanti e facilitanti del cervello (nucleo del mesencefalo, ponte, midollo allungato, ecc.). Studi sperimentali condotti sulle scimmie da Fulton e McCouch (1969) hanno dimostrato che la cessazione dell'amplificazione e degli impulsi regolatori dalla corteccia cerebrale alle cellule del midollo spinale è di grande importanza per il verificarsi dello shock spinale.
Alcuni autori considerano l'insorgenza di shock spinale dal punto di vista del concetto di aumentata sensibilità delle formazioni denervate (Cannon e Rosenbluth, 1957). Ciò spiega la conseguente maggiore eccitabilità del midollo spinale. Secondo I.P. Pavlov, un'irritazione prolungata ed eccessivamente forte porta all'affaticamento e all'esaurimento delle cellule nervose, a seguito della quale in esse si sviluppa l'inibizione, prevenendo un ulteriore esaurimento. In questo caso l'inibizione, senza essere auto-affaticamento, funge da guardiano della cellula. Studi sperimentali condotti da V.N. Drozdova (1968), ha permesso di rilevare nello shock spinale caratteristiche caratteristiche dell'inibizione protettiva - fluttuazioni ondulatorie nel livello di attività riflessa, discrepanza tra la gravità dei riflessi e la forza della stimolazione, che indica uno stato di fase, accelerazione del recupero dallo stato di shock spinale in condizioni di sonno fisiologico prolungato.
E.A. Asratyan (1940) osservò il verificarsi di shock spinale nei cani dopo una sezione semidorsale del midollo spinale. Il loro shock spinale a volte è stato ancora più pronunciato che in caso di rottura anatomica completa del midollo spinale. Allo stesso tempo, i riflessi degli arti, della coda e degli organi pelvici non venivano evocati nemmeno in caso di forti irritazioni. Allo stesso tempo, accarezzare le teste degli animali e mostrare loro il cibo provocava non solo una reazione motoria della testa e degli arti anteriori, ma anche i movimenti degli arti posteriori e della coda. Di conseguenza, i motoneuroni negli animali da esperimento hanno mantenuto la loro funzione. Da qui è nata l'ipotesi che la scomparsa dei riflessi durante uno shock spinale profondo, e forse in molti casi gravi disturbi motori, siano causati non tanto da un danno ai motoneuroni, ma da una disfunzione delle sezioni afferenti dell'arco riflesso (E.A. Asratyan, 1940 ; V. N. Drozdova, 1968). La correttezza dell'ipotesi di un minor danno ai motoneuroni, formulata sulla base dei risultati di studi sperimentali, è confermata da osservazioni cliniche. Così come. Khurina, che ha monitorato il ripristino delle funzioni sensoriali e motorie in 58 pazienti con conseguenze di traumi alla colonna vertebrale e al midollo spinale, ha scoperto che in 53 di loro il ripristino dei movimenti ha preceduto il ripristino della sensibilità, e solo in 5 pazienti il ripristino delle funzioni sensoriali la funzione si è verificata prima.
I cambiamenti nello stato funzionale del segmento prossimale del midollo spinale e delle parti superiori del sistema nervoso centrale nei pazienti con lesioni del midollo spinale sono stati mostrati negli studi di L.Ya. Livshits (1975) e Yu.V. Zotova (1980).
In uno studio sulle reazioni vascolari riflesse periferiche che si verificano in risposta alla somministrazione sottocutanea di adrenalina in 20 pazienti con conseguenze di midollo spinale e trauma del midollo spinale, L.Ya. Livshits ha scoperto la diffusione dei cambiamenti nella risposta vascolare sia in aree con innervazione clinicamente compromessa (al di sotto del livello di danno del midollo spinale) sia in aree con innervazione clinicamente preservata (al di sopra del livello di danno del midollo spinale - corrispondente alla sua parte prossimale). I cambiamenti nelle reazioni vascolari riflesse si sono manifestati sotto forma di: a) aumento della sensibilità dei vasi cutanei all'adrenalina; b) asimmetrie affilate di reazioni vascolari; c) reazioni vascolari paradossali. In alcuni pazienti, il cambiamento nella reattività vascolare al di sopra del livello della lesione del midollo spinale è stato ancora più pronunciato rispetto alle aree la cui innervazione avviene con la partecipazione del segmento distale del midollo spinale danneggiato. I dati ottenuti non hanno escluso la possibilità di interruzione della regolazione vascolare superiore. Yu.V. Zotov ha condotto un test di adattamento al freddo su 27 pazienti con conseguenze di lesioni del midollo spinale. Nella maggior parte dei pazienti con trauma alla colonna vertebrale toracica e lombare superiore e al midollo spinale con interruzione completa della conduzione, il tempo di adattamento della pelle al freddo al di sotto del livello della lesione non è cambiato al di sopra del livello della lesione - corrispondente a; segmento prossimale del midollo spinale: è stato esteso. Insieme a ciò, sono state notate una temperatura iniziale più bassa e una significativa asimmetria termica.
I fenomeni di shock spinale nelle prime ore, giorni e persino settimane possono causare il quadro clinico della cosiddetta rottura trasversale fisiologica del midollo spinale. Queste idee sono coerenti con i dati clinici.
Lo shock spinale più profondo e prolungato si verifica con una rottura anatomica del midollo spinale, caratterizzata da una forte diminuzione del tono dei muscoli degli arti paralizzati e dalla scomparsa dei riflessi sia somatici che autonomici, che venivano effettuati con il partecipazione del segmento caudale del midollo spinale. Shock spinale semplice, secondo i dati sperimentali di E.A. Asratyan (1965), dura 15-20 giorni. Le osservazioni cliniche mostrano che lo shock spinale negli esseri umani può durare più a lungo. I pazienti guariscono da questa condizione in media dopo 4-8 settimane. dopo l'infortunio. I fenomeni di shock spinale nell'uomo possono essere mantenuti e approfonditi dall'esposizione a vari tipi di sostanze irritanti costanti (ematomi, frammenti ossei, corpi estranei metallici, cicatrici, ecc.) per molte settimane, mesi e persino anni (V.M. Ugryumov et al., 1958). Anche i disturbi del liquido cerebrospinale e della circolazione sanguigna, il gonfiore del midollo spinale approfondiscono i fenomeni di shock spinale.
In caso di lesione delle parti superiori del midollo spinale (regione cervicale e toracica superiore), può verificarsi un danno al tronco simpatico, che provoca significativa ipotensione arteriosa, bradicardia e ipotermia con estremità inferiori calde. Si verifica la cosiddetta desimpatizzazione post-traumatica spinale, un tipo di shock spinale, che dovrebbe essere distinto dallo shock ipovolemico post-traumatico (ipotensione arteriosa, ipotermia, tachicardia). La desimpatia spinale può non solo essere associata a un danno al tronco simpatico in T1-L2 (R.L. Gelli, D.W. Speight, P.P. Simon, 1995), ma anche essere causata dall'ischemia delle colonne laterali - colonne di Clark. A seguito di un trauma alla colonna vertebrale e al midollo spinale, quando le strutture anteriori, inclusa l'arteria spinale anteriore, sono danneggiate o compresse, la microcircolazione del midollo spinale viene interrotta. La più colpita è la zona di confine della vascolarizzazione tra il bacino delle arterie spinali anteriore e posteriore, cioè la zona delle sezioni mediocentrali delle corna dorsali e delle colonne di Clark. L'assenza di anastomosi vascolari funzionalmente significative in questa zona porta all'ischemia di questa zona, che si manifesta con sintomi neurologici concomitanti, inclusa la desimpatia spinale. Che questo possa essere un processo dinamico è indicato da un aumento del tono del sistema nervoso simpatico in risposta a farmaci appropriati.
È molto importante differenziare lo shock spinale in diaschisi, shock spinale con desimpatizzazione spinale e shock post-traumatico ipovolemico nelle lesioni spinali, spesso combinate. Nel primo caso l'intervento chirurgico non è controindicato, mentre nelle altre condizioni il paziente deve essere portato fuori dallo shock e solo successivamente operato.
Un altro fenomeno che si verifica nei pazienti con lesioni spinali nel periodo acuto è disreflessia autonomica. La disreflessia autonomica è un fenomeno con un meccanismo poco chiaro, manifestato da ipertensione parossistica, bradicardia, forte mal di testa pulsante, ansia, grave sudorazione della pelle sopra il sito della lesione e dolore addominale parossistico (R. Charbonneau-Smith, 1989). La condizione richiede un trattamento sintomatico e di solito si risolve entro 2-4 giorni. Non esistono casi di combinazione di shock spinale e disreflessia autonomica.
Dopo la regressione dei sintomi acuti della lesione, diventa possibile valutare la profondità del deficit neurologico. In rari casi, la lesione del midollo spinale può essere attribuita a una specifica malattia neurologica con sindromi neurologiche definite:
1. Danno completo al midollo spinale.
2. Lesione incompleta del midollo spinale:
a) sindrome spinale anteriore,
b) sindrome spinale posteriore,
c) Sindrome di Brown-Séquard,
d) sindrome centromidollare,
e) sindrome del cono,
g) sindrome della cauda equina.
Lesione completa del midollo spinaleè una manifestazione di grave lesione del midollo spinale.
Sindrome spinale anteriore spesso osservato con meccanismi di iperflessione della lesione con fratture da compressione dei corpi vertebrali, talvolta con sintomi di lussazione. È estremamente raro come manifestazione di lesione spinale, principalmente a causa del meccanismo di iperestensione della lesione.
Segno di Brown-Séquard si verifica principalmente con lesioni penetranti del midollo spinale. Nei casi di lesione del midollo spinale nella sua forma pura, è raro, ma in alcuni pazienti viene rilevato un complesso sindrome simile alla sindrome di Brown-Séquard. In tali pazienti esiste una tendenza significativa al recupero neurologico a lungo termine.
Sindrome centromidollare più spesso riscontrato in pazienti anziani con spondilosi grave, nel rachide cervicale, in presenza di stenosi del canale spinale (Schneider, 1954). Il meccanismo della lesione è principalmente l'iperestensione, la caduta sulla testa, i colpi alla regione parietale. A volte l'esame radiografico non rivela alcun disturbo osseo traumatico. Neurologicamente, la sindrome si manifesta come debolezza, predominante negli arti superiori. I pazienti presentano spesso disturbi sensoriali, disestesia, iperpatia e disturbi degli organi pelvici e spesso vengono rilevate disfunzioni sessuali. Nel lungo periodo si osserva un significativo recupero delle funzioni neurologiche. Questa sindrome fu descritta da Schneider (1954), che la ritenne causata da un'emorragia della sostanza grigia con edema della sostanza bianca adiacente. Altri ricercatori hanno però dimostrato che questo quadro morfologico classico non sempre si verifica (Quencer, 1992): sono state individuate anomalie diffuse nella sostanza bianca delle colonne laterali. Il meccanismo della lesione è associato alla protrusione del legamento giallo nel canale spinale e alla compressione a breve termine del cervello durante l'iperestensione: lo stretching è considerato uno dei possibili meccanismi di questo tipo di lesione.
Sindrome spinale anteriore riscontrato frequentemente anche in pazienti con lesioni del midollo spinale (Villanueva, 1994). Viene spesso rilevato nelle fratture da compressione, nei meccanismi di flessione delle lesioni e nelle ernie del disco traumatiche. I pazienti presentano una compromissione completa della funzione motoria e della funzione sensoriale delle colonne laterali, mentre la funzione delle colonne posteriori è preservata. Questa sindrome è sfavorevole in termini di recupero.
Sindrome del cono si verifica con il trauma del thoracolube. In questa sindrome, il danno traumatico coinvolge non solo il cervello, ma anche le radici adiacenti della cauda equina. La sindrome comporta danni ai motoneuroni superiori e inferiori. Con una lesione incompleta del midollo spinale, i pazienti spesso sperimentano un significativo ripristino della funzione neurologica. Spesso si verifica una grave violazione del controllo della funzione degli organi pelvici con la capacità di muoversi in modo indipendente.
In presenza di lesioni traumatiche al di sotto di L1, i pazienti possono svilupparsi sindrome della cauda equina. In questo caso vengono rivelate la paresi flaccida degli arti inferiori, l'areflessia e la disfunzione degli organi pelvici. Si rileva una significativa atrofia degli arti inferiori. I deficit neurologici in questi pazienti sono spesso asimmetrici e si osserva un recupero significativo nel lungo periodo.
Per una valutazione unificata dello stato neurologico nel 1969, Frankel propose di utilizzare un sistema di classificazione:
UN- Danno completo al midollo spinale. Non c'è sensazione o movimento al di sotto del livello del danno.
B- Danno incompleto. Tutti i tipi di sensibilità al di sotto del livello di danno vengono preservati, ad eccezione dei tipi di sensibilità fantasma, non c'è movimento.
C- Danno incompleto. Viene preservata una forza muscolare minore, ma i movimenti sono così deboli da non avere alcun significato funzionale. La funzione sensoriale non è sempre compromessa o no.
D- Danno incompleto. La forza muscolare è preservata. I movimenti salvati hanno un significato funzionale e possono essere utilizzati per il movimento.
E- Pieno recupero. Tutte le funzioni motorie e sensoriali sono state ripristinate. I riflessi patologici possono persistere.
L'American Spinal Injury Association ha proposto un sistema unificato per valutare il danno neurologico nelle lesioni del midollo spinale. (scala ASIA). Questo sistema valuta la forza muscolare nei 10 importanti dermatomi accoppiati su una scala a sei punti:
0 - plegia;
1 - contrazione muscolare determinata visivamente o palpabilmente;
2 - movimenti attivi che non sono in grado di resistere alla forza gravitazionale;
3 - movimenti attivi in grado di resistere alla forza gravitazionale;
4 - gamma completa di movimenti attivi che possono sopportare una resistenza moderata;
5 - movimenti attivi a gamma completa, che possono resistere a una forte resistenza.
Funzioni motorie valutato testando la forza in 10 gruppi muscolari di controllo e correlato con i segmenti del midollo spinale:
1. C5 - flessione del gomito (bicipite, brachioradiale).
2. C6 - estensione del polso (estensore radiale lungo e breve del carpo).
3. C7 - estensione del gomito (tricipiti).
4. C8 - flessione delle dita (flessore profondo delle dita).
5. T1 - adduzione del mignolo (abduttore digiti minimi).
6. L2 - flessione dell'anca (ileopsoas).
7. L3 - flessione del ginocchio (quadricipite).
8. L4 - estensione dorsale del piede (tibiale anteriore).
9. L5 - estensione del pollice (estensore lungo dell'alluce).
10. S1 - flessione dorsale del piede (gastrocnemio, soleo).
Il valore massimo possibile su questa scala è 100 punti.
Sensibilità viene controllato ai punti di controllo per ciascun segmento e valutato sulla seguente scala:
0 - nessuna sensibilità.
1 - compromissione sensoriale.
2 - sensibilità normale.
La sensibilità e le funzioni motorie vengono valutate bilateralmente e i punteggi ottenuti in ciascun segmento vengono sommati. Quando si valuta la forza muscolare, il punteggio massimo per 10 segmenti su ciascun lato è 50; quando si controlla la sensibilità per 28 segmenti su ciascun lato, è 56 punti.
Secondo il grado di lesione del midollo spinale Tutti i tipi di danno neurologico sono classificati come segue:
UN- danno completo: non si rilevano né funzioni motorie né sensoriali, non ci sono segni di sensibilità anale nei segmenti S4-S5;
IN- lesione incompleta: le funzioni motorie sono assenti al di sotto del livello di lesione, ma sono preservati elementi di sensibilità nei segmenti S4-S5;
CON- lesione incompleta: le funzioni motorie sono preservate al di sotto del livello di lesione e nella maggior parte dei gruppi muscolari di controllo la forza è inferiore a 3 punti;
D- lesione incompleta: le funzioni motorie sono preservate al di sotto del livello di lesione e nella maggior parte dei gruppi muscolari di controllo la forza è pari o superiore a 3 punti;
E- normale: le funzioni motorie e sensoriali non sono compromesse.
Quando si valuta lo stato, viene utilizzato il concetto livello di danno neurologico, che è stato definito come il livello più caudale con funzioni motorie e sensoriali normali (livello con sensibilità invariata e forza muscolare di almeno 3 punti). Secondo questo sistema di classificazione il danno neurologico è considerato completo quando le funzioni motorie e sensoriali sono assenti in entrambi i segmenti sacrali (S4-S5). Se c'è sensibilità o movimento in questi segmenti, il danno è considerato incompleto. Come dimostrato dal lavoro di Stauffer e Waters (1982), tale valutazione è la più informativa nel determinare la prognosi e il grado del successivo recupero neurologico. La classificazione include il concetto di zona di lesione, che ora è stato cambiato nel concetto di zona di violazione parziale (1992). Questa zona è considerata il numero di segmenti situati al di sotto del livello neurologico, dove l'innervazione è parzialmente preservata (American Spinal Injury Association -ASIA; 1992).
Letteratura
1. GELLY R.L., SPITE D.W., Simon P.P. Ortopedia d'urgenza. Colonna vertebrale. - M.: Medicina, 1995, 420 p.
2. DROZDOVA V.N. Sulla fisiologia dello shock spinale. - Nel libro: Problemi di studio sperimentale e clinico delle conseguenze della lesione del midollo spinale. - M., 1956, pp. 36-48.
3. LIVSHITS A.V. Chirurgia del midollo spinale. M.: Medicina, 1990, 330 p.
4. UGRUMOV V.M. Complicazioni delle lesioni della colonna vertebrale e del midollo spinale. - Nel libro: Guida in più volumi alla neurologia. - M., 1962. - T. 8. - P. 588.
5. ALBIN M.S. Lesione spinale cervicale acuta // Crit. Clinica di cura. - 1985. -Vol. 3. - Pag. 267.
6. Comitato sui traumi dell'American College of Surgeons: manuale per studenti del corso Advanced Life Support. Chicago, American College of Surgeons, 1989.
7. Comitato sui traumi dell'American College of Surgeons: supporto vitale avanzato al trauma. Chicago, American College of Surgeons, 1985.
8. American Spinal Injury Association: standard per la classificazione neurologica dei pazienti con midollo spinale. Chicago, Associazione americana per le lesioni spinali, 1982.
9. American Spinal Injury Association: standard per la classificazione neurologica dei pazienti con midollo spinale. Chicago, Associazione americana per le lesioni spinali, 1992.
10. BRACKEN M.B., SHEPARD M.J., COLLINS W.F. et al. Uno studio randomizzato e controllato con metilprednisolone o naloxone nel trattamento delle lesioni acute del midollo spinale // N. Engl. J.Med. - 1990. -Vol. 322. - P. 1405-1411.
11. BRAUGHLER J.M., HALL E.D. Applicazione attuale della terapia steroidea ad alte dosi per lesioni del sistema nervoso centrale: una prospettiva farmacologica // Neurosurg. - 1985. -Vol. 62. - P. 806-810.
12. DEMEDIUK P., SAUNDERS R.D., ANDERSON D.K. et al. Cambiamenti lipidici della membrana nel midollo spinale di gatto laminectomizzato e traumatizzato // Proc. Nati. Accade. Sci. STATI UNITI D'AMERICA. - 1985. -Vol. 82. - P. 7071-7075.
13. DUH M. - S., SHEPARD M. J., WILBERGER M. D. et al. L'efficacia della chirurgia nel trattamento della lesione acuta del midollo spinale e la sua relazione con il trattamento farmacologico // Neurochirurgia. - 1994. -Vol. 35. - P. 248-249.
14. FADEN AL., LEMKE M., DERNEDIUK P. Effetti di BW755C, un inibitore misto della ciclossigenasi-lipossigenasi, a seguito di lesione traumatica del midollo spinale nei ratti // Cervello. Ris. - 1988. - 463. - P. 63-68.
15. FAGAN S.C., CASTELLANI D., GENGO F.M. Concentrazioni di prostanoidi nel liquido cerebrospinale umano dopo infarto cerebrale ischemico acuto // Clin. Esp. Farmaco. Fisiolo. - 1986. -Vol. 13, 10. - P. 629-632.
16. FRANKEL H. L., HANCOCK D. O., HYSLOP G. et al. Il valore della riduzione posturale nella gestione iniziale delle lesioni chiuse della colonna vertebrale con paraplegia e tetraplegia // Paraplegia. - 1969. - 7. - P. 179-192.
17. GEISLER F.H., DORSEY F.C., COLEMAN W.F. Recupero della funzione motoria dopo lesione del midollo spinale: uno studio randomizzato, controllato con placebo con ganglioside GM-I // N. Engl. J.Med. - 1991. -Vol. 324. - P. 1829-1838.
18. GREEN BA, EDGAR R. Dolore da lesione spinale. Nel D.M. Lungo a cura di: Terapia attuale in chirurgia neurologica // Filadelfia, B.C. Decker. - 1989. - P. 294-297.
19. GREEN B.A., KLOSE K.J. Rigenerazione del midollo spinale: l'interfaccia laboratorio/clinica. In Bodis Wollner I., Zimmerman E.A. a cura di: Rigenerazione neurale e trapianto. vol. 6. New York, Alan R. Liss, 1989, pp. 171-182.
20. GREEN B.A., MAGANA I. Trauma del midollo spinale: aspetti clinici. In Davidoff R., a cura di: Manuale del midollo spinale. Vol. IV e V. New York, Marcel Dekker, 1987, pp. 63-92.
21. GREEN B.A., EISMONT F.J., KLOSE K.J. Gestione delle lesioni del midollo cervicale compresi i progressi nell'ingegneria riabilitativa. In Camins M.B., O'Leary P.F. eds.: Disorders of the Cervical Spine, Williams & Wilkins, 1992, P. 351-367.
22. VERDE B.A., VERDE K.L., KLOSE K.J. Terapia cinetica per lesioni del midollo spinale // Colonna vertebrale. - 1983. -Vol. 8. - P. 722-728.
23. GREEN B.A., KHAN T., KLOSE K.J. Uno studio comparativo della terapia steroidea nella lesione acuta sperimentale del midollo spinale // Paraplegia. - 1980. -Vol. 18. - P. 181-186.
24. GREEN B.A., KLOSE K.J., GOLDBERG M.L. Considerazioni cliniche e di ricerca sulla lesione del midollo spinale. In Becker D., Poviishock J. eds.: Rapporto sullo stato dei traumi del sistema nervoso centrale dell'NIH. Bethesda, MD, National Institutes of Health, 1985, pp. 341-368.
25. GREEN B.A., KLOSE K.J., EISMONT F.J. et al. Gestione immediata del paziente con lesione del midollo spinale. In Lee B.Y., Ostrander L., Cochran V.B., Shaw W.W. a cura di: Il paziente con lesioni del midollo spinale: gestione completa. Filadelfia, W. B. Saunders, 1991, pp. 24-33.
26. GREEN B.A., EISMONT F.J., O"HEIR J. Lesione del midollo spinale: un approccio sistemico: prevenzione, servizi medici di emergenza e gestione del pronto soccorso // Crit. Care Clin. - 1987. - Vol. 3. - P. 471 -494.
27. GREEN B.A., GABRIELSON M., HALL W.J. et al. Analisi degli incidenti in piscina con lesioni del midollo spinale // Paraplegia. - 1980. -Vol. 18. - P. 94-100.
28. GUTTMANN L. Lesioni del midollo spinale: gestione e ricerca complete. Oxford, Blackwell Scientific, 1973.
29. Hsu S.U., HALUSHKA P.V., HOG AN E.L. et al. Alterazione dei livelli di thrornboxane e prostaciclina nella lesione sperimentale del midollo spinale // Neurologia. - 1985. -Vol. 35. - P. 1003-1009.
30. Hsu C.Y., HALUSHKA P.V., HOGAN EX., Cox R.D. Aumento del livello di trombossano nella lesione sperimentale del midollo spinale // J. Neurol. Sci. - 1986. -Vol. 74. - P. 289-296.
31. Hsu C.Y., HALUSHKA P.V., SPICER K.M. et al. Profilo temporale dello squilibrio trombossano-prostaciclina nella lesione sperimentale del midollo spinale // Neurol. Sci. - 1988. -Vol. 83. - P. 55-62.
32. KIWAK K.J., MOSKOWITZ M.A., LEVINE L. Produzione di leucotrieni nel cervello di gerbillo dopo insulto ischemico, emorragia subaracnoidea e lesione concussiva // Neurosurg. - 1985. -Vol. 62. - P. 865-869.
33. KLOSE K. J., GREEN B. A., SMITH R. S. et al. Indice neurospinale dell'Università di Miami: un metodo quantitativo per determinare la funzione del midollo spinale // Paraplegia. - 1980. -Vol. 28. - P. 331-336.
34. LEVI L., WOLF A., BELZBERG H. Parametri emodinamici in pazienti con trauma acuto del midollo cervicale: descrizione, intervento e previsione del risultato // Neurochirurgia. - 1993. -Vol. 33. - P. 1007-1016.
35. MlTSUHASHI T., LKATA T., MORHNOTO K. et al. Aumento della produzione di eicosanoidi, TXA, PGI e LTC nelle lesioni sperimentali del midollo spinale // Paraplegia. - 1994. -Vol. 32. - P. 524-530.
36. QUENCER R. M., BUNGE R. P., EGNOR M. et al. Sindrome traumatica acuta del midollo centrale: correlazioni MRI-patologiche // Neuroradiologia. - 1992. -Vol. 34. - P. 8-94.
37. RUGE D. Lesioni del midollo spinale. – Springfield, Thomas, 1969.
38. SCHNEIDER RC La sindrome della lesione acuta del midollo spinale anteriore // J. Neurosurg. - 1955. -Vol. 12. - P. 95-122.
39. SCHNEIDER RC La sindrome della lesione acuta del midollo spinale cervicale centrale // J. Neurosurg. - 1954. -Vol. 11. - P. 546-577.
40. SHARMA H.S., OLSSON Y., CERVOS-NAVARRO J. I primi cambiamenti cellulari perifocali e l'edema nella lesione traumatica del midollo spinale sono ridotti dall'indometacina, un inibitore della sintesi delle prostaglandine: studio sperimentale nel ratto // Ada.
Neuropatolo. - 1993. -Vol. 85. - P. 145-153.
41. TATOR C.H., FEHIINGS M.G. Revisione della teoria della lesione secondaria del trauma acuto del midollo spinale con enfasi sui meccanismi vascolari // J. Neurosurg. - 1991. -Vol. 75. - P. 15-26.
42. TEMPEL G.E., MARTIN H.F. III. Gli effetti benefici di un antagonista del recettore del trombossano sulla perfusione del midollo spinale in seguito a lesione del midollo sperimentale // J. Neurol. Sci. - 1992. -Vol. 109. - P. 162-167.
43. VILLANUEVA P., PATCHEN S.J., GREEN B.A. Lesione del midollo spinale: una sfida in terapia intensiva per gli anni '90. In Sivak E., Higgins T., Seiver A. eds.: The High Risk Patient: Management of the Critically III, Lea & Febiger, 1994, P. 146 -159 .
44. WILCOX N.E., STAUFFER E.S. Follow-up di 423 pazienti consecutivi ricoverati al centro per lesioni del midollo spinale, Ospedale Rancho Los Amigos, dal I gennaio al 31 dicembre 1967 // Paraplegia. - 1972. -Vol. 10. - P. 115-122.
45. WINKLER T., SHARMA H.S., STALBERG E., OLSSON Y. L'indometacina, un inibitore della sintesi delle prostaglandine attenua l'alterazione dei potenziali evocati del midollo spinale e la formazione di edema dopo un trauma al midollo spinale: uno studio sperimentale nel ratto // Neuroscienze . - 1993. -Vol. 52. - P. 1057-1067.