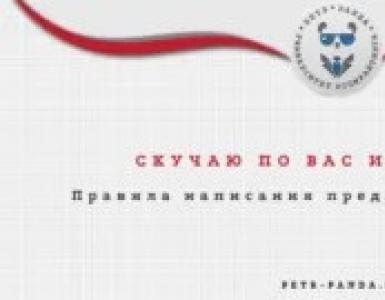Malattie degli animali giovani. Malattie non trasmissibili. Sviluppo metodologico di una lezione aperta "diagnosi delle malattie infettive dei bovini giovani con disturbi digestivi e un sistema di misure per prevenire queste malattie"
Si tratta di una malattia contagiosa ad azione rapida che colpisce tutte le specie animali, compresi gli animali da pelliccia e l'uomo. È caratterizzato da un forte aumento della temperatura corporea, dalla formazione di tumori densi (carbonchi) sulla pelle, sull'intestino, sui polmoni e sulle tonsille.
La malattia è causata da un microbo a forma di bastoncino particolarmente resistente all'azione dei disinfettanti; ad esempio, se bollito, muore dopo 45-60 minuti; una soluzione di formaldeide all'1% o una soluzione di soda caustica al 10% lo uccide solo dopo 2 ore Quando l'agente patogeno entra nel terreno, il microbo forma spore che persistono in esso per decenni.
Gli animali si infettano più spesso al pascolo o attraverso mangimi che contengono spore del microbo dell'antrace provenienti dal terreno. Una persona viene infettata quando taglia le carcasse o apre i cadaveri di animali con antrace.
L'antrace può verificarsi in modo fulmineo, acuto o cronico.
Durante la malattia fulminante, i bovini malati sono agitati, la temperatura corporea sale a 41–42 °C e le mucose degli occhi diventano bluastre. L'animale cade improvvisamente e muore in preda alle convulsioni. Nel decorso acuto si osserva un aumento della temperatura corporea fino a 42 ° C, tremori, cianosi delle mucose degli occhi ed emorragie, nonché gonfiore della cicatrice (timpania). La durata della malattia è fino a 2-3 giorni. Il decorso cronico si manifesta con perdita di peso, gonfiore sotto la mascella inferiore e gonfiore dei linfonodi sottomandibolari e retrofaringei. Spesso, l'antrace si manifesta nella cosiddetta forma carbonulosa, in cui nel sito di penetrazione dell'agente patogeno e in altre parti del corpo appare un gonfiore doloroso duro e ben definito della pelle e del tessuto sottocutaneo, e successivamente si formano ulcere in il centro del gonfiore.
Il cadavere di un animale morto di antrace è gonfio, non c'è rigidità e dall'ano, dalla bocca e dalle narici viene rilasciato fluido sanguinante o sangue non coagulato di colore scuro. Il gonfiore si trova sulla pelle.
Se sospetti l'antrace, dovresti chiamare immediatamente un veterinario. È severamente vietato aprire i cadaveri se si sospetta questa malattia e scuoiarli.
Il trattamento viene effettuato solo da un veterinario, utilizzando siero anti-antrace per via intramuscolare in una dose di 100-200 ml pro capite o gamma globulina - 40-80 ml, antibiotici, ad esempio penicillina per via intramuscolare 2-3 mila unità / kg e altri farmaci .
La base della prevenzione è la vaccinazione annuale degli animali contro l'antrace: bovini adulti - due volte l'anno con un intervallo di 6 mesi, animali giovani - a 3 mesi, seguita dalla rivaccinazione ogni 3 mesi. Gli animali che sono guariti dalla malattia sviluppano un'immunità stabile e duratura.
Rabbia
Questa è una malattia virale acuta che si verifica con gravi danni al sistema nervoso e di solito termina con la morte. Sono colpiti animali da fattoria e domestici di ogni tipo, animali selvatici, soprattutto giovani, nonché esseri umani.
La malattia è causata da un virus termolabile (a una temperatura di 60°C viene distrutto in 5-10 minuti), ma resistente alle basse temperature, rapidamente inattivato se esposto ad alcali e acidi, ma relativamente resistente al fenolo e iodio.
La fonte dell'infezione sono gli animali malati che secernono il virus nella saliva e lo trasmettono attraverso il morso. Il virus persiste nella saliva per 8-10 giorni. Il virus dal sito del morso si diffonde lungo i tronchi nervosi fino al cervello e al midollo spinale, colpendo le cellule nervose, provocando le manifestazioni della malattia. Dal momento dell'infezione alla comparsa dei segni della malattia, possono trascorrere diversi giorni e talvolta diversi mesi. In media, i sintomi compaiono entro 3-6 settimane.
Nei bovini si osserva più spesso una forma silenziosa, che si esprime in muggiti rauchi, sbavando, andatura instabile, perversione dell'appetito e paralisi degli arti. Nella forma violenta si esprime una particolare aggressività nei confronti dei cani: i pazienti rompono il guinzaglio, si lanciano contro i muri, scavano il terreno con gli zoccoli e ruggiscono con voce rauca.
La diagnosi di rabbia viene effettuata sulla base delle caratteristiche epizootiche (diffusione della malattia) e dei segni clinici della malattia, nonché quando è confermata dai risultati di un esame di laboratorio del cadavere.
Il trattamento è inefficace. Un animale malato dovrebbe essere isolato e dovrebbe essere chiamato un veterinario.
La prevenzione si basa sulla vaccinazione degli animali e sull'eliminazione dei cani randagi. Gli animali che hanno morso le persone vengono isolati e tenuti sotto osservazione per 30 giorni.
La malattia di Aujeszky
La malattia di Aujeszky, o falsa rabbia, è una malattia virale acuta dei bovini e di altri animali da fattoria, animali da pelliccia, gatti, cani e roditori (ratti, topi), che si manifesta con danni al sistema nervoso centrale, al sistema respiratorio e caratteristici grattamenti il sito di ingresso del patogeno.
La malattia di Aujeszky è causata da un virus della famiglia degli herpesvirus, sensibile all'etere, al fenolo e ai raggi ultravioletti, ma con pronunciata resistenza nell'ambiente esterno, soprattutto alle basse temperature.
La fonte dell'infezione sono animali malati e portatori di virus. L'infezione avviene da pazienti tenuti insieme e attraverso cibo e aria contaminati dal virus, attraverso ferite e graffi, e il feto viene infettato dalla madre.
Negli animali, dopo un periodo di incubazione da 1 a 15 giorni, appare un forte prurito nei siti di penetrazione del virus, principalmente sulle labbra e sugli arti. Gli animali strofinano questi punti contro gli oggetti circostanti, graffiano e masticano le zone pruriginose del corpo, fino alle ossa esposte (ad esempio un arto). Successivamente compaiono agitazione, convulsioni, forti gemiti, sbavatura e sudorazione profusa, digrignamento dei denti e talvolta cecità. La temperatura corporea rimane normale. Dopo 1-2 giorni l'animale muore.
Tra i neonati, quasi tutto il 100% dei malati muore, nei gruppi fino a 2 mesi di età - fino al 40% e nei gruppi più anziani - 1-3%.
La diagnosi viene stabilita sulla base di dati clinici ed epidemiologici e dei risultati degli esami di laboratorio (biotest).
Il trattamento di solito non funziona.
Per la prevenzione viene utilizzato un vaccino; è inoltre necessario attuare misure veterinarie e sanitarie generali.
afta epizootica
Si tratta di una malattia virale acuta e a rapida diffusione degli animali artiodattili, caratterizzata da febbre a breve termine, formazione di vesciche (ales) ed erosioni sulla mucosa della bocca, sulla fessura interzoccoli, sulla pelle della mammella e sul piano nasale. Anche la persona è malata. Il tasso di mortalità tra gli animali giovani è dell'80-100%, negli animali adulti con forma maligna - 40-90%.
L'agente eziologico è uno dei 7 tipi di virus del genere aphthovirus, che è stabile nell'ambiente esterno, quindi con un'umidità relativa del 30–40% e una temperatura di 18 °C il virus essiccato rimane attivo per 2 anni.
La fonte dell'infezione sono gli animali malati, così come quelli nel periodo di incubazione della malattia (2-21 giorni) e gli individui guariti. Gli animali che hanno contratto un tipo di afta epizootica possono ammalarsi nuovamente se infettati da un diverso tipo di virus. Il virus viene rilasciato nell'ambiente esterno con il contenuto e le pareti di afte, latte, saliva, urina, aria espirata e feci. Si trasmette attraverso il contatto di animali malati con animali sani, nonché attraverso tutti gli oggetti contaminati dal virus.
Nei soggetti malati si manifesta aumento della temperatura corporea, sbavatura e spesso zoppia (Fig. 18). All'esame, sulla mucosa della cavità orale e della lingua si trovano vescicole (afte) piene di liquido limpido o torbido. Le stesse vescicole si trovano sulla pelle della fessura tra gli zoccoli. Successivamente le bolle escono e al loro posto sono visibili aree rosse. I pazienti guariscono in 3-4 settimane, ma durante questo periodo il virus si diffonde attraverso vari oggetti, nonché scarpe e indumenti ad altre famiglie. Durante e dopo la malattia sono possibili aborti, nati morti di vitelli e talvolta la morte.
Riso. 18. Segni di afta epizootica nei bovini:a – danni agli arti; b – secrezione dalle cavità orale e nasale
La diagnosi viene fatta sulla base dei segni clinici.
Il trattamento e la prevenzione devono essere effettuati solo come indicato da un veterinario. È necessario migliorare le condizioni di detenzione e alimentazione degli animali. Si lava il cavo orale con una soluzione di acido acetico al 2%, una soluzione di permanganato di potassio in rapporto 1:1000, si utilizzano antibiotici, farmaci cardiaci, glucosio per via endovenosa e, se colpite le estremità, pediluvi con una soluzione al 5%. vengono utilizzate soluzioni di formaldeide. Se sospetti l'afta epizootica, dovresti chiamare immediatamente un veterinario e adottare tutte le misure per prevenire la diffusione del virus: quarantena, isolamento del focolaio di afta epizootica.
Tubercolosi
Questa è una malattia contagiosa degli animali e dell'uomo, che si manifesta cronicamente e caratterizzata dalla formazione di tubercoli in vari tessuti e organi soggetti a necrosi (tubercoli).
L'agente eziologico della malattia è un micobatterio altamente resistente all'azione dei disinfettanti, ad esempio se riscaldato a 85 °C muore dopo 30 minuti e una soluzione al 5% di formaldeide provoca la morte dopo 12 ore. può sopravvivere nel terreno per 1-2 anni, nell'acqua dei fiumi - 5 mesi, nelle feci e sui pascoli - 1 anno.
La fonte dell'infezione è un animale malato che rilascia agenti patogeni nell'ambiente esterno con espettorato, secrezione nasale, latte, urina e feci. L'infezione avviene a livello nutrizionale e aerogeno. La diffusione della malattia è facilitata dagli allevamenti affollati di animali, dal pascolo e dall'abbeveraggio di individui sani e malati e dalla somministrazione di latte scremato non disinfettato agli animali giovani.
Il periodo di incubazione della malattia dura fino a 45 giorni. La malattia spesso si presenta senza segni caratteristici, in forma cronica; solo quando qualche organo è danneggiato compaiono i segni corrispondenti. Nei bovini, i polmoni o l’intestino sono più spesso colpiti. In questo caso si possono osservare tosse o diarrea e, se è colpita la mammella, si sviluppa una mastite con gonfiore dei linfonodi sovramammellali.
La diagnosi può essere fatta solo dopo aver condotto studi batteriologici, allergici e sierologici, eseguiti da un veterinario, differenziando la malattia da polmonite contagiosa, paratubercolosi, actinomicosi, leucemia.
Gli animali malati vengono uccisi. La quarantena in allevamento è obbligatoria.
 Riso. 19. Reazione intradermica positiva alla tubercolina nei bovini
Riso. 19. Reazione intradermica positiva alla tubercolina nei boviniLa base della prevenzione è l'esame di tutti gli animali con un test alla tubercolina. Coloro che reagiscono alla tubercolina vengono inviati alla macellazione (Fig. 19). Va ricordato che gli animali affetti da tubercolosi possono espellere gli agenti patogeni nel loro latte, attraverso i quali l'uomo si infetta. Questo latte è particolarmente pericoloso per i bambini.
Brucellosi
Si tratta di una malattia cronica degli animali e dell'uomo, caratterizzata da aborto, ritenzione della placenta, infiammazione della mucosa uterina e spesso danni alle articolazioni.
L'agente causale, il batterio Brucella, non è molto resistente ai disinfettanti; ad esempio, la bollitura lo uccide all'istante. La Brucella rimane vitale nel terreno da diversi giorni a 100 giorni o più, a seconda dell'umidità e dell'insolazione.
Gli animali affetti da brucellosi espellono l'agente patogeno nel latte, con le secrezioni dal canale del parto, durante l'aborto, il parto e anche nelle urine. L'infezione avviene attraverso le mucose del tratto digestivo con cibo e acqua, la congiuntiva, le mucose delle vie respiratorie, la vagina e la pelle. Una persona può essere infettata da animali malati.
Il periodo di incubazione della malattia è di 2-3 settimane o più. La brucellosi è cronica e nella maggior parte dei casi asintomatica. Il sintomo principale della malattia nelle femmine è l'aborto e la ritenzione della placenta e nei maschi l'infiammazione dei testicoli. Nelle mucche, l'aborto avviene a 7-8 mesi di gravidanza. Più della metà delle mucche e delle manze della mandria abortiscono.
La diagnosi viene effettuata sulla base dei risultati di studi clinici, sierologici, allergici e batteriologici del feto abortito o del suo stomaco, pezzi di fegato e milza, nonché latte e sangue in un laboratorio veterinario. Quando si effettua una diagnosi, è necessario escludere campilobatteriosi, tricomoniasi, leptospirosi, salmonellosi e malattie non trasmissibili con sintomi di aborto.
Gli animali malati non vengono curati e vengono mandati al macello. La quarantena in allevamento è obbligatoria.
Per la prevenzione, l'allevamento deve essere dotato di animali testati per la brucellosi. Tutti i casi di aborto devono essere segnalati al veterinario.
Pasteurellosi
Si tratta di una malattia infettiva dei bovini e di altri animali domestici e selvatici, caratterizzata nella sua forma acuta da segni di setticemia (una forma di sepsi di un'infezione generale, in cui microrganismi patogeni sono presenti nel sangue senza coinvolgere vari organi e tessuti del processo infiammatorio) e infiammazione emorragica delle mucose delle vie respiratorie e dell'intestino. Anche la persona è malata.
L'agente patogeno Pasteurella non è molto resistente all'azione dei disinfettanti; ad esempio, se riscaldato a 70–90 °C, muore entro 5-10 minuti. La sopravvivenza massima nel suolo e nell'acqua è di 26 giorni, nel letame – 72 giorni.
Gli animali malati e guariti rilasciano la pasteurella nell'ambiente esterno attraverso le secrezioni nasali e le feci. L'insorgenza della malattia in qualsiasi periodo dell'anno è influenzata da fattori di stress. Le vie di infezione sono nutrizionali e aerogene. La mortalità varia dal 10 al 75%.
Il decorso della malattia è iperacuto, acuto, subacuto e cronico. Il periodo di incubazione (il tempo dal momento in cui l'agente patogeno entra nel corpo dell'animale fino alla comparsa dei primi segni clinici) dura da alcune ore a 2-3 giorni, a volte di più.
Nei casi iperacuti, gli animali muoiono rapidamente dopo un aumento della temperatura corporea e lo sviluppo di diarrea, e talvolta senza mostrare alcun segno.
Nei casi acuti, la temperatura corporea dei bovini aumenta, compaiono mancanza di respiro, tosse, secrezione dalle narici e talvolta diarrea mista a sangue (più spesso negli animali giovani); inoltre, può verificarsi gonfiore alla testa, alla faringe e al collo. verificarsi. Nella maggior parte dei casi gli animali muoiono oppure la malattia assume un decorso subacuto o cronico.
Il decorso cronico è accompagnato da emaciazione, anemia, gonfiore delle articolazioni e delle gambe.
La diagnosi viene effettuata sulla base di dati clinici ed epidemiologici e dei risultati dell'esame batteriologico di parte degli organi interni dei cadaveri. Quando si effettua una diagnosi, è necessario escludere la febbre paratifo e l'antrace.
Ai pazienti viene somministrato siero iperimmune contro la pasteurellosi in una dose di 60-80 ml e antibiotici tetraciclinici, farmaci sulfamidici e agenti sintomatici.
La prevenzione consiste nel somministrare un vaccino a individui sani, immunizzare tutti gli animali che hanno avuto contatti con animali malati, isolare gli individui malati e disinfettare i locali.
Leptospirosi
Si tratta di una malattia infettiva di molte specie di animali: bovini grandi e piccoli, maiali, cavalli, cani, cammelli, animali da pelliccia, piccoli mammiferi selvatici di tutte le razze ed età, caratterizzata da febbre, anemia (anemia), ittero, aborto di animali gravidi o nascita di prole non vitale, danno renale (emoglobinuria - presenza di emoglobina nelle urine), necrosi delle mucose e della pelle, atonia del tratto gastrointestinale. Anche la persona è malata.
È causato da un microrganismo, la Leptospira, che non è resistente all'azione dei disinfettanti, ma muore rapidamente se riscaldato.
Gli animali malati e guariti espellono l'agente patogeno nelle urine per lungo tempo. L'infezione avviene più spesso attraverso il cibo e l'acqua.
Il decorso della malattia può essere acuto, subacuto, cronico e asintomatico. Nei bovini adulti è spesso asintomatica, ma nei bovini giovani è acuta. Nei casi acuti, la temperatura corporea dei malati aumenta e nelle urine appare sangue. Alcuni animali presentano scolorimento itterico e necrosi delle mucose degli occhi, della bocca e di alcune aree della pelle, spesso diarrea o stitichezza. Gli animali gravidi abortiscono. Nel decorso subacuto si notano gli stessi sintomi, ma meno pronunciati, e nel decorso cronico i sintomi sono debolmente espressi, emaciazione e diminuzione dei progressi della produttività.
La diagnosi viene effettuata sulla base di dati clinici ed epidemiologici e dei risultati degli esami del sangue di laboratorio. Poiché, indipendentemente dal decorso della malattia, nel sangue dell'animale vengono rilevati anticorpi specifici 5-7 giorni dopo l'infezione, la leptospirosi si sviluppa dopo 10-20 giorni e dura fino a 1-2 anni. Il numero di portatori di leptospirone in un'azienda agricola sfavorevole a questa malattia tra i bovini può essere dell'1–5%, meno spesso – 10–20%. La leptospirosi deve essere differenziata dalla brucellosi, campilobatteriosi, tricomoniasi, salmonellosi e altre malattie.
Per il trattamento viene utilizzato l'antibiotico streptomicina, che viene somministrato per via intramuscolare in una quantità di 10-12 mila unità per 1 kg di peso corporeo ogni 12-14 ore per 4-5 giorni.
La prevenzione della leptospirosi consiste nella messa in quarantena degli animali appena arrivati, nell'attuazione di misure di deratizzazione e nell'ispezione di routine del bestiame. Gli animali malati vengono isolati e curati, il resto della popolazione viene curato. Negli allevamenti svantaggiati agli animali viene somministrato un vaccino polivalente contro la leptospirosi.
Listeriosi
Si tratta di una malattia infettiva dei bovini e degli animali di quasi tutte le specie, compreso il pollame, nonché dell'uomo, caratterizzata da danni al sistema nervoso, fenomeni settici, aborto e mastite. La mortalità varia dal 47 al 100%.
L'agente eziologico è un piccolo batterio - Listeria, che è stabile nell'ambiente esterno e persiste a lungo nel suolo, nell'acqua e sulle piante. I disinfettanti comunemente usati lo disattivano rapidamente.
La fonte dell'agente patogeno sono animali malati e guariti che rilasciano l'agente patogeno nell'ambiente esterno con urina, feci, latte, secrezione dalla cavità nasale, occhi, genitali e animali portatori di listeria. Il serbatoio della Listeria in natura sono i roditori e alcune specie di animali selvatici. L'infezione avviene a livello nutrizionale, aerogeno, attraverso la pelle danneggiata e le mucose degli organi genitali.
Il periodo di incubazione della listeriosi è di 7-30 giorni. La malattia si manifesta in modo acuto, subacuto e cronico. Si differenzia da altre malattie infettive nella varietà delle forme di manifestazione clinica: nervosa, settica, genitale, atipica, asintomatica.
Con la forma nervosa, i bovini sperimentano depressione, rifiuto di nutrirsi, talvolta aumento della temperatura corporea, fotofobia, lacrimazione, perdita di appetito, diarrea, convulsioni e coma. La durata di questa forma della malattia è di 7-14 giorni, nella maggior parte dei casi gli animali muoiono.
La forma genitale si manifesta con aborti nella 2a metà della gravidanza, ritenzione della placenta, endometrite e mastite.
La forma atipica con sintomi di febbre, polmonite e gastroenterite è rara.
La diagnosi viene effettuata sulla base dei segni clinici e dell'esame di laboratorio degli organi colpiti del cadavere.
Il trattamento è spesso inutile, tuttavia, a volte all'inizio della malattia vengono prescritti antibiotici tetraciclinici, ad esempio clortetraciclina per via orale alla dose di 25-30 mg/kg di peso animale, ossitetraciclina o tetraciclina allo stesso dosaggio 2-3 volte al giorno fino a quando recupero e 3 giorni dopo.
Per prevenire la listeriosi, è necessario adottare misure per prevenire l'introduzione dell'agente patogeno nell'azienda agricola, misure di deratizzazione e controllo della qualità dei mangimi (soprattutto insilati). Se in un allevamento vengono rilevati pazienti affetti da listeriosi, vengono imposte restrizioni sull'importazione o sull'esportazione di animali. Gli animali che mostrano segni di danni al sistema nervoso vengono inviati al macello. Agli animali rimanenti vengono vaccinati o trattati con antibiotici per via orale in dosi terapeutiche 1-2 volte al giorno per 1 settimana.
Tricofitosi
La tricofitosi, o tigna, è una malattia fungina contagiosa caratterizzata dalla formazione sulla pelle di aree calve rotonde e nettamente limitate con capelli spezzati, ricoperte di croste e squame. Anche la persona è malata.
La malattia è causata dai funghi trichophyton, che sono altamente resistenti al calore e ai disinfettanti. Persistono a lungo nell'ambiente esterno: sulla lettiera, nel terreno, sugli oggetti in legno.
I portatori di funghi patogeni sono topi, ratti e altri roditori. La fonte dell'infezione sono gli animali malati e guariti che infestano locali e attrezzature. Le condizioni meteorologiche avverse, soprattutto nel periodo autunno-invernale, e i danni superficiali alla pelle contribuiscono alla manifestazione della tigna.
Il periodo di incubazione dura da 1 settimana a 1 mese. La malattia è cronica e si esprime nella comparsa sulla pelle di piccole macchie rotonde, glabre, ricoperte di squame e croste grigio-amianto. Molto spesso viene colpita la pelle intorno agli occhi, al naso e alle orecchie, diffondendosi all'intero cuoio capelluto, al collo e agli arti.
La diagnosi viene effettuata sulla base dei segni clinici e dell'irradiazione ultravioletta delle aree interessate e sull'esame microscopico dei raschiati cutanei, che viene effettuato in un laboratorio veterinario.
Per trattare la tigna, le aree colpite vengono trattate con agenti fungicidi. Per scopi terapeutici e profilattici, vaccini vivi e inattivati altamente efficaci, affidabili e poco tossici vengono utilizzati in dosi 2 volte superiori a quelle profilattiche.
Per prevenire la malattia e la reinfezione, la vaccinazione e le misure igienico-sanitarie vengono effettuate all'interno e all'esterno.
Actinomicosi
L'actinomicosi è una malattia infettiva cronica caratterizzata dalla formazione di tumori (granulomi) in vari organi, il più delle volte nella mascella inferiore.
La malattia è causata da un fungo radiante: l'actinomicete, che vive nel terreno, su foraggi grossolani e mangimi concentrati. L'agente patogeno muore se riscaldato a 70–80 °C per 5 minuti, in una soluzione di formaldeide al 3% per 5–7 minuti. La bassa temperatura favorisce la sopravvivenza degli attinomiceti per 1-2 anni.
I microbi penetrano nei tessuti, causandone danni, quando si mangia mangime attraverso la mucosa orale danneggiata, attraverso la pelle danneggiata, i capezzoli delle mammelle, le ferite di castrazione, il tratto respiratorio superiore e durante la dentizione negli animali giovani.
Nei bovini vengono colpiti le ossa e i tessuti della mascella inferiore, i linfonodi e le ghiandole mammarie (se infettati attraverso i capezzoli della mammella). Nell'area dello spazio intermascellare appare un tumore denso, che aumenta di dimensioni, poi si ammorbidisce e la pelle si rompe (Fig. 20). Da una o più fistole risultanti fuoriesce un pus giallastro e cremoso contenente granuli grigio-giallastri delle dimensioni di un chicco di miglio. Il pus diventa poi sanguinante e si mescola a frammenti di tessuto morto. I tumori della faringe e della laringe rendono difficile la deglutizione e talvolta la respirazione. La temperatura corporea dei pazienti è inizialmente normale, ma in seguito, quando la malattia è complicata da altri microbi, aumenta.
 Riso. 20. Actinomicosi della mascella inferiore dei bovini
Riso. 20. Actinomicosi della mascella inferiore dei boviniLa diagnosi viene effettuata sulla base dei segni clinici e dei risultati di laboratorio del pus.
Gli animali raramente guariscono senza trattamento. Pertanto, la penicillina (100-400 mila unità) viene iniettata nel sito del tumore per 4-5 giorni o l'ossitetraciclina (200-400 mila unità). Questi stessi antibiotici vengono iniettati nel tessuto sano attorno al tumore. Evitare lesioni alle mucose del cavo orale. Le aree danneggiate vengono trattate con soluzioni disinfettanti. Il cibo ruvido e graffiante deve essere cotto a vapore prima di essere somministrato.
Necrobatteriosi
La necrobatteriosi, o panaritium dei bovini, è una malattia infettiva caratterizzata da necrosi e decomposizione purulenta della pelle della fessura interzoccolo e della corolla, in alcuni casi sulla mammella, nella cavità orale, nei genitali, nel fegato, nei polmoni e negli animali giovani - necrosi di singole aree delle cavità della mucosa orale. I più sensibili alla malattia sono bovini, renne, pecore, cavalli e polli.
La necrobatteriosi è causata da un batterio a forma di bastoncino, che risiede permanentemente nel tratto gastrointestinale (nel rumine dei ruminanti) ed è diffuso nell'ambiente. L'agente patogeno è relativamente resistente ai disinfettanti, ad esempio, in una soluzione di formaldeide (1: 100) e una soluzione al 2,5% di creolina muore dopo 20 minuti, in una soluzione al 5% di soda caustica - dopo 10 minuti e quando riscaldato a 100°C – in 1 min.
La fonte dell'infezione sono gli individui malati e guariti, così come gli individui sani. Gli animali si infettano quando l'agente patogeno penetra nel terreno, dove i batteri patogeni vivono costantemente, soprattutto in luoghi umidi. La necrobatteriosi si verifica più spesso durante i periodi umidi dell'anno, con lesioni alla pelle o alle mucose e quando gli animali vengono tenuti in stanze umide su lettiere sporche e bagnate. L’incidenza può raggiungere il 30–90%.
Il periodo di incubazione dura fino a 3 giorni. Le persone malate sperimentano la zoppia. Quando si esamina la fessura interzoccolo e la corolla, vengono rilevati arrossamento e gonfiore della pelle. Successivamente l'area arrossata si espande, sulla pelle della fessura interzoccolo e della corolla appare un versamento sieroso e si forma un'ulcera con bordi frastagliati. L'arto interessato è caldo al tatto e doloroso. L'animale è depresso, non mangia cibo e la sua temperatura corporea aumenta.
Nei vitelli si osservano densi film grigio-bianchi o giallastri, strettamente collegati al tessuto, sulla lingua, sulle gengive e meno spesso sul palato. Se appare una malattia che colpisce la pelle della fessura tra gli zoccoli e la mucosa della cavità orale, è necessario invitare urgentemente un veterinario, poiché approssimativamente gli stessi segni si osservano con l'afta epizootica e alcuni altri pericolosi malattie virali.
La diagnosi viene posta sulla base dei segni clinici e degli studi batteriologici, differenziando dall'afta epizootica, dalla diarrea virale e dalla febbre catarrale maligna dei bovini.
Durante il trattamento, le ulcere necrotiche vengono trattate chirurgicamente, il tessuto morto viene rimosso e la ferita pulita viene lavata con una soluzione al 3% di permanganato di potassio o una soluzione al 3% di perossido di idrogeno. La clortetraciclina viene somministrata per via intramuscolare alla dose di 3–4 mg/kg di peso corporeo per 3–5 giorni, dibiomicina, ditetraciclina (15mila unità/kg).
Dato che la necrobatteriosi si verifica negli allevamenti dove sussistono le condizioni per danni alle estremità, in particolare alla pelle della fessura interzoccolo e della corolla, vengono adottate misure per eliminare questi fattori: fornire lettiera asciutta nelle stalle, rifilatura tempestiva, rifilatura delle zoccoli, ecc. Quando appare la malattia, i pazienti vengono isolati e trattati e vengono esaminati gli zoccoli degli animali rimanenti, le ferite esistenti vengono trattate con una soluzione disinfettante (soluzione di creolina al 5-10%, soluzione di formaldeide al 2-10%, soluzione di rame al 5%) soluzione di solfato, ecc.). Sono utili i pediluvi con le soluzioni indicate per 3–5 giorni.
Carbonchio enfisematoso
Il carbonchio enfisematoso, o emcar, è una malattia infettiva acuta caratterizzata dalla formazione di tumori in aree del corpo ricche di muscoli e da morte rapida. Sono colpiti i bovini di età compresa tra 3 mesi e 4 anni, poiché i bovini giovani acquisiscono l'immunità passiva attraverso il latte materno e gli animali di età superiore a 4 anni sono immuni a causa dell'immunità acquisita spontaneamente.
L'agente eziologico è il microbo anaerobico sporigeno Clostridium, che è molto resistente ai disinfettanti, ad esempio una soluzione di formaldeide al 3% lo uccide dopo 10 minuti e la luce solare diretta lo uccide dopo 24 ore. Sotto forma di spore, l'agente patogeno può sopravvivere nel terreno fino a 35 anni e più.
La fonte dell'agente infettivo sono gli animali malati, nei cui cadaveri si formano spore che infettano l'ambiente. Gli animali si infettano con cibo e acqua attraverso la pelle danneggiata. La malattia ha una stagionalità estivo-autunnale.
Il periodo di incubazione della malattia è di 1-5 giorni. Nei pazienti, la temperatura corporea sale fino a 41 °C, si forma un gonfiore, inizialmente caldo e doloroso, poi freddo e indolore, e successivamente si sviluppa zoppia. Le persone malate muoiono entro poche ore.
La diagnosi viene stabilita sulla base di dati clinici ed epidemiologici, nonché dei risultati dell'esame di laboratorio del contenuto dei gonfiori. La malattia si differenzia dall'edema maligno, dall'antrace e dalla pasteurellosi.
Il trattamento, di regola, è inutile a causa della morte rapida, ma può essere efficace nella fase iniziale della malattia (penicillina alla dose di 4-8 mila unità/kg, dibiomicina - 40 mila unità/kg).
Per la prevenzione, tutti gli animali di età superiore a 3 mesi e inferiore a 4 anni vengono vaccinati e, se si verifica una malattia, l'allevamento viene messo in quarantena.
Febbre catarrale maligna
Questa è una malattia virale acuta caratterizzata dall'infiammazione delle mucose della cavità orale, delle vie respiratorie, degli occhi, del seno frontale, nonché dallo sviluppo di danni ai polmoni, all'intestino e al sistema nervoso centrale.
L'agente eziologico è un virus dell'herpes resistente ai disinfettanti. Ad esempio, a una temperatura di 4 °C muore dopo 14 giorni.
La malattia non è contagiosa e si manifesta più spesso quando bovini e ovini vengono tenuti insieme, soprattutto in autunno e primavera. La fonte dell'infezione sono animali malati e portatori di virus.
Il periodo di incubazione varia da diverse settimane a 3-4 mesi. Gli animali malati mostrano diffidenza, paura, depressione o violenza. La temperatura corporea sale fino a 41–42 °C, la sete si manifesta con completa perdita di appetito e mancanza di gomme da masticare, fotofobia, lacrimazione abbondante e gonfiore delle palpebre. Successivamente, l'iride e la cornea vengono colpite (opacizzazione con ulcerazione), la mucosa della cavità orale diventa rosso vivo, quindi compaiono zone morte, la mucosa nasale è secca, con crepe. I pazienti sviluppano diarrea, infiammazione dei bronchi e dei polmoni. Gli animali che sono guariti dalla malattia non sviluppano l’immunità.
La diagnosi viene posta sulla base dei segni clinici, distinguendo dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla leptospirosi.
Nel trattamento vengono utilizzati farmaci cardiaci, glucosio, antibiotici e farmaci sulfamidici. È utile somministrare per via sottocutanea per due volte (ogni 48 ore) 80-100 ml di sangue prelevato da un animale malato (autoemoterapia).
A scopo preventivo, bovini e ovini non dovrebbero essere tenuti insieme.
Parainfluenza
Si tratta di una malattia virale contagiosa acuta caratterizzata da danno primario al sistema respiratorio. Colpisce principalmente i vitelli di età compresa tra 10 giorni e 5-6 mesi.
L'agente eziologico è il paramixovirus, che è scarsamente resistente ai disinfettanti. Ad esempio, viene inattivato da etere, cloroformio, soluzioni di acidi e alcali.
La fonte dell'agente infettivo sono animali malati e portatori del virus che infettano individui sani tramite goccioline trasportate dall'aria ed eventualmente per via orale con il latte di mucche malate; la trasmissione sessuale non può essere esclusa. Si verifica più spesso nella stagione fredda, facilitata dallo stress, in particolare dal trasporto e dall'affollamento degli animali.
Il periodo di incubazione della malattia dura 24-30 ore e si sviluppano depressione, iperemia della mucosa nasale, lacrimazione, secrezione nasale, mancanza di respiro, aumento della temperatura corporea fino a 40,9-41,5 °C, tosse e congiuntivite.
La diagnosi viene posta sulla base dei risultati degli esami di laboratorio su strisci, tamponi prelevati dalla mucosa nasale al 2-5° giorno di malattia, campioni di siero sanguigno prelevati nei primi 2-3 giorni, poiché i sintomi della parainfluenza sono simili ad altri malattie virali respiratorie.
Gli animali malati vengono isolati e curati, gli animali rimanenti e le mucche madri vengono vaccinati. Per il trattamento vengono utilizzati siero iperimmune, globulina non specifica, siero convalescente e allo stesso tempo antibiotici, sulfamidici e farmaci nitrofuranici.
Le misure di prevenzione e controllo consistono nell'osservanza delle misure veterinarie, sanitarie e tecnologiche generali per l'allevamento del bestiame, nonché nella vaccinazione preventiva dei vitelli, poiché gli animali guariti sono immuni alla reinfezione e i vitelli nati da mucche immuni ricevono anticorpi con il colostro. Pertanto, la vaccinazione è più efficace durante il periodo di estinzione degli anticorpi materni (5-7 giorni dopo la nascita).
Rinotracheite infettiva
Si tratta di una malattia contagiosa che si manifesta nelle forme respiratorie, genitali, congiuntivali, nervose e con sintomi atipici.
L'agente eziologico della malattia è un virus dell'herpes, che non è molto resistente ai disinfettanti; ad esempio, viene rapidamente inattivato in un ambiente acido e distrutto in una soluzione di formaldeide (1:500).
I bovini sono suscettibili alla rinotracheite infettiva, indipendentemente dalla razza e dall’età. La fonte del virus sono animali malati e guariti (quasi per tutta la vita). Il virus si diffonde attraverso la tosse, la secrezione nasale, l'accoppiamento libero o attraverso lo sperma durante l'inseminazione artificiale. L'infezione si verifica quando gli animali malati e quelli sani vengono tenuti insieme. La rapida diffusione è facilitata dalla formazione di un gruppo di bestiame e dai suoi alloggi affollati. Le epidemie si verificano 6-30 giorni dopo l'introduzione di nuovi lotti di bestiame.
La forma respiratoria si osserva soprattutto nei vitelli da ingrasso, manifestandosi con secrezione nasale, tosse, febbre, perdita di appetito, mancanza di respiro, secrezione di liquido schiumoso dalla bocca, grave iperemia (trabocco di sangue) della pelle del piano nasale. Senza complicazioni, la malattia dura 5-7 giorni e termina con il recupero. Con complicazioni si sviluppa una broncopolmonite che dura diverse settimane. Gli animali perdono molto peso e il tasso di mortalità in questo caso è elevato.
La forma genitale è osservata nelle mucche e nei tori. Si manifesta come una lesione caratteristica degli organi genitali: iperemia e gonfiore delle mucose della vulva, vestibolo della vagina, secrezione viscosa mucopurulenta, frequente bisogno di urinare. Nei tori è caratterizzata dalla comparsa di pustole sulle mucose del prepuzio, del glande e del corpo del pene. La malattia dura 10-15 giorni, la temperatura aumenta brevemente e termina con la guarigione. Nelle mucche e nelle manze gravide, è accompagnato da aborti dopo 5-6 mesi di gravidanza in assenza di altri sintomi della malattia.
La forma congiuntivale è accompagnata da lacrimazione, essudato, iperemia e gonfiore della congiuntiva, piccole emorragie su di essa e, in caso di complicazioni, annebbiamento della cornea.
La forma nervosa si verifica nei vitelli fino a 6 mesi di età. Si osservano anoressia, aumento della temperatura corporea, incoordinazione dei movimenti e contrazioni muscolari spasmodiche, della durata di 3-4 minuti, che portano alla caduta dell'animale. I vitelli perdono peso e muoiono entro 3-7 giorni.
La diagnosi viene fatta sulla base di esami di laboratorio del sangue e delle secrezioni nasali, distinguendo dalla diarrea virale, dalla parainfluenza, dalla febbre catarrale e dalla pasteurellosi.
Per il trattamento vengono utilizzati sieri iperimmuni, globuline, sieri convalescenti (ad esempio, per i vitelli, un aerosol in una dose di 2 ml/m 2 ambiente, antibiotici tetraciclinici nella quantità di 5 μg/ml sono pre-disciolti nel siero) , e in caso di complicazioni con una seconda infezione, vengono utilizzati antibiotici prolungati (a lungo termine). ), azioni sulfamidici e nitrofuraniche.
Come misura preventiva, i bovini malati vengono isolati e quelli sani vengono vaccinati. Per prevenire la diffusione e l'introduzione dell'infezione nell'allevamento, nei locali vengono collocati animali della stessa età, rispettando le norme microclimatiche, nonché adottando altre misure veterinarie e sanitarie per disinfettare i locali.
Diarrea virale bovina
Si tratta di una malattia contagiosa caratterizzata da infiammazione e ulcerazione delle mucose del tratto digestivo, rinite, febbre, diarrea e talvolta zoppia. Gli animali giovani di età compresa tra 2 mesi e 2 anni sono i più sensibili, ma anche i vitelli molto giovani possono ammalarsi.
L'agente causale è il togavirus, che è scarsamente resistente all'azione dei disinfettanti, come l'etere e il cloroformio, e ad una temperatura di 37 °C il virus muore dopo 5 giorni.
La fonte dell'infezione sono gli animali malati. L'insorgenza della malattia è facilitata da fattori di stress, da una grande concentrazione di animali sensibili e dal loro raggruppamento. L'infezione avviene tramite goccioline trasportate dall'aria, con acqua potabile, cibo e attraverso il contatto diretto di animali malati con animali sani, soprattutto quando fa freddo. Si presenta spesso come un'infezione mista con parainfluenza e altre malattie respiratorie.
Il periodo di incubazione della malattia dura da 1 a 14 giorni. Si manifesta in modo latente, subacuto, acuto, cronico. Nei casi acuti e subacuti, la temperatura corporea aumenta improvvisamente (fino a 42,4 °C), si verificano depressione, tachicardia, leucopenia (dal 2 al 4° giorno), appare secrezione nasale e poi tosse, congiuntivite, lacrimazione, salivazione, erosione e ulcere sulle labbra, sulle gengive, sul dorso della lingua e spesso nella zona tra gli artigli. Il 7-9 giorno appare la diarrea, che dura 1-4 settimane. Le feci sono acquose, scure, con bolle di gas, spesso con muco e coaguli di sangue. Le mucche incinte subiscono aborti.
Il decorso cronico si manifesta con un lento emaciamento, diarrea e morte degli animali.
Con un decorso latente, non si osservano segni visibili.
La diagnosi viene effettuata sulla base dei risultati degli esami di laboratorio sul siero del sangue.
Il trattamento per la diarrea virale è sintomatico. Nella fase iniziale della malattia vengono prescritti antibiotici ad ampio spettro, ad esempio sintomicina per via orale ogni 6-8 ore a 0,03-0,04 g/kg di peso corporeo dell'animale per 3-5 giorni, clortetraciclina (biomicina) - 2-3 volte al giorno 0,02 g/kg di peso corporeo fino al recupero, streptomicina - per via intramuscolare 3-5 mila unità, eritromicina - 40 mila unità 2 volte al giorno per 4-6 giorni, nonché per via orale ittiolo 5-10 g per 100 –200 ml di acqua per 3-4 giorni.
A scopo profilattico vengono utilizzati interferone bovino, sieri iperimmune, sieri convalescenti e per creare un'immunità attiva, gli animali vengono vaccinati con vaccino vivo (nelle aziende da ingrasso) e inattivato (per il bestiame riproduttivo) contro la diarrea virale. Inoltre proteggono l’azienda agricola dall’introduzione dell’agente patogeno tramite portatori di virus, mangimi, attrezzature, trasporti, ecc.
Encefalopatia spongiforme bovina
Si tratta di una malattia infettiva a decorso lento caratterizzata da danni al sistema nervoso: alterazioni degenerative nel cervello con formazione di vacuoli.
L'agente eziologico della malattia è un prione, una particella infettiva simile a una proteina resistente ai fattori di inattivazione.
I bovini adulti sono malati - da 2,9 a 11 anni. La fonte dell'infezione sono gli animali malati. Si rivelano gradualmente e costantemente, indipendentemente dalla stagione dell'anno. Anche i vitelli possono essere infettati dall'agente patogeno.
Il periodo di incubazione della malattia dura da 2,5 a 8 anni. I sintomi compaiono solo negli animali adulti. Si osservano paura, paura, cadute sotto l'influenza del rumore o del tatto, a volte aggressività, digrignamento dei denti, tremori muscolari, atassia, andatura ondeggiante, debolezza degli arti pelvici e aumento della sensibilità al dolore. La temperatura corporea rimane normale. La fase clinica dura fino a 1-5 mesi o più. L'esito è fatale.
La diagnosi viene fatta sulla base dell'esame istologico del cervello.
Poiché l'agente patogeno è diffuso all'estero, è necessario adottare misure per prevenire l'introduzione dell'agente patogeno, in particolare con i prodotti della macellazione del bestiame.
Salmonellosi o febbre paratifoide
Si tratta di una malattia infettiva dei bovini giovani e di altri animali da fattoria, molto spesso dopo lo svezzamento o quando vengono trasferiti al latte, nonché degli animali da pelliccia, caratterizzata da danni all'intestino, ai polmoni, al fegato e ad altri organi.
La salmonellosi è causata dal microbo Salmonella, poco resistente all'azione dei disinfettanti.
I vitelli vengono infettati all'età di 10 giorni fino a 2 mesi da animali malati e portatori di batteri in qualsiasi periodo dell'anno, più spesso nella stagione invernale-primaverile, attraverso mezzi nutrizionali, spesso attraverso latte infetto e latte scremato.
Il periodo di incubazione dura 1–8 giorni. Il decorso della malattia è acuto o cronico. Durante il decorso acuto, gli individui malati hanno un aumento della temperatura corporea (febbre), si rifiutano di nutrirsi e si sdraiano di più. Il 2-3o giorno appare la diarrea, le feci sono liquide, c'è molto muco e talvolta sangue. Si notano aumento della respirazione e congiuntivite. Se un animale malato non muore entro 3-5 giorni, sviluppa un decorso cronico, caratterizzato dalla comparsa di tosse, mancanza di respiro, polmonite e infiammazione delle articolazioni. I pazienti muoiono entro 5-10 giorni, alcuni guariscono e restano indietro nello sviluppo per molto tempo. Tali animali possono infettare quelli sani.
La diagnosi viene effettuata sulla base di dati clinici ed epizoologici, dei risultati dell'esame batteriologico e sierologico del sangue e dei tessuti degli animali morti. È necessario differenziare la salmonellosi dalla dispepsia e dalla colibacillosi.
Ai pazienti vengono somministrati antibiotici per via orale (sintomicina, cloramfenicolo, clortetraciclina, terramicina), farmaci sulfamidici (norsulfazolo, etazolo) e nitrofurani (furazolidone, furagina). Data la compatibilità di questi agenti terapeutici, le loro combinazioni sono efficaci.
L'accoppiamento tempestivo, l'alimentazione adeguata degli animali gravidi, l'introduzione di preparati batterici e premiscele nella dieta degli animali giovani aiutano a prevenire lo sviluppo di questa malattia. Per prevenire la salmonellosi vengono vaccinate le mucche gravide e poi i vitelli. Gli animali che si sono ripresi dalla malattia sviluppano una forte immunità.
Colibacillosi
Si tratta di una malattia infettiva acuta dei giovani animali da fattoria e degli animali da pelliccia, che si manifesta con diarrea, grave intossicazione e disidratazione.
L'agente eziologico è il patogeno Escherichia coli, scarsamente resistente ai disinfettanti.
I vitelli si infettano nei primi 3-7 giorni dopo la nascita attraverso oggetti circostanti infetti, colostro, contenitori del latte, aria, mani e tute del personale di servizio, nonché attraverso il contatto con ratti e topi domestici a causa della ridotta resistenza naturale del corpo dei neonati, violazioni delle norme zootecniche e veterinarie - sanitarie relative alla custodia, alimentazione e cura delle madri, degli animali appena nati e degli animali giovani durante il periodo dello svezzamento dalla madre.
La principale via di infezione è nutrizionale, meno spesso aerogena, possibilmente intrauterina. La fonte dell'infezione sono gli animali malati e guariti, le madri portatrici di E. coli patogeno. La colibacillosi si registra più spesso nel periodo inverno-primavera. I vitelli possono avere un'immunità passiva (10-14 giorni) se hanno ricevuto latte da mucche immunizzate.
Con la malattia si verifica prima un aumento e poi una diminuzione della temperatura, debolezza, feci molli e successivamente diarrea con masse bianche schiumose liquide. La durata della malattia è di 2-3 giorni con un tasso di mortalità fino al 90%.
La diagnosi viene stabilita sulla base dei dati epizootici, clinici e dei risultati dell'esame batteriologico delle feci. Differenziare dalle malattie gastrointestinali di origine non infettiva, salmonellosi, diarrea virale.
Durante il trattamento, vengono prescritti siero iperimmune, gamma globulina, colifago, antibiotici in base ai risultati della determinazione della sensibilità dell'agente patogeno isolato, farmaci sulfamidici e nitrofuranici, agenti dietetici e sintomatici per ripristinare il metabolismo del sale marino e l'equilibrio acido-base, a neutralizzare le tossine e compensare la carenza di proteine, carboidrati e vitamine.
L'attuazione di una serie di misure organizzative, economiche, zootecniche, veterinarie, sanitarie e zooigieniche volte ad aumentare la resistenza del corpo delle madri e degli animali giovani, nonché a prevenire l'infezione degli animali attraverso oggetti ambientali, serve a combattere e prevenire la diffusione di colibacillosi. L'uso profilattico di globuline non specifiche e sieri sanguigni, la vaccinazione delle mucche gravide e l'immunizzazione passiva dei neonati con siero iperimmune specifico e gammaglobuline aiutano ad eliminare la malattia.
Quando i vitelli si ammalano di infezioni gastrointestinali, il quadro clinico e le alterazioni patologiche sono generalmente molto simili. Tuttavia è necessario differenziare le seguenti infezioni: enterite da rotavirus, enterite da coronavirus, enterite da parvovirus, diarrea virale, infezione da adenovirus, colibacillosi, salmonellosi, streptococcosi, enterotossiemia anaerobica (Tabella 40).
Infezione da rotavirus differenzia da coronavirus, diarrea virale, colibacillosi, streptococcosi, enterotossiemia.
Infezione da coronavirus differenzia dall'infezione da rotavirus, diarrea virale, colibacillosi, streptococcosi, enterotossiemia
Infezione da parvovirus differenzia dalle infezioni da rotavirus e coronavirus, diarrea virale, colibacillosi, streptococcosi, enterotossiemia
Infezione da rotavirus. La malattia dura da 2 a 5 giorni e si manifesta con diarrea abbondante, depressione generale, rifiuto di nutrirsi e un leggero aumento a breve termine della temperatura corporea. Le feci sono acquose, di colore giallo paglierino, talvolta con muco, e hanno un odore aspro. All'autopsia si riscontra un'infiammazione catarrale o catarrale-emorragica nell'intestino tenue dei vitelli morti.
Infezione da coronavirus. All'inizio si notano segni di depressione, poi si sviluppa la diarrea, che si trasforma in diarrea abbondante. La temperatura corporea rientra nei limiti normali. Feci - consistenza liquida, di colore giallo o giallo-verdastro, senza cattivo odore, mescolata con latte coagulato, muco e sangue. Con il progredire della malattia si nota un'ulcerazione della mucosa orale, accompagnata dal rilascio di saliva schiumosa. Gli animali malati sono depressi, il loro stomaco è gonfio. Durante l'autopsia dei cadaveri dei vitelli morti, vengono rilevate emorragie e ulcere sulla mucosa della cavità orale, dell'esofago e dell'abomaso.
Infezione da parvovirus. I vitelli malati presentano diarrea abbondante, leggero aumento della temperatura corporea (fino a 40 °C), le feci sono di colore grigio chiaro con una quantità significativa di muco. Cambiamenti patologici e anatomici si osservano sotto forma di infiammazione catarrale-emorragica dell'intestino.
Colibacillosi(escherichiosi) è una malattia acuta dei vitelli neonati, caratterizzata da diarrea profusa, grave intossicazione, disidratazione, talvolta fenomeni settici e nervosi, malattia diffusa (50-70%) ed elevata mortalità e si osserva principalmente nei vitelli di 1-7 giorni di età . La fonte degli agenti infettivi sono i vitelli malati e guariti, nonché le madri portatrici di ceppi patogeni di Escherichia coli. L'infezione si verifica principalmente per via orale bevendo latte infetto, leccando mangiatoie, pareti, gabbie o succhiando mammelle contaminate. L'infezione intrauterina è possibile con una diminuzione della reattività immunitaria generale, della protezione locale del tratto genitale e delle proprietà protettive della barriera placentare.
Esistono forme enteritiche (intestinali), settiche, nervose e atipiche di colibacillosi. Con la forma enteritica, si notano depressione, diminuzione dell'appetito e diarrea abbondante nei vitelli di 1-3 giorni. Le feci sono liquide, ma non acquose, di colore biancastro e contengono grumi di colostro non digerito. Nel corso del tempo, l'escrezione fecale diventa involontaria, si verificano disidratazione e esaurimento del corpo e si sviluppa una deficienza immunitaria. La temperatura solitamente non è elevata. All'autopsia vengono registrati segni di infiammazione catarrale dell'intestino e infiammazione sierosa dei linfonodi mesenterici.
La forma settica si manifesta nei vitelli di età compresa tra 1 e 7 giorni ed è caratterizzata dalla penetrazione dell'agente patogeno negli organi interni (fegato, reni), cervello, articolazioni, ecc. Insieme a disturbi digestivi, segni di aumento della temperatura corporea, grave depressione e disfunzione del sistema nervoso centrale si manifestano sotto forma di paresi e convulsioni.
All'autopsia si nota un quadro di setticemia: gastroenterite acuta catarrale-emorragica, diatesi emorragica, emorragie sotto la capsula dei reni e della milza, sull'epicardio, sull'endocardio, sulle membrane sierose delle cavità toracica e addominale, linfoadenite sierosa-emorragica , milza settica e degenerazione granulare del fegato, dei reni e del miocardio .
Nella forma nervosa, i vitelli di 2-5 giorni, insieme a segni di diarrea e tossicosi, mostrano chiaramente paresi e paralisi degli arti anteriori, posture forzate, atassia e convulsioni.
Nelle forme atipiche nei vitelli nella prima settimana di vita, oltre alla diarrea abbondante, si osservano danni alle vie respiratorie e alle articolazioni (poliartrite). Vengono inviati al laboratorio campioni fecali ottenuti dal retto di 3-4 animali malati che non sono stati trattati con antibiotici.
Per la diagnosi post mortem vengono selezionati un cuore con vasi legati, osso tubolare, pezzi di cervello, fegato con cistifellea, reni, area interessata dell'intestino tenue e linfonodi regionali.
Infezione da streptococco(streptococcosi, diplococcosi) è una malattia infettiva che si manifesta nei neonati sotto forma di setticemia, in decorso subacuto e cronico, manifestata dall'infiammazione dei polmoni e dell'intestino. Esistono forme tossico-settiche, polmonari, intestinali, articolari e miste della malattia. La diagnosi viene stabilita in modo completo, tenendo conto dei dati epizootici, clinici, patologici e dei risultati positivi dell'esame batteriologico.
I segni clinici della forma intestinale nei vitelli di 8 giorni comprendono depressione, diarrea e feci schiumose miste a sangue e muco. Nella forma settica si notano febbre alta (40-42 °C), diarrea, emorragie sulle mucose e indebolimento dell'attività cardiaca. Potrebbero verificarsi danni alle vie respiratorie e alle articolazioni.
I cambiamenti patologici sono caratterizzati da: gastroenterite catarrale, diatesi emorragica, febbre settica (consistenza gommosa), infiammazione dei linfonodi mesenterici, degenerazione granulare del fegato, dei reni e del miocardio.
Salmonellosi- una malattia infettiva caratterizzata da setticemia, disfunzione del tratto digestivo, danni al sistema respiratorio e alle articolazioni. La diagnosi si basa sull'analisi di dati clinici ed epidemiologici, cambiamenti patologici e risultati di studi microbiologici.
Tabella 40
Diagnosi differenziale delle infezioni gastrointestinali acute nel vitello
in base alle caratteristiche cliniche ed epidemiologiche di base e ai test di laboratorio
| NO. | Nome della malattia | Caratteristiche epizootiche e patologiche di base dell'infezione | Da quali malattie è necessario distinguere | Materiale biologico studiato in laboratorio | Test virologici e sierologici utilizzati per differenziare le malattie |
| Infezione da rotavirus | La malattia dura da 2 a 5 giorni e si manifesta con diarrea abbondante, depressione generale, rifiuto di nutrirsi e un leggero aumento a breve termine della temperatura corporea. Le feci sono acquose, di colore giallo paglierino, talvolta con muco, e hanno un odore aspro. All'autopsia si riscontra un'infiammazione catarrale o catarrale-emorragica nell'intestino tenue dei vitelli morti. | Enterite da coronavirus, colibacillosi, streptococcosi, diarrea virale | Feci, tessuto interessato, milza, cervello, campioni di sangue appaiati | Isolamento del virus per PEC, TB, SPEV, MDBC I focolai di cellule falciformi si formano senza danneggiare il monostrato cellulare. L'antigene virale viene rilevato mediante reazione di immunodiffusione (IDR), immunofluorescenza (IFR), test di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) e microscopia immunoelettronica | |
| 2. | Infezione da coronavirus | All'inizio si notano segni di depressione, poi si sviluppa la diarrea, che si trasforma in diarrea abbondante. La temperatura corporea rientra nei limiti normali. Le feci hanno consistenza liquida, di colore giallo o giallo-verdastro, senza cattivo odore, mescolata a latte coagulato, muco e sangue. Con il progredire della malattia si nota un'ulcerazione della mucosa orale, accompagnata dal rilascio di saliva schiumosa. Gli animali malati sono depressi, il loro stomaco è gonfio. Durante l'autopsia dei cadaveri dei vitelli morti, vengono rilevate emorragie e ulcere sulla mucosa della cavità orale, sull'esofago e sull'abomaso | Enterite da rotavirus, colibacillosi, streptococcosi, diarrea virale | Feci, aree interessate del tessuto intestinale, milza, cervello, campioni di sangue appaiati | Secrezione virale per PEC, TB, MA-104, MDBC.Si forma il sincizio, si formano granuli all'interno del citoplasma. L'antigene virale viene rilevato nelle reazioni: immunodiffusione (RID), immunofluorescenza (IF), test di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) e microscopia immunoelettronica. |
| Infezione da parvovirus | I vitelli malati presentano diarrea abbondante, leggero aumento della temperatura corporea (fino a 40 °C), le feci sono di colore grigio chiaro con una quantità significativa di muco. Cambiamenti patologici e anatomici si osservano sotto forma di infiammazione catarrale-emorragica dell'intestino | Enteriti da rotavirus e coronavirus, colibacillosi, streptococcosi, diarrea virale | Feci, tessuto interessato, milza, cervello, campioni di sangue appaiati | Isolamento virale per PEC, TB, HRT-18, MDBC. L'effetto citopatico è caratterizzato dalla lisi cellulare. Si formano inclusioni eosinofile. L'antigene virale viene rilevato nelle seguenti reazioni: emoagglutinazione (HHA), emoadsorbimento (RGads), inibizione dell'emoagglutinazione (HTI), inibizione dell'emoagglutinazione (HHAds), immunofluorescenza (RIF), test di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) |
Nei vitelli di 2-4 settimane di età con forma di enterite si notano un forte aumento della temperatura corporea (fino a 41,5 ° C), depressione e rifiuto di nutrirsi. Giacciono a lungo con la testa allungata o stanno curvi. Il terzo giorno di malattia appare una diarrea abbondante, le feci diventano liquide con una miscela di muco, a volte sangue e hanno un odore sgradevole. In alcuni vitelli, la salmonellosi si manifesta sotto forma di sepsi e termina con la morte.
I cambiamenti patologici nel decorso acuto della forma di enterite sono caratterizzati da fenomeni di infiammazione catarrale-emorragica, talvolta fibrinosa, della mucosa dello stomaco e dell'intestino. Il fegato è in uno stato di degenerazione granulare o grassa, la cistifellea è solitamente dilatata e piena di bile densa e scura. La milza è notevolmente ingrandita.
Al laboratorio vengono inviati il fegato con la cistifellea e i linfonodi mesenterici, la milza, il rene, l'osso tubulare, le feci intravitali prelevate dal retto, il sangue nei giorni 1-4 di malattia, il siero del sangue e in caso di aborto un feto fresco .
La diagnosi è considerata stabilita:
1) quando si isola una coltura con proprietà culturali e biologiche caratteristiche da materiale patologico e si determina il sierotipo;
2) con una reazione di sieroagglutinazione positiva con un titolo pari o superiore a 1:200 con un punteggio non inferiore a tre croci (+++).
Enterotossiemia anaerobica- una malattia acuta e grave dei vitelli, caratterizzata da enterite ulcerosa catarrale-emorragica, grave tossiemia, emorragie sulle mucose delle cavità nasali e orali. I vitelli si ammalano nei primi tre giorni di vita.
La diagnosi viene stabilita sulla base dell'analisi di dati epizootici, clinici, poloo-anatomici, dei risultati di studi microbiologici e tossicologici. La fonte principale dell'agente infettivo sono gli animali adulti sani, portatori di microbi, che secernono clostridi nelle feci e infettano il colostro, le ciotole, i secchi e la biancheria da letto. Dopo la comparsa dei primi segni della malattia, gli animali malati diventano la principale fonte di agenti infettivi per i vitelli appena nati.
L'esame clinico rivela diarrea abbondante, feci di consistenza liquida, maleodoranti, con bolle di gas e spesso miste a sangue. La temperatura è salita a 41°C.
Nel decorso iperacuto della malattia, i cadaveri di animali giovani sono gonfi e si decompongono rapidamente, dalle aperture nasali e dalla cavità orale è visibile una secrezione schiumosa rossastra. L'essudato sieroso-emorragico si accumula nella cavità addominale, si osserva un intenso catarrale-emorragico (spesso con ulcerazioni), infiammazione dell'abomaso, dell'intestino tenue e crasso. Sono presenti abbondanti emorragie sulle mucose intestinali e sulle membrane sierose. Il tessuto perirenale e il mesentere dell'intestino crasso sono edematosi. Nei reni e nel fegato si osserva una pronunciata iperemia congestizia e degenerazione granulare.
Fine del lavoro -
Questo argomento appartiene alla sezione:
Malattie degli animali da allevamento
Sul sito si legge: “malattie degli animali da allevamento”.
Se hai bisogno di materiale aggiuntivo su questo argomento, oppure non hai trovato quello che cercavi, ti consigliamo di utilizzare la ricerca nel nostro database delle opere:
Cosa faremo con il materiale ricevuto:
Se questo materiale ti è stato utile puoi salvarlo sulla tua pagina sui social network:
| Twitta |
Combattere le cimici
Le cimici appartengono agli emitteri (Hecmiptera), sanguisughe. Sono state descritte circa 40mila specie. Il rappresentante più comune è la cimice (Cinex lectularius), che nidifica viva
Misure per combattere gli scarafaggi
Gli scarafaggi sono insetti sinantropici e zootropici e possono anche abitare negli allevamenti - cucine, magazzini. Appartengono all'ordine dei Blattotteri. Più comune
Requisiti moderni per la qualità del latte
Il latte è uno dei prodotti alimentari più preziosi. Contiene più di 100 componenti vitali per l'uomo e gli animali giovani. I principali sono proteine, grassi, carboidrati
Indicatori organolettici
Gli indicatori organolettici (colore, odore, gusto, consistenza) sono di grande importanza quando si valuta la qualità sanitaria del latte. Possono cambiare sotto l'influenza di vari fattori, risultando
Acidità del latte
L'acidità caratterizza la freschezza del latte. Si esprime in gradi Turner convenzionali (°T). In media l'acidità titolabile del latte fresco di animale sano è di 16-18 °T. Durante la conservazione
Densità del latte
La densità è il criterio principale per la naturalezza del latte. Per tutti i tipi di latte non deve essere inferiore a 1,027 g/cm3, ovvero 27°A. Nel latte vaccino naturale, l'indicatore di densità può fluttuare
Contaminazione batterica
La contaminazione batterica è il principale indicatore che caratterizza la qualità sanitaria del latte. La qualità del latte viene spesso ridotta a causa dell'aumento del contenuto di batteri. Grado di contaminazione
Relazione tra conta delle cellule somatiche e diminuzione della produzione di latte
Numero di cellule somatiche, migliaia/cm3 Diminuzione della produzione di latte, obiettivo/anno USA Belgio
La qualità sanitaria del latte e la sua idoneità tecnologica per la produzione di latticini dipendono in gran parte dalla presenza di microflora in esso. La contaminazione del latte durante la mungitura è dovuta a
Cambiamenti nella quantità di microflora durante la conservazione del latte
Il tipo e il grado di contaminazione batterica del latte dipendono non solo dal grado di contaminazione primaria, ma anche dalla temperatura e dal tempo della contaminazione primaria. Allo stesso tempo, si verifica lo sviluppo della microflora nel molo
L'influenza della mastite sulla qualità del latte
La mastite è uno dei principali fattori che riducono la qualità del latte e, di conseguenza, dei latticini. Durante i processi infiammatori nella ghiandola mammaria, la composizione chimica del latte cambia, ad es
Metodi e mezzi per disinfettare la mammella delle mucche per ridurre la contaminazione batterica del latte
Negli ultimi anni molta attenzione è stata posta al trattamento sanitario della mammella, che ha un impatto significativo sulla riduzione della contaminazione batterica del latte e contribuisce in modo significativo
Metodi di controllo tecnico della qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Attualmente sono stati sviluppati metodi espressi e, sulla base, sono stati creati dispositivi automatici ad azione rapida per controllare la qualità del latte e dei latticini. Quando si crea un'analisi
La relazione tra il contenuto di cellule somatiche nel latte raccolto e l'incidenza della mastite subclinica nelle vacche della mandria
Numero di cellule somatiche nel latte raccolto migliaia in 1 cm 3- Incidenza delle vacche nella mandria Mastite subclinica 594,6
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 3 gennaio 2001
“Regolamento sulla procedura per il rilascio dei permessi per l’importazione nel territorio doganale della Repubblica di Bielorussia per scopi veterinari di medicinali, sostanze farmaceutiche e altri prodotti veterinari
Posizione
sulla procedura per il rilascio dei permessi per l'importazione nel territorio doganale della Repubblica di Bielorussia per scopi veterinari di medicinali, sostanze farmaceutiche e altri prodotti veterinari
Requisiti generali di prevenzione
1. Gli allevamenti di suini destinati alla riproduzione e all'allevamento di suini devono funzionare come imprese chiuse. Viene effettuato l'ingresso e l'uscita dall'area di produzione dell'impresa
Requisiti veterinari per il completamento di complessi industriali
1. Il reclutamento e il rifornimento delle aziende è consentito solo con suini sani provenienti dai propri allevamenti o da allevamenti assegnati, centri di selezione ibrida, centri sicuri
Studi diagnostici e trattamenti terapeutici e profilattici dei suini durante il periodo di quarantena
N. Età Nome degli eventi Nota
Norme per lo stato biochimico ed ematologico del corpo suino
Parametri biochimici Unità. modifica Scrofe Suinetti Neonati prima della poppata 4-6 giorni di vita
Parametri microclimatici ottimali per i suini
N. Parametri microclimatici Scrofe del primo periodo di gravidanza e scrofe singole del secondo periodo di gravidanza
Ollulanosi
La diagnosi intravitale viene effettuata mediante microscopia del vomito di un animale malato e postuma esaminando raschiature della mucosa gastrica nell'area delle ghiandole fuldali. Esame del capezzolo
Criptosporidiosi
La diagnosi viene effettuata sulla base del rilevamento di oocisti di cryptosporidium nelle feci (mediante striscio nativo e metodi di flottazione). Le oocisti vengono rilevate negli strisci dopo la colorazione Ziehl-Neelsen con colorazione aggiuntiva
Imprese zootecniche
(Approvato dalla Direzione Principale del Ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Bielorussia il 10 marzo 2005) Base per la prevenzione delle malattie del bestiame causate da agenti infettivi ad alta e bassa patogenicità, soprattutto quando
Incidenza delle malattie respiratorie nei bovini
Anni analizzati Totale capi di bestiame Vitelli ricevuti (capi) Animali malati con danni agli organi respiratori
Incidenza delle malattie gastrointestinali nei bovini
Anni analizzati Totale bestiame Vitelli ricevuti (capi) Animali malati con danni al tratto gastrointestinale
Dati sulla mortalità del bestiame
Anni analizzati Totale animali in circolazione (capi) Vitelli ricevuti (capi) Totale malattie (capi) Bovini abbattuti
Dati sulla macellazione forzata dei bovini
Anni analizzati Totale animali in circolazione (capi) Vitelli ricevuti (capi) Totale malattie (capi) Forzati
Dati sullo smaltimento improduttivo del bestiame
Anni analizzati Totale animali in circolazione (capi) Vitelli ricevuti (capi) Totale malattie (capi) Morti e
Dati sullo smaltimento improduttivo dei vitelli a causa di malattie respiratorie
Anni Vitelli accolti (capi) Totale vitelli malati (capi) Vitelli morti e costretti all'abbattimento a causa di malattie respiratorie
Dati sullo smaltimento improduttivo dei vitelli affetti da malattie gastrointestinali
Anni Vitelli accolti (teste) Totale vitelli malati (teste) Vitelli morti e costretti all'abbattimento a causa di problemi al tratto gastrointestinale
Dati sull’incidenza della mastite bovina
Anni Totale capi in circolazione (teste) Totale vacche (teste) Totale manze primogenite (teste) Affette da mastite
Dati sull'incidenza delle mucche con lesioni degli organi riproduttivi
Anni Totale capi in circolazione (capi) Totale vacche (capi) Totale manze primo vitello (capi) Vacche malate e manze primo vitello
Azienda zootecnica
1.1. Denominazione dell'impresa ________________________________________________ 1.2. Regione, distretto, località _______________________________________________________ 1.3. Direzione pre
Caratteristiche della situazione epizootica nell'impresa
2.1. Se viene identificata una malattia presso l'azienda, indicare il nome della malattia, l'età e il sesso degli animali, la morbilità e la mortalità degli animali) ________________________________ _________________________
Esecuzione di misure antiepizootiche e preventive
3.1. Diagnosi iniziale ___________________, finale _________________ Modalità e data della diagnosi __________________________________________ 3.2. Diagnosi confermata
Broncopolmonite (polmonite catarrale). Broncopolmonite
Infiammazione dei bronchi e dei polmoni, accompagnata dalla formazione di essudato catarrale e dal riempimento con esso del lume dei bronchi e delle cavità alveolari. Gli animali giovani di tutte le specie animali sono i più sensibili. La malattia può diffondersi.
Eziologia. Malattia polietiologica.
1. Meccanismi protettivi e adattativi ridotti.
Violazioni della tecnologia e delle norme veterinarie e sanitarie per l'allevamento, la custodia e l'alimentazione degli animali. Fattori freddi. Fattori stagionali (inizio primavera e tardo autunno). La nascita di animali giovani sottosviluppati, ipotrofici e con ridotta vitalità. Mancanza di proteine, singoli aminoacidi, vitamine e componenti minerali nella dieta. Mancanza di deambulazione, mancanza di radiazioni ultraviolette naturali o artificiali, ecc. Inalazione prolungata di polvere nella stagione calda.
2. I fattori predisponenti sono associati alle caratteristiche degli organi respiratori degli animali giovani.
I neonati hanno:
vie aeree anteriori sottosviluppate;
tessuto alveolare sottosviluppato;
aumento dell'afflusso di sangue al tessuto polmonare;
scarsa elasticità del tessuto polmonare;
le mucose degli organi respiratori dei vitelli appena nati sono molto tenere, le ghiandole non sono ancora completamente sviluppate e secernono poco muco;
muscoli respiratori deboli;
petto ristretto;
fiato corto.
Tutte queste caratteristiche insieme creano i prerequisiti necessari per lo sviluppo di malattie.
3. Agenti patogeni.
Patogenesi. La broncopolmonite si riferisce alla polmonite focale ed è caratterizzata dalla diffusione lobulare del processo infiammatorio. Innanzitutto vengono colpiti i bronchi, i bronchioli e i lobuli, dopo di che il processo può coprire diversi lobuli, segmenti e lobi dei polmoni (polmonite focale piccola e grande, confluente). Le aree craniche dei polmoni (lobi apicali e cardiaci) sono quasi sempre colpite per prime.
Nello strato sottomucoso della membrana bronchiale si osserva prima uno spasmo, quindi la paresi dei capillari e il ristagno venoso del sangue, emorragie e sviluppo di gonfiore, diminuisce l'attività fagocitica dei leucociti e l'attività lisozima del muco bronchiale.
Nelle fasi iniziali della malattia si sviluppa un'infiammazione sierosa, sierosa-catarrale o catarrale nei bronchi e negli alveoli. L'essudato non coagulabile, costituito da mucina, leucociti, eritrociti, cellule epiteliali bronchiali e microbi, suda nel lume dei bronchi e degli alveoli. La funzione barriera dell'epitelio diminuisce, la microflora si moltiplica nella mucosa bronchiale e nei lumi delle vie respiratorie, il che porta all'assorbimento di tossine e prodotti di decomposizione nel sangue e nella linfa. Di conseguenza, l'intossicazione del corpo si sviluppa con un aumento della temperatura corporea, disfunzione dei sistemi cardiovascolare, respiratorio, digestivo e altri.
Una diminuzione della superficie respiratoria dei polmoni porta all'interruzione dello scambio di gas, ad un aumento compensatorio dei movimenti respiratori e della funzione cardiaca. Con lo scompenso si sviluppano ipossiemia, ipossia e acidosi tissutale. Nel decorso acuto della malattia, di solito vengono colpiti per primi i lobuli superficiali dei polmoni. Nel decorso cronico della malattia, il processo può diventare lobare a seguito della fusione di singoli focolai di infiammazione in grandi focolai (con polmonite lobare confluente, organizzazione dell'essudato, carnificazione del tessuto polmonare, indurimento e calcificazione del tessuto polmonare
focolai nic, decadimento purulento-necrotico del tessuto polmonare e dei bronchi. Possibili complicanze sono enfisema, pleurite, pericardite.
Quadro patologico. Nei casi acuti si presentano lesioni lobulari multiple nei lobi apicali e cardiaci sotto forma di lesioni polmonari localizzate superficialmente o nello spessore del polmone. Le lesioni, di dimensioni variabili da uno a diversi centimetri, sono di colore blu-rosso o rosso pallido, dense al tatto, affondano nell'acqua e quando vengono tagliate dai bronchi fuoriesce un essudato catarrale.
Nella broncopolmonite cronica - presenza di estesi focolai polmonari (polmonite confluente), pleurite, pericardite. I linfonodi mediastinici sono ingranditi. I cambiamenti associati sono esaurimento, distrofia del miocardio, del fegato, dei reni, atrofia muscolare, ecc.
Quadro clinico. Nei casi acuti, debolezza generale, apatia, mancanza di appetito; aumento della temperatura da lieve a moderato; tosse prima secca, poi grassa, profonda; respiro affannoso, mancanza di respiro; secrezione sierosa-catarrale o catarrale dalle aperture nasali; nei polmoni c'è una respirazione vescicolare dura, rantoli umidi. La percussione individua aree di ottusità (prevalentemente nella zona dei lobi apicali e cardiaci).
Gli esami del sangue hanno rivelato leucocitosi neutrofila con spostamento a sinistra, linfopenia, eosinopenia, monocitosi, eritropenia, emoglobinemia, VES accelerata, diminuzione dell'alcalinità di riserva.
La broncopolmonite cronica è caratterizzata da un lungo decorso, diminuzione dell'appetito, emaciazione, crescita stentata, diminuzione della produttività e delle prestazioni, tendenza a sdraiarsi costantemente, mucose pallide, diminuzione dell'elasticità della pelle, capelli arruffati, ecc. La temperatura è normale o bassa . La tosse è prolungata, di solito quando ci si alza in piedi. L'auscultazione rivela una respirazione vescicolare aspra, rantoli secchi o umidi, ottusità nel tessuto polmonare.
Fluire. Se il decorso della malattia (trattamento) è favorevole, la guarigione avviene in media in 7-10 giorni. Se il decorso è sfavorevole, i lobi colpiti si fondono in grandi focolai (polmonite confluente, lobare), l'infiammazione diventa di natura purulento-necrotica, possono esserci ascessi nei polmoni, pleurite o pericardite.
IN diagnosi differenziale escludere malattie infettive e invasive manifestate da sintomi di danno alle vie respiratorie e ai polmoni.
Con la bronchite, non vi è alcun aumento o un lieve aumento della temperatura corporea, le aree opache dei polmoni non vengono identificate, la leucocitosi non è espressa e l'esame radiografico non rivela focolai ombreggiati nei polmoni.
A differenza della polmonite lobare, nella broncopolmonite non vi è improvvisa malattia, decorso graduale, febbre di tipo costante, focolai lobari di ottusità nei primi giorni della malattia o secrezione fibrinosa dalle aperture nasali.
Trattamento. I pazienti con bronchite acuta e cronica e broncopolmonite vengono trattati in modo completo utilizzando agenti patogenetici e sintomatici. Per prevenire la bronchite cronica, viene completato il trattamento della forma acuta.
Gli animali con segni di polmonite lobare e catarrale sono inizialmente considerati pazienti infettivi, quindi, fino a quando l'eziologia non sarà definitivamente chiarita, vengono tenuti in un reparto di isolamento.
Il trattamento degli animali con broncopolmonite è più efficace nelle fasi iniziali della malattia, quando sono colpiti principalmente i bronchi e i bronchioli e il processo essudativo è di natura sieroso-catarrale.
Tali lesioni si osservano solitamente nei primi 3-7 giorni dalla comparsa della febbre. Durante questo periodo, nei polmoni non si sono ancora sviluppati cambiamenti purulenti, necrotici e indurenti e l'efficacia terapeutica (recupero) raggiunge oltre il 90%.
Nei casi cronici, in presenza di focolai polmonari localizzati di natura indurativa nei polmoni, a seguito del trattamento, le condizioni generali degli animali possono migliorare e la loro produttività e prestazione possono aumentare. Tuttavia, il tessuto polmonare di tali animali non viene completamente ripristinato, quindi dopo il trattamento non è consigliabile utilizzarli come animali da riproduzione. Gli animali con malattie croniche, così come quelli con focolai purulento-necrotici progressivi confluenti nei polmoni, di regola vengono scartati.
Eliminazione del fattore eziologico. Creare normali condizioni zooigieniche. I pazienti vengono trasferiti in una stanza moderatamente umida, calda, ben ventilata (ma senza correnti d'aria), in cui la temperatura deve essere mantenuta costantemente allo stesso livello.
Terapia dietetica. Smetti di somministrare cibo sfuso, polveroso e irritante, nonché cibo di scarsa qualità. La dieta dovrebbe consistere principalmente di vitamine verdi e mangime liquido o inumidito. Assunzione di acque minerali alcaline.
Espettoranti e antitosse. Per ammorbidire le pareti bronchiali indurite durante la peribronchite, si consiglia di utilizzare ioduro di sodio o di potassio con cibo liquido in ragione di 0,01–0,02 mg/kg al giorno 2–3 volte per 1–2 settimane.
Terapia antibiotica. In caso di broncopolmonite acuta, subacuta e cronica, vengono prescritti streptomicina, tetraciclina, ossitetraciclina, cloramfenicolo, ampicillina, kanamicina, lincomicina, gentamicina, oxacillina, polimixina, eritromicina, enrofloxacina e altri antibiotici. Tra i farmaci sulfamidici, viene data preferenza ai farmaci a lunga durata d'azione (sulfadimetossina, sulfapiridazina). Si consiglia di utilizzare sulfamidici complessi (biseptolo, sulfvetrim, ecc.).
Iniezioni intratracheali. 5-10 ml di una soluzione sterile allo 0,5% di novocaina vengono iniettati nel terzo inferiore del collo utilizzando un ago sterile (lentamente per 30 secondi). Dopo che il riflesso della tosse si è attenuato, senza rimuovere l'ago, iniettare sale di penicillina sodico o potassico 10.000-15.000 unità/kg diluito in acqua distillata o sulfamidici solubili in ragione di 0,05 g/kg. La somministrazione intratracheale viene prescritta 1-2 volte al giorno per 3-5 giorni consecutivi.
Agenti che dilatano il lume dei bronchioli ed enzimi proteolitici. Utilizzato per la bronchite cronica e la peribronchite, che tende a causare stenosi e ostruzione del lume bronchiale. Nel trattamento dei vitelli affetti da bronchite cronica, si ottengono buoni risultati con la somministrazione giornaliera, per 3-5 giorni, sottocutanea o endovenosa di aminofillina ad una velocità di 5-8 mg/kg. Iniezioni intratracheali di trypsin o pepsina (per fluidificare l'essudato) alla dose di 1-2 mg/kg in una soluzione di novocaina.
Metodo di trattamento combinato. Innanzitutto, al vitello viene iniettata per via endovenosa o sottocutanea l'aminofillina in una dose di 1–3 ml di una soluzione al 2,4% (l'effetto dilatatore dei bronchi si verifica entro 2–3 minuti dalla somministrazione dell'aminofillina). Immediatamente, 5-10 ml di una soluzione al 5% di novocaina vengono iniettati per via intratracheale e dopo che il riflesso della tosse si è attenuato, 5-10 ml di una soluzione allo 0,5% di novocaina con una dose di antibiotico ed enzima proteolitico disciolto in esso (pepsina o trypsin - 1,5–2 mg/kg). È possibile iniettare per via intratracheale una soluzione di olio di mentolo al 5%, 10 ml per i primi 2 giorni. Prima dell'inserimento intratracheale, l'animale viene fissato in modo tale
le aree interessate dei polmoni occupavano una posizione più bassa.
Blocco della novocaina nodo stellato o blocco secondo Shakurov.
Fisioterapia, sostanze irritanti e distraenti nei casi cronici e protratti. Riscaldare la parete toracica con lampade a incandescenza, strofinare il torace con trementina o alcool di senape al 5%, impacchi caldi, piastre riscaldanti, ecc.
Cardiotonico. Caffeina, benzoato di sodio 10–20%, olio di canfora 20%, cordiammina, sulfocanfocaina, ecc.
Antipiretici. Prescritto per la febbre grave. Aspirina, analgin, paracetamolo, ecc. Miscela litica: analgin + difenidramina + papaverina cloridrato in parti uguali.
Terapia antitossica.
Glucosio al 5% per la disidratazione - IV o SC 10–20 ml/kg;
soluzioni di cloruro di sodio 0,9%, disolo, trisolo, acesolo, Ringer, Ringer-Lock, ecc. 10–20 ml/kg;
poliglucina, reopoliglucina, hemodez, ecc. 10–20 ml/kg;
esametilentetrammina: grande – 0,05–0,1 ml/kg per via endovenosa o sottocutanea in diluizione;
siero antisettico secondo Kadykov: soluzioni endovenose di 5 ml di acido ascorbico, 300 ml di distillato. acqua, 2 ml di canfora grattugiata, glucosio 40% - 15–20 ml, 10 ml di Vit PP, 120 ml di alcool rettificato). Per un animale di grandi dimensioni.
Terapia vitaminica. Tetravit, trivit, eleovit, hemobalance, dufolight, chintonik. Aminoacidi, integratori minerali. Farmaci che aumentano la resistenza generale del corpo. Preparazioni di ginseng, eleuterococco, poliglobuline, gamma globuline, sangue autologo, sieri iperimmune, timogeno, immunofan, cicloferone, interferone, fosprenil, maxidin, catozal, ecc.
Terapia probiotica.
Terapia patogenetica - farmaci antinfiammatori (glucocorticoidi, antistaminici, salicilati, ecc.). Difenidramina, suprastin, tavegil, pipolfen, diazolin, fenkarol, prednisolone, desametasone, acido acetilsalicilico, soluzione di cloruro di calcio al 10% per via endovenosa fino a 0,5 ml/kg, ecc. Il gluconato di calcio o il borgluconato possono essere somministrati per via intramuscolare o orale.
Terapie inalatorie e aerosol. Il metodo più rilevante per le lesioni di massa di animali giovani con broncopolmonite. L'aerosolterapia viene effettuata in ambienti sigillati (camere speciali, mobili o fisse). Attrezzare una stanza con un volume di 30–50 m3 per la stazione di inalazione in ragione del trattamento simultaneo di 15–20 vitelli di 1–3 mesi di età (2–3 m3 per animale). Sono installati sistemi di ventilazione di alimentazione e scarico e fognature.
Nelle piccole stalle per vitelli e nelle stazioni mediche e sanitarie, vengono utilizzate camere pieghevoli con un volume di 7-16 m per il trattamento simultaneo di 3-5 vitelli (è possibile utilizzare temporaneamente un film di polietilene).
Gli aerosol vengono spruzzati da generatori collegati a compressori che creano una pressione di 2–5 kg/cm e forniscono un flusso d'aria fino a 100 l/minuto. Per una camera di inalazione di 30–50 m3 è sufficiente l'installazione di SAG-1 o VAU-1; per camere di dimensioni più piccole – AI-1, ecc. I generatori di aerosol sono installati rigorosamente secondo le istruzioni (ad esempio, SAG -2 ad un'altezza di 1–1,5 m dal pavimento, un generatore ogni 50 m3 di volume d'aria medio).
Camere piccole (10–20 m3) vengono utilizzate più spesso per la terapia aerosolica con antibiotici e sulfamidici e camere grandi (50–100 m3) per altri agenti antibatterici e per il trattamento preventivo di gruppo degli animali.
Per l'aerosolterapia di gruppo di animali con danni prevalentemente al tratto respiratorio (nella fase iniziale della polmonite) viene utilizzato per 1 m3
1 ml di soluzione acquosa al 50% di iodotrietilenglicole, 0,1 ml di acido lattico, 5 ml di soluzione di trementina al 10%, 15 ml di siero di canfora secondo Kadykov.
Antibiotici, farmaci sulfamidici. Benzilpenicillina, ampicillina, kanamicina, streptomicina, neomicina, ossitetraciclina, ortociclina, eritromicina vengono spruzzate alla velocità di 5–8 mg/m3, norsulfazolo solubile, etazolo - 0,5 mg/m3. Gli antibiotici vengono sciolti in una soluzione allo 0,5% di novocaina. Per la stabilizzazione vengono utilizzate soluzioni di glicerina al 20-30%. Quando si utilizzano antibiotici, assicurarsi di inattivare l'aerosol residuo nella camera e sugli animali entro 10 minuti secondo le istruzioni.
L'efficacia terapeutica aumenta con l'uso combinato di agenti antibatterici con vitamine o microelementi. Preparare soluzioni medicinali in acqua distillata o novocaina all'1% immediatamente prima della spruzzatura. La durata di una sessione di aerosolterapia è di 50-60 minuti, è necessario eseguire 1-2 sessioni di questo tipo al giorno, il corso del trattamento (a seconda del grado di danno polmonare) è di 7-15 giorni.
Diuretici. Furosemide, diacarb, diuver, esametilentetrammina, ecc.
Prevenzione.
1.La custodia e l'alimentazione degli animali devono essere conformi alle norme zooigieniche.
2. Eliminare i fattori del freddo.
3. Eliminare la contaminazione da polvere e gas nei locali (fognature e ventilazione).
4. Effettuare regolarmente la pulizia meccanica e la disinfezione dei locali.
5. Rafforzare la resistenza naturale del corpo degli animali giovani: indurimento camminando, allevamento in campeggio, irradiazione ultravioletta, arricchimento della dieta con vitamine e integratori minerali, uso di gamma e poliglobuline, sieri convalescenti, biostimolanti, ecc.
6. Evitare l'ipotermia degli animali, soprattutto dopo essere stati in stanze calde e soffocanti o durante il trasporto.
7. Gli animali caldi non devono ricevere acqua fredda o lasciati esposti a vento freddo o correnti d'aria.
8.Diagnosi precoce e trattamento tempestivo dei pazienti affetti da broncopolmonite.
Gastroenterite. Gastroenterite, abomasoenterite
Una malattia che si manifesta con danni alla parete dello stomaco, dell'intestino tenue, indigestione e interruzione di altre funzioni del corpo. La gastroenterite si verifica durante il periodo di crescita postnatale degli animali giovani: nei vitelli - di età superiore a 15 giorni, nei suinetti - a 15-30 giorni di età e nei primi giorni dopo lo svezzamento dalle scrofe, negli agnelli - all'età di 1,5-4 anni mesi e più. Si verifica negli animali adulti, ma è meno comune.
Eziologia. Il fattore principale è nutrizionale: cambio improvviso del mangime, scarsa qualità (mangime avariato), somministrazione di mangime congelato o consumo di acqua fredda, consumo di latte di scarsa qualità (mastite), avvelenamento, esposizione prolungata al fattore freddo, surriscaldamento, ipovitaminosi A, dispepsia (la sua conseguenza), avvelenamento. L'intestino può essere coinvolto nel processo a causa dell'infiammazione dello stomaco, del fegato, del pancreas, ecc.
Inoltre, le cause della gastroenterite possono essere carenza, endocrina, intossicazione e allergia:
carente - mancanza di vitamine (A, D, E, C, B), aminoacidi, microelementi;
endocrino – stress, ipofunzione della tiroide;
allergico – sensibilizzazione agli antigeni nutrizionali, malattie autoimmuni;
intossicazione – principalmente avvelenamento e come conseguenza di processi infettivi.
Una diminuzione della resistenza è sicuramente inclusa. La gastroenterite secondaria si verifica con un'ostruzione intestinale persistente e come conseguenza di malattie invasive e infettive.
Lesioni croniche sono possibili con l'esposizione regolarmente ripetuta alla mucosa gastrica. Motilità compromessa del tratto gastrointestinale, malattie del tratto digestivo sovrastante, fegato, pancreas.
Le gravi malattie gastrointestinali dei vitelli appena nati sono causate da vari agenti eziologici e molto spesso si presentano sotto forma di infezioni miste. Inoltre, in ciascuna azienda zootecnica, la struttura eziologica delle malattie, nonché i fattori che predispongono e contribuiscono alla comparsa e allo sviluppo delle malattie, sono diversi.
Tra gli agenti virali che possono causare indipendentemente malattie gastrointestinali nei vitelli neonati vi sono la rota, la corona, l'entero, il parvovirus, il virus della diarrea virale - malattie delle mucose dei bovini, rinotracheite infettiva bovina, ecc.
I virus coinvolti nella comparsa e nello sviluppo della diarrea causano estremamente raramente la morte di animali giovani appena nati. La loro importanza nella patogenesi della malattia è associata al danno alle cellule della mucosa intestinale, all'interruzione del processo di colonizzazione (adesione) della microflora benefica e all'aggravamento della disbiosi.
Gli agenti batterici che possono causare diarrea nei vitelli o complicare le infezioni virali comprendono Escherichia enteropatogena, enterotossigena ed enteroinvasiva, Salmonella, Clostridia, Enterococcus, rappresentanti dei generi Citrobacter, Klebsiella, Proteus, Morganella, Yersinia, Providence, Pseudomonas, Campylobacter, ecc.
L'eziologia delle malattie gastrointestinali nei vitelli può coinvolgere la clamidia, il criptosporidio, i funghi patogeni, ecc. La fonte del criptosporidio, oltre ai vitelli malati, sono i roditori (topi, ratti) e i gatti. I vitelli vengono infettati dal criptosporidio fin dai primi giorni dopo la nascita e si ammalano prima del compimento di un mese.
Patogenesi. Insorgenza patogena → reazione infiammatoria → aumento della secrezione di muco → aumento della viscosità del succo gastrico → inibizione della funzione acidogena dello stomaco (abomaso) → stato ipoacido → alterazione dell'eccitabilità dell'apparato neuromuscolare ed escretore di stomaco, intestino e pancreas → disturbo della cavità e della digestione parietale → formazione di prodotti incompleti decadimento → attivazione della microflora condizionatamente patogena → disbatteriosi → processi putrefattivi e fermentativi nella cavità intestinale → intossicazione del corpo con endo- ed esotossine → disturbi metabolici, funzioni di vari organi e sistemi .
→→→ rapido movimento del chimo attraverso l'intestino → perdita di nutrienti, elettroliti e acqua → disidratazione, acidosi metabolica, spostamento metabolico.
I casi più gravi sono la gastroenterite fibrinosa, emorragica e ulcerosa.
Quadro clinico. La gastroenterite catarrale è la forma più comune. Quando è mite, la temperatura è normale o subfebbrile. L'appetito diminuisce, la peristalsi aumenta, la diarrea frequente con una piccola quantità di muco nelle feci. Se è interessato lo stomaco, di solito si verifica stitichezza. Si osservano suinetti che vomitano. Decorso grave della malattia: anoressia, aumento della motilità intestinale, diarrea frequente, le feci sono liquide, maleodoranti, presentano vari tipi di impurità (frammenti di cibo, mucose, lembi di fibrina, muco, pus, sangue). Il vomito è spesso possibile. L'addome è sollevato o gonfio (flatulenza), le pareti addominali sono dolorosamente tese. Depressione, febbre lieve, segni di patologia del sistema cardiovascolare. Aumento dell’emoglobina e dei globuli rossi,
leucocitosi neutrofila con spostamento nucleare a sinistra, aumento della VES e della viscosità del sangue. Oliguria grave, urina acida, possibilmente proteine, leucociti, epitelio.
Successivamente, aumentano i segni di disidratazione e intossicazione: diminuzione dell'elasticità della pelle, enoftalmo, polso accelerato e debole, respirazione rapida e superficiale. Gli animali giovani malati si muovono lentamente, giacciono di più con gli occhi socchiusi e reagiscono male agli stimoli ambientali; a volte si notano contrazioni muscolari fibrillari o movimenti irregolari. Si verificano ipotermia, stato stuporoso, coma e morte. Nella gastroenterite catarrale cronica, la diarrea si alterna alla stitichezza. C'è molto muco e talvolta sangue nelle feci. La peristalsi intestinale è aumentata o indebolita. L'appetito è ridotto. Depressione ed emaciazione significativa. I capelli sono arruffati e la caduta è ritardata. Possono verificarsi malattie secondarie.
Il cadavere è esausto. Lo stomaco e l'intestino contengono resti di cibo non digerito, a volte a causa della mescolanza di sangue sono di colore bruno-marrone e c'è molto muco. La mucosa del tubo digerente è gonfia, piegata, talvolta con emorragie. In alcuni casi, sulla mucosa dello stomaco e dell'intestino tenue sono presenti pellicole di fibrina e ulcerazioni. Il fegato è color argilla ed ha una consistenza flaccida. Quando i reni vengono tagliati, la struttura risulta levigata, il muscolo cardiaco risulta flaccido e in alcuni casi le cavità cardiache risultano espanse.
Diagnosi. Diagnosticato sulla base di dati anamnestici, clinici, scatologici, patologici, nonché sui risultati di studi batteriologici, virologici, elmintologici e tossicologici. Diagnosi differenziale. Sono escluse salmonellosi, pasteurellosi, clostridiosi, streptococcosi, gastroenterite virale e altre malattie infettive e invasive.
Decorso e prognosi. Il decorso acuto della gastroenterite catarrale dura 3–7–10 giorni, con altri tipi di infiammazione, così come il processo catarrale subacuto, fino a 2–3–4 settimane. L'esito in quest'ultimo caso è generalmente favorevole, ma in altre forme di infiammazione è prudente.
Trattamento. Gli animali malati vengono isolati e curati. La terapia dovrebbe mirare a sopprimere la microflora patogena e condizionatamente patogena, normalizzare l'equilibrio salino e acido-base, aumentare la resistenza del corpo e ripristinare la digestione compromessa.
Cibo dietetico. Una tecnica obbligatoria quando si trattano animali giovani con diarrea è quella di escludere o limitare la quantità di latte somministrata al 50% nei giorni successivi al trattamento. Lattosato, spelact, idrolisina enzimatica ed emolisato sono usati come farmaci e prodotti alimentari dietetici.
Al posto del latte, prima di assumere i farmaci, ai vitelli viene somministrata gelatina di farina d'avena, yogurt dietetico, latte acidofilo e soluzioni di reidratazione (sale di glucosio).
Terapia etiotropica. Ha lo scopo di sopprimere la microflora patogena e opportunistica e prevede l'uso di antibiotici, sulfamidici, nitrofurani, fluorochinoli e altri agenti antibatterici, coccidiostatici.
L'uso di agenti antibatterici è più efficace all'inizio dello sviluppo del processo infettivo, tenendo conto della sensibilità dei patogeni batterici ai farmaci, utilizzando combinazioni di antibiotici e altri farmaci con diversi meccanismi d'azione e con un effetto potenziante o sinergico e le loro dosi ottimali.
Il ripristino della composizione qualitativa e quantitativa della normale microflora intestinale dopo la terapia antibatterica viene effettuato mediante l'uso di probiotici.
Terapia probiotica. PABA, ABA, decotto di fieno, sporobacterin, bifidumbacterin, lactobacterin, bifitrilak, biosporin, lactobifadol, vetom, ecc.
Disposizioni generali:
i microrganismi inclusi in questi preparati sono la microflora simbiotica naturale del macroorganismo o la microflora transitoria;
lotta per un posto competitivo con la microflora patogena;
penetrare facilmente nel sangue e nei tessuti del corpo;
distruzione della microflora patogena con i propri enzimi (hanno un effetto battericida);
secernono sostanze biologicamente attive che agiscono come biostimolanti.
In medicina veterinaria viene utilizzato per la maggior parte delle malattie infettive, comprese quelle virali.
Terapia sintomatica. Per ripristinare la digestione compromessa e alleviare la sindrome da diarrea, vengono prima prescritti astringenti di origine vegetale o minerale.
Terapia sostitutiva. Per ripristinare la digestione compromessa, vengono utilizzati estratto duodenale, emolisato, polyentered, poliparenchimina, pepsina, abomin, succo gastrico artificiale, pancreatina, ecc.
Utilizzo di antiossidanti. Per rafforzare il sistema di difesa antiossidante (antiossidante) del corpo dei vitelli, secondo le istruzioni vengono utilizzate vitamine E, aminoacidi (metionina, cistina, glutatione) e preparati di selenio (selenito di sodio, depolene).
Cardiotonico. Per mantenere l'attività cardiaca vengono utilizzati benzoato di caffeina-sodio, canfora, sulfocanfocaina, siero di canfora secondo Kadykov e bromuro di tiamina.
Terapia antitossica. Per la reidratazione vengono utilizzate soluzioni contenenti ioni sodio, cloro, potassio e glucosio. Gli agenti di reidratazione più efficaci: rehydraltan, vetglucosalan, kalinat, rehydran, citroglucosalan, vetseptol, ecc. I farmaci vengono utilizzati per via orale, endovenosa, intraperitoneale, sottocutanea.
Mezzi efficaci contro la disidratazione e l'aumento della resistenza complessiva del corpo sono il sangue glucosato e il siero sanguigno allogenico, ecc.
Terapia vitaminica. Tra i mezzi di terapia patogenetica sono efficaci i preparati vitaminici e gli agenti con attività immunomodulante e adattogena: vitamine A, D3, E, C, B12, tetravit, trivit, preparati di beta-carotene (Carolin, Kartok, Carcel), tintura di Eleuterococco, nucleinato di sodio, levamisolo, dibazolo, acido fumarico, timogeno, immunofan, ASD (2).
Terapia specifica i pazienti con colibacillosi, salmonellosi e altre malattie infettive, insieme a questi farmaci, prevedono l'uso di sieri iperimmune, globuline, fagi e altri farmaci secondo le istruzioni.
Prevenzione.
La prevenzione generale delle malattie gastrointestinali negli animali giovani è assicurata dal rigoroso rispetto delle raccomandazioni per la produzione di animali giovani sani:
l'utilizzo di mangimi completi e di qualità sanitaria e di diete bilanciate per vacche e manze, soprattutto nella seconda metà della gravidanza e nel periodo di asciutta;
aumentare la resistenza naturale del corpo dei vitelli appena nati prevenendo l'ipotermia, l'alimentazione tempestiva e corretta del colostro, nonché eliminando le cause che lo riducono e provocano l'insorgenza della malattia;
creazione di un regime sanitario e igienico ottimale nei box di maternità (stalle) e nei locali del dispensario durante il periodo di detenzione dei vitelli;
sterminio dei roditori (topi, ratti) nei locali, impedendo l'accesso a cani e gatti;
prevenire l'accumulo e la diffusione di microrganismi patogeni e opportunisti nei dispensari aziendali;
rispetto da parte di veterinari e allevatori di norme di igiene personale durante la fornitura di cure ostetriche, l'accoglienza e l'alimentazione dei vitelli appena nati.
Per compensare la disbiosi fisiologica e il possibile sviluppo precoce di resistenza alla colonizzazione intestinale, dopo la somministrazione del primo colostro ai neonati, è necessario somministrare probiotici - preparati (lattobifadolo, streptobifido, ecc.) contenenti la normale microflora intestinale vivente o i suoi metaboliti e sostanze che stimolano lo sviluppo della normale microflora nell'intestino. Anche la somministrazione precoce di preparati probiotici è importante perché la normale microflora intestinale agisce negli animali appena nati come primo e sicuro stimolatore del sistema immunitario.
Per eliminare e prevenire le immunodeficienze in un neonato dopo aver assunto il colostro, vengono utilizzati immunomodulatori: T-activina, immunofan e altri preparati globulinici, sieri iperimmune specifici, siero di sangue convalescente, nonché abactan, abactan-R, abactan-D e altri farmaci secondo alle istruzioni.
Per aumentare la resistenza non specifica e la reattività immunobiologica, fin dai primi giorni di vita del neonato, introdurre nel colostro e nel latte integratori di proteine-vitamine-macro-microminerali, tenendo conto della loro carenza di colostro e latte, nonché di altre sostanze biologicamente attive - estratto di eleuterococco, nucleinato di sodio, ecc. secondo le istruzioni.
Negli allevamenti permanentemente sfavorevoli con malattie gastrointestinali dei vitelli causate da monoinfezioni batteriche (colibacillosi, salmonellosi, ecc.), vengono utilizzati monovaccini appropriati per immunizzare le madri e per le infezioni batteriche associate (colibacillosi, salmonellosi, infezioni da Proteus e Klebsiella) - un vaccino inattivato associato contro queste infezioni.
Negli allevamenti permanentemente sfavorevoli a causa di malattie gastrointestinali dei vitelli causate da infezioni virali (corona, rota, IRT, ecc.), tenendo conto della situazione epizootica, si utilizzano opportuni vaccini mono o associati per immunizzare le vacche e le manze gravide.
Negli allevamenti sfavorevoli alla diarrea virale, una malattia delle mucose, i riproduttori vengono immunizzati per la prima volta 2-3 settimane prima dell'inseminazione (accoppiamento) e nuovamente alla fine della gravidanza (7-8 mesi). Questo schema di immunizzazione consente di proteggere il feto dall'infezione transplacentare e dallo sviluppo di tolleranza, fornendo allo stesso tempo una protezione affidabile del vitello neonato dall'infezione attraverso l'immunità colostrale.
Negli allevamenti permanentemente sfavorevoli a causa di malattie gastrointestinali dei vitelli causate da un'associazione di virus, batteri e altri agenti patogeni, vengono utilizzati vaccini adeguati per immunizzare in modo completo le madri incinte e, se necessario, i giovani animali da loro ottenuti.
Situazione epizootica della brucellosi, caratteristiche di diagnosi e prevenzione
Brucellosi(Brucellosi), febbre maltese, febbre ondulatoria è una malattia cronica infettiva di molte specie di animali domestici e selvatici, che si manifesta con febbre, danni al sistema muscolo-scheletrico, al sistema nervoso, aborto, ritenzione della placenta, endometrite e disturbi della capacità riproduttiva degli animali .
Riferimento storico. La malattia era conosciuta in Inghilterra all'inizio del XIX secolo, dove era molto diffusa e prendeva il nome dal sintomo più caratteristico degli animali: l'aborto spontaneo. L’eziologia è rimasta sconosciuta per molto tempo. Nel 1876 Frank, introducendo materiale patologico proveniente da mucche abortite nel canale del parto di animali sani, provocò l'aborto e stabilì così la contagiosità della malattia, confermata poi da Lehnert (1878) e Brourer (1880). La malattia era chiamata aborto infettivo. L'agente patogeno fu scoperto nel 1896 dal ricercatore danese V. Bang in collaborazione con Stribolte. Un microbo fu isolato da mucche malate, in seguito chiamato Bacillus Bang.
Alla fine del 19° secolo. Sulla costa e sulle isole del Mar Mediterraneo, in particolare sull'isola di Malta, le persone si infettavano con la febbre, chiamata maltese, o febbre di Gibilterra, cretese, napoletana o mediterranea. Nel 1886, D. Bruce, esaminando il cadavere di un soldato morto di febbre di Malta, scoprì un microbo al microscopio. Quando inoculava materiale patologico su un mezzo nutritivo, Bruce isolò un microbo identico, chiamandolo successivamente micrococco (Micrococcus melitensis). A. Wright e D. Semple nel 1897 stabilirono la capacità del siero dei malati di agglutinare una coltura di micrococco, che costituì la base per la diagnosi di brucellosi. Successivamente, il dottor Zammit ha stabilito che i portatori dell'agente causale di questa malattia sono le capre e che le persone vengono infettate dalla febbre maltese consumando latte di animali infetti. La febbre maltese umana e l’aborto bovino infettivo sono stati a lungo presi in considerazione
malattie indipendenti. Successivamente è stata stabilita l'identità del bacillo di Bang con il micrococco di Bruce. Nel 1914 Traum trovò quella massa
gli aborti nei suini sono causati da un microbo morfologicamente simile all'agente eziologico dell'aborto nei bovini. Questo microrganismo è stato chiamato Vas. abortus suis. A. Ivens nel 1918 dimostrò la parentela degli agenti patogeni. Nel 1923 designò l'intero gruppo con il nome della specie Brucella (da Bruce) e la malattia divenne nota come brucellosi. Heddelson nel 1929 presentò la sua classificazione dei patogeni noti della brucellosi e introdusse nomi semplificati dei patogeni:
Fratello melitensis = Micrococcus melitensis (Bruce);
Fratello abortus = Batterio abortus bovis (Bang);
Fratello suis = Batterio abortus suis (Traum).
Uno schema simile è attualmente generalmente accettato, sebbene ad esso siano stati aggiunti alcuni altri rappresentanti che causano la brucellosi. Le prime segnalazioni della comparsa della brucellosi nei bovini in Russia risalgono al 1900. Nel 1913, V.I. Yakimov fu il primo a diagnosticare la brucellosi di capra. Un contributo significativo allo studio della brucellosi è stato dato dagli scienziati sovietici S.N. Vyshelessky, P.F. Zdrodovsky, P.A. Vershilova, M.K. Yuskovets, E.S. Orlov, P.S. Ulasevich, P.A. Trilenko e altri.
La malattia è diffusa in molti paesi del mondo, ma soprattutto in Africa, America centrale e meridionale, alcuni paesi dell’Asia e dell’Europa.
Patogeno. Attualmente il genere Brucella conta 6 specie.
Fratello abortus è l'agente eziologico della brucellosi nei bovini, yak, bufali, cammelli e cavalli.
Fratello melitensis è l'agente eziologico della malattia nelle pecore, nelle capre e il più pericoloso per l'uomo.
Fratello suis è l'agente eziologico della malattia nei suini e nei cervi. Portatori della 2a biovar
B. suis non sono solo maiali, ma anche lepri, 4o cervo, 5o roditori simili a topi.
Fratello neotomae – isolato dal ratto dell’erba madre negli Stati Uniti.
Fratello ovis è l'agente eziologico dell'epididimite infettiva negli ovini, non circolatoria
vagando per il territorio del nostro Paese.
Fratello canis – isolato dai cani.
L'identificazione delle specie e dei biovarianti è importante per chiarire la natura del serbatoio, la fonte dell'agente patogeno e le vie di diffusione della malattia.
Dati epizootologici. La brucellosi è comune in quasi tutti i paesi del mondo. Il più importante significato epizootologico ed economico nel nostro paese è la brucellosi di bovini, renne e suini. In termini epidemiologici, la brucellosi degli ovini e dei caprini è la più pericolosa. A causa della possibilità di pericolo sociale, è incluso nell'elenco delle infezioni da quarantena e particolarmente pericolose (EDI). Tutti i tipi di animali domestici (bovini, maiali, cervi, cervi, yak, bufali, cavalli, cammelli, cani, gatti), lepri, saiga, volpi, roditori, cinghiali sono sensibili alla brucellosi. Gli uccelli sono resistenti alla brucellosi anche con l'infezione sperimentale. La malattia è più diffusa tra ovini, caprini, bovini e suini. Focolai di brucellosi possono persistere nella fauna selvatica a causa di ungulati, lagomorfi e roditori. Casi sporadici della malattia si registrano in cavalli, bufali, cammelli, cani, animali da pelliccia e pollame. Il grado di diffusione della brucellosi non dipende dalle caratteristiche climatiche e geografiche della zona. Molto più importante è la concentrazione di animali sensibili e la capacità di rispettare le norme veterinarie e sanitarie. Grado
la suscettibilità all'infezione da brucellosi dipende dall'età, dallo stato fisiologico del corpo, dalle condizioni di detenzione, alimentazione, ecc. È stata stabilita la resistenza alla brucellosi nei giovani animali da allevamento (agnelli e vitelli fino a 3-4 mesi, suinetti fino a 5 mesi). La resistenza diminuisce verso la pubertà. Gli animali giovani e maturi sono particolarmente sensibili alla brucellosi. Nei riproduttori, la resistenza è significativamente ridotta sotto l'influenza della gravidanza. Il grado di infezione dei riproduttori è sempre superiore a quello dei maschi riproduttori e soprattutto dei castrati.
La fonte dell'infezione sono gli animali affetti da brucellosi, in particolare con manifestazioni cliniche di infezione e portatori di brucellosi. Il serbatoio dell'infezione è molto spesso il bestiame piccolo e grande. Gli animali infettati da Brucella espellono l'agente patogeno nel latte, nelle urine, nelle feci, nel liquido amniotico, nel feto, nelle membrane e nello sperma durante l'intero periodo della malattia. I più pericolosi a questo proposito sono il feto e la placenta degli animali affetti da brucellosi che abortiscono. Ciò provoca l'accumulo dell'agente patogeno nell'ambiente esterno e crea la possibilità di reinfezione degli animali. I prodotti infetti da Brucella e le materie prime di origine animale, gli articoli per la cura, i mangimi, la lettiera, l'acqua, il suolo e gli indumenti umani sono fattori di trasmissione.
Modi per infettare gli animali con la brucellosi:
Nutrizionale, quando si consumano cibo e acqua contaminati da secrezioni di animali malati. In questo caso la Brucella invade l'organismo attraverso le mucose del tubo digerente;
aerogenico, quando l'agente patogeno entra nelle mucose del naso;
contatto. Qui è necessario tenere conto del contatto diretto della Brucella con la pelle danneggiata, sebbene l'infezione degli animali attraverso la pelle si verifichi in casi eccezionali. La modalità congenita (sessuale) dell'infezione è di importanza decisiva, soprattutto nei suini.
Segni clinici. La durata del periodo di incubazione è di 2-4 settimane. Nella maggior parte dei casi, la brucellosi è asintomatica, soprattutto in assenza di animali gravidi. Il decorso predominante dell'infezione è cronico, durante il periodo di generalizzazione del processo è acuto. Negli animali gravidi, indipendentemente dal tipo, la brucellosi è caratterizzata da aborti nella seconda metà della gravidanza. Nelle mucche, l'aborto avviene nella seconda metà della gravidanza, a 5-8 mesi.
1-2 giorni prima dell'aborto, l'animale avverte iperemia e gonfiore delle labbra e della mucosa vaginale. Un liquido mucoso, talvolta rosso-brunastro, viene rilasciato dal tratto genitale e la mammella si gonfia. Dopo un aborto si sviluppano ritenzione di placenta, endometrite e, meno comunemente, mastite. Possibili artriti, igromi, borsiti. Nei tori si osservano orchite purulento-necrotica, epididimite, artrite e sinovite.
Nei cavalli gli aborti si verificano molto raramente, di solito nelle prime fasi della gravidanza. È possibile una borsite nella zona della nuca e del garrese, che si trasforma in processi purulento-necrotici, che spesso coinvolgono i processi spinosi e le vertebre cervicali.
Nelle renne, la brucellosi si manifesta in modo latente, le manifestazioni cliniche sotto forma di aborti, mastiti, borsiti, artrite, tendovaginite e orchite sono rare. Il segno clinico più comune e caratteristico è la borsite. Nelle pecore e nelle capre, gli aborti dovuti all'eziologia della brucellosi si osservano nel 4°-5° mese di gravidanza. Dopo l'aborto si notano ritenzione della placenta ed endometrite. Fino al 20% degli animali potrebbe rimanere sterile in futuro. Negli arieti sono possibili orchiti ed epididimiti.
Gli aborti sono tipici delle scrofe, sia nella prima che nella seconda metà della gravidanza. Prima di un aborto si notano diminuzione dell'appetito, gonfiore della mammella e meno spesso diarrea. Dopo un aborto può verificarsi ritenzione della placenta con conseguente sviluppo di endometrite e vaginite. I suini sono inoltre caratterizzati dalla formazione di ascessi sotto la pelle, negli organi interni e nei linfonodi. Secondo alcuni ricercatori, ciò è spiegato dalle proprietà piogene e dalla maggiore virulenza dell'agente eziologico della brucellosi nei suini. Nei cinghiali sono possibili orchiti, epididimiti e infiammazioni delle vescicole seminali (vescicoliti). Nei cani la brucellosi è cronica e molto spesso asintomatica. Le femmine sono caratterizzate da aborti nel 30-50esimo giorno di gravidanza, dalla nascita di prole morta e da processi infiammatori nell'utero. Nei maschi vengono colpiti i genitali con lo sviluppo di epididimite e orchite. Nei casi più gravi, il parenchima della prostata e i tubuli seminiferi dei testicoli vengono distrutti e si sviluppa l'aspermatogenesi, che porta alla sterilità.
Negli animali da pelliccia affetti da brucellosi si riscontra un'alta percentuale di sterilità delle femmine, aborti e aumento della mortalità dei cuccioli appena nati. Va notato che i segni clinici elencati separatamente di natura sporadica o di massa non giustificano una diagnosi di brucellosi. Ciò è dovuto al fatto che sintomi simili possono accompagnare una serie di altre malattie infettive.
Cambiamenti patologici. Negli animali che hanno abortito, le membrane sono gonfie e ricoperte di scaglie di fibrina e pus. Possono esserci segni di metrite catarrale purulenta, danni ai reni, alla milza, al fegato (ascessi). Nei maschi si nota lo sviluppo di orchite purulento-necrotica. Nelle femmine: mastite, sofarite, cisti vengono rilevate nelle ovaie, danni articolari e borsiti sono comuni. Nei feti abortiti, gonfiore del tessuto sottocutaneo e del cordone ombelicale, accumulo di liquido rosso-bruno con scaglie di fibrina nel torace e nelle cavità addominali, emorragie sulle membrane sierose e mucose, infiammazione catarrale delle mucose del tratto gastrointestinale e dei polmoni, si trovano aree necrotiche nel fegato.
Misure per la prevenzione e l'eliminazione della brucellosi negli animali. Le misure preventive contro la brucellosi dovrebbero basarsi su un rigoroso isolamento degli allevamenti sfavorevoli, eliminando ogni possibilità che l'agente patogeno venga trasportato dal focolaio epizootico. Per prevenire l’introduzione dell’agente infettivo negli allevamenti sicuri è necessario:
Reclutare la mandria solo da allevamenti sicuri e spostare gli animali solo con il permesso di specialisti veterinari;
tutti gli animali in arrivo dovrebbero essere messi in quarantena per 30 giorni e testati con metodi sierologici per la brucellosi;
non è consentito il contatto degli animali con allevamenti di allevamenti disagiati, nonché le visite del personale presso allevamenti disagiati;
garantire il rispetto delle norme veterinarie e sanitarie per l'alimentazione, la detenzione e lo sfruttamento degli animali;
Condurre test diagnostici preventivi pianificati annuali sugli animali per la brucellosi utilizzando metodi sierologici e allergici.
Se si sospetta che un animale sia affetto da brucellosi, adottare immediatamente misure per stabilire una diagnosi mediante esame del sangue degli animali e, in caso di aborti, un esame batteriologico obbligatorio dei feti e delle membrane abortiti. Una volta effettuata la diagnosi, vengono imposte restrizioni all'allevamento e viene elaborato un piano di recupero dalla brucellosi.
Secondo i termini delle restrizioni, è vietato:
Ingresso e uscita di animali sensibili, raggruppamento di animali all'interno dell'azienda agricola, approvvigionamento di animali e mangimi per l'esportazione in altre aziende agricole, utilizzo di animali malati per la riproduzione;
contatto di allevamenti svantaggiati con allevamenti sani;
l'uso di pascoli su cui sono pascolati animali malati per 3 mesi, nonché l'uso di bacini stagnanti per l'irrigazione;
esportazione di latte non disinfettato ottenuto da mucche in un allevamento disfunzionale. Il latte dovrà essere lavorato direttamente presso l'azienda agricola svantaggiata fino all'abolizione delle restrizioni; il latte delle mucche che reagiscono positivamente deve essere bollito o trasformato in burro chiarificato; il latte delle mucche che non rispondono viene disinfettato a una temperatura di 70°C per 30 minuti o a una temperatura di 85–90° per 20 secondi o mediante bollitura.
Gli animali malati e positivi vengono isolati e inviati al macello entro 15 giorni. Nelle aziende agricole sfavorevoli è necessario effettuare la disinfezione, la disinfestazione, la deratizzazione, la riparazione sanitaria dei locali e altre misure veterinarie e sanitarie in conformità con le norme e le raccomandazioni su questi temi.
Applicazione della metodologia per il monitoraggio della prevalenza della leucemia bovina nelle aziende agricole utilizzando tecnologie innovative
La leucemia bovina è una malattia tumorale maligna del sistema linfoide che si verifica a seguito dell'infezione con il virus della leucemia.
L'agente eziologico della malattia è un virus oncogeno di tipo C (oncornavirus) contenente RNA, appartenente al genere Oncovirus C, famiglia Retroviridae. Il virus della leucemia bovina è morfologicamente simile agli agenti causali della leucemia in altre specie animali, ma esistono differenze significative nella struttura antigenica. In condizioni sperimentali è stato possibile riprodurre l'infezione da VLCRS in pecore, conigli, maiali, scimmie e altre specie animali. È stata inoltre determinata la somiglianza della sequenza nucleotidica delle proteine VLCV e del virus dell'immunodeficienza umana (HIV).
Il virus non è resistente alle alte temperature, quindi durante la pastorizzazione del latte a 76°C muore entro 20 secondi e quando viene bollito muore all'istante. A basse temperature e congelamento profondo, la vitalità del virus rimane. È sensibile ai disinfettanti convenzionali e perde rapidamente attività se esposto a soluzioni di soda caustica, formaldeide, etanolo, fenolo e altri disinfettanti in concentrazioni generalmente accettate. Quando il sangue si secca, il virus muore poiché i linfociti perdono la loro vitalità.
La fonte dell'agente eziologico della malattia sono gli animali infetti da VLBRS in tutte le fasi del processo infettivo. I fattori di trasmissione del virus possono essere qualsiasi fluido biologico (sangue, latte, sperma, liquido amniotico, ecc.) contenente linfociti infetti, poiché VLCRS è integrato nei cromosomi delle cellule linfoidi colpite, condannando l'organismo colpito all'infezione per tutta la vita.
Esistono due modalità di trasmissione del virus della leucemia: verticale - dalla madre al feto (intrauterina) e orizzontale - da un animale (infetto) a un altro animale (intatto). L'infezione nell'utero di una madre infetta si verifica nel 5-7% dei vitelli (secondo molti ricercatori) e in un paziente affetto da leucemia nel 10-20%.
Gli animali sani vengono infettati da individui infetti da VLCRS principalmente nei seguenti casi:
Violazioni delle norme di asepsi e antisepsi durante le attività veterinarie e zootecniche (prelievi di sangue, somministrazione di farmaci, vaccini e sieri, rimozione delle corna, trattamento degli zoccoli, esami rettali, ostetricia, fissaggio degli animali tramite il setto nasale, fecondazione artificiale, etichettatura degli animali, eccetera.) ;
abbeverare i vitelli di età superiore ai 10 giorni con latte di mucche infette;
utilizzo di tori da monta per l'accoppiamento libero di vacche e manze.
I bovini di tutte le età sono suscettibili alla leucemia. Negli animali giovani fino a 5-6 mesi di età, la funzione protettiva è svolta dagli anticorpi del colostro ottenuti con il colostro di una mucca infetta, quindi la leucemia si verifica estremamente raramente. La malattia si manifesta più spesso all'età di 4-7 anni, ma gli animali possono ammalarsi anche nell'utero.
Esistono 4 fasi nello sviluppo dell'infezione: incubazione, infettiva, ematologica e tumorale. Il periodo di incubazione dura da 16 giorni a 3 mesi o più; il trasporto latente del virus può durare tutta la vita ed è asintomatico. L'infezione di solito si manifesta 2 mesi dopo l'infezione nella reazione RID. Lo stadio ematologico si manifesta con alterazioni del sangue sotto forma di leucocitosi, linfocitosi. Si sviluppa nel 4-5% degli animali infetti e successivamente progredisce fino allo stadio tumorale terminale della malattia. Solo in questa fase vengono rivelati i segni clinici caratteristici: i linfonodi e la milza si ingrandiscono, compaiono escrescenze tumorali nell'ematopoietico e in altri organi e tessuti con interruzione della loro funzione. Il processo risultante è irreversibile. Questo stadio è registrato nell'1% degli animali ematologicamente malati.
È caratteristico che la leucemia si manifesti spesso nelle mucche altamente produttive. Ciò è dovuto al fatto che tali animali hanno uno stato immunitario ridotto, una capacità di adattamento e una resistenza generale del corpo a causa della mancanza di composti biologicamente attivi (vitamine, macro e microelementi, ecc.).
La leucemia provoca danni economici significativi, che consistono in perdita di latte, lettiera, restrizioni sulla vendita di latte, abbattimento prematuro di mucche e tori, smaltimento di carcasse e organi e costi per attività di miglioramento della salute. Inoltre, è stata accertata una diminuzione del valore nutrizionale del latte delle mucche infette da BLV a causa della diminuzione del contenuto di proteine totali e della maggior parte degli aminoacidi, compresi quelli essenziali. Inoltre, il ringiovanimento di una mandria sana, eliminando le mucche adulte dalla produzione e sostituendole con manze, riduce la produzione lorda di latte. Grandi danni economici vengono causati anche agli allevamenti a causa delle restrizioni al lavoro di allevamento e alle attività economiche a causa dei problemi di leucemia.
Il latte e la carne di animali affetti da leucemia sono pericolosi per l'uomo perché contengono metaboliti dannosi del triptofano e di altri aminoacidi ciclici. Il latte delle mucche affette da leucemia è vietato per il consumo umano.
Il latte delle mucche infette e di altre mucche della mandria in via di guarigione (azienda agricola, appezzamento sussidiario individuale, azienda agricola privata) viene consegnato a un impianto di lavorazione del latte o utilizzato all'interno dell'azienda agricola dopo la pastorizzazione nella consueta modalità tecnologica. Dopo la disinfezione, il latte viene utilizzato senza restrizioni (clausola 4.4 delle Regole per la prevenzione e il controllo della leucemia nei bovini, M., 1999, di seguito denominate “Regole...”). Dal 01.01.2016 sono state apportate modifiche alle norme tecniche per il latte e i prodotti lattiero-caseari, secondo le quali il latte deve essere ottenuto da animali da allevamento sani in una zona esente da malattie infettive e altre malattie comuni all'uomo e agli animali. Se il risultato dei test ematologici sugli animali per la leucemia è positivo, ma non sono presenti cambiamenti patologici caratteristici di questa malattia, la carcassa e gli organi vengono rilasciati senza restrizioni.
Al momento, lo sviluppo della scienza e della pratica non consente la creazione di mezzi efficaci per il trattamento e la prevenzione di questa malattia. Ma avendo a disposizione metodi intravitali affidabili per diagnosticare la leucemia, seguendo le “Regole...”, è diventato possibile attuare efficacemente misure di miglioramento della salute.
Attualmente, la situazione delle epizoozie legate alla leucemia bovina nella regione di Samara continua a rimanere tesa. Le aziende agricole che attuano pienamente le misure sanitarie in conformità con le “Regole...” si sbarazzano della leucemia bovina molto prima rispetto alle aziende agricole che non rispettano le regole di cui sopra. Secondo la squadra epizootica, al 1° gennaio 2016, 14 aziende agricole nella regione di Samara sono state guarite dal virus della leucemia.
L'esperienza pluriennale del Samara Research Institute sul problema della leucemia bovina ha dimostrato che è necessario sviluppare una metodologia per controllare la diffusione della leucemia bovina nelle aziende agricole utilizzando tecnologie innovative. La metodologia sviluppata prevede i seguenti punti:
1. Chiarimento della situazione epizootica della leucemia in questa azienda agricola.
2. Determinazione del grado di infezione degli animali da parte del virus della leucemia al fine di sviluppare un piano individuale di misure antileucemiche, tenendo conto del tasso di infezione, del numero di capi di bestiame, del sesso e delle fasce di età, della tecnologia di allevamento, della presenza e ubicazione delle aziende agricole e dei pascoli, ecc. Il piano determina i tempi della ricerca e i responsabili esecutori delle misure organizzative ed economiche, di selezione e zootecniche, veterinarie e sanitarie.
3. Conduzione di studi sulla leucemia: utilizzando il metodo sierologico - una volta al trimestre, ematologicamente - una volta ogni sei mesi. (La ricerca su animali giovani per VLCRS dovrebbe iniziare a 6 mesi di età.)
4. Secondo i risultati degli studi RID, gli animali che reagiscono positivamente devono essere rimossi dalla mandria (trasferiti in gruppi di ingrasso), gli animali ematologicamente malati devono essere portati in un impianto di lavorazione della carne. Allo stesso tempo, è necessario organizzare il lavoro per creare una mandria libera da VLBRS sostituendo le mucche infette con manze sane.
5. Gli animali appena entrati nell'allevamento devono essere messi in quarantena per 30 giorni per studi e trattamenti sierologici, ematologici e di altro tipo.
6. Applicazione di tecnologie innovative per l'elaborazione, la sistematizzazione e l'analisi dei risultati della ricerca. Per fare ciò, è necessario inserire i risultati degli studi sierologici ed ematologici nel programma informatico “Monitoraggio della leucemia bovina”.
7. Sulla base dei risultati ottenuti, vengono elaborate raccomandazioni per i dirigenti e il servizio veterinario dell'allevamento sull'adeguamento delle misure antileucemiche.
1. Compilazione corretta dei documenti di accompagnamento (ad esempio, è necessario indicare l'età degli animali studiati con il metodo ematologico).
2. Rispetto della tecnologia di raccolta del sangue per evitare la coagulazione.
3. Rispetto delle regole di asepsi e antisepsi per evitare la reinfezione degli animali, compreso l'uso di guanti monouso individualmente per ciascun animale durante l'esame rettale e l'inseminazione artificiale.
4. Organizzazione di parti separati per le giovenche con status RID(–) e RID(+), nonché pascolo separato degli animali RID(+) e RID(–) durante il periodo di pascolo.
5. Controllo costante della numerazione affidabile degli animali (non sono ammessi numeri doppi). In caso di smarrimento del tag è necessario ripristinare immediatamente il numero.
6. Rispetto dei termini di ricerca: i bovini giovani dovrebbero essere esaminati sierologicamente a partire da 6 mesi. età ad intervalli di 3 mesi. I campioni di sangue per la ricerca vengono prelevati non prima di 30 giorni dopo la somministrazione di vaccini e allergeni agli animali e, per gli animali gravidi, 30 giorni prima o 30 giorni dopo. Gli esami ematologici delle mucche vengono effettuati 2 volte l'anno con un intervallo di 6 mesi.
Avendo una vasta esperienza nell'implementazione di linee guida metodologiche per misure sanitarie anti-leucemia nelle regioni di Samara e Orenburg, il NIVS di Samara, nella fase finale del miglioramento della salute in una delle aziende agricole, ha condotto un esperimento per ridurre a due il tempo tra gli studi sierologici sui riproduttori mesi. Ciò ha permesso di accelerare il raggiungimento di un tasso di infezione pari allo zero% negli allevamenti. Ma quando il gruppo di mucche è stato rifornito di manze, è stata successivamente identificata una testa RID(+), che è stata abbandonata dagli studi diagnostici e non è stata esaminata durante l'anno. Questo fatto ha mostrato la necessità di una contabilità più chiara del bestiame e di monitorare la frequenza degli studi per ciascun animale.
Per risolvere questo problema, i dipendenti del Samara NIWS hanno sviluppato (2008) e migliorato il programma informatico "Monitoraggio della leucemia bovina" (certificato di registrazione statale n. 2012612294 del 2 marzo 2012), che consente di determinare rapidamente la situazione epizootica e misure antiepizootiche tempestive e corrette.
Diamo uno sguardo più da vicino alle capacità del programma “Monitoraggio della leucemia bovina”. Sulla base di questo programma è stato creato un “Database di competenze sulla leucemia bovina” che viene costantemente aggiornato con nuove informazioni. In questo database è possibile inserire le informazioni sui vari allevamenti e poi cercare l'allevamento desiderato; in questo caso gli allevamenti possono essere serviti in diversi laboratori veterinari, i cui dati vengono inseriti anche nel programma. Le funzionalità del programma consentono di inserire i risultati degli esami nel database separatamente per ciascuna regione, distretto, azienda agricola, base, mandria e animale specifico. In questo caso vengono indicati il numero di campioni da esaminare, la data dello studio, l'età degli animali, il tipo di studio, l'analisi primaria o secondaria, i numeri di inventario degli animali e i risultati stessi. Una volta inseriti i risultati nel database, è possibile stampare o semplicemente visualizzare un'anteprima del report. È conveniente visualizzare i risultati degli esami sotto forma di rapporto, poiché ciò consente di vedere immediatamente la data dello studio successivo e i risultati degli studi precedenti, rintracciare gli animali con numeri doppi, identificare la sovraesposizione a RID(+) e la presenza di animali non esaminati e aumentare il tempo tra gli studi diagnostici.
Sulla base di questi esami, i collaboratori della NIVS elaborano raccomandazioni per ulteriori interventi sanitari e adeguano le misure antileucemiche. Un esempio dell'implementazione di successo della metodologia nella lotta contro la leucemia sono i risultati della riabilitazione di Stepnoe JSC nel distretto di Tashlinsky della regione di Orenburg sotto la guida della Samara NIVS.
Il lavoro per migliorare la salute dell'azienda agricola è iniziato nel 2008 con la determinazione della situazione epizootica relativa alla leucemia. Dopo aver determinato il grado di infezione degli animali da parte del virus della leucemia, è stato sviluppato per l'azienda un piano individuale di misure antileucemiche, tenendo conto del tasso di infezione, del numero di capi di bestiame e dei gruppi di età, della tecnologia di allevamento, della presenza e ubicazione delle aziende agricole e dei pascoli, ecc. I piani determinavano i termini e gli esecutori responsabili delle misure organizzative ed economiche, zootecniche, veterinarie e sanitarie.
 Gli studi sierologici sono stati effettuati una volta al trimestre, gli studi ematologici - una volta ogni sei mesi. Secondo i risultati degli studi, gli animali sensibili al RID(+) sono stati trasferiti all'ingrasso e gli animali ematologicamente malati sono stati portati in un impianto di lavorazione della carne. Allo stesso tempo, i risultati di questi studi sono stati inseriti in un programma per computer.
Gli studi sierologici sono stati effettuati una volta al trimestre, gli studi ematologici - una volta ogni sei mesi. Secondo i risultati degli studi, gli animali sensibili al RID(+) sono stati trasferiti all'ingrasso e gli animali ematologicamente malati sono stati portati in un impianto di lavorazione della carne. Allo stesso tempo, i risultati di questi studi sono stati inseriti in un programma per computer.
Nella fase iniziale il tasso di infezione degli animali giovani era del 20,1%, mentre quello dei riproduttori era di circa il 60%. L'incidenza della morbilità dei riproduttori nel 2008 è stata del 2,9%.
Secondo le “Regole...”, per JSC Stepnoe è stata scelta la terza opzione di misure di miglioramento della salute negli allevamenti non affetti da leucemia (più del 30% delle mucche e delle manze infette da VLKRS).
Grazie all'attuazione di un piano individuale di misure antileucemiche, il tasso di infezione tra gli animali giovani è sceso nel secondo trimestre del 2008 all'11,7%, nel terzo trimestre al 3,2% e nel quarto trimestre al 2,0% ( Figura 10). Grazie alla separazione degli animali, nel quarto trimestre del 2011 il tasso di infezione dei riproduttori è sceso al 22,6% (fig. 11). Nel secondo trimestre del 2013, questa cifra era del 4,4%.
Grazie all'applicazione efficace della metodologia sviluppata, il tasso di infezione tra gli animali giovani nell'allevamento oggi è sceso allo 0,4% (giovenche in età riproduttiva) con uno studio trimestrale di 1.500-1.700 capi di animali giovani e le vendite riproduttive di questi animali vengono effettuati. Il tasso di infezione dei riproduttori è dello 0,9%; è stata formata una mandria RID(–) di 1.003 capi.
I risultati ottenuti mostrano che l’implementazione della metodologia sviluppata utilizzando tecnologie innovative può ridurre significativamente l’infezione degli animali, semplificare significativamente il lavoro degli specialisti dei servizi veterinari e ridurre il tempo necessario agli allevamenti per riprendersi dalla VLBRS.
ANATOMICO-FISIOLOGICO
CARATTERISTICHE DEGLI ANIMALI GIOVANI.
Il problema della diagnosi precoce e corretta della malattia negli animali giovani, nonché l'attuazione di misure efficaci di trattamento e prevenzione, sono in gran parte determinati dalle caratteristiche dell'organismo in crescita, che variano ampiamente a seconda dell'età dell'animale. sono considerati fisiologicamente maturi se le loro costanti morfofisiologiche corrispondono alla loro età maturità morfofisiologica, il peso corporeo alla nascita di un animale varia a seconda della razza entro l'intervallo: per un vitello 20-45 kg, ovvero il 7-9% del corpo materno peso, per un suinetto - 1,0-1,5 kg, o 0,5-1,0 % del peso corporeo di una scrofa, agnello - 2,0-4,3 kg, o 6-8% del peso di una pecora, puledro - 26-50 kg, o 8 -12% del peso corporeo della madre. La lunghezza del corpo di un vitello appena nato è di 70-95 cm, un maialino - 20-25 cm, un agnello - 30-50 cm; puledro - 75-145 cm Alla nascita, un maialino ha 4 canini e 4 incisivi laterali, un vitello ha 4-6 incisivi e 12 molari e un agnello ha 6 incisivi. Nelle prime ore dopo la nascita, la temperatura rettale nei vitelli è di 37,6-38,4°C. Ad un giorno di età aumenta a 38,7-38,9°C, per poi salire a 39,2-39,5°C. Durante il periodo neonatale, gli animali giovani hanno un moncone del cordone ombelicale, che viene trattato con una soluzione di iodio. Scompare nei suinetti al 5-7° giorno di vita, nei vitelli dopo 8-10 giorni, nei puledri entro il 10-12° giorno. Nei neonati sono ben espressi numerosi riflessi incondizionati, in particolare il cibo e la termoregolazione, e ne caratterizzano ampiamente le caratteristiche fisiologiche. Già nelle prime ore è chiaramente espresso il riflesso di suzione, che si manifesta nei movimenti di ricerca del cibo. Suinetti, agnelli, puledri allattano ogni 0,5-2,0 ore. Il primo giorno, il vitello allatta in media 5 volte e nei tre giorni successivi 6-8 volte. La durata di una poppata varia da 2 a 25 minuti. Un vitello succhia 6-8 kg di colostro al giorno. La frequenza dei suoi movimenti di suzione può arrivare fino a 120 al minuto, la porzione di sorso è fino a 5 ml. Il sistema digestivo alla nascita dei vitelli è caratterizzato dai seguenti valori approssimativi: volume del rumine - 730 ml, abomaso - 1250 ml, lunghezza dell'intestino tenue - 15,9 m, intestino crasso - 2 m Nei suinetti appena nati, la capacità dello stomaco è in media 25 ml, la lunghezza dell'intestino tenue è di 3,8 m, e la capacità è di 100 ml, la lunghezza dell'intestino crasso è di 0,8 m Nei primi 10-15 giorni di vita, la capacità del rumine e soprattutto del abomaso aumenta significativamente nei vitelli. Pertanto, nei vitelli di 15 giorni, il volume del rumine raggiunge 1,3 l e l'abomaso - 4 l, la lunghezza dell'intestino tenue aumenta a 20,6 m, l'intestino crasso - fino a 2,7 m. Nei suinetti di 10 giorni, il volume dello stomaco è già di 73 ml, la lunghezza dell'intestino tenue è di 5,5 m e il volume arriva fino a 200 ml, la lunghezza dell'intestino crasso è fino a 1,2 m e la capacità è 90 ml. L'atto di succhiare è accompagnato dal rilascio di saliva. Nei primi giorni dopo la nascita, le ghiandole sottomandibolari e sublinguali secernono più attivamente. Con l’età, anche le ghiandole parotidi vengono coinvolte nella secrezione. Mescolare il latte con la saliva è un fattore importante nella prevenzione della malattia, poiché favorisce la formazione di piccoli coaguli di caseina nello stomaco, disponibili per l'ulteriore digestione. Nei ruminanti neonati, ciò è facilitato anche dalla manifestazione del riflesso esofageo, quando, scavalcando il prestomaco non funzionante, a differenza degli adulti, il colostro ingerito entra nell'abomaso. Il prestomaco inizia a funzionare man mano che i vitelli e gli agnelli si abituano a nutrirsi con mangime grossolano e succulento, poi compare l'atto della masticazione del ruminante, che nei vitelli avviene all'età di 12-14 giorni e oltre. Durante il periodo di allattamento al latte negli animali giovani, il tipo di digestione intestinale è più pronunciato. L'abomaso dei vitelli da latte e degli agnelli, a differenza dei ruminanti adulti, contiene una quantità relativamente elevata dell'enzima rennina (chimosina), che favorisce la coagulazione del caseinogeno del latte e la formazione di piccoli coaguli sciolti destinati ad un'ulteriore decomposizione. L'acido cloridrico libero non si trova nello stomaco nelle prime 2 ore di vita nei vitelli e fino ai 14-20 giorni di età nei suinetti, il che facilita l'assorbimento delle immunoglobuline del colostro materno nelle prime ore dopo la nascita, che vengono poi evacuate nello stomaco. l'intestino, dove vengono assorbiti dalle cellule epiteliali della mucosa dell'intestino tenue per pinocitosi ed entrano nella linfa e poi nel sangue. Questa caratteristica nei neonati è più pronunciata nelle prime 12-24 ore e scompare entro 36-48 ore dalla nascita. Di conseguenza, i fattori di resistenza umorale nei primi giorni dopo la nascita negli animali giovani dipendono interamente dall'apporto di immunoglobuline dall'esterno con il colostro materno, e così si crea l'immunità colostrale e la produzione dei propri anticorpi inizia dopo i 10 giorni di età. vitelli e dopo 12-15 giorni nei suinetti.
Pertanto, è estremamente importante somministrare il colostro ai neonati nelle prime ore dopo la nascita. Nei primi giorni di vita gli animali giovani hanno una reazione protettiva cellulare più pronunciata rispetto a quella umorale. La transizione dei neonati a condizioni ambientali con una temperatura inferiore rispetto all'utero materno provoca cambiamenti significativi nella bioenergetica. Il metabolismo basale nei vitelli è di 3,6 kcal/ora/kg, nei suinetti 4,0-6,0 kcal/ora/kg, negli agnelli 1,92 kcal/ora/kg. Dal momento della nascita aumenta il metabolismo energetico negli animali giovani, che è associato alla regolazione dei meccanismi di termoregolazione. Gli animali giovani appena nati spendono sostanzialmente la stessa quantità di energia per 1 kg di aumento di peso - circa 4800 kcal di mangime, con valori di 1 kg di aumento - 30 g di azoto e 1720 kcal. La formazione dei processi energetici è strettamente correlata alle caratteristiche delle funzioni di altri sistemi corporei e, in particolare, dei sistemi respiratorio e cardiovascolare. Alla nascita si verificano i primi movimenti respiratori extrauterini, facilitati dalla conseguente notevole pressione negativa nella cavità pleurica, che favorisce l'espansione dei polmoni. Allo stesso tempo, un numero enorme di capillari polmonari si apre e il sangue dal ventricolo destro entra nella circolazione polmonare. E poi il sangue viene trasportato attraverso le vene polmonari nell'atrio sinistro, dove si forma un'alta pressione e la valvola di Eustachio chiude l'apertura ovale tra gli atri. A causa della ristrutturazione della circolazione sanguigna, le pareti dei vasi ombelicali crollano, il dotto di Orano e le arterie ombelicali vengono cancellate. La capacità di mantenere una temperatura corporea costante si accompagna ad un aumento del consumo di ossigeno e alla formazione di una maggiore produzione di calore. Ciò è facilitato dall'irritazione dei recettori cutanei e polmonari dall'attivazione dei meccanismi di termoregolazione centrale, dall'aumento del tono dei muscoli scheletrici e dell'attività dei muscoli respiratori. Il tono muscolare aumenta ulteriormente se la mucca lecca il neonato. Leccare o asciugare il corpo del neonato lo libera dal liquido amniotico che lo ricopre, permette di asciugarsi più velocemente e quindi di risparmiare consumo di calore. Dopo la nascita, fin dai primi minuti di vita, la formazione di calore nei vitelli è più intensa, mentre nei suinetti e negli agnelli appena nati è meno accentuata. L'instaurazione della perfezione nella termoregolazione negli agnelli avviene dal 2-3 al 16 giorno e nei suinetti entro i 20 giorni di età. La frequenza cardiaca e respiratoria nei vitelli durante il periodo neonatale sono 134 e 47, negli agnelli 210 e 70-90, nei suinetti 248 e 86. All'età di 30 giorni, la frequenza cardiaca e respiratoria diminuisce nei vitelli a 100 e 41, negli agnelli - a 162 e 45, nei suinetti - a 124 e 41.
Negli animali giovani appena nati, i bronchi sono più stretti, ci sono poche fibre elastiche di collagene nei polmoni e il diametro degli alveoli è inferiore rispetto agli animali adulti. Ciò si associa alla presenza di respiro superficiale e alla mancanza di movimenti attivi, alla persistenza di atelettasie in alcune zone dei polmoni; durante il periodo neonatale si esplicano in maniera predominante i meccanismi di regolazione simpatica del cuore e ciò si manifesta con le sue contrazioni più frequenti.
Un animale giovane appena nato ha già riflessi generali e locali da quasi tutti i recettori e alcuni riflessi si formano dopo la nascita. Nei primi giorni di vita ne compaiono alcuni, vale a dire: suzione (cibo), motoria, protettiva (lampeggiamento). Man mano che cresci e ti sviluppi, la tua sensibilità al dolore aumenta. Il 3-4o giorno di vita inizia a formarsi un riflesso condizionato per un certo tempo di alimentazione.
che si esprime in eccitazione e ansia, aumento del contenuto di leucociti nel sangue prima dell'inizio dell'alimentazione, ecc. Durante il periodo neonatale, le ghiandole surrenali e il pancreas funzionano attivamente, ma la funzione endocrina delle gonadi è bassa e solo aumenta con l'età. In generale, gli ormoni anabolizzanti predominano in giovane età. Il riflesso motorio si manifesta nei vitelli nell'attività motoria, che varia dai 200-500 movimenti nelle prime ore di vita ai 400-500 movimenti nel primo giorno. La postura eretta si realizza nei vitelli fisiologicamente maturi 10-20 minuti a 70-80 minuti dopo la nascita.
A seconda del grado di deviazione delle condizioni ambientali dai parametri richiesti, si verifica una reazione allo stress e, di conseguenza, avviene l'adattamento del corpo o il verificarsi di varie patologie.
Classificazione delle malattie degli animali giovani. Allevare animali giovani sani e preservarli dalle malattie e dalla morte è uno dei compiti principali dell’allevamento. La sua difficoltà sta nel fatto che nei primi giorni il corpo del neonato è scarsamente adattato alle condizioni ambientali sfavorevoli a causa delle caratteristiche morfofunzionali del primo periodo postnatale. Pertanto, una serie di malattie, il loro decorso e le misure per combatterle hanno le loro caratteristiche.
L’incidenza e la morte di giovani animali da allevamento a causa di malattie interne non trasmissibili provocano notevoli danni economici. Gli animali giovani rappresentano circa il 75-90% della mortalità rispetto agli animali adulti, il che indica la grande importanza della diagnosi tempestiva, del trattamento e della prevenzione delle malattie. La morbilità e la mortalità si osservano più spesso durante il periodo neonatale. Nei successivi periodi di crescita e sviluppo degli animali giovani si riscontrano anche caratteristiche in corso di patologia non contagiosa rispetto a quella degli animali adulti.
Classificazione delle malattie degli animali giovani per origine prevede la suddivisione nei seguenti quattro gruppi condizionali: malattie causate da disturbi intrauterini dello sviluppo fetale (prenatale); patologia nella prole insorta durante la nascita della madre (perinatale); malattie del periodo neonatale (neonatale) malattie della successiva crescita e sviluppo degli animali giovani (postnatale).
Per localizzazione il principale focus patologico nei singoli organi o sistemi corporei, le malattie degli animali giovani sono divise in malattie dell'apparato digerente, respiratorio e anche in un gruppo speciale associato a disturbi metabolici - malattie da carenza. divulgazione delle caratteristiche delle malattie tenendo conto dei periodi di sviluppo prenatale, perinatale e postnatale. La manifestazione di malattie nel primo periodo postnatale è strettamente legata alle caratteristiche morfofunzionali della prole, che devono essere conosciute e utilizzate nella prevenzione mirata della patologia, tenendo conto delle condizioni prenatali dello sviluppo corporeo.
MALATTIE PRENATALI
IPOTROFIA FETALE (IPOTROFIA CONGENITA) -IPOTROFIAEMBRIONE
Una sindrome di patologia fetale intrauterina, diffusa tra vitelli, agnelli e suinetti, accompagnata dalla sua immaturità morfofunzionale. Dopo la nascita, i loro indicatori fisiologici non corrispondono alla loro vera età embrionale. La condizione del neonato è caratterizzata da una ridotta reattività alle condizioni ambientali, al carico di colostro e alle infezioni.
Eziologia e patogenesi. La causa principale della malnutrizione prenatale è una violazione quantitativa e qualitativa delle norme di alimentazione degli animali gravidi, un disordine metabolico in essi, che causa tossicosi della gravidanza, e la sua conseguenza è la tossicosi e l'ipossia del feto, disordini metabolici in esso, indebolimento del feto la differenziazione dei tessuti e degli organi del feto, che insieme porta all'immaturità morfologica e funzionale della prole.
Negli allevamenti di suini, il numero di soggetti ipotrofici aumenta durante il parto invernale e all'inizio della primavera. Durante il periodo della tarda primavera e del parto estivo, il livello di malnutrizione congenita nei suinetti nella maggior parte degli allevamenti di suini diminuisce. Il numero di suinetti ipotrofici è maggiore nelle figliate di scrofe occasionali, così come nei primi due parti.
In alcuni casi, nelle cucciolate delle scrofe, indipendentemente dalle condizioni di alimentazione e di stabulazione, insieme ai neonati normalmente sviluppati, nascono anche suinetti ipotrofici, il che si spiega con disturbi individuali del trofismo fetale. Con l'aumento dei suinetti (oltre 12), aumenta anche il numero dei suinetti ipotrofici nella lettiera. I suinetti più sottosviluppati sono quelli nati per ultimi nella figliata.
Spesso la malnutrizione postnatale nei suinetti e negli agnelli nei primi periodi di vita è dovuta al fatto che le scrofe e le pecore hanno poco o nessun latte. Un'alimentazione inadeguata di scrofe e pecore lattanti, mastite, ipotermia di animali giovani appena nati, dispepsia, broncopolmonite e altri fattori di stress nel periodo postembrionale predispongono allo sviluppo della malnutrizione.
La malnutrizione prenatale è caratterizzata da una violazione dei processi morfofisiologici dello sviluppo fetale, che spesso si manifesta con un lento aumento del peso del feto nel suo insieme e dei singoli organi. Più spesso, gli organi a crescita relativamente rapida (muscoli, fegato, cuore, ecc.) Restano indietro nella crescita.
Il sottosviluppo degli organi interni nella prole si manifesta sia nella diminuzione della loro massa assoluta che nell'inferiorità della loro struttura (immaturità delle cellule del parenchima, loro insufficiente differenziazione, sottosviluppo e compattazione del tessuto muscolare, conservazione delle aree dell'ematopoiesi embrionale, mancanza di grasso nei depositi di grasso, ecc.).
Con la malnutrizione, organi e tessuti sono caratterizzati da un sottosviluppo funzionale, che contribuisce inevitabilmente a una diminuzione della loro reattività, patologia metabolica e tossicosi. Nei neonati ipotrofici, la concentrazione di emoglobina e il contenuto di eritrociti sono ridotti, si sviluppa ipoproteinemia e ipoglicemia, si verificano disidratazione, disturbi del metabolismo idrico-elettrolitico e assorbimento di vitamine, si sviluppa un disturbo della regolazione neuroendocrina, la reattività immunobiologica del corpo di neonati e la sua resistenza alle malattie infettive è drasticamente ridotta.
A causa della secrezione indebolita E la funzione motoria degli organi digestivi, l'immaturità della funzione barriera della mucosa intestinale e la funzione antitossica del fegato spesso sviluppano tossicosi. La contrattilità miocardica inadeguata e la ridotta funzione ventilatoria dei polmoni mantengono uno stato di ipossia, che spesso è la causa diretta della morte di giovani animali appena nati sottosviluppati nelle prime ore e giorni di vita.
Sotto l'influenza di fattori sfavorevoli nel periodo postnatale, la crescita e lo sviluppo degli animali giovani rimangono lenti, persistono disturbi nel metabolismo di proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali, l'ematopoiesi e l'emoglobina fetale nel sangue sono ritardati. L'adattabilità degli animali giovani ai mutevoli stimoli ambientali diminuisce e contribuisce allo sviluppo di dispepsia, colibacillosi e altre malattie.
Sintomi Nei vitelli fisiologicamente immaturi, basso tono muscolare, la comparsa del riflesso di suzione è ritardata e debolmente espressa, si nota l'inibizione dell'implementazione della postura eretta fino a 2,5-3 ore, e talvolta fino a 6-7 ore, che caratterizza diminuzione del tono neuromuscolare, manifestazione ritardata dell'attività motoria, riflessi alimentari E funzioni statiche.
Il peso corporeo degli animali giovani appena nati è solitamente inferiore del 10-30% rispetto ai valori normali e anche la lunghezza del corpo è ridotta. Il tessuto adiposo sottocutaneo è scarsamente espresso o assente. La pelle dei vitelli è secca, spesso rugosa, elastica, turgore E i muscoli sono bruscamente indeboliti.
L'atto respiratorio è rapido, i movimenti respiratori sono superficiali, il polso è debolmente palpabile, i suoni cardiaci sono ovattati, le mucose sono pallide o bluastre. La temperatura corporea è solitamente al limite inferiore della norma o inferiore e le parti distali delle estremità sono fredde. La sensibilità tattile e al dolore è debole o non espressa. Con la malnutrizione, i giovani animali si sdraiano e la postura eretta è incerta, accorciata e quando si cammina si osserva un'oscillazione del corpo.
Un esame del sangue rivela bassi tassi metabolici, il fenomeno dell'acidosi, una diminuzione dei livelli di cellule B e T, immunoglobuline, con una concentrazione relativamente alta di emoglobina fetale.
Se i pazienti ipotrofici non vengono curati, la maggior parte di loro muore nella prima settimana di vita, e quelli che sopravvivono rimangono indeboliti e, molto più spesso di quelli normalmente sviluppati, sviluppano dispepsia e altre malattie. I segni di malnutrizione compaiono più chiaramente nei suinetti nelle prime 2-3 settimane dalla nascita. Negli animali giovani, il residuo del cordone ombelicale cade più tardi e la ferita ombelicale guarisce più tardi.
Cambiamenti patologici. Il cadavere è esausto. La massa degli organi interni è ridotta di dimensioni, si esprime la lassità scheletrica e cardiaca
muscoli, il grasso sottocutaneo è assente, spesso ci sono aree nei polmoni, atelettasia, aumento del contenuto di trasudato nella cavità pericardica, i ventricoli del cuore sono dilatati.
La lobulazione del fegato e dei reni è debolmente espressa, la struttura del fascio del fegato è interrotta, non c'è glicogeno, le cellule giganti e gli elementi linfoidi sono chiaramente visibili. Fenomeni di distrofia si osservano in tutti gli organi interni e nel tessuto muscolare.
Diagnosi. Vengono presi in considerazione i segni clinici caratteristici e, prima di tutto, la nascita di animali giovani di peso ridotto e di piccole dimensioni, con un riflesso di suzione debolmente espresso. L'analisi delle condizioni di alimentazione e mantenimento del bestiame in questi casi consente di identificare le violazioni delle regole di alimentazione e mantenimento, nonché errori nel lavoro di allevamento e determinare le cause specifiche della malnutrizione nell'azienda agricola. Sono tipici bassi tassi metabolici.
Per escludere malattie infettive viene effettuata un'analisi della situazione epizootica e studi batteriologici e virologici sui cadaveri.
Trattamento. Gli animali giovani malati sono sottoposti a trattamenti complessi. Se il riflesso di suzione viene preservato, i suinetti ipotrofici vengono posti sui capezzoli della mammella, che secernono più colostro. Se il riflesso di suzione è assente, agli animali giovani viene somministrato colostro caldo in piccole dosi frazionarie attraverso una tettarella o una pipetta. Il riscaldamento degli animali giovani è importante. I riscaldatori d'aria, i termoventilatori elettrici e le lampade riscaldanti vengono utilizzati per mantenere una temperatura ambiente più elevata rispetto alla temperatura richiesta per animali giovani sani.
Come terapia sostitutiva, si consiglia di utilizzare trasfusioni di sangue nei vitelli fin dal primo giorno di vita in ragione di 1 ml/kg di peso corporeo da mucche sane, per somministrare concentrati di vitamine A, D, E a tutti i tipi di animali giovani , così come il glucosio. Ai suinetti vengono iniettati per via intramuscolare 2-4 ml di sangue citrato di mucche sane e, contemporaneamente, vengono iniettati per via intraperitoneale 10 ml di una soluzione di glucosio al 20% con l'aggiunta di vitamine B: e B12.
L'aminopeptide viene somministrato per via endovenosa a vitelli fino a 50-250 ml, agnelli, suinetti - fino a 30 ml al giorno in dosi frazionarie in più dosi. L'idrolisina viene utilizzata per via endovenosa o sottocutanea per 3-5 giorni in dosi: suinetti - fino a 40 ml, agnelli - fino a 25 e vitelli - 50-150 ml.
Per stimolare l'aumento di peso e aumentare la resistenza, vengono utilizzati bacillichina, biovit e altri stimolanti.
Prevenzione. Per prevenire la malnutrizione congenita è necessario rispettare i requisiti zooigienici per l'alimentazione e il mantenimento dei riproduttori. Le diete dovrebbero essere complete non solo in termini di valore nutrizionale complessivo, ma anche di contenuto di tutti gli altri componenti, soprattutto nella seconda metà della gravidanza. Il patrimonio riproduttivo necessita di passeggiate sistematiche. Di fondamentale importanza nella prevenzione della malnutrizione è la corretta organizzazione della campagna di accoppiamento, la selezione razionale dei tori, l'abbattimento tempestivo delle regine inferiori alla riproduzione e la prevenzione dell'accoppiamento di giovani femmine fisiologicamente immature.
La prevenzione della malnutrizione nel periodo postnatale si basa sul rigoroso rispetto degli standard di alimentazione e mantenimento degli animali giovani e dei riproduttori. È necessario osservare le regole igieniche durante il periodo del parto. I suinetti più deboli e più piccoli vengono generalmente ammessi vicino ai capezzoli delle mammelle, che producono più colostro. In caso di carenza di colostro, gli agnelli e i suinetti dovrebbero essere nutriti tempestivamente con colostro artificiale. Utilizzo di idrolizzati proteici in volume 10-40 ml per animale al giorno per 4 giorni consecutivi, poi 2 volte a settimana fino a quando lo svezzamento dà buoni risultati L'uso di metilmetionina solfonio cloruro e del suo complesso con vitamine A e B1 nelle scrofe e nei suinetti riduce il numero di nati morti nella lettiera e suinetti ipotrofici del 27-46%.
MALATTIE DEL PERIODO DI NASCITA (MALATTIE PERINATALI)
IPOSSIA FETALE -IPOSSIAEMBRIONE
L'ipossia fetale è una condizione patologica di un animale che si verifica a causa della carenza di ossigeno ed è accompagnata da disfunzioni nel corpo e da nati morti.
Eziologia e patogenesi. La malattia di solito si verifica a causa di complicazioni durante il parto. Questa è la separazione prematura delle membrane, la compressione del cordone ombelicale, accompagnata dalla cessazione del flusso sanguigno, un forte aumento della contrattilità dell'utero, le sue rotture e un travaglio prolungato. Le ragioni che contribuiscono sono l'alimentazione compromessa, che causa patologia metabolica negli animali gravidi, nonché uno stato stagnante nell'utero gravido in assenza di esercizio durante il periodo di sviluppo fetale. Tutti questi fattori contribuiscono all'aumento prematuro della saturazione del sangue fetale con anidride carbonica, che provoca l'eccitazione precoce del centro respiratorio e i primi movimenti respiratori. Nel canale del parto, il torace compresso non consente ai polmoni di espandersi completamente e, quando l'inalazione avviene prematuramente, nei polmoni viene aspirato muco denso. La penetrazione del liquido amniotico nei polmoni non solo impedisce lo scambio dei gas respiratori, ma aumenta anche le dimensioni delle aree atelettasiche, contribuendo allo sviluppo dell'asfissia nella prole.
Sintomi Nelle forme gravi della malattia, immediatamente dopo la nascita, si nota la quasi completa estinzione dei riflessi e letargia. L'ipossia negli animali giovani appena nati si registra più spesso nei tori nati da manze primogenite, quando non è stata fornita loro assistenza entro diverse ore dall'inizio del parto o quando l'assistenza non era corretta. Con una presentazione cefalica del feto, si osservano segni di ipossia già durante il parto. Pertanto, con l'aumento del tono muscolare dell'utero, la compressione del feto è rivelata dal gonfiore della sua parte anteriore e il gonfiore delle labbra, delle palpebre e della lingua è particolarmente evidente. La lingua, che spesso cade fuori dalla cavità orale, è gonfia, cianotica e non affonda nella cavità orale dopo che il neonato è stato rimosso dal canale del parto. La mucosa orale è gonfia, bluastra o meno spesso pallida.
Si osserva una colorazione bluastra del bordo incisale anteriore delle gengive che, nei casi più gravi, diventa viola scuro o quasi nero. L'atto della respirazione è disturbato, ci sono deviazioni nell'attività del cuore. La concentrazione di ossigeno nel sangue diminuisce e l'anidride carbonica aumenta e raggiunge 8,7-12,2 kPa. La riserva alcalina del sangue si è ridotta a 14,7-18,9 mmol/l.
Diagnosi. Quando si effettua una diagnosi, vengono presi in considerazione una serie di segni caratteristici di ipossia, deviazioni nel ritmo e nella forza della respirazione, respiro sibilante, tachicardia o bradicardia, cianosi delle mucose, gonfiore della lingua e altri segni.
Trattamento. Per salvare la vita del neonato, il neonato viene sollevato per gli arti pelvici o posto in posizione con la parte posteriore del corpo sollevata in modo da facilitare il deflusso del liquido fetale dalla cavità orale e dalle vie nasali inferiori. Quindi si apre la cavità orale del neonato, si tira fuori la lingua e si tenta di spremere il liquido amniotico aerato dai passaggi nasali, mentre allo stesso tempo si accarezza con forza lungo la parte posteriore del naso fino allo specchio nasale. Metti un impacco freddo sulla parte posteriore della testa e massaggia il petto. È utile eseguire movimenti circolari ritmici con l'arto sinistro del neonato, a condizione che la mano sinistra sia fissata nell'area del metacarpo e la destra sopra l'articolazione del gomito, durante i quali la scapola si alza e si abbassa leggermente . Tali esercizi spesso portano al successo se eseguiti con attenzione e per almeno 10-15 minuti. L'ossigeno può essere utilizzato inserendo un tubo di gomma nei passaggi nasali o inserendo il tubo direttamente nella trachea attraverso il naso o la bocca. Per stimolare il centro della respirazione e della circolazione utilizzare lobelia vitelli 0,02 g, oppure dicofedrina 3 ml per via intramuscolare, oppure triidrossimetilamminometano 5-6 ml/kg con contemporanea somministrazione di glucosio. Per ridurre l'acidosi nel corpo, viene utilizzata la somministrazione endovenosa di una soluzione al 4% di bicarbonato di sodio in una soluzione di glucosio al 10%: 4-5 ml per 1 kg di peso corporeo. La prevenzione si basa principalmente sulla creazione di condizioni ottimali durante la gravidanza, nonché su una buona formazione professionale del personale zootecnico e sull'assistenza ostetrica qualificata.
IPOIMMUNOGLOBULINEMIA
VITELLI NEONATI -
IPO1 MMUNOGLOBULINEMIA
NEONATORIOVITULORUM
L'ipoimmunoglobulinemia dei vitelli neonati è una sindrome patologica caratterizzata da uno stato di immunodeficienza dell'organismo, che si manifesta con un'insufficienza dell'immunità colostrale causata da disturbi della nutrizione colostrale nei primi giorni di vita dei vitelli e che porta ad una diminuzione della resistenza immunologica a fattori ambientali avversi . L’ipoimmunoglobulinemia è una potenziale causa di malattie gastrointestinali di varie eziologie.
L'ipoimmunoglobulinemia nei vitelli giovani è diffusa, si verifica in molti allevamenti e presenta diversi gradi di gravità. L'ipoimmunoglobulinemia nettamente espressa (il contenuto di immunoglobuline nel siero del sangue è compreso tra 0 e 0,1 g%) è stata osservata nel 17,9% dei vitelli, moderatamente espressa (1,01-1,5 g%) - nel 42,0% e lievemente espressa (1,51-2,0 g %) - nel 28,1%. Minore è il livello della tecnologia per l'allevamento dei vitelli in una fattoria, maggiore è la prevalenza e il grado di deficienza immunitaria nei neonati (M. A. Kostyna).
Eziologia. La causa principale della patologia è associata ad una ridotta alimentazione del colostro. Si tratta della somministrazione tardiva del colostro della prima produzione di latte, limitandone la quantità e riducendone la qualità, utilizzando colostro contaminato o freddo, bevendolo quando si è raffreddato e sostituendolo con il latte.
-------
| sito di raccolta
|-------
| Igor Aleksandrovich Rubinskij
| Diagnosi differenziale delle malattie nei suini giovani
-------
Uno dei problemi più gravi nell'allevamento di suini è l'incidenza e la mortalità del bestiame, che tra i suinetti da latte rappresenta il 10-20% della lettiera totale, con la perdita maggiore che si verifica nei primi dieci giorni di vita. Negli allevamenti di suini si verificano spesso situazioni in cui muore quasi tutta la prole, il che porta all'interruzione della riproduzione della mandria con tutte le conseguenze che ne conseguono. Le misure per prevenire la mortalità spesso non danno il risultato desiderato, poiché non si basano su una diagnosi accurata e sulla conoscenza delle ragioni che l'hanno causata.
La diagnosi di malattie nei suinetti appena nati dovrebbe comprendere l'esame clinico ed epizootologico, l'autopsia dei cadaveri o dei suinetti uccisi a fini diagnostici e altri test di laboratorio (batteriologici, istologici, ecc.).
La breve durata del corso, il basso contenuto informativo e la somiglianza delle manifestazioni cliniche talvolta complicano la diagnosi intravitale delle malattie nei suinetti neonati. Nel complesso diagnostico, un collegamento importante e in molti casi decisivo può essere un esame patologico, che consente di identificare segni specifici di singole malattie, ottenere criteri oggettivi per la loro differenziazione e selezionare intenzionalmente materiale per altri studi di laboratorio.
Questo libro descrive vari metodi di ricerca necessari per una diagnosi accurata e complessa, fornisce la classificazione delle malattie dei suinetti appena nati da noi sviluppata e una breve descrizione di ciascuna malattia. Insieme a ciò, vengono presentate raccomandazioni sul campionamento e sulla selezione dei metodi di ricerca di laboratorio per effettuare una diagnosi finale di una malattia specifica.
La classificazione si basa su un principio nosologico: vengono presentate malattie che hanno una specifica eziologia, patogenesi e manifestazione clinica e morfologica. In alcuni casi vengono prese singole sindromi che tradizionalmente vengono considerate malattie indipendenti (ipoglicemia, dispepsia, anemia), poiché esse, indipendentemente dalla causa che le ha determinate, sono principalmente specifiche in termini clinici e morfologici. Considerando che il periodo neonatale dei suinetti è solitamente limitato a 10-14 giorni, la classificazione non include le malattie che si verificano nei suinetti più anziani. Le malattie sono raggruppate tenendo conto dei fattori eziologici.
Malattie causate da disturbi dello sviluppo intrauterino ed errori nell'alimentazione delle scrofe:
Deformità.
Ipotrofia.
Ipovitaminosi A.
Ipovitaminosi E; ipoplasia miofibrillare.
Ipovitaminosi C.
Ipotiroidismo.
Ipossia cronica.
Tremore congenito.
Malattie derivanti da complicazioni durante il parto:
Ipossia acuta.
Lesione alla nascita.
Malattie e cause di morte legate a condizioni di vita e di alimentazione sfavorevoli nel primo periodo neonatale:
Raffreddamento.
Fame.
Ipoglicemia.
Dispepsia.
Lesioni, strangolamento da parte di una scrofa.
Polmonite.
Anemia.
Avvelenamento con preparati di ferro.
Malattie infettive causate da microrganismi opportunisti:
Sepsi.
Diplococcosi.
Streptococcosi.
Salmonellosi.
Colibacillosi.
Obbatteriosi del campilo.
Clamidia.
Infezioni da adeno e rotavirus.
Infezioni da Picorna e parvovirus.
Gastroenterite trasmissibile.
Infezione causata dal coronavirus 777.
Rinite atrofica.
La malattia di Teschen.
Encefalomielite causata da coronavirus emoagglutinante.
Malattie infettive causate da microrganismi patogeni:
Brucellosi.
Leptospirosi.
Listeriosi.
Necrobatteriosi.
Enterotossiemia anaerobica.
Peste suina classica.
La malattia di Aujeszky.
Vaiolo.
Malattie invasive:
Coccidiosi, criptosporidiosi.
Malattia emolitica
Immunodeficienze congenite
Studio clinico ed epidemiologico. Considerando la stretta connessione tra le malattie dei suinetti appena nati e lo sviluppo intrauterino, il decorso e la durata del parto, lo stato delle scrofe e i fattori zooigienici, per la diagnosi obiettiva è importante la conoscenza dei dati anamnestici, compresa la situazione epizootica nell'allevamento.
Ad esempio, le malattie infettive causate da microrganismi opportunisti, di regola, sono di natura stazionaria e si manifestano in epidemie più o meno evidenti sullo sfondo di situazioni stressanti, errori di igiene o alimentazione. Si tratta dei cambiamenti del microclima, del sovraffollamento, dell'introduzione di animali provenienti da altri allevamenti; scarsa qualità, alimentazione inadeguata o insufficiente, mancanza di misure preventive generali e speciali.
Durante l'esame clinico ed epidemiologico è importante tenere conto della perdita di figliata, degli aborti e dei nati morti dei suinetti e monitorare le condizioni delle scrofe e dei verri da riproduzione. Pertanto, in alcune malattie enzootiche, i cinghiali riproduttori sono i primi a rispondere alla malattia riducendo la potenza. Molte malattie caratteristiche dei suini di tutte le età possono manifestarsi nelle scrofe gravide, ad esempio accorciando o prolungando il periodo di gestazione.
Un esame clinico completo di un maialino neonato, a differenza di un animale adulto, è complicato dalle sue piccole dimensioni e dall'incapacità di condurre auscultazione informativa, percussioni, esami delle urine e del sangue. A questo proposito può essere utile l’osservazione dell’intera popolazione e l’analisi dei dati oggettivi ottenuti. È importante tra i tanti segni clinici, spesso di carattere generale, evidenziare quelli specifici inerenti a determinate malattie o gruppi di malattie: diarrea, fenomeni nervosi, ittero, ecc. Ciò restringerà la ricerca diagnostica.
Per una ricerca clinica ed epidemiologica mirata abbiamo sviluppato tabelle diagnostiche differenziali che combinano varie malattie in base ai segni clinici principali e chiaramente manifestati. Le tabelle sono presentate nella sezione “Diagnosi differenziale”.
Autopsia patoanatomica. L'autopsia dei cadaveri o dei suinetti uccisi a fini diagnostici è consentita in luoghi appositamente designati o adattati, escludendo la possibilità di diffusione di agenti patogeni. Dovrebbe essere effettuato dopo aver visitato i porcili e aver ispezionato il bestiame.
L'accessibilità pratica e il contenuto informativo oggettivo durante l'esame patologico consentono di collocarlo al centro di collegamento di tutta la ricerca in corso. Di norma, durante le autopsie dei cadaveri, i dati anamnestici vengono riassunti, confrontati con i risultati della sezione e, se necessario, confermati o chiariti da altri esami di laboratorio. Quest'ultimo, in particolare virologico e batteriologico, può essere efficace solo con un esame mirato, dipendente da un'autopsia, che permetta di ipotizzare determinate malattie e selezionare il materiale appropriato.
La tecnica dell'autopsia dei cadaveri dei suinetti appena nati, rispetto al metodo dell'autopsia dei cadaveri dei suinetti più anziani e dei maiali adulti, presenta alcune caratteristiche.
L'esame esterno comprende l'esame del cordone ombelicale; allo stesso tempo ne vengono determinati lo spessore, la levigatezza, lo stato dei vasi sanguigni, la presenza di emorragie, ecc .. Allo stesso tempo, viene esaminata la placenta, prestando attenzione all'ingrossamento, al gonfiore, alla presenza di necrosi, all'essudato, ecc. .
Il criterio per la maturità di un maialino appena nato in una certa misura è il suo peso, quindi prima dello studio il cadavere viene pesato.
Quando si definisce il rigor mortis, si tiene conto del fatto che nei neonati si sviluppa rapidamente dopo la morte e può manifestarsi in un maiale entro 30-40 minuti. Molto spesso il rigore è assente a causa della carenza di glicogeno nei muscoli. I cadaveri dei suinetti appena nati si seccano rapidamente, il che si manifesta principalmente con l'essiccazione delle mucose delle cavità orali e nasali.
Per aprire le cavità del corpo e rimuovere gli organi interni, è conveniente il metodo dell'eviscerazione completa degli organi secondo Shore. Tuttavia, per prevenire la comparsa di artefatti nel tessuto cerebrale che si verificano durante il deflusso del sangue dalla testa dopo aver tagliato i vasi del corpo, prima di esaminare il torace e le cavità addominali, è consigliabile aprire prima il cranio ed esaminare il cervello. Dopo aver preparato la pelle, il cranio viene aperto con le forbici utilizzando incisioni semicircolari dalle orbite degli occhi al forame magno.
L'apertura della cavità addominale è preceduta dall'esame dell'anello ombelicale. Prima di rimuovere gli organi dalle cavità addominale e toracica, vengono esaminati i vasi ombelicali.
Se è necessario determinare la natimortalità, vengono eseguiti i test di nuoto di Galeno o Breslavia. Il primo utilizza i polmoni, il secondo utilizza il complesso degli organi delle cavità toracica e addominale. Se un maialino nasce morto, i suoi organi affogheranno nell'acqua. Il campione è non valido con materiale marcio e decomposto, la cui densità specifica è ridotta a causa della formazione e dell'accumulo di gas nei tessuti.
Mediante dissezione sequenziale, i cambiamenti rilevati vengono registrati, riepilogati e analizzati. Per stabilire una malattia specifica in base ai risultati dell'autopsia, è possibile utilizzare i dati nella Tabella 5.
Studi batteriologici e virologici. Questi metodi di ricerca sono particolarmente importanti durante le epidemie di malattie infettive e nei casi in cui l'autopsia patologica non fornisce una diagnosi definitiva o viene effettuata senza dati anamnestici clinici ed epidemiologici.
Il materiale per gli studi batteriologici e virologici viene prelevato immediatamente dopo la morte del suinetto. Innanzitutto vengono esaminati i tessuti e gli organi in cui sono presenti cambiamenti macroscopici, nonché il sangue del cuore, della milza, del fegato, dei reni, dei linfonodi e del cervello. È meglio coltivare o prelevare materiale durante un'autopsia, quando gli organi non sono ancora stati rimossi dal cadavere, ad esempio, quando si apre la cavità toracica, le colture vengono prelevate dalle cavità pleurica e pericardica e dal cuore. Si consiglia di riporre gli organi di un cadavere in barattoli separati (sacchetti di plastica).
Nei casi in cui è necessario conservare il materiale patologico per un certo periodo, viene posto in frigorifero e durante il trasporto in un thermos con ghiaccio. Con questa conservazione il materiale è adatto alla ricerca per 1–2 giorni. L'inscatolamento con una soluzione di glicerina al 50% consente di conservare il materiale per diverse settimane.
Considerando che gli agenti causali di alcune malattie possono essere isolati da suinetti malati solo durante la vita, per studi batteriologici e virologici efficaci è indicata la selezione di materiale proveniente da suinetti vivi malati o uccisi al culmine della malattia. Di seguito vengono fornite raccomandazioni per il campionamento, la scelta dei metodi di ricerca e dei terreni per le colture primarie.
Esame istologico. Molte malattie dei suinetti neonati, a causa della loro breve durata, non presentano cambiamenti macroscopici caratteristici ben definiti, pertanto, per determinare la presenza e la natura dei processi patologici nei tessuti, l'esame istologico è di grande importanza, soprattutto quando si differenziano le malattie infettive. A tale scopo, durante l'autopsia, vengono ritagliati con forbici affilate pezzi di tessuto provenienti sia da organi patologicamente alterati che da organi apparentemente normali. Va ricordato che i tessuti dei neonati, in particolare fegato, cervello e reni, sono più morbidi e delicati di quelli degli animali adulti e richiedono un'attenta manipolazione. I pezzi ritagliati vengono fissati in una soluzione di formaldeide al 5-10%, che consente l'uso della maggior parte dei metodi di ricerca istologica utilizzati nella pratica patologica (viene prelevato 5-10 volte più fissativo rispetto al materiale). Dopo 2-3 giorni, il materiale fissato viene inviato al laboratorio tramite corriere espresso o posta in un contenitore sigillato.
Esame stereoscopico. Questo metodo consente di osservare lo stato dei villi della mucosa intestinale, che è importante per differenziare le malattie dei suinetti che si verificano con danni al tratto gastrointestinale.
A tale scopo le anse intestinali, aperte nel punto di inserzione del mesentere, devono essere raddrizzate e fissate con spilli su cartone; fissare per 12 ore in una soluzione di formaldeide al 5-10%. Lo studio viene effettuato utilizzando un microscopio stereoscopico.
Microscopia a luminescenza. Strisci, strisci da impronta digitale e sezioni istologiche trattate con sieri fluorescenti specifici vengono esaminati al microscopio a fluorescenza. Questa microscopia può essere il metodo più veloce per diagnosticare accuratamente le malattie infettive dei suinetti neonati come la peste, la TGES e l'infezione da parvovirus.
Microscopia elettronica a trasmissione. Viene utilizzato per la diagnosi rapida e accurata delle malattie virali, poiché con il suo aiuto è possibile osservare i virus nei tessuti e differenziarli.
Microscopia elettronica a scansione. Permette di osservare la superficie di cellule, organi e tessuti. È conveniente per uno studio dettagliato delle mucose dello stomaco e dell'intestino in varie malattie del tratto gastrointestinale, nonché dei microrganismi presenti su di essi.
Quando si conducono studi clinici, epizootologici e patologici, vengono identificati e accumulati vari fatti (sintomi, cambiamenti patologici,
dati anamnestici, ecc.) che necessitano di analisi per “scoprire” una specifica malattia.
A questo scopo è possibile utilizzare le tabelle diagnostiche differenziali sviluppate per molte delle malattie più comuni, raggruppate per segni clinici caratteristici: aborto, suinetti nati morti (Tabella 1); diarrea (Tabella 2); disturbi nervosi (Tabella 3); lesioni della pelle e delle mucose visibili (Tabella 4).
I cambiamenti patologici più caratteristici o frequenti in alcune malattie sono presentati nella Tabella 5. I cambiamenti sono distribuiti tra organi e sistemi e sono riportati nella sequenza dell'autopsia, iniziando con l'esame esterno e terminando con i singoli organi. La tabella 5 può essere utilizzata come “chiave” per la diagnosi durante l'autopsia dei suinetti, soprattutto in assenza di anamnesi.
1. Diagnosi differenziale delle malattie dei suinetti e delle scrofe appena nati, accompagnate da aborti e nati morti
Nota. Scelta di un metodo diagnostico accurato (Tabella 6).
2. Diagnosi differenziale delle malattie dei suinetti neonati manifestate da diarrea
3. Diagnosi differenziale delle malattie dei suinetti neonati accompagnate da disturbi nervosi (atassia, tremore degli arti, paralisi, paresi, convulsioni)
4. Diagnosi differenziale delle malattie dei suinetti neonati che si manifestano con danni alla pelle e alle mucose visibili
5. Cambiamenti patologici nelle malattie dei suinetti neonati
La diagnosi presunta, basata su un complesso di dati clinici, epidemiologici e patologici, necessita spesso di essere confermata da altri esami di laboratorio. In questo caso, i dati della Tabella 6 forniranno qualche aiuto.
6. Selezione del materiale, scelta dei metodi di ricerca e dei terreni per l'inoculazione primaria durante la ricerca batteriologica
Le deformità si manifestano nella struttura irregolare, nella localizzazione o nell'assenza di organi o parti del corpo. Una delle principali cause di deformità è l'ereditarietà dei cosiddetti geni “letali”, che portano ad uno sviluppo improprio dei tessuti dell'embrione e del feto. La probabilità di anomalie ereditarie aumenta con la consanguineità e un alto grado di consanguineità, infezioni virali e avvelenamento delle scrofe.
Nei suinetti, le più comuni deformità degli arti (aumento del numero delle dita, fusione delle dita, elefantiasi, contratture e accorciamento degli arti), anomalie renali (cistosi), anomalie cardiache (mancata chiusura del forame ovale), atresia dell'ano e del retto. Sono possibili anche deformità miste, ad esempio anomalie degli arti e del cranio, dei reni e del cuore. Tutte le deformità sono abbastanza dimostrative; L'esame del cuore richiede la massima attenzione quando si diagnosticano i suoi difetti congeniti.
L'ipotrofia è l'immaturità, il sottosviluppo del neonato. Le cause possono essere un'alimentazione inadeguata delle scrofe gravide, in particolare la mancanza di proteine e minerali nella dieta, oppure un'alimentazione eccessiva e l'obesità delle scrofe. L'ipotrofia può essere la causa diretta della morte di un suino appena nato; inoltre, i suinetti ipotrofici sono molto sensibili al freddo e alla fame.
Sono considerati segni di malnutrizione il ridotto peso corporeo, la sproporzionalità nello sviluppo della testa rispetto al corpo e la magrezza delle ossa tubolari. Gli organi interni (cuore, cervello, milza, stomaco) sono grandi rispetto alle dimensioni del corpo.
L'ipovitaminosi A è associata alla carenza di vitamina A nell'alimentazione delle scrofe gravide. Si manifesta con anomalie dello sviluppo renale (agenesia, rene a ferro di cavallo), microftalmia e anoftalmia. Le anomalie dell'occhio si verificano a causa del sottosviluppo dell'apertura ottica e della violazione del nervo con lo stesso nome in essa contenuto.
D'altra parte, un'assunzione eccessiva di vitamina A nelle scrofe gravide può causare deformità che si manifestano con accorciamento, ispessimento e fragilità delle ossa lunghe.
L'ipovitaminosi E si manifesta nei suinetti appena nati in due forme principali: danno cardiaco e un peculiare cambiamento nei muscoli scheletrici chiamato ipoplasia miofibrillare.
I cambiamenti nel cuore hanno segni tipici della malattia dei muscoli bianchi, manifestandosi sotto forma di distrofia granulare e necrosi di Zenker delle fibre muscolari. Macroscopicamente il cuore presenta una colorazione variegata dovuta all'alternanza di zone rosse e grigio-rossastre.
Quando sono colpiti i muscoli scheletrici, i cambiamenti interessano principalmente il muscolo tricipite surale, il muscolo semitendinoso e, meno comunemente, altri muscoli del bacino e della coscia, nonché il muscolo longissimus dorsi e il muscolo tricipite brachiale. Nei suinetti malati, i suinetti sono pelvici, meno spesso tutti e quattro gli arti vengono messi da parte, i suinetti non possono muoversi, il che li priva della possibilità di allattare l'utero. I muscoli interessati sono di consistenza morbida, di colore più chiaro del solito e sulla superficie della sezione trasversale sono visibili singole aree acquose. Microscopicamente, nei muscoli colpiti, si nota un piccolo numero di miofibrille; alcuni sarcolemmi sono quasi vuoti o contengono solo un nucleo e un po' di fluido proteico rosa chiaro (colorato con ematossilina-eosina).
L'ipovitaminosi C si manifesta con un'elevata fragilità delle ossa tubulari, la presenza di focolai di necrosi nelle metafisi; attorno alle metafisi sono pronunciate emorragie sottoperiostee; spesso il periostio è separato dalla sostanza compatta da un coagulo sanguigno. Tali cambiamenti sono meno comuni nelle costole e nelle mascelle.
Ipotiroidismo (mixedema enzootico). La malattia è causata dalla carenza di iodio nelle scrofe. I suinetti nascono gonfi, soprattutto al collo, alla parte posteriore della testa, alla parte anteriore del torace e meno spesso all'addome; molti hanno un'assenza totale o parziale di stoppia. I suinetti muoiono tra il 1° e il 3° giorno di vita.
All'autopsia si evidenzia pelle e tessuto sottocutaneo pastosi e ispessiti a causa della loro impregnazione con un infiltrato gelatinoso; i muscoli scheletrici sono acquosi; si osservano spesso idropisia delle cavità sierose, atelettasia parziale dei polmoni, gonfiore dei tessuti della lingua, gonfiore dei tessuti attorno alla laringe; In tutti gli animali la ghiandola tiroidea è ingrossata, densa e di colore rosso scuro.
L'esame istologico ha rivelato un disturbo della circolazione sanguigna e linfatica nella pelle, nel tessuto sottocutaneo, nei muscoli scheletrici e negli organi parenchimali, degenerazione granulare e vacuolare nel fegato e nei reni e nella ghiandola tiroidea - iperplasia dell'epitelio follicolare, una piccola quantità di colloide in loro.
L'ipossia cronica è causata da un apporto prolungato e insufficiente di ossigeno al feto a causa di disfunzione della placenta, alterazioni del cordone ombelicale, malattie croniche delle scrofe, accompagnate da una diminuzione del livello di ossigeno nel sangue (polmonite cronica e pericardite , obesità, ulcera gastrica, ecc.).
La patomorfologia dell'ipossia cronica è generalmente simile a quella dell'ipossia intrauterina acuta (vedi sotto). Al contrario di questi ultimi, i frutti che hanno sofferto di ipossia cronica sono spesso sottosviluppati, poiché con carenza di ossigeno tutti i processi metabolici sono difettosi. Inoltre, l'ispessimento del cordone ombelicale e della placenta e la dilatazione dei vasi sanguigni del cordone ombelicale vengono spesso osservati come manifestazione compensatoria.
Il tremore congenito è una malattia di natura ereditaria e si manifesta sotto forma di spasmi clonici dei muscoli della testa e degli arti, che si fermano solo durante il riposo e il sonno. L'essenza del mioclono è un'interruzione della produzione di mielina, che porta alla sua assenza o carenza nelle membrane dei processi nervosi, che è più pronunciata nel cervello e nel midollo spinale. Cambiamenti simili si verificano anche nella tossicosi delle scrofe gravide da composti organofosforici e nella peste classica (una delle sue manifestazioni).
Macroscopicamente si nota ipoplasia del cervelletto e del midollo spinale, rispetto al cervello di un suinetto normalmente sviluppato.
Istologicamente si osserva l'assenza o il forte assottigliamento delle guaine mieliniche attorno agli assoni e una diminuzione del numero degli oligodendrociti.
L'ipossia acuta si verifica principalmente a causa di un travaglio prolungato o patologico. Tipicamente si manifesta con la nascita di suinetti maturi senza segni di respirazione in presenza di attività cardiaca. Insieme a questo, molti suinetti che hanno sofferto di ipossia intrauterina acuta nascono vivi, ma successivamente muoiono per disturbi respiratori, encefalopatia, ipoglicemia e altre complicazioni.
Un segno caratteristico dell'ipossia intrauterina è una colorazione bruno-giallastra o bruno-verdastra della pelle macchiata dal meconio rilasciato nel liquido amniotico a causa del rilassamento dello sfintere anale. Insieme a questo, con l'ipossia, l'atelettasia totale o parziale dei polmoni, si verificano emorragie localizzate sotto l'epicardio, la pleura, nel timo, nelle ghiandole surrenali e nella materia cerebrale.