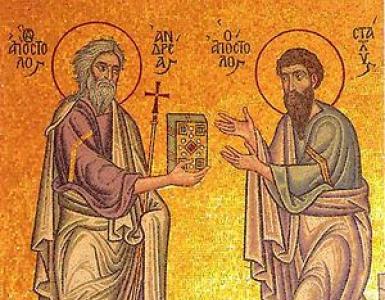Cosa significa il sistema endocrino? Organi del sistema endocrino
L'insieme delle ghiandole endocrine che producono ormoni è chiamato sistema endocrino del corpo.
Dal greco il termine “ormoni” (hormaine) significa incoraggiare, mettere in moto. Gli ormoni sono sostanze biologicamente attive prodotte da ghiandole endocrine e cellule speciali presenti in tessuti come le ghiandole salivari, lo stomaco, il cuore, il fegato, i reni e altri organi. Gli ormoni entrano nel flusso sanguigno e influenzano le cellule degli organi bersaglio, situati direttamente nel luogo della loro formazione (ormoni locali) o ad una certa distanza.
La funzione principale delle ghiandole endocrine è produrre ormoni che vengono distribuiti in tutto il corpo. Ciò porta ad ulteriori funzioni delle ghiandole endocrine dovute alla produzione di ormoni:
- Partecipazione ai processi metabolici;
- Mantenere l'ambiente interno del corpo;
- Regolazione dello sviluppo e della crescita del corpo.
La struttura delle ghiandole endocrine
Gli organi del sistema endocrino includono:
- Ipotalamo;
- Tiroide;
- Pituitaria;
- Ghiandole paratiroidi;
- Ovaie e testicoli;
- Isole pancreatiche.
Durante la gravidanza la placenta, oltre ad svolgere altre funzioni, è anche una ghiandola endocrina.
L'ipotalamo secerne ormoni che stimolano la funzione della ghiandola pituitaria o, al contrario, la sopprimono.
La ghiandola pituitaria stessa è chiamata la principale ghiandola endocrina. Produce ormoni che influenzano altre ghiandole endocrine e coordina le loro attività. Inoltre, alcuni ormoni prodotti dalla ghiandola pituitaria hanno un effetto diretto sui processi biochimici nel corpo. Il tasso di produzione ormonale da parte della ghiandola pituitaria si basa sul principio del feedback. Il livello di altri ormoni nel sangue dà alla ghiandola pituitaria un segnale che dovrebbe rallentare o, al contrario, accelerare la produzione di ormoni.
Tuttavia, non tutte le ghiandole endocrine sono controllate dall’ipofisi. Alcuni di essi reagiscono indirettamente o direttamente al contenuto di determinate sostanze nel sangue. Ad esempio, le cellule del pancreas, che producono insulina, rispondono alla concentrazione di acidi grassi e glucosio nel sangue. Le ghiandole paratiroidi rispondono alle concentrazioni di fosfato e calcio e la midollare surrenale risponde alla stimolazione diretta del sistema nervoso parasimpatico.
 Le sostanze e gli ormoni simili agli ormoni sono prodotti da vari organi, compresi quelli non inclusi nella struttura delle ghiandole endocrine. Pertanto, alcuni organi producono sostanze simili agli ormoni che agiscono solo nelle immediate vicinanze del loro rilascio e non rilasciano le loro secrezioni nel sangue. Queste sostanze includono alcuni ormoni prodotti dal cervello, che colpiscono solo il sistema nervoso o due organi. Ci sono altri ormoni che influenzano l'intero corpo nel suo insieme. Ad esempio, la ghiandola pituitaria produce l’ormone stimolante la tiroide, che agisce esclusivamente sulla ghiandola tiroidea. A sua volta, la ghiandola tiroidea produce ormoni tiroidei, che influenzano il funzionamento dell’intero corpo.
Le sostanze e gli ormoni simili agli ormoni sono prodotti da vari organi, compresi quelli non inclusi nella struttura delle ghiandole endocrine. Pertanto, alcuni organi producono sostanze simili agli ormoni che agiscono solo nelle immediate vicinanze del loro rilascio e non rilasciano le loro secrezioni nel sangue. Queste sostanze includono alcuni ormoni prodotti dal cervello, che colpiscono solo il sistema nervoso o due organi. Ci sono altri ormoni che influenzano l'intero corpo nel suo insieme. Ad esempio, la ghiandola pituitaria produce l’ormone stimolante la tiroide, che agisce esclusivamente sulla ghiandola tiroidea. A sua volta, la ghiandola tiroidea produce ormoni tiroidei, che influenzano il funzionamento dell’intero corpo.
Il pancreas produce insulina, che influenza il metabolismo dei grassi, delle proteine e dei carboidrati nel corpo.
Malattie delle ghiandole endocrine
Di norma, le malattie del sistema endocrino derivano da disturbi metabolici. Le cause di tali disturbi possono essere le più diverse, ma soprattutto il metabolismo viene interrotto a causa della mancanza di minerali e organismi vitali nel corpo.
Il corretto funzionamento di tutti gli organi dipende dal sistema endocrino (o ormonale, come a volte viene chiamato). Gli ormoni prodotti dalle ghiandole endocrine, entrando nel sangue, agiscono come catalizzatori per vari processi chimici nel corpo, cioè la velocità della maggior parte delle reazioni chimiche dipende dalla loro azione. Gli ormoni regolano anche il funzionamento della maggior parte degli organi del nostro corpo.
Quando le funzioni delle ghiandole endocrine vengono interrotte, l'equilibrio naturale dei processi metabolici viene interrotto, il che porta alla comparsa di varie malattie. Spesso le patologie endocrine derivano da intossicazione del corpo, lesioni o malattie di altri organi e sistemi che interrompono il funzionamento del corpo.
Le malattie delle ghiandole endocrine comprendono malattie come il diabete, la disfunzione erettile, l'obesità e le malattie della tiroide. Inoltre, se il corretto funzionamento del sistema endocrino viene interrotto, possono verificarsi malattie cardiovascolari, malattie del tratto gastrointestinale e delle articolazioni. Pertanto, il corretto funzionamento del sistema endocrino è il primo passo verso la salute e la longevità.
Un'importante misura preventiva nella lotta contro le malattie delle ghiandole endocrine è la prevenzione dell'avvelenamento (sostanze tossiche e chimiche, prodotti alimentari, prodotti di secrezione della flora intestinale patogena, ecc.). È necessario purificare tempestivamente il corpo dai radicali liberi, dai composti chimici e dai metalli pesanti. E, naturalmente, ai primi segni della malattia è necessario sottoporsi ad un esame approfondito, perché prima si inizia il trattamento, maggiori sono le possibilità di successo.
Il sistema endocrino è un insieme di ghiandole endocrine che producono e rilasciano ormoni nella circolazione sanguigna, non hanno dotti escretori e secernono secrezioni negli organi corrispondenti. Gli ormoni possono agire contemporaneamente come messaggeri chimici per un numero enorme di cellule e tessuti e regolare quasi ogni attività metabolica del corpo.
Le ghiandole endocrine sono riccamente vascolarizzate e presentano una fitta rete di vasi sanguigni. Le cellule all'interno di questi organi contengono ormoni in granuli o vescicole intracellulari che si fondono con la membrana plasmatica, rispondendo a un segnale appropriato e rilasciando gli ormoni nello spazio extracellulare.
Il sistema endocrino, insieme al sistema nervoso, integra i segnali provenienti dall'ambiente interno ed esterno. Inoltre, produce molecole effettrici sotto forma di ormoni, che possono far sì che il corpo risponda adeguatamente per mantenere l’omeostasi. Mentre il sistema nervoso centrale reagisce istantaneamente agli stimoli, la reazione endocrina è lenta, ma differisce nella durata dell'azione. Ad esempio, la secrezione a lungo termine dell’ormone della crescita nel corpo influenza lo sviluppo delle ossa, che favorisce la crescita dell’intero corpo, nonché l’aumento delle dimensioni di ciascun organo interno. Come altro esempio, il cortisolo, prodotto durante i periodi di stress, può influenzare l’appetito e i processi metabolici nella muscolatura scheletrica e liscia per un periodo di ore o settimane.
Il sistema endocrino è coinvolto in tutti i processi che si verificano nel corpo umano. Gli ormoni possono influenzare i singoli organi in vari modi, dal movimento del tratto digestivo all’assorbimento e all’elaborazione del glucosio e di altre sostanze. Alcuni influenzano la ritenzione del calcio nelle ossa o il mantenimento della contrazione muscolare. Inoltre, gli ormoni sono coinvolti nello sviluppo e nella formazione delle funzioni immunitarie e riproduttive adattative del corpo. Influenzano la crescita generale e il metabolismo modificando il modo in cui ogni cellula assorbe e utilizza i nutrienti essenziali.
Organi del sistema endocrino
Il sistema endocrino comprende le ghiandole pituitaria e pineale situate nel cervello, la tiroide e le ghiandole paratiroidi nel collo, il timo nella regione toracica, le ghiandole surrenali e il pancreas nella cavità addominale e le gonadi nel sistema riproduttivo.

A partire dal cervello, l'ipotalamo, la ghiandola pituitaria e le ghiandole pineale sono coinvolte nella regolazione di altri organi endocrini e dei ritmi circadiani, alterando lo stato metabolico del corpo. La ghiandola pineale è situata al centro del cervello, in un'area chiamata epitalamo. La ghiandola pituitaria si trova molto vicino all'ipotalamo, con il quale si stabilisce un contatto diretto e si formano circuiti di feedback per la produzione di ormoni. Insieme, l'ipotalamo e la ghiandola pituitaria possono regolare il funzionamento di numerosi organi del sistema endocrino, principalmente le gonadi e le ghiandole surrenali. In effetti, l'ipotalamo è l'anello centrale che unisce due principali percorsi regolatori: il sistema nervoso ed endocrino. L'ipotalamo è costituito da gruppi di neuroni, cellule nervose che raccolgono informazioni da tutto il corpo e integrano gli impulsi nei lobi anteriori e posteriori della ghiandola pituitaria.
Nel collo si trovano le ghiandole tiroide e paratiroidi. La ghiandola tiroidea è costituita da due lobi simmetrici collegati da uno stretto pezzo di tessuto chiamato istmo. La sua forma ricorda una farfalla. La lunghezza di ciascun lobo è di 5 cm e l'istmo è di 1,25 cm La ghiandola si trova sulla superficie anteriore del collo dietro la cartilagine tiroidea. Ciascuno dei suoi lobi si trova solitamente davanti alle ghiandole paratiroidi. La dimensione delle ghiandole paratiroidi è di circa 6x3x1 mm, il peso varia da 30 a 35 grammi e il loro numero varia, quindi alcune persone possono averne più di due paia.
Il timo o ghiandola del timo è un organo grigio-rosato del sistema endocrino, situato nello sterno tra i polmoni e costituito da due lobi. Il timo svolge un ruolo importante nel funzionamento del sistema immunitario, essendo responsabile della produzione e della maturazione dei linfociti (cellule T). Questo organo è insolito in quanto il suo picco di attività si verifica durante l'infanzia. Dopo la pubertà, il timo si contrae lentamente e viene sostituito dal tessuto adiposo. Prima dell'inizio della pubertà, il peso del timo è di circa 30 grammi.
Le ghiandole surrenali si trovano sopra i reni. Sono di colore giallastro, circondati da uno strato di grasso, situato sotto il diaframma stesso e collegato ad esso tramite tessuto connettivo. Le ghiandole surrenali sono costituite da midollo e corteccia, che hanno secrezione esterna ed interna.
Il pancreas è un organo che svolge le funzioni sia del sistema digestivo che endocrino. L'organo ghiandolare si trova vicino alla flessura C del duodeno dietro lo stomaco. È costituito da cellule che svolgono sia funzioni esocrine, producendo enzimi digestivi, sia cellule endocrine nelle isole di Langerhans, producendo insulina e glucagone. Gli ormoni sono coinvolti nel metabolismo e nel mantenimento dei livelli di glucosio nel sangue e quindi le due diverse funzioni dell'organo sono integrate ad un certo livello.
Le gonadi (ghiandole sessuali maschili e femminili) svolgono importanti funzioni nel corpo. Influenzano il corretto sviluppo degli organi riproduttivi durante la pubertà e preservano anche la fertilità. Organi come il cuore, i reni e il fegato funzionano come organi endocrini, secernendo l'ormone eritropoietina, che influenza la produzione di globuli rossi.
Malattie del sistema endocrino
Le malattie del sistema endocrino si verificano principalmente per due ragioni: un cambiamento nel livello di un ormone secreto dalla ghiandola o un cambiamento nella sensibilità dei recettori nelle cellule del corpo. Per questi motivi, il corpo non risponde adeguatamente all’omeostasi generale. La malattia più comune è il diabete, che interferisce con il metabolismo del glucosio. Il diabete mellito ha un enorme impatto sulla qualità della vita di una persona perché livelli adeguati di glucosio non sono solo importanti per mantenere il funzionamento del corpo, ma possono anche inibire la crescita di microrganismi o cellule tumorali.

Anche gli squilibri ormonali nel sistema riproduttivo sono significativi in quanto possono influenzare la fertilità, l’umore e il benessere generale di una persona. La ghiandola tiroidea è un componente importante del sistema endocrino con livelli alti e bassi di secrezione, che influenzano la capacità del corpo di funzionare in modo ottimale. La produzione dell’ormone tiroideo dipende dal micronutriente essenziale iodio. Una carenza di questo elemento può portare ad un ingrossamento della ghiandola tiroidea poiché il corpo cerca di compensare i bassi livelli ormonali.
Diabete
Il diabete è una malattia metabolica in cui il livello di glucosio nel sangue supera la norma. Il diabete si verifica a causa di una carenza dell'ormone insulina, prodotto dalle cellule beta delle isole di Langerhans nel pancreas. Lo sviluppo della malattia è associato ad un'insufficiente sintesi di insulina o ad una diminuzione della sensibilità dei recettori delle cellule del corpo ad essa.

L'insulina è un ormone anabolico che stimola il trasporto del glucosio nelle cellule muscolari o nel tessuto adiposo, dove viene immagazzinato come glicogeno o convertito in grasso. L'insulina inibisce il processo di sintesi del glucosio nelle cellule, interrompendo la gluconeogenesi e la degradazione del glicogeno. In genere, l'insulina viene rilasciata quando si verifica un forte aumento della glicemia dopo aver mangiato. La secrezione di insulina protegge le cellule dall’eccesso distruttivo di glucosio a lungo termine, consentendo la conservazione e l’utilizzo dei nutrienti. Il glucagone è un ormone pancreatico secreto dalle cellule alfa, a differenza dell'insulina, rilasciato quando i livelli di zucchero nel sangue diminuiscono. Come prevenire il diabete
Ipotiroidismo
L'ipotiroidismo è una condizione che si verifica a causa della mancanza di ormoni tiroidei, tiroxina (T4) e triiodotironina (T3). Questi ormoni contengono iodio e derivano da un amminoacido: la tirosina. La carenza di iodio è la causa principale dell’ipotiroidismo, poiché la ghiandola non riesce a sintetizzare una quantità sufficiente di ormone.

La causa della malattia può essere un danno alla ghiandola tiroidea dovuto a infezione o infiammazione. La malattia si verifica anche a causa di una carenza dell'ormone ipofisario, che stimola la ghiandola tiroidea, e di disturbi nel funzionamento dei recettori ormonali.
L'ipogonadismo è una malattia in cui si verifica una diminuzione del livello degli ormoni sessuali. Le gonadi (testicoli e ovaie) secernono ormoni che influenzano lo sviluppo, la maturazione e il funzionamento degli organi genitali, nonché la comparsa dei caratteri sessuali secondari. L'ipogonadismo può essere primario o secondario. La causa primaria è dovuta al fatto che le gonadi producono bassi livelli di ormoni sessuali. La causa dello sviluppo dell'ipogonadismo secondario può essere l'insensibilità degli organi ai segnali per la produzione di ormoni provenienti dal cervello. A seconda del periodo in cui si manifesta, l'ipogonadismo può presentare vari sintomi.

Nei ragazzi con ipogonadismo germinale possono formarsi genitali femminili o genitali esterni di tipo intermedio. Durante la pubertà, la malattia colpisce l'instaurarsi del ciclo mestruale, lo sviluppo delle ghiandole mammarie e dell'ovulazione nelle donne, la crescita del pene e l'ingrossamento dei testicoli nei ragazzi, lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari e i cambiamenti nella struttura corporea. In età adulta, la malattia porta a diminuzione del desiderio sessuale, infertilità, sindrome da stanchezza cronica o addirittura perdita di massa muscolare e ossea.
L'ipogonadismo può essere rilevato facendo un esame del sangue. Il trattamento della malattia richiederà una terapia ormonale sostitutiva a lungo termine.
Il nostro corpo ha molti organi e sistemi; in effetti, è un meccanismo naturale unico. Ci vuole molto tempo per studiare completamente il corpo umano. Ma farsi un’idea generale non è così difficile. Soprattutto se questo è necessario per comprendere una qualsiasi delle tue malattie.
Secrezione interna
La stessa parola “endocrino” deriva da una frase greca e significa “secernere all’interno”. Questo sistema del corpo umano normalmente ci fornisce tutti gli ormoni di cui potremmo aver bisogno.
Grazie al sistema endocrino, nel nostro corpo avvengono molti processi: 
- crescita, sviluppo globale:
- metabolismo;
- produzione di energia;
- lavoro coordinato di tutti gli organi e sistemi interni;
- correzione di alcuni disturbi nei processi corporei;
- generazione di emozioni, gestione del comportamento.
L’importanza degli ormoni è enorme
Già nel momento in cui una minuscola cellula - un bambino non ancora nato - inizia a svilupparsi sotto il cuore di una donna, sono gli ormoni che regolano questo processo.
Abbiamo bisogno della formazione di questi composti letteralmente per tutto. Anche innamorarsi.
In cosa consiste il sistema endocrino?
 I principali organi del sistema endocrino sono:
I principali organi del sistema endocrino sono:
- ghiandole tiroidee e timo;
- ghiandola pineale e ghiandola pituitaria;
- ghiandole surrenali;
- pancreas;
- testicoli negli uomini o ovaie nelle donne.
Tutti questi organi (ghiandole) sono cellule endocrine unite. Ma nel nostro corpo, in quasi tutti i tessuti, ci sono singole cellule che producono anche ormoni.
Per distinguere tra cellule secretorie unite e sparse, il sistema endocrino generale umano è suddiviso in:
- ghiandolare (comprende le ghiandole endocrine)
- diffuso (in questo caso parliamo di singole cellule).
Quali sono le funzioni degli organi e delle cellule del sistema endocrino?
La risposta a questa domanda è nella tabella seguente:
| Organo | Di cosa è responsabile? |
| Ipotalamo | Controllo della fame, della sete, del sonno. Invio di comandi alla ghiandola pituitaria. |
| Pituitaria | Rilascia l'ormone della crescita. Insieme all'ipotalamo coordina l'interazione del sistema endocrino e nervoso. |
| Tiroide, paratiroidi, timo | Regolano i processi di crescita e sviluppo umano, il funzionamento dei suoi sistemi nervoso, immunitario e motorio. |
| Pancreas | Monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue. |
| Corteccia surrenale | Regolano l'attività del cuore e dei vasi sanguigni e controllano i processi metabolici. |
| Gonadi (testicoli/ovaie) | Producono cellule sessuali e sono responsabili dei processi di riproduzione. |
- Viene qui descritta la “zona di responsabilità” delle principali ghiandole endocrine, cioè gli organi dell'ES ghiandolare.
- Gli organi del sistema endocrino diffuso svolgono le proprie funzioni e allo stesso tempo le cellule endocrine in essi contenute sono impegnate a produrre ormoni. Questi organi includono lo stomaco, la milza, l'intestino, ecc. Tutti questi organi producono vari ormoni che regolano le attività degli stessi “ospiti” e li aiutano a interagire con il corpo umano nel suo insieme.
È ormai noto che le nostre ghiandole e le singole cellule producono circa trenta tipi di ormoni diversi. Tutti vengono rilasciati nel sangue in quantità diverse e con frequenze diverse. Viviamo infatti solo grazie agli ormoni.
Sistema endocrino e diabete mellito
Se l'attività di una ghiandola endocrina viene interrotta, si verificano varie malattie.
Tutti influenzano la nostra salute e la nostra vita. In alcuni casi, la produzione impropria di ormoni cambia letteralmente l’aspetto di una persona. Ad esempio, senza l'ormone della crescita una persona sembra un nano e una donna senza il corretto sviluppo delle cellule riproduttive non può diventare madre.
Il pancreas è progettato per produrre l’ormone insulina. Senza di esso, la scomposizione del glucosio nel corpo è impossibile. Nel primo tipo di malattia, la produzione di insulina è troppo bassa e ciò interrompe i normali processi metabolici. Il secondo tipo di diabete significa che gli organi interni rifiutano letteralmente di accettare l'insulina.
Il metabolismo alterato del glucosio nel corpo innesca molti processi pericolosi. Esempio:
- Non c'era alcuna degradazione del glucosio nel corpo.
- Per trovare energia, il cervello dà un segnale per scomporre i grassi.
- Durante questo processo si forma non solo il glicogeno necessario, ma anche composti speciali: i chetoni.
Tutte le ghiandole endocrine in medicina sono combinate sistema endocrino umano. Il suo compito è controllare le funzioni di base del corpo umano, quindi anche eventuali disturbi ormonali funzionali, e ancor più le malattie endocrinologiche, richiedono un atteggiamento particolarmente serio.
Malattie metaboliche: cause
Quali malattie possono essere chiamate ormonali? In quali casi è necessario contattare un endocrinologo? A quale esame deve sottoporsi il paziente per stabilire una diagnosi accurata e prescrivere un trattamento? Queste domande preoccupano molti pazienti e i loro parenti, perché i disturbi ormonali causano disturbi nel funzionamento di molti organi e sistemi del corpo umano e, in assenza di un trattamento adeguato, possono portare a condizioni estremamente gravi nell'uomo.
I disturbi ormonali comprendono problemi di altezza, peso, sviluppo, disfunzioni sessuali, instabilità emotiva e comportamento mentalmente squilibrato.
Il sistema endocrino è attivamente coinvolto nell'attuazione delle funzioni vitali del corpo umano, tra cui la digestione del cibo e il mantenimento di uno stato equilibrato del corpo.
Quali organi compongono il sistema endocrino?
Le ghiandole del sistema endocrino comprendono la ghiandola pituitaria, la ghiandola pineale, l'ipotalamo, la tiroide e le ghiandole paratiroidi, le ghiandole surrenali e le gonadi.

Il ruolo delle ghiandole endocrine nel corpo– normalizzazione del sistema nervoso e immunitario, mantenendo il normale stato acido-base dell’organismo. Le ghiandole endocrine formano insieme la parte ghiandolare del sistema, che produce composti speciali: gli ormoni sono sostanze che, attraverso reazioni chimiche, regolano l'attività degli organi umani.
A cosa portano le disfunzioni del sistema ormonale?
È molto importante sapere che non tutte le malattie possono essere una conseguenza della disfunzione delle ghiandole endocrine e degli squilibri ormonali. Pertanto, non è sempre necessario correre immediatamente da un endocrinologo. Le disfunzioni sessuali possono essere causate dalla presenza di un'infezione e necessitano di essere esaminate da un urologo o un ginecologo; l'instabilità emotiva spesso richiede l'intervento di uno psicoterapeuta: la consultazione con uno specialista qualificato e un esame completo e completo aiuteranno a stabilire una diagnosi accurata e a fornire trattamento efficace.
Le malattie del sistema endocrino sono il risultato della secrezione eccessiva o insufficiente di alcuni ormoni. Ciò può portare a patologie della crescita, comparsa di osteoporosi, diabete mellito, aumento dei livelli di colesterolo nel plasma sanguigno e disturbi della ghiandola tiroidea.
Ghiandola tiroidea nel sistema endocrino
Posizione della ghiandola tiroidea nel sistema endocrino e nel corpo nel suo insiemeè centrale tra le altre ghiandole.
 È un collegamento protettivo del corpo. Il sangue che circola nel corpo umano passa completamente attraverso la ghiandola tiroidea in 17 minuti. Durante questo periodo, lo iodio secreto dalla ghiandola tiroidea distrugge i microrganismi instabili che entrano nel sangue a causa di danni alla pelle, alle mucose o durante l'ingestione e la digestione del cibo. I microrganismi più resistenti, portatori di virus, si indeboliscono durante questo ciclo, poi ad ogni ciclo successivo diventano ancora più deboli fino alla morte.
È un collegamento protettivo del corpo. Il sangue che circola nel corpo umano passa completamente attraverso la ghiandola tiroidea in 17 minuti. Durante questo periodo, lo iodio secreto dalla ghiandola tiroidea distrugge i microrganismi instabili che entrano nel sangue a causa di danni alla pelle, alle mucose o durante l'ingestione e la digestione del cibo. I microrganismi più resistenti, portatori di virus, si indeboliscono durante questo ciclo, poi ad ogni ciclo successivo diventano ancora più deboli fino alla morte.
La ghiandola tiroidea è un elemento importante del sistema endocrino, poiché produce ormoni necessari per le funzioni fisiologiche del corpo umano. Calcitonina- uno degli ormoni prodotti da questa ghiandola. È necessario per lo sviluppo e il normale funzionamento del sistema nervoso, del sistema circolatorio, del sistema digestivo, del sistema riproduttivo, del sistema muscolo-scheletrico, dei capelli e della pelle. Questo composto influenza il metabolismo del calcio nel corpo: per l'uomo, sia la carenza di questo microelemento, che provoca disturbi del ritmo cardiaco e cambiamenti nella struttura ossea, sia un eccesso, che causa forti crampi, sono ugualmente pericolosi.
 Un altro ormone prodotto dalla ghiandola tiroidea è la tiroxina. È responsabile della velocità di funzionamento del corpo. La secrezione di ormoni da parte della ghiandola tiroidea dipende in gran parte dalla quantità di iodio nel corpo, quindi è importante per la salute della ghiandola tiroidea che la dieta sia ricca di alimenti contenenti iodio. Questi prodotti includono tutti i frutti di mare e le alghe.
Un altro ormone prodotto dalla ghiandola tiroidea è la tiroxina. È responsabile della velocità di funzionamento del corpo. La secrezione di ormoni da parte della ghiandola tiroidea dipende in gran parte dalla quantità di iodio nel corpo, quindi è importante per la salute della ghiandola tiroidea che la dieta sia ricca di alimenti contenenti iodio. Questi prodotti includono tutti i frutti di mare e le alghe.
Gli squilibri ormonali che si verificano a causa della carenza di iodio nella maggior parte dei casi non hanno manifestazioni esterne, motivo per cui la carenza di iodio viene spesso chiamata fame nascosta. Molte persone non notano affatto la mancanza di iodio e non sono consapevoli della presenza di malattie endocrine. Tuttavia, i seguenti sintomi sono allarmanti:
- letargia, stanchezza;
- diminuzione della concentrazione e disturbi della memoria;
- cambiamento improvviso di peso;
- irritabilità, depressione;
- dolore muscolare;
- elevata incidenza di varie malattie infettive.
A causa della carenza di iodio nel corpo, possono verificarsi non solo malattie endocrine, ma anche malattie di altri organi e sistemi. Ciò accade perché il lavoro di tutti gli organi del sistema endocrino è strettamente interconnesso.
Anche la diminuzione dell'immunità, le malattie degli organi ORL, i disturbi cardiaci, le malattie del sistema riproduttivo, del sistema nervoso e del sistema muscolo-scheletrico possono essere il risultato di una carenza di iodio.
Se compaiono i minimi segni che prima non erano caratteristici di una persona, è necessaria una visita medica. Quando si contatta un endocrinologo, il paziente viene esaminato e viene redatto un piano di esame, dopo di che il medico deve dare l'invio per un esame ecografico della tiroide, test ormonali e, se necessario, uno studio scintigrafico. Senza determinare la vera causa dei disturbi nel funzionamento di organi e sistemi, è impossibile eliminare questi disturbi.
Come dimenticare le malattie della tiroide? 
Noduli sul collo, mancanza di respiro, mal di gola, pelle secca, ottusità, perdita di capelli, unghie fragili, gonfiore, gonfiore del viso, occhi opachi, stanchezza, sonnolenza, pianto, ecc. - questa è tutta una mancanza di iodio nel corpo. Se i sintomi sono evidenti, è possibile che la tua ghiandola tiroidea non sia più in grado di funzionare normalmente... Non sei solo, secondo le statistiche, fino a un terzo dell'intera popolazione del pianeta soffre di problemi alla tiroide .
Come dimenticare le malattie della tiroide? Ne parla il professor Vladimir Trofimovich Ivashkin.
ORGANI DEL SISTEMA ENDOCRINO
ORGANI DEL SISTEMA ENDOCRINO
Organi del sistema endocrino, O ghiandole endocrine, produrre sostanze biologicamente attive - ormoni, che vengono rilasciati nel sangue e, diffondendosi in tutto il corpo, colpiscono le cellule di vari organi e tessuti (celle bersaglio), regolandone la crescita e l'attività grazie alla presenza di cellule specifiche su queste cellule recettori ormonali.
Le ghiandole endocrine (come ad esempio l'ipofisi, la ghiandola pineale, le ghiandole surrenali, la tiroide e le paratiroidi) sono organi indipendenti, ma oltre ad essi gli ormoni vengono prodotti anche dalle singole cellule endocrine e dai loro gruppi, sparsi tra loro. tessuti non endocrini: si formano tali cellule e i loro gruppi sistema endocrino disperso (diffuso). Un numero significativo di cellule del sistema endocrino disperso si trova nelle mucose di vari organi, sono particolarmente numerose nel tratto digestivo, dove la loro totalità è chiamata sistema gastroenteropancreatico (GEP).
Le ghiandole endocrine, che hanno una struttura organica, sono solitamente ricoperte da una capsula di tessuto connettivo denso, dalla quale trabecole assottigliate, costituite da tessuto connettivo fibroso sciolto e portanti vasi e nervi, si estendono in profondità nell'organo. Nella maggior parte delle ghiandole endocrine, le cellule formano cordoni e sono strettamente adiacenti ai capillari, il che garantisce la secrezione di ormoni nel flusso sanguigno. A differenza di altre ghiandole endocrine, le cellule della tiroide non formano filamenti, ma sono organizzate in piccole vescicole chiamate follicoli. I capillari delle ghiandole endocrine formano reti molto fitte e, a causa della loro struttura, hanno una maggiore permeabilità: sono fenestrati o sinusoidali. Poiché gli ormoni vengono rilasciati nel sangue e non sulla superficie del corpo o nelle cavità degli organi (come nelle ghiandole esocrine), le ghiandole endocrine non hanno dotti escretori.
Tessuto funzionalmente leader (che produce ormoni). le ghiandole endocrine sono tradizionalmente considerate epiteliali (appartenenti a vari tipi istogenetici). Infatti, l'epitelio è il tessuto funzionalmente leader della maggior parte delle ghiandole endocrine (tiroide e paratiroidi, lobi anteriori e intermedi dell'ipofisi, corteccia surrenale). Alcuni elementi endocrini delle gonadi sono anche di natura epiteliale (cellule follicolari ovariche, sustentociti testicolari, ecc.). Tuttavia
Attualmente non vi è dubbio che anche tutti gli altri tipi di tessuti siano in grado di produrre ormoni. In particolare, gli ormoni sono prodotti dalle cellule del tessuto muscolare (liscio nell'apparato iuxtaglomerulare del rene - vedere Capitolo 15 e striato, compresi i cardiomiociti secretori negli atri - vedere Capitolo 9).
Alcuni elementi endocrini delle gonadi sono di origine del tessuto connettivo (ad esempio, endocrinociti interstiziali - cellule di Leydig, cellule dello strato interno della teca dei follicoli ovarici, cellule del chilo del midollo ovarico - vedere Capitoli 16 e 17). L'origine neurale è caratteristica delle cellule neuroendocrine dell'ipotalamo, delle cellule della ghiandola pineale, della neuroipofisi, della midollare del surrene e di alcuni elementi del sistema endocrino disperso (ad esempio, cellule C della ghiandola tiroidea - vedi sotto). Alcune ghiandole endocrine (ghiandola pituitaria, ghiandola surrenale) sono formate da tessuti che hanno origini embrionali diverse e si trovano separatamente nei vertebrati inferiori.
Le cellule delle ghiandole endocrine sono caratterizzate da elevata attività secretoria e notevole sviluppo dell'apparato sintetico; la loro struttura dipende innanzitutto dalla natura chimica degli ormoni prodotti. Nelle cellule che producono ormoni peptidici è molto sviluppato il reticolo endoplasmatico granulare, il complesso del Golgi; nelle cellule che sintetizzano ormoni steroidei è presente il reticolo endoplasmatico agranulare, i mitocondri con creste tubolare-vescicolari. L'accumulo degli ormoni avviene solitamente a livello intracellulare sotto forma di granuli secretori; i neuroormoni dell'ipotalamo possono accumularsi in grandi quantità all'interno degli assoni, allungandoli bruscamente in alcune aree (corpi neurosecretori). L'unico esempio di accumulo extracellulare di ormoni è nei follicoli della ghiandola tiroidea.
Gli organi del sistema endocrino appartengono a diversi livelli di organizzazione. Quello inferiore è occupato dalle ghiandole che producono ormoni che colpiscono vari tessuti del corpo. (effettore, O periferiche, ghiandole). L'attività della maggior parte di queste ghiandole è regolata da speciali ormoni tropici del lobo anteriore ghiandola pituitaria(secondo livello più alto). A sua volta, il rilascio degli ormoni tropici è controllato da speciali neurormoni ipotalamo, che occupa la posizione più alta nell’organizzazione gerarchica del sistema.
Ipotalamo
Ipotalamo- area del diencefalo contenente speciali nuclei neurosecretori, le cui cellule (cellule neuroendocrine) prodotto e secreto nel sangue neuroormoni. Queste cellule ricevono impulsi efferenti da altre parti del sistema nervoso e i loro assoni terminano sui vasi sanguigni (sinapsi neurovascolari). I nuclei neurosecretori dell'ipotalamo, a seconda delle dimensioni delle cellule e delle loro caratteristiche funzionali, si dividono in grande- E piccola cellula.
Nuclei magnocellulari dell'ipotalamo formato dai corpi delle cellule neuroendocrine, i cui assoni lasciano l'ipotalamo, formando il tratto ipotalamo-ipofisario, attraversano la barriera emato-encefalica, penetrano nel lobo posteriore della ghiandola pituitaria, dove formano terminali sui capillari (Fig. 165 ). Questi kernel includono sovraottico E paraventricolare, che secernono ormone antidiuretico, O vasopressina(aumenta la pressione sanguigna, garantisce il riassorbimento dell'acqua nei reni) e ossitocina(provoca le contrazioni dell'utero durante il parto, così come le cellule mioepiteliali della ghiandola mammaria durante l'allattamento).
Nuclei parvocellulari dell'ipotalamo produrre una serie di fattori ipofisiotropi che migliorano (fattori di rilascio, O Liberini) o opprimere (fattori inibitori, O statine) la produzione di ormoni da parte delle cellule del lobo anteriore, raggiungendoli attraverso sistema vascolare portale. Gli assoni delle cellule neuroendocrine di questi nuclei formano terminali rete capillare primaria V elevazione mediana, essendo la zona di contatto neuroemale. Questa rete si raccoglie ulteriormente nelle vene porta, penetrando nel lobo anteriore della ghiandola pituitaria e rompendosi in rete capillare secondaria tra i filamenti di endocrinociti (vedere Fig. 165).
Cellule neuroendocrine ipotalamiche- forma processuale, con un grande nucleo vescicolare, un nucleolo ben visibile e un citoplasma basofilo contenente un reticolo endoplasmatico granulare sviluppato e un grande complesso di Golgi, da cui sono separati i granuli neurosecretori (Fig. 166 e 167). I granuli vengono trasportati lungo l'assone (fibra neurosecretoria) lungo il fascio centrale di microtubuli e microfilamenti, e in alcuni punti si accumulano in grandi quantità, allungando in modo varicoso l'assone - preterminale E estensioni terminali dell'assone. Le più grandi di queste aree sono chiaramente visibili al microscopio ottico e vengono chiamate corpi neurosecretori(Gerring). Terminali (sinapsi neuroemiche) caratterizzato dalla presenza, oltre ai granuli, di numerose vescicole leggere (ritorno alla membrana dopo l'esocitosi).
Pituitaria
Pituitaria regola l'attività di numerose ghiandole endocrine e funge da sito per il rilascio di ormoni ipotalamici dai grandi nuclei cellulari dell'ipotalamo. Interagendo con l'ipotalamo, la ghiandola pituitaria forma una singola sistema neurosecretorio ipotalamo-ipofisi. La ghiandola pituitaria è costituita da due parti embriologicamente, strutturalmente e funzionalmente diverse: lobo neurale (posteriore) - parti della crescita del diencefalo (neuroipofisi) e adenoipofisi, Il cui tessuto principale è l'epitelio. L'adenoipofisi si divide in una più grande lobo anteriore (parte distale), stretto parte intermedia (quota) e poco sviluppato parte tuberale.
La ghiandola pituitaria è ricoperta da una capsula di tessuto connettivo fibroso denso. Il suo stroma è rappresentato da strati molto sottili di tessuto connettivo lasso associati ad una rete di fibre reticolari, che nell'adenoipofisi circonda filamenti di cellule epiteliali e piccoli vasi.
Lobo anteriore (parte distale) ghiandola pituitaria e nell'uomo costituisce la maggior parte della sua massa; si forma per anastomizzazione trabecole, O cordoni, cellule endocrine, strettamente correlato al sistema capillare sinusoidale. In base alle caratteristiche di colorazione del loro citoplasma si distinguono: 1) cromofilo(intensamente macchiato) e 2) cromofobico(coloranti che accettano debolmente) cellule (endocrinociti).
Cellule cromofile A seconda del colore dei granuli secretori contenenti ormoni, sono suddivisi in Endocrinociti acidofili e basofili(Fig. 168).
Endocrinociti acidofili produrre ormone somatotropo o ormone della crescita, che stimola la crescita e prolattina o ormone lattotropico, che stimola lo sviluppo delle ghiandole mammarie e l'allattamento.
Endocrinociti basofili includere gonadotropico, tireotropico E cellule corticotrope, che producono di conseguenza: ormone che stimola i follicoli(FSH) e ormone luteinizzante(LH) - regolano la gametogenesi e la produzione di ormoni sessuali in entrambi i sessi, ormone stimolante la tiroide- migliora l'attività dei tireociti, ormone adrenocorticotropo- stimola l'attività della corteccia surrenale.
Cellule cromofobe - un gruppo eterogeneo di cellule, che comprende cellule cromofile dopo l'escrezione di granuli secretori, elementi cambiali scarsamente differenziati che possono trasformarsi in basofili o acidofili.
Pars intermedius della ghiandola pituitaria nell'uomo è molto poco sviluppato ed è costituito da stretti filamenti discontinui di cellule basofile e cromofobe che circondano una serie di cavità cistiche (follicoli), contenente colloide(sostanza non ormonale). La maggior parte delle cellule secernono ormone stimolante i melanociti(regola l'attività dei melanociti), alcuni hanno le caratteristiche dei corticotropi.
Lobo posteriore (neurale). contiene: germogli (fibre neurosecretorie) e terminali delle cellule neurosecretrici dei grandi nuclei cellulari dell'ipotalamo, attraverso i quali la vasopressina e l'ossitocina vengono trasportate e rilasciate nel sangue; aree ampliate lungo i processi e nell'area dei terminal - corpi neurosecretori(Gerring); numerosi capillari fenestrati; pituite- cellule gliali ramificate che svolgono funzioni di sostegno, trofiche e regolatrici (Fig. 169).
Tiroide
Tiroide- la più grande delle ghiandole endocrine del corpo - formata da due azioni, collegati da un istmo. Ogni azione è coperta capsula dal tessuto connettivo fibroso denso, dal quale si estendono nell'organo strati (setti) che trasportano vasi e nervi (Fig. 170).
Follicoli - unità morfofunzionali della ghiandola - formazioni chiuse di forma rotonda, la cui parete è costituita da un singolo strato di epiteliale cellule follicolari (tireociti), il lume contiene il loro prodotto secretorio - colloide (vedi Fig. 170 e 171). Le cellule follicolari producono sostanze contenenti iodio ormoni tiroidei (tiroxina, triiodotironina), che regolano l’attività delle reazioni metaboliche e dei processi di sviluppo. Questi ormoni si legano alla matrice proteica e si formano tireoglobulina immagazzinati all'interno dei follicoli. Le cellule follicolari sono caratterizzate da nuclei grandi e leggeri con nucleolo ben visibile, numerose cisterne dilatate del reticolo endoplasmatico granulare e un grande complesso di Golgi; sulla superficie apicale si trovano numerosi microvilli (vedi Fig. 4 e 172). La forma delle cellule follicolari può variare da piatta a colonnare a seconda dello stato funzionale. Ogni follicolo è circondato rete capillare perifollicolare. Tra i follicoli ci sono stretti strati di tessuto connettivo fibroso sciolto (stroma della ghiandola) e isole compatte epitelio interfollicolare(vedi Fig. 170 e 171), che probabilmente funge da fonte
Tuttavia, è stato stabilito che i follicoli possono formarsi dividendo quelli esistenti.
Cellule C (cellule parafollicolari) sono di origine neurale e producono un ormone proteico calcitonina, avere un effetto ipocalcemico. Vengono rilevati solo mediante metodi di colorazione speciali e molto spesso si trovano singolarmente o in piccoli gruppi parafollicolarmente - nella parete del follicolo tra i tireociti e la membrana basale (vedi Fig. 172). La calcitonina si accumula nelle cellule C in granuli densi e viene rimossa dalle cellule mediante il meccanismo dell'esocitosi quando aumenta il livello di calcio nel sangue.
Ghiandole paratiroidi
Ghiandole paratiroidi produrre polipeptide ormone paratiroideo (ormone paratiroideo), che è coinvolto nella regolazione del metabolismo del calcio, aumentando il livello di calcio nel sangue. Ogni ghiandola è ricoperta da un sottile capsula costituito da tessuto connettivo denso, da cui si estendono i setti, dividendolo in lobuli. I lobuli sono formati da filamenti di cellule ghiandolari - paratirociti, tra i quali si trovano sottili strati di tessuto connettivo con una rete di capillari fenestrati contenenti cellule adipose, il cui numero aumenta notevolmente con l'età (Fig. 173 e 174).
Paratirociti sono divisi in due tipologie principali: principale E ossifilo(vedi Fig. 174).
Principali cellule paratiroidee costituiscono la parte principale del parenchima dell'organo. Queste sono piccole cellule poligonali con citoplasma debolmente ossifilo. Disponibile in due versioni (leggero E paratiroidi a capo scuro), che riflettono rispettivamente un'attività funzionale bassa e alta.
Paratirociti ossifili più grandi dei principali, il loro citoplasma è intensamente colorato con coloranti acidi ed è caratterizzato da un altissimo contenuto di grandi mitocondri con scarso sviluppo di altri organelli e assenza di granuli secretori. Nei bambini, queste cellule sono rare e il loro numero aumenta con l’età.
Ghiandole surrenali
Ghiandole surrenali- ghiandole endocrine, che consistono di due parti - corticale E materia cerebrale, aventi diversa origine, struttura e funzione. Ogni ghiandola surrenale è ricoperta da uno spesso capsula dal tessuto connettivo denso, da cui si estendono nella corteccia sottili trabecole che trasportano vasi e nervi.
Corteccia (corteccia) della ghiandola surrenale si sviluppa dall'epitelio celomico. Prende
gran parte del volume dell'organo ed è formato da tre strati concentrici vagamente delimitati (zone):(1) zona glomerulare,(2) zona del fascio e (3) zona delle maglie(Fig. 175). Cellule della corteccia surrenale (corticosterociti) produrre corticosteroidi- un gruppo di ormoni steroidei sintetizzati dal colesterolo.
Zona glomerulosa - sottile esterno, adiacente alla capsula; formato da cellule colonnari con citoplasma di colore uniforme, che formano archi arrotondati (“glomeruli”). Le cellule di questa zona secernono mineralcorticoidi- ormoni che influenzano il contenuto di elettroliti nel sangue e la pressione sanguigna (nell'uomo il più importante è aldosterone).
Zona del fascio - medio, costituisce la maggior parte della corteccia; è costituito da grandi cellule ossifile vacuolate - corticosteroidi spugnosi(spongiociti), che formano filamenti orientati radialmente (“fasci”) separati da capillari sinusoidali. Sono caratterizzati da un contenuto molto elevato di goccioline lipidiche (più che nelle cellule delle zone glomerulari e fascicolari), mitocondri con creste tubolari, potente sviluppo del reticolo endoplasmatico agranulare e del complesso del Golgi (Fig. 176). Queste cellule producono glucocorticoidi- ormoni che hanno un effetto pronunciato su vari tipi di metabolismo (soprattutto carboidrati) e sul sistema immunitario (il principale nell'uomo è cortisolo).
Zona a maglie - interno stretto, adiacente al midollo allungato - è rappresentato da corde epiteliali anastomizzate che corrono in diverse direzioni (formando una "rete"), tra le quali si trovano i vasi sanguigni;
pilastri. Le cellule di questa zona sono più piccole di quelle della zona fascicolare; nel loro citoplasma sono presenti numerosi lisosomi e granuli di lipofuscina. Loro producono steroidi sessuali(i principali negli esseri umani sono deidroepiandrosterone e il suo solfato - hanno un debole effetto androgenico).
Midollo surrenale ha un'origine neurale: si forma durante l'embriogenesi da cellule che migrano dalla cresta neurale. Consiste in cromaffine, gangliari E cellule di sostegno.
Cellule cromaffini del midollo situati sotto forma di nidi e cordoni, hanno forma poligonale, nucleo grande, citoplasma a grana fine o vacuolato. Contengono piccoli mitocondri, file di cisterne del reticolo endoplasmatico granulare, un grande complesso di Golgi e numerosi granuli secretori. Sintetizzano le catecolamine - adrenalina e norepinefrina - e si dividono in due tipologie:
1)surrenociti (cellule cromaffini leggere)- predominano numericamente, producono adrenalina, che si accumula in granuli con una matrice moderatamente densa;
2)cellule norepinefrina (cellule cromaffini scure)- producono norepinefrina, che si accumula in granuli con una matrice compattata al centro e leggera lungo la periferia. Oltre alle catecolamine, i granuli secretori in entrambi i tipi di cellule contengono proteine, tra cui cromogranine (stabilizzatori osmotici), encefaline, lipidi e ATP.
Cellule gangliari - sono contenuti in piccoli numeri e rappresentano neuroni autonomi multipolari.
ORGANI DEL SISTEMA ENDOCRINO
Riso. 165. Schema della struttura del sistema neurosecretorio ipotalamo-ipofisario
1 - nuclei neurosecretori a grandi cellule dell'ipotalamo, contenenti i corpi delle cellule neuroendocrine: 1.1 - sopraottico, 1.2 - paraventricolare; 2 - tratto neurosecretorio ipotalamo-ipofisario, formato da assoni di cellule neuroendocrine con vene varicose (2.1), che terminano con sinapsi neurovascolari (neuroemali) (2.2) sui capillari (3) nel lobo posteriore dell'ipofisi; 4 - barriera ematoencefalica; 5 - nuclei neurosecretori a piccole cellule dell'ipotalamo, contenenti i corpi delle cellule neuroendocrine, i cui assoni (5.1) terminano in sinapsi neuroemiche (5.2) sui capillari della rete primaria (6), formata dall'arteria pituitaria superiore ( 7); 8 - vene portali della ghiandola pituitaria; 9 - rete secondaria di capillari sinusoidali nel lobo anteriore della ghiandola pituitaria; 10 - arteria pituitaria inferiore; 11 - vene ipofisarie; 12 - seno cavernoso
I nuclei neurosecretori a grandi cellule dell'ipotalamo producono ossitocina e vasopressina, liberine e statine a piccole cellule

Riso. 166. Cellule neuroendocrine del nucleo sopraottico dell'ipotalamo
1 - cellule neuroendocrine nelle diverse fasi del ciclo secretorio: 1.1 - accumulo perinucleare di neurosecrezione; 2 - processi di cellule neuroendocrine (fibre neurosecretorie) con granuli neurosecretori; 3 - corpo neurosecretore (Gerring) - dilatazione varicosa dell'assone di una cellula neuroendocrina; 4 - nuclei di gliociti; 5 - capillare sanguigno

Riso. 167. Schema dell'organizzazione ultrastrutturale della cellula neuroendocrina ipotalamica:
1 - perikaryon: 1.1 - nucleo, 1.2 - cisterne del reticolo endoplasmatico granulare, 1.3 - complesso del Golgi, 1.4 - granuli neurosecretori; 2 - inizio dei dendriti; 3 - assone con vene varicose; 4 - corpi neurosecretori (aringa); 5 - sinapsi neurovascolare (neuroematica); 6 - capillare sanguigno

Riso. 168. Ghiandola pituitaria. Zona del lobo anteriore
Colorazione: ematossilina-eosina
1 - endocrinocita cromofobo; 2 - endocrinocita acidofilo; 3 - endocrinocita basofilo; 4 - capillare sinusoidale

Riso. 169. Ghiandola pituitaria. Area del lobo neurale (posteriore).
Colorazione: paraldeide-fucsina e Heidenhain azan
1 - fibre neurosecretorie; 2 - corpi neurosecretori (aringa); 3 - nucleo pituicito; 4 - capillare sanguigno fenestrato

Riso. 170. Tiroide (vista generale)
Colorazione: ematossilina-eosina
1 - capsula fibrosa; 2 - stroma del tessuto connettivo: 2.1 - vaso sanguigno; 3 - follicoli; 4 - isole interfollicolari

Riso. 171. Tiroide (sito)
Colorazione: ematossilina-eosina
1 - follicolo: 1.1 - cellula follicolare, 1.2 - membrana basale, 1.3 - colloide, 1.3.1 - vacuoli di riassorbimento; 2 - isola interfollicolare; 3 - tessuto connettivo (stroma): 3.1 - vaso sanguigno

Riso. 172. Organizzazione ultrastrutturale delle cellule follicolari e delle cellule C della tiroide
Disegnare con i campi elettromagnetici
1 - cellula follicolare: 1.1 - cisterne del reticolo endoplasmatico granulare, 1.2 - microvilli;
2- colloide nel lume del follicolo; 3 - cellula C (parafollicolare): 3.1 - granuli secretori; 4 - membrana basale; 5 - capillare sanguigno

Riso. 173. Ghiandola paratiroidea (vista generale)
Colorazione: ematossilina-eosina
1 - capsula; 2 - filamenti di paratirociti; 3 - tessuto connettivo (stroma): 3.1 - adipociti; 4 - vasi sanguigni

Riso. 174. Ghiandola paratiroidea (sito)
Colorazione: ematossilina-eosina
1 - principali cellule paratiroidee; 2 - paratirocito ossifilo; 3 - stroma: 3.1 - adipociti; 4 - capillare sanguigno

Riso. 175. Ghiandola surrenale
Colorazione: ematossilina-eosina
1 - capsula; 2 - sostanza corticale: 2.1 - zona glomerulosa, 2.2 - zona fasciculata, 2.3 - zona reticularis; 3 - midollo; 4 - capillari sinusoidali

Riso. 176.Organizzazione ultrastrutturale delle cellule della corteccia surrenale (corticosterociti)
Disegni con EMF
Cellule della corteccia (corticosterociti): A - glomerulare, B - fascicolata, C - zona reticolare
1 - nucleo; 2 - citoplasma: 2.1 - cisterne del reticolo endoplasmatico agranulare, 2.2 - cisterne del reticolo endoplasmatico granulare, 2.3 - complesso del Golgi, 2.4 - mitocondri con creste tubolare-vescicolari, 2.5 - mitocondri con creste lamellari, 2.6 - goccioline lipidiche, 2.7 - granuli di lipofuscina