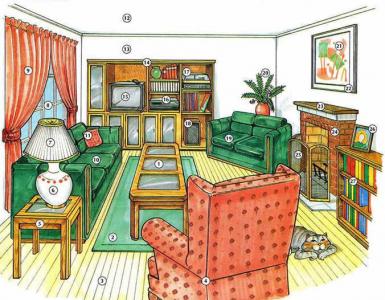Vaiolo: tipi, sintomi, caratteristiche di prevenzione e trattamento. Il vaiolo (o vaiolo) è una malattia del passato. Il vaiolo
Il vaiolo (o vaiolo) è un'infezione altamente contagiosa di origine virale che provoca sintomi di intossicazione, febbre in due stadi ed esantema vescicolo-pustoloso. Questa è la malattia più antica. Le prime menzioni di esso furono scoperte durante la decifrazione di papiri egiziani scritti nel 3000 a.C. Nel XVIII secolo un’epidemia spazzò via 1/10 della popolazione del pianeta. C'è stato un tempo in cui il vaiolo uccideva 10-12 milioni di persone ogni anno. La medicina moderna è riuscita a controllare la diffusione dell’infezione. L’ultimo caso di infezione è stato registrato nella città somala di Marka nel 1977.
La malattia è causata da due grandi virus a DNA, Variola major e Variola minor, che appartengono alla famiglia Poxviridae del genere Orthopoxvirus. I virioni hanno una forma a mattone e una struttura complessa. È costituito da un guscio, proteine e una molecola di DNA lineare a doppio filamento con estremità covalenti chiuse.
L'agente eziologico del vaiolo, se rilasciato nell'ambiente esterno, non muore. Non teme l'essiccamento né il congelamento, ea temperatura ambiente vive fino a diciassette mesi. Muore se riscaldato a 100 gradi dopo dieci minuti o se esposto a una soluzione di formaldeide all'1%.

Entra nel corpo umano attraverso il rinofaringe. Si deposita sulla mucosa del tratto respiratorio superiore. Si accumula lì e poi penetra nei linfonodi regionali. È qui che avviene la prima ondata di replicazione del virione. Un rapido aumento del loro numero contribuisce alla penetrazione dell'agente patogeno nel flusso sanguigno.
Insieme ad esso, si diffonde in tutto il corpo. Le cellule del fegato, della milza e del sistema nervoso centrale vengono infettate. Il tropismo per le cellule della pelle porta alla formazione di elementi di vaiolo. Sono interessati gli strati papillari e subpapillari del derma. Ciò spiega la comparsa di edemi e infiltrazioni infiammatorie. Questi fenomeni diventano la base per il rigonfiamento e la degenerazione reticolare, la formazione di elementi di enanthema e quindi di esantema. La loro comparsa in massa si osserva alla fine della prima settimana dall'inizio del periodo prodromico.

Manifestazioni cliniche nei diversi stadi della malattia
Lo sviluppo dell'infezione avviene in cinque fasi. Le loro caratteristiche sono riportate nella tabella seguente.
| Nome del periodo | Sintomi clinici | Termini di flusso |
| Incubazione | Non si mostra affatto | 9-14 giorni, occasionalmente estesi a 22 giorni |
| Premonitore | Inizia con un forte aumento della temperatura corporea fino a 40 gradi, il paziente avverte debolezza, malessere generale e lieve nausea. Ha un forte dolore alla parte bassa della schiena e ai muscoli. A volte (non tutti) si sviluppa un'eruzione cutanea nelle aree del triangolo di Simon o sul petto, simile all'eruzione cutanea della scarlattina o del morbillo. Entro la fine del periodo, la temperatura corporea diminuisce | 2-4 giorni |
| Fase avventata | Piccole macchie rosa compaiono sulla pelle e sulle mucose. Dopo un giorno si trasformano in papule, dopo tre giorni in vescicole e diventano simili alle vescicole multicamera. Al centro delle vescicole si osserva una retrazione ombelicale. Elementi di un'eruzione cutanea compaiono sul viso, sul busto e su tutti gli arti accoppiati. Possono essere trovati sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi. Questa è la caratteristica con cui viene identificato il vaiolo. L'eruzione cutanea, a differenza della varicella, è monomorfa (tutti gli elementi compaiono contemporaneamente, tutti attraversano gli stessi stadi di sviluppo, tutti guariscono immediatamente). La comparsa di eruzioni cutanee provoca un nuovo aumento della temperatura corporea e la formazione di una seconda ondata di intossicazione | 4-5 giorni |
| Stadio di suppurazione | Inizia con un netto peggioramento delle condizioni del paziente. La temperatura corporea è di 39-40 gradi. Gli elementi dell'eruzione suppurano, perdono la loro qualità multiloculare e diventano dolorosi. Entro la fine della terza settimana dall'inizio della malattia, le vescicole si aprono, il loro contenuto fuoriesce e al loro posto si forma l'erosione, che si ricopre rapidamente di una crosta nera. Ecco perché il vaiolo ha un secondo nome (nero). Il processo di formazione della crosta è accompagnato da un forte prurito | 3 giorni (7-10° giorno) |
| Fase di convalescenza | Inizia dalla quarta settimana dopo l'inizio dell'infezione. La temperatura corporea si normalizza, le condizioni generali del paziente migliorano. C'è un fenomeno in cui le croste generalmente cadono. La pelle sottostante è molto desquamata. Al posto delle vescicole si formano cicatrici profonde, che creano l'effetto della pelle butterata. | Non ha confini temporali chiari |
Classificazione della malattia
La descrizione dei sintomi del vaiolo deve essere adeguata tenendo conto delle forme della malattia e della gravità dell'infezione. Oggi è stato sviluppato il seguente schema di classificazione. Permette di formulare previsioni.
| Modulo | Sottotipo | Caratteristiche cliniche | Esito fatale in % | |
| Nelle persone vaccinate | Nei non vaccinati | |||
| Regolare | Drenare | Le pustole compaiono sul viso, sulla pelle situata sulle superfici estensori degli arti. | 26,3 | 62 |
| Discreto | Le vescicole sono sparse in tutto il corpo | 0,7 | 9,3 | |
| Modificato (varioloide) | Drenare Discreto |
Si differenzia dal vaiolo ordinario per il suo decorso accelerato e per l'assenza di sintomi di intossicazione. Durante il periodo prodromico appare un'eruzione papulare pallida. I suoi elementi si trasformano rapidamente in pustole. Si seccano senza formare vescicole. Non ci sono zone di iperemia attorno alle vescicole, quindi in medicina questa forma ha il secondo nome "vaiolo bianco" | 0 | 0 |
| Nessuna eruzione cutanea | L'infezione si sviluppa tenendo conto di tutte le fasi dello sviluppo ad eccezione dello stadio rash. La diagnosi è confermata solo sulla base di studi sierologici | 0 | 0 | |
| Piatto | Drenare Discreto |
Sul corpo compaiono papule piatte | 66,7 | 96,5 |
| Emorragico | Presto | È caratterizzato da un decorso fulmineo, in cui, anche nel periodo prodromico, appare un'eruzione cutanea piena di contenuto misto a sangue. La sua formazione porta a massicce emorragie nella pelle | 100 | 100 |
| Tardi | Le emorragie si formano dopo che la formazione dell'eruzione cutanea è stata completata | 89,8 | 96,8 | |
Fonti di infezione
La fonte dell'infezione è una persona malata. Comincia a essere contagioso per gli altri pochi giorni prima della fine del periodo di incubazione dell'infezione e fino alla caduta delle croste, in media quaranta giorni dall'inizio della malattia. Il maggior numero di virioni è prodotto da persone in cui il vaiolo si manifesta in forma grave e protratta.
La natura della contagiosità è determinata dalla localizzazione dell'agente patogeno nel corpo umano. Poiché la maggior parte dei virioni è contenuta nel tratto respiratorio superiore, la trasmissione aerea è considerata la via principale. L'agente eziologico del vaiolo entra nell'ambiente esterno insieme a particelle di muco, saliva ed espettorato quando si tossisce, si starnutisce o si parla ad alta voce. Le persone che inalano aria contenente particelle dei fluidi biologici elencati si infettano.

Quando le goccioline con virioni vitali si seccano, si trasformano in nucleoli. Si disperdono facilmente con l'aiuto delle correnti d'aria. In questo modo l'agente patogeno entra facilmente nelle stanze vicine. Il funzionamento del sistema di riscaldamento e ventilazione contribuisce alla diffusione del contagio verso l’alto. In questo modo, nel secolo scorso, si sono verificati focolai della malattia in istituti medici a più piani, in cui persone infette venivano ricoverate in ospedale con una diagnosi errata.
La localizzazione dell'agente patogeno nelle cellule della pelle spiega la possibilità della sua esistenza a lungo termine al di fuori del corpo ospite. I virioni vitali si trovano sui vestiti di una persona malata e sugli oggetti che usa. Quando si smistano le cose, quando le si scuote, l'agente infettivo entra di nuovo nell'aria, si mescola con le particelle di polvere. In questo modo si forma un aerosol secondario che può portare a infezioni attraverso la polvere aerodispersa. La stragrande maggioranza delle persone non immuni è altamente suscettibile alle infezioni. Può essere diverso. Il 40% dei pazienti muore. Chi rimane in vita riceve un'immunità intensa, che dura dieci anni.
Diagnosi differenziale
Nelle fasi iniziali dello sviluppo, il vaiolo presenta una serie di sintomi simili ad altre malattie infettive. La diagnosi differenziale aiuta a fare una diagnosi accurata.

Ad esempio, durante il periodo prodromico, diventa possibile la comparsa di un'eruzione cutanea simile alla scarlattina e al morbillo. Con il vaiolo si verificano in determinati luoghi: il triangolo toracico e il triangolo di Simon (una sezione di pelle tra l'addome e le cosce, delimitata da linee che collegano gli assi iliaci anteriori con punti situati sulle articolazioni del ginocchio).
Con la varicella, le vescicole non compaiono sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi. Si formano sul corpo e hanno una struttura a camera singola (se forata con un ago, la bolla con contenuto sieroso viene completamente sgonfiata). L'infezione causata dal terzo ceppo di herpes è caratterizzata da polimorfismo.
Il vaiolo viene diagnosticato dai seguenti sintomi di supporto:
- esordio acuto;
- febbre a due ondate;
- dolore alla parte bassa della schiena e ai muscoli;
- rash prodromico (eruzione cutanea nel triangolo di Simon);
- formazione graduale di pustole;
- vescicole multiloculari;
- processo obbligatorio di suppurazione di elementi avventati;
- monomorfismo delle eruzioni cutanee.

La storia epidemiologica è di grande importanza: la malattia si diffonde rapidamente e provoca grandi e piccoli focolai. Se è necessario effettuare una diagnosi differenziale con dermatite tossicoallergica e sindrome di Steven-Johnson, vengono utilizzati test sierologici di laboratorio e microbiologia.
Metodi di trattamento
Se la diagnosi viene confermata, il paziente è soggetto a ricovero immediato per un periodo di quaranta giorni. Gli viene prescritto un regime pastello e una dieta delicata. Il trattamento viene effettuato in tre direzioni. Eseguito:
- etiotropico;
- patogenetico;
- terapia sintomatica.

Vengono utilizzate gammaglobuline specifiche e farmaci antivirali (Metisazon, Ribavirina). Per prevenire l'aggiunta di una componente batterica, gli antibiotici vengono somministrati fin dal primo giorno. Per effettuare l'intossicazione vengono utilizzate soluzioni glucosio-saline, agenti desensibilizzanti e viene eseguita la terapia vitaminica. Gli analgesici aiutano a combattere il dolore e i sonniferi vengono prescritti per normalizzare il sonno.
Parallelamente a ciò, viene effettuata l'elaborazione locale:
- per il cavo orale viene scelta una soluzione all'1% di bicarbonato di sodio (5-6 volte al giorno);
- per gli occhi si utilizza una soluzione al 20% di solfacile sodico (3-4 volte al giorno);
- per le palpebre soluzione di acido borico all'1%;
- per gli elementi di un'eruzione cutanea sul corpo, è più adatta una soluzione al 5% di permanganato di potassio (durante la formazione di croste, viene utilizzato un unguento al mentolo all'1% per ridurre il prurito).
Dopo il completamento del corso, con una prognosi favorevole, il paziente viene trasferito all'osservazione del dispensario.
Complicazioni
La complicanza più comune è lo shock tossico-infettivo. Un'infezione grave può portare allo sviluppo di ascesso, osteoartrite, encefalite, meningite e polmonite. La malattia porta spesso alla comparsa di cicatrici sulla cornea degli occhi.
Misure di prevenzione
La prevenzione globale del vaiolo ha permesso nel 1980 di dichiarare ufficialmente l'eradicazione dell'infezione sulla Terra. Ciò è stato fatto durante la trentatreesima sessione dell’OMS. Nel 1958, la delegazione dell’URSS propose che tutti i paesi sviluppati adottassero un programma per assistere nella vaccinazione della popolazione dei paesi poveri. Questa soluzione, come ha dimostrato la pratica, si è rivelata efficace: nel 1971 la malattia fu sconfitta in America Latina, nel 1975 nei paesi asiatici e nel 1977 in Africa.
I bambini di tre anni venivano vaccinati di routine, quindi la rivaccinazione veniva effettuata all'età di 8 e 16 anni. Una volta ogni cinque anni veniva vaccinato tutto il personale militare, i dipendenti dei trasporti internazionali, gli hotel specializzati nell'accoglienza di ospiti stranieri e i donatori di sangue. Tali misure hanno permesso di sconfiggere la malattia. Oggi solo le persone che lavorano con colture virali per scopi scientifici (assistenti di laboratorio, ricercatori) sono soggette a vaccinazione obbligatoria.
Fin dall’antichità il vaiolo è stato un flagello dell’umanità. Le sue descrizioni dettagliate sono state trovate nei più antichi monumenti scritti dell'India e della Cina. Devastanti pandemie di vaiolo si diffusero ripetutamente in tutto il mondo. Nel XVIII secolo L’Inghilterra e le sue colonie nel Nord America furono particolarmente colpite dal vaiolo. Dopo la pubblicazione della famosa opera di E. Jenner nel 1798, il suo metodo di vaccinazione contro il vaiolo iniziò ad essere ampiamente utilizzato in tutto il mondo. Le epidemie di vaiolo venivano registrate sempre meno spesso e la malattia era più lieve. Eppure, focolai di infezione persistevano in molte regioni del mondo: in Sud America, Sud-Est asiatico e Africa.
Nel 1967 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) adottò a Ginevra un programma per debellare completamente il vaiolo in tutto il mondo. L’attuazione delle misure di vaccinazione di massa e di quarantena ha portato ad una graduale diminuzione dell’incidenza. Nel maggio 1980 l'OMS annunciò la completa eliminazione di questa infezione particolarmente pericolosa. Da allora sono stati segnalati solo pochi decessi dovuti al vaiolo. Erano associati alla contaminazione del laboratorio dei ricercatori o erano il risultato di complicazioni dopo la vaccinazione. Da allora la vaccinazione contro il vaiolo è diventata facoltativa.
Epidemiologia.
Il vaiolo colpisce solo le persone; l’infezione sperimentale sugli animali da laboratorio è difficile. L'agente eziologico del vaiolo è un virus filtrabile, antigenicamente correlato al vaccinia, il virus del vaiolo bovino, la cui struttura fine e i modelli di riproduzione sono stati ben studiati. Il periodo di incubazione del vaiolo dura da 8 a 14 giorni, solitamente ca. 11-12. I pazienti sono contagiosi durante l'intero periodo dell'eruzione cutanea e, a quanto pare, anche diversi giorni prima della comparsa dell'eruzione cutanea, per un totale di circa tre settimane. Il virus viene rilasciato dalle vescicole che scoppiano e si seccano sulla pelle, dalla cavità orale e si trova nelle urine e nelle feci del paziente. L'agente infettivo viene trasmesso attraverso il contatto diretto, tramite goccioline trasportate dall'aria, da portatori sani e animali, e può rimanere vitale su indumenti e biancheria da letto. Tutte le persone non vaccinate sono suscettibili all’infezione; Non esiste un’immunità naturale al vaiolo. Sebbene la malattia possa manifestarsi a qualsiasi età, i bambini sotto i quattro anni sono particolarmente vulnerabili.
Quadro clinico.
Il periodo iniziale della malattia è per molti aspetti simile al quadro clinico dell'influenza: è caratterizzato da un rapido aumento della temperatura, mal di testa, dolori muscolari e lombari, brividi e spesso vomito. È difficile fare una diagnosi di vaiolo finché l'eruzione cutanea non appare al quarto giorno di malattia. Un'eruzione cutanea abbondante sulla testa e sugli arti inizialmente appare come macchie rosa, che si trasformano rapidamente in vescicole (vescicole) piene di liquido trasparente e poi di pus, simili a molteplici foruncoli. Le vesciche si aprono e, una volta asciutte, diventano croccanti, scomparendo gradualmente entro tre settimane, nei casi più gravi lasciando segni permanenti: butterati. A seconda della gravità dei sintomi clinici, la malattia varia dalle forme più gravi di vaiolo emorragico, o “nero”, con pustole drenanti piene di sangue e pus e grave tossicosi generale, a forme lievi (varioloide) senza eruzioni cutanee e talvolta anche senza febbre. Un decorso più lieve si verifica soprattutto nelle persone vaccinate contro il vaiolo in un lontano passato.
Trattamento.
I farmaci chemioterapici specifici per il trattamento del vaiolo non sono stati sufficientemente sviluppati. Si raccomandano riposo a letto, nutrizione liquida nutriente, impacchi di ghiaccio e sedativi. Per l'igiene delle aree cutanee colpite da eruzioni cutanee vengono utilizzati lavaggi antisettici, lozioni e polveri. Per prevenire infezioni secondarie vengono utilizzati farmaci sulfamidici o penicillina.
Prevenzione.
L'isolamento del paziente in una stanza separata è assolutamente obbligatorio. Tutte le persone in contatto con il paziente vengono sottoposte ad esame di quarantena e vaccinate. Questa misura, adottata entro i primi tre giorni dal contatto con il paziente, previene lo sviluppo di forme gravi della malattia.
Si tratta di una malattia infettiva umana, classificata come infezione particolarmente pericolosa, causata dal virus Orthopoxvirus variola, caratterizzata da febbre, intossicazione ed eruzioni cutanee specifiche sulla pelle e sulle mucose. La diffusione del vaiolo avviene tramite aerosol e l'agente patogeno è così stabile nell'aria che può causare l'infezione di persone non solo nella stessa stanza con il paziente, ma anche nelle stanze vicine. A metà degli anni '70 del XX secolo, la completa eliminazione del vaiolo nei paesi sviluppati portò all'abolizione della vaccinazione preventiva contro questa malattia.
informazioni generali
Si tratta di una malattia infettiva umana, classificata come infezione particolarmente pericolosa, causata dal virus Orthopoxvirus variola, caratterizzata da febbre, intossicazione ed eruzioni cutanee specifiche sulla pelle e sulle mucose.
Caratteristiche dell'agente patogeno
Il virus Orthopoxvirus variola fa parte del gruppo dei virus del vaiolo animale e umano, è stabile nell'ambiente, tollera facilmente le basse temperature e l'essiccazione e può rimanere vitale se congelato per diversi anni. A temperatura ambiente persiste nelle croste di vaiolo fino a un anno, nell'espettorato e nel muco fino a tre mesi. Se riscaldato a 100° C, il virus essiccato muore solo dopo 5-10 minuti.
Il serbatoio e la fonte del vaiolo è una persona malata. Il virus viene rilasciato durante l'intero periodo dell'eruzione cutanea; i pazienti sono particolarmente contagiosi nei primi 8-10 giorni. Non si osserva un portatore asintomatico e convalescente e la cronicità non è tipica. La localizzazione predominante dell'agente patogeno nel corpo umano sono le mucose della bocca, del naso, della faringe e del tratto respiratorio superiore; l'escrezione avviene attraverso la tosse, gli starnuti e durante la respirazione. La pelle può anche fungere da sito per il rilascio di agenti patogeni.
Il vaiolo viene trasmesso attraverso il meccanismo dell'aerosol principalmente attraverso goccioline e polvere sospese nell'aria. Un aerosol contenente un agente patogeno può viaggiare con la corrente d'aria per una distanza considerevole, colpendo le persone che si trovano nella stessa stanza del paziente e penetrando nelle stanze vicine. Il vaiolo tende a diffondersi in condomini a più piani, istituzioni mediche e gruppi affollati.
La sensibilità naturale umana è alta. Gli individui non immunizzati si infettano nella stragrande maggioranza dei casi; la percentuale di individui immuni non supera i 12 su 100 non vaccinati (in media 5-7%). Dopo essere sopravvissuti alla malattia, si forma un'immunità stabile a lungo termine (più di 10 anni).
Sintomi del vaiolo
Il periodo di incubazione del vaiolo è solitamente di 9-14 giorni, ma può aumentare fino a 22 giorni. Ci sono periodi della malattia: prodromico (o periodo dei precursori), eruzioni cutanee, suppurazione e convalescenza. Il periodo prodromico dura da due a quattro giorni, compaiono febbre, sintomi di intossicazione (mal di testa, brividi, debolezza, dolori muscolari, parte bassa della schiena). Allo stesso tempo, sulle cosce e sul petto può comparire un'eruzione cutanea simile a un esantema da morbillo o scarlattina.
Entro la fine del periodo prodromico, la febbre solitamente diminuisce. Il 4-5 giorno appare un'eruzione cutanea da vaiolo (il periodo dell'eruzione cutanea), inizialmente rappresentando una piccola roseola, che progredisce in papule e dopo 2-3 giorni in vescicole. Le vescicole hanno l'aspetto di piccole vescicole multicamera, circondate da pelle iperemica e con una piccola depressione ombelicale al centro. L'eruzione cutanea è localizzata sul viso, sul busto, sugli arti, esclusi i palmi delle mani e le piante dei piedi; a differenza della varicella, gli elementi dell'eruzione cutanea in una zona sono monomorfi. Con il progredire dell'eruzione cutanea, la febbre e l'intossicazione aumentano nuovamente.
Verso la fine della prima settimana di malattia, all'inizio della seconda, inizia un periodo di suppurazione: la temperatura aumenta bruscamente, la condizione peggiora e gli elementi eruttivi suppurano. I butteri perdono la loro natura multicamerale, si fondono in un'unica pustola purulenta e diventano dolorosi. Una settimana dopo, le pustole si aprono formando croste necrotiche nere. La pelle inizia a prudere molto. A 20-30 giorni inizia il periodo di convalescenza. La temperatura corporea del paziente si normalizza gradualmente dopo 4-5 settimane di malattia, i segni del vaiolo guariscono, lasciando dietro di sé una desquamazione pronunciata e, successivamente, cicatrici, a volte molto profonde.
Esistono forme cliniche gravi di vaiolo: papuloso-emorragico (vaiolo nero), confluente e porpora vaiolo. Il decorso moderato è vaiolo sparso, il decorso lieve è vaiolo senza eruzione cutanea e febbre: varioloide. Il vaiolo di solito si manifesta in questa forma negli individui vaccinati. Caratterizzata da rare eruzioni cutanee che non lasciano cicatrici, non sono presenti sintomi di intossicazione.
Complicazioni del vaiolo
Molto spesso, il vaiolo è complicato da shock tossico-infettivo. Si notano complicazioni infiammatorie del sistema nervoso: mielite, encefalite, neurite. Esiste la possibilità di infezione secondaria e lo sviluppo di complicanze purulente: ascessi, cellulite, linfoadenite, polmonite e pleurite, otite, osteomielite. Può svilupparsi sepsi. Dopo aver sofferto di vaiolo, potrebbero esserci conseguenze sotto forma di cecità o sordità.
Diagnosi e trattamento del vaiolo
La diagnosi di vaiolo viene effettuata mediante esame virusoscopico utilizzando un microscopio elettronico, nonché metodi virologici e sierologici: microprecipitazione in agar, ELISA. Lo scarico di pustole e croste di vaiolo è soggetto ad esame. A partire da 5-8 giorni dalla malattia è possibile determinare anticorpi specifici utilizzando RN, RSK, RTGA, ELISA.
Il trattamento del vaiolo consiste nella prescrizione di farmaci antivirali (metisazone) e nella somministrazione di immunoglobuline. La pelle colpita da eruzioni cutanee da vaiolo viene trattata con agenti antisettici. Inoltre (a causa della natura purulenta dell'infezione), viene prescritta una terapia antibiotica: vengono utilizzati antibiotici dei gruppi di penicilline semisintetiche, macrolidi e cefalosporine. La terapia sintomatica consiste nella disintossicazione attiva mediante infusione endovenosa di soluzioni di glucosio, soluzioni di sale marino. Talvolta nella terapia sono inclusi i glucocorticoidi.
Previsione e prevenzione del vaiolo
La prognosi dipende dalla gravità del decorso e dalle condizioni del corpo del paziente. Gli individui vaccinati di solito manifestano forme lievi di vaiolo. Il vaiolo grave con una componente emorragica può provocare la morte.
Attualmente viene effettuata una prevenzione specifica del vaiolo per impedirne l'importazione da regioni epidemiche pericolose. L’eradicazione del vaiolo nei paesi sviluppati è stata ottenuta attraverso la vaccinazione di massa e la rivaccinazione della popolazione nel corso di diverse generazioni; attualmente, la vaccinazione universale pianificata è impraticabile. Se viene identificato un paziente affetto da vaiolo, viene isolato e vengono adottate misure di quarantena anche per tutti coloro che hanno avuto contatti con il paziente. La fonte dell'infezione viene accuratamente disinfettata, le persone a contatto vengono vaccinate entro i primi tre giorni dal momento del contatto.
Il vaiolo è una malattia infettiva particolarmente pericolosa. È conosciuto fin dall'antichità. In passato, le epidemie di vaiolo hanno causato molte vittime. Solo nella parte europea del continente si ammalano ogni anno circa 10 milioni di persone. Allo stesso tempo, il tasso di mortalità ha raggiunto il 40% (e talvolta l'80%).
Grazie alla vaccinazione di massa nel 20° secolo, il vaiolo è stato debellato. La popolazione non è stata vaccinata contro di essa da molto tempo, ma ai nostri tempi rimane la cautela riguardo a questa malattia. Esistono malattie virali che sono geneticamente molto vicine a questa infezione.
L'agente eziologico della malattia e le vie di infezione
Ecco come appare il virus che causa il vaiolo. Ora questa malattia non si verifica, ma è ancora considerata un'infezione particolarmente pericolosa.Il vaiolo è causato dal più grande virus conosciuto, chiamato Poxvirus variolae major. Il suo genoma è rappresentato da una molecola di DNA a doppio filamento. Questo microrganismo è molto stabile nell'ambiente esterno.
La fonte dell'infezione è una persona malata che diventa contagiosa diversi giorni prima che compaiano i primi sintomi e continua a diffondere il virus finché le croste non cadono. La suscettibilità al vaiolo tra la popolazione è elevata indipendentemente dall’età. L'infezione di individui sani può verificarsi:
- da goccioline trasportate dall'aria;
- a diretto contatto con il paziente o con i suoi effetti personali e oggetti domestici comuni.
L'agente infettivo entra nel corpo umano attraverso le vie respiratorie e, meno comunemente, attraverso la pelle.
- La sua riproduzione primaria avviene nel sistema linfatico, da dove il virus entra facilmente nel sangue e si diffonde in tutte le direzioni, colpendo principalmente le cellule epiteliali. Questo processo è accompagnato da reazioni tossiche e febbre (prima ondata).
- Sulla pelle appare un'eruzione vescicante, che si infetta rapidamente e diventa purulenta, provocando una seconda ondata di aumento della temperatura corporea e un'intossicazione ancora più pronunciata. È in questo momento che aumenta il rischio di morte per shock tossico, complicanze purulente (sepsi) o sindrome tromboemorragica.
Dopo l'infezione si forma una forte immunità che rimane per tutta la vita.
Manifestazioni cliniche
Dal momento in cui il virus entra nel corpo umano fino alla comparsa dei primi sintomi patologici, passano dai 5 ai 24 giorni. La malattia inizia in modo acuto e ha un quadro clinico caratteristico, le cui principali manifestazioni sono:
- febbre (la temperatura corporea sale a 40 gradi e oltre; ha un decorso ondulatorio, la prima ondata si osserva all'inizio della malattia, la seconda - durante il periodo dell'eruzione cutanea);
- brividi;
- eruzione cutanea prodromica (diventa evidente nei primi giorni della malattia e scompare rapidamente);
- vera eruzione cutanea da vaiolo (compare il 4-5o giorno della malattia dopo un periodo di immaginario miglioramento delle condizioni del paziente; colpisce la pelle del viso, del busto, degli arti e delle mucose; all'inizio sembra vescicole con contenuto sieroso, ma si infettano rapidamente e diventano purulente; le pustole si aprono a 15-17 giorni e si ricoprono di croste, che cadono dopo pochi giorni, lasciando ruvide cicatrici).
La condizione generale dei pazienti durante il periodo acuto dell'infezione è grave. Ciò è particolarmente evidente durante il periodo di infezione da vaiolo, che è accompagnato da febbre alta, disturbi della coscienza e tachicardia. Dopo l'apertura degli elementi purulenti dell'eruzione cutanea, si verifica un miglioramento e vengono avviati processi di ripristino nel corpo.
In alcuni pazienti, il vaiolo ha un decorso ancora più grave. Si osserva nella forma confluente ed emorragica della malattia:
- Il primo è caratterizzato da grave intossicazione e dalla presenza di un'eruzione cutanea abbondante, che scompare durante il periodo di suppurazione. In questo caso compaiono emorragie sulla pelle e sanguinamento in varie sedi. Ma la morte può verificarsi anche prima della comparsa dell'eruzione cutanea con lo sviluppo di shock tossico.
- La forma emorragica del vaiolo si manifesta con un aumento del sanguinamento e con l'inzuppamento di pustole nel sangue.
Se il corpo ha un'immunità parziale, la malattia ha un decorso lieve con febbre a breve termine ed elementi isolati di un'eruzione cutanea che non si manifesta o senza di essi.
Principi di diagnosi e trattamento
 La malattia è stata debellata grazie alla vaccinazione di massa.
La malattia è stata debellata grazie alla vaccinazione di massa. La diagnosi di vaiolo viene stabilita tenendo conto delle manifestazioni cliniche e dei dati epidemiologici (contatto con un paziente o lavoro in laboratorio con materiale contenente il virus).
- È confermato dal rilevamento dell'agente patogeno negli strisci di elementi dell'eruzione cutanea mediante microscopia elettronica o anticorpi fluorescenti.
- È possibile rilevare frammenti di DNA del virus.
Il trattamento di tali pazienti viene effettuato in un ospedale con isolamento obbligatorio e rispetto del regime epidemico. Include:
- somministrazione di immunoglobuline anti-vaiolo;
- prescrizione di farmaci antibatterici ad ampio spettro;
- terapia di disintossicazione.
Quale medico devo contattare?
Il vaiolo è un'infezione particolarmente pericolosa e richiede non solo il trattamento da parte di uno specialista in malattie infettive, ma anche il monitoraggio dei contatti, la quarantena, la sanificazione e la disinfezione. Se si sospetta il vaiolo, i medici devono segnalarlo al Roszdravnadzor o strutture simili.
Conclusione
La prognosi per il vaiolo è grave con un'alta probabilità di esito sfavorevole. La malattia può diffondersi rapidamente, causando epidemie. Pertanto, anche i casi isolati di vaiolo possono essere pericolosi.
Ci sono molte malattie gravi nel mondo che possono essere trasmesse rapidamente, essendo le più pericolose. Tali malattie includono il vaiolo, che infetta solo gli esseri umani. Anche se il paziente si libera della sindrome, potrebbero comunque manifestarsi effetti collaterali: molto spesso si tratta di cicatrici che compaiono nel sito della lesione. Inoltre, può verificarsi una perdita parziale o completa della vista. Per evitare tali conseguenze, è necessario conoscere le principali vie di infezione, le cause e i sintomi della malattia per cercare aiuto medico in tempo. Ciò è dovuto al fatto che alcune persone confondono il vaiolo con la varicella, il che è più semplice.
Definizione
Il vaiolo nero, o come viene anche chiamato vaiolo naturale, è una grave malattia antroponotica acuta altamente contagiosa. Si trasmette da persona a persona attraverso goccioline trasportate dall'aria. In questo caso, il paziente sviluppa uno stato febbrile, presenta forti eruzioni cutanee e il corpo diventa intossicato. Solo il corpo umano è suscettibile alla malattia, anche se i ricercatori hanno provato sperimentalmente a infettare gli animali.
L'agente eziologico è un virus simile al vaiolo bovino. Il periodo di incubazione del virus Variola dura 8-14 giorni, con una media di circa 11 giorni. In questo caso il paziente può essere contagioso 3-5 giorni prima della comparsa dell'eruzione cutanea, di conseguenza la malattia dura circa tre settimane. I microrganismi dannosi compaiono dalle vescicole scoppiate sulla pelle del paziente, vengono trasmessi da goccioline trasportate dall'aria dalla cavità orale e si trovano nelle urine e nelle feci.

Il virus può rimanere a lungo sugli abiti e sugli oggetti personali del paziente. La malattia è così grave che il sistema immunitario del paziente non può farcela. La malattia può manifestarsi a qualsiasi età, ma l’infanzia rimane la più vulnerabile.
Il periodo più pericoloso è la prima settimana della malattia, quando il portatore del vaiolo ha il maggior numero di batteri virali nella sua saliva. Quando le vesciche scoppiano, si seccano e al loro posto si formano cicatrici, il paziente rimane comunque contagioso perché il virus del vaiolo non scompare completamente.
Qual è la differenza tra vaiolo nero e varicella?
Spesso, quando appare un'eruzione cutanea, i pazienti non sanno che tipo di malattia hanno: naturale o naturale. Esiste un certo numero di segni in base ai quali è possibile determinare quale tipo di vaiolo ha un paziente. Il primo indicatore è la localizzazione dell'eruzione cutanea. Il tipo varicella è caratterizzato da un'eruzione cutanea sui palmi e sulle piante dei piedi, mentre il vaiolo è caratterizzato da un'eruzione cutanea sulla pelle di tutto il corpo e sulla mucosa.
L'indicatore successivo sono i sintomi. Il vaiolo è caratterizzato da una temperatura elevata fino a 40 gradi o più, con forte dolore nella zona sacrale e le eruzioni cutanee possono comparire molto prima rispetto ad altri segni della malattia. Nel caso della varicella, la temperatura corporea raggiunge i 39 gradi e può aumentare quando sul paziente appare una nuova eruzione cutanea. Inoltre, con la varicella non ci sono eruzioni cutanee sulla mucosa, cosa che, al contrario, si osserva con il vaiolo.
Tipi di malattia
 La comparsa del vaiolo è caratterizzata dalla presenza di due ceppi del virus, quindi si distinguono due tipi, tra i quali esistono differenze:
La comparsa del vaiolo è caratterizzata dalla presenza di due ceppi del virus, quindi si distinguono due tipi, tra i quali esistono differenze:
- Variola maggiore. Questo tipo di vaiolo è caratterizzato da alti tassi di mortalità, perché è il tipo più pericoloso ed è difficile da curare. Come risultato della riproduzione e dell'esposizione al virus del vaiolo, iniziano gravi emorragie interne e possono comparire ulcere. Questo tipo ha una sua particolarità: se il paziente sopravvive, sviluppa l'immunità alla malattia, sebbene il corpo rimanga coperto di cicatrici per tutta la vita.
- Variola minore. L'agente eziologico del vaiolo è un virus apparso a causa del basso tenore di vita degli abitanti dei paesi del sud. La malattia ha un basso tasso di mortalità e si presenta in una forma abbastanza lieve. In questo caso non compaiono eruzioni cutanee purulente e lo stato febbrile non dura a lungo. A differenza del primo tipo, questo tipo di malattia non causa complicazioni.
Vie di infezione
Il virus del vaiolo può essere trasmesso solo da un paziente infetto. Nella maggior parte dei casi, la malattia viene trasmessa da goccioline trasportate dall'aria o polvere-aria. Inoltre, l'agente eziologico del vaiolo può essere trasmesso attraverso l'uso di oggetti infetti che cadono nelle mani di una persona sana.
Il metodo di infezione della polvere aerodispersa è caratterizzato dall'ingresso nelle aree respiratorie di una persona sana di piccole parti di croste purulente essiccate e secrezioni di muco. Dopo un po’, tali particelle si trasformano in polvere e volano nell’aria, infettando gli altri mentre cambiano la biancheria intima del paziente.
Il raggio di diffusione della polvere contaminata può raggiungere gli 800 metri.
Se oggetti infetti contenenti sangue o secrezioni purulente del paziente cadono nelle mani di una persona sana, si verificherà il processo di infezione da vaiolo se sulla pelle sono presenti tagli, ferite, ecc.
Esiste una versione in cui le mosche che hanno un contatto diretto con la pelle infetta fungono da portatori del virus del vaiolo. Nonostante non siano in grado di infettarsi, gli insetti possono diffondere particelle di pus ad altri.
Sintomi
 Fasi di sviluppo del vaiolo.
Fasi di sviluppo del vaiolo. Una malattia come il vaiolo attraversa 4 fasi nel suo decorso:
- Insorgenza della malattia. Questo periodo dura al massimo 4 giorni. All'inizio della malattia, la temperatura può salire fino a 40 gradi, il paziente inizia ad avvertire mal di testa, dolori muscolari e vomito. Spesso il dolore del paziente si sposta nell'area del sacro e del coccige. In questo caso, nei primi 2 giorni, può comparire un'eruzione cutanea, non accompagnata da altri sintomi.
- Eruzioni cutanee. L'eruzione cutanea da vaiolo può colpire l'interno delle cosce, il basso addome, i muscoli pettorali e l'area delle scapole. Il paziente può avere allucinazioni, soprattutto nei bambini. Nei giorni successivi l'eruzione cutanea si addensa, la temperatura scende, ma l'eruzione cutanea colpisce le mucose del paziente. Tali eruzioni cutanee scoppiano nel tempo e al loro posto compaiono ulcere.
- Suppurazione dell'eruzione cutanea. Durante questo periodo, le aree infette si gonfiano notevolmente, la temperatura corporea raggiunge nuovamente i 40 gradi, sono possibili la comparsa di tachicardia e una diminuzione della pressione sanguigna. Dalla bocca del paziente si avvertono odori sgradevoli e il fegato e la milza si ingrossano. In questa fase, il paziente perde conoscenza, riappaiono le allucinazioni e si verificano stati convulsivi. Questo periodo può durare fino a 7 giorni.
- La fase successiva è caratterizzata dall'essiccazione e dalla caduta delle croste. Tuttavia, da alcune ferite possono ancora fuoriuscire secrezioni purulente, che si trasformano in croste. Successivamente, i pazienti spesso soffrono di forte prurito. Dopo circa una settimana, le croste iniziano a cadere e al loro posto compaiono cicatrici.
Spesso nei pazienti il processo di suppurazione della ferita non finisce. Questo, a sua volta, porta alla morte.
Diagnostica
Il complesso diagnostico comprende diversi tipi di esame. Per studiare la malattia in dettaglio, al paziente vengono prelevate croste e strisci del contenuto della ferita, sangue e muco. Il batterio del virus del vaiolo nero viene determinato utilizzando un microscopio elettronico e PCR.