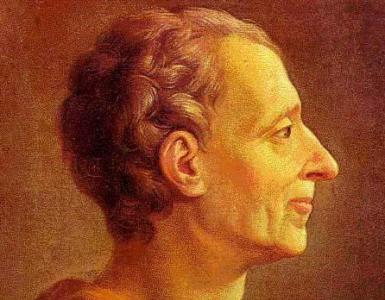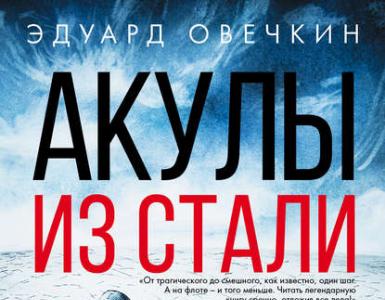Cultura antica. Un uomo dell'antichità. Cos'è la società antica? Vita e cultura nella società antica
1. Cultura antica. Un uomo dell'antichità.Antichità
L'antica cultura del Mediterraneo è considerata una delle creazioni più importanti dell'umanità. Limitata nello spazio (principalmente la costa e le isole dell'Egeo e dello Ionio) e nel tempo (dal II millennio a.C. ai primi secoli del cristianesimo), la cultura antica ha ampliato i confini dell'esistenza storica, affermandosi di diritto con il significato universale dell'architettura e scultura, poesia epica e drammaturgia, scienze naturali e sapere filosofico.
Le antiche civiltà greca e romana occupavano territori geograficamente vicini l'uno all'altro ed esistevano quasi contemporaneamente, quindi non sorprende che siano strettamente imparentati tra loro. Entrambe le civiltà avevano culture diverse che si sviluppavano interagendo tra loro.
L'antichità ha mostrato al mondo varie forme di organizzazione della società umana: politica e sociale. La democrazia è nata nell’antica Grecia, aprendo enormi possibilità umanistiche per la libera espressione di cittadini a pieno titolo, la combinazione di libertà e azione politica organizzata. Roma ha fornito esempi di un sistema repubblicano ben consolidato di vita e di governo, e poi di un impero - non solo come stato, ma come una forma speciale di convivenza di molti popoli con un ruolo speciale per il governo centrale, come stato di "pacificazione" ” di molte tribù, lingue, religioni e terre. Roma ha rivelato al mondo il ruolo più importante del diritto e della regolamentazione di tutti i tipi di rapporti umani e ha mostrato che senza un diritto perfetto non può esistere una società normalmente esistente, che il diritto deve garantire i diritti dei cittadini e delle persone, e il compito di lo Stato deve vigilare sul rispetto della legge.
L'antichità ha trasmesso alle epoche successive la massima "l'uomo è la misura di tutte le cose" e ha mostrato quali vette può raggiungere una persona libera nell'arte, nella conoscenza, nella politica, nella costruzione dello stato e, infine, nella cosa più importante: nella conoscenza di sé e nella conoscenza di sé. miglioramento. Le bellissime statue greche divennero lo standard di bellezza del corpo umano, la filosofia greca divenne un esempio della bellezza del pensiero umano e le migliori azioni degli eroi romani divennero esempi della bellezza del servizio civile e della creazione dello stato.
Nel mondo antico fu compiuto un grandioso tentativo di unire l'Occidente e l'Oriente in un'unica civiltà, per superare la disunità dei popoli e delle tradizioni in una grande sintesi culturale, che rivelò quanto sia fruttuosa l'interazione e la compenetrazione delle culture. Uno dei risultati di questa sintesi fu l'emergere del cristianesimo, che nacque come religione di una piccola comunità alla periferia del mondo romano e si trasformò gradualmente in una religione mondiale.
Arte
Il senso dell’uomo come libero cittadino (un “essere politico”), senza precedenti nella storia, si è riflesso nella cultura artistica e nell’arte, e ha determinato la loro straordinaria ascesa e fioritura. Le conquiste degli antichi greci e romani sono così grandiose che l'intera storia dell'arte mondiale è impensabile senza soggetti antichi, mitologia greca e romana, canoni e campioni antichi.
L'arte antica (V-IV secolo a.C.) è giustamente definita classica, poiché era un modello nell'incarnazione della bellezza perfetta, dove la virtù dell'anima, la forza della mente, è completamente fusa con la bellezza del corpo . Ciò potrebbe essere espresso nel modo più completo nella scultura. Plutarco ha attirato l'attenzione sull'importanza della scultura nella vita dei Greci, notando che ad Atene c'erano più statue che persone viventi.
La scultura greca raggiunse la sua perfezione nell'opera del grande Fidia, che creò molte bellissime creazioni, tra cui spiccava la famosa statua di Zeus Olimpio, realizzata in avorio e oro. La maestosa statua di 14 metri di un formidabile dio seduto su un trono era l'incarnazione della saggezza e della filantropia. Era considerata una delle sette “meraviglie del mondo” ed è conosciuta solo attraverso descrizioni e immagini su monete antiche.
Tra gli altri scultori che glorificarono l'arte antica, si dovrebbero citare: Prassitele, che fu il primo nella storia a raffigurare Afrodite sotto forma di una bellissima donna nuda (Afrodite di Cnido); Lisippo, che lasciò ai suoi discendenti un bellissimo ritratto di Alessandro Magno (conservato anche in copia romana); Leochares, autore del leggendario Apollo Belvedere.
Architettura
Insieme alla scultura, l'architettura antica raggiunse il suo massimo splendore, molti monumenti dei quali, fortunatamente, sono sopravvissuti fino ad oggi. Il Grande Partenone e le rovine del Colosseo impressionano ancora oggi per la loro bellezza e imponenza.
Il principio fondamentale di opportunità, chiarezza e coraggio del pensiero ingegneristico ha permesso di soddisfare sia le esigenze quotidiane di una vasta popolazione sia il sofisticato gusto estetico degli aristocratici (le loro ville con parchi e palazzi avevano prezzi favolosi). Le tradizioni etrusche in architettura e l'invenzione del cemento permisero ai romani di passare dai semplici soffitti a travi ad archi, volte e cupole.
I romani passarono alla storia come costruttori eccezionali. Costruirono strutture monumentali, anche le cui rovine stupiscono ancora l'immaginazione. Questi includono anfiteatri, circhi, stadi, terme (bagni pubblici), palazzi di imperatori e nobili. A Roma costruirono condomini - insula - con 3-6, e talvolta anche 8 piani.
I templi romani, con la loro forma rettangolare e portici, somigliavano a quelli greci, ma a differenza di questi ultimi erano eretti su alte piattaforme con scale (podi). Nell'architettura del tempio romano veniva utilizzato il tipo di rotonda, cioè un tempio rotondo. Questo era uno dei templi più antichi: il Tempio di Vesta. Il risultato più significativo della tecnologia costruttiva romana fu il tempio di tutti gli dei: il Pantheon a Roma. La cupola del Pantheon con un diametro di 43 m era considerata la più grande del mondo.
Indubbiamente, l'edificio romano più grandioso è la costruzione dell'anfiteatro: il Colosseo, che era un'ellisse con una circonferenza di 524 metri, il muro del Colosseo era alto 50 metri ed era costituito da tre livelli.
Già nel II secolo. AVANTI CRISTO e. I costruttori romani inventarono il cemento, che contribuì alla diffusione delle strutture a volta ad arco, che divennero un elemento caratteristico dell'architettura romana, come gli archi di trionfo - monumenti di gloria militare e imperiale. Un certo numero di archi - portici furono utilizzati nella costruzione di ponti in pietra a più livelli, all'interno dei quali c'erano tubi che fornivano acqua alla città. Le fondamenta del Colosseo (I secolo) con una profondità di 5 m furono costruite in cemento, così come le fortezze, i ponti, gli acquedotti, i moli portuali e le strade.
Teatro
Tra i vari divertimenti tanto amati nell'antichità, il teatro occupava un posto particolarmente importante nella vita degli antichi greci e romani: svolgeva varie funzioni, tra cui morali ed etiche, educative e umanistiche. Ad Atene nel V secolo. AVANTI CRISTO AC, che divenne il centro della creatività letteraria e poetica, fiorirono la tragedia e la commedia . La tragedia - una traduzione diretta di "canto delle capre" - nasce da un canto corale cantato da satiri vestiti di pelli di capra e raffiguranti i compagni costanti del dio del vino Dioniso. Divenne una forma ufficiale di creatività quando ad Atene fu approvata la festa nazionale del Grande Dionisio.
Le più popolari furono le tragedie dei tre più grandi drammaturghi ateniesi: Eschilo, Sofocle ed Euripide. Ognuno di loro ha risolto i problemi del bene e del male, del destino e della punizione, della gioia e della compassione a modo suo. Aristotele nella sua Poetica, definendo la tragedia, dice che essa “attraverso la compassione e la paura purifica tali passioni” e provoca la catarsi (purificazione).
Il fiorire di un altro genere - la commedia - è associato al nome di Aristotele. Le trame delle commedie furono tratte dall'allora vita politica di Atene, a differenza delle tragedie, le cui trame erano basate sul passato mitologico. Le immagini artistiche create da famosi drammaturghi si distinguono per la profondità delle loro caratteristiche psicologiche e per secoli hanno emozionato molte generazioni di spettatori. Prometeo, Edipo, Medea, Fedra personificano il passato leggendario dei secoli antichi.
Letteratura
Lo sviluppo della letteratura antica, nata dal folklore e dalle leggende eroiche del passato, è strettamente connesso con il teatro antico. Il periodo scritto della letteratura greca antica inizia con i poemi di Omero e continua nell'epopea didattica di Esiodo (Teogonia, Opere e Giorni). Uno dei migliori parolieri romani fu Catullo, che dedicò molte poesie sull'amore alla famosa bellezza Clodia. Tuttavia, l '"età dell'oro" per la poesia romana fu il regno di Ottaviano Augusto (27 a.C. - 14 d.C.). Nell'"età augustea" vissero e operarono i tre poeti romani più famosi: Virgilio, Orazio, Ovidio. L'Eneide incompiuta di Virgilio glorificava la grandezza di Roma e lo spirito romano. Orazio apprezzava molto l'obiettivo del poeta, espresso nel suo famoso "Monumento", imitato da molti poeti, tra cui A. S. Pushkin. L'indubbio apice della poesia d'amore romana è l'opera di Ovidio, che è stata incarnata in opere famose come le poesie "Metamorfosi", "La scienza dell'amore", ecc.
Il tutore di Nerone, il famoso filosofo Seneca, diede un contributo significativo allo sviluppo del genere tragico. È stata questa antica tragedia che i drammaturghi moderni hanno scelto come modello. Le tragedie di Seneca sono scritte nello spirito del "nuovo stile": monologhi patetici prolungati, metafore e confronti ingombranti sono destinati più al lettore che allo spettatore.
Olimpiadi
L'espressione più sorprendente dell'antico agone furono i famosi Giochi Olimpici , che la Grecia ha donato al mondo. Le origini delle prime Olimpiadi si perdono nell'antichità, ma nel 776 a.C. e. Era la prima volta che il nome del vincitore della gara veniva scritto su una tavoletta di marmo, e quest'anno è considerato l'inizio del periodo storico dei Giochi Olimpici. Il luogo dei festeggiamenti olimpici era il bosco sacro di Altis. Il posto è stato scelto molto bene. Tutti gli edifici, sia primi che successivi - templi, tesorerie, uno stadio, un ippodromo - furono eretti in una valle pianeggiante incorniciata da morbide colline ricoperte di fitta vegetazione. La natura di Olimpia sembra essere intrisa dello spirito di pace e prosperità instaurato durante i Giochi Olimpici. Migliaia di spettatori si accampano nel bosco sacro. Ma la gente è venuta qui non solo per il bene delle competizioni, qui sono stati conclusi accordi commerciali, poeti, oratori e scienziati si sono rivolti al pubblico con i loro nuovi discorsi e opere, artisti e scultori hanno presentato ai presenti i loro dipinti e sculture. Lo stato aveva il diritto di annunciare qui nuove leggi, trattati e altri documenti importanti. Una volta ogni quattro anni si teneva una vacanza, simile a quella che l'antichità non conosceva: una festa di comunicazione spirituale tra le migliori menti e i talenti più brillanti della Grecia.
2. La formazione della cultura ucraina.
L'influenza delle culture vicine sulla cultura dell'Ucraina
Sin dai tempi antichi, lo spazio culturale dell’Ucraina ha risentito dell’influenza delle vicine integrazioni pre-statali e statali. Le terre slave furono soggette a continui attacchi da parte delle tribù nomadi: Avari, Pecheneg, Khazari, Polovtsiani. Nel IX secolo, varie tribù divennero dipendenti da Kievan Rus. Comunicando con gli slavi, erano esposti alle reciproche influenze culturali e spesso si assimilavano alla popolazione locale.
Nei secoli IX-X. L'influenza di Bisanzio e dei paesi del “circolo bizantino” fu significativa. Cronache già antiche, cronache e altre fonti testimoniano i contatti dinastici e spirituali di Kievan Rus e con i suoi vicini stati europei. La fusione delle tradizioni bizantine e occidentali con il patrimonio culturale di Kiev divenne la base per la formazione di un'identità culturale ucraina unica.
Nel XIII secolo, la minaccia per lo stato di Kiev fu rappresentata dai conquistatori mongolo-tartari (dal 1239), i cavalieri-crociati tedeschi, che nel 1237 formarono un potente stato unendo gli ordini livoniano e teutonico, l'Ungheria, che dal 1205 aveva temporaneamente sottomesso al suo potere le terre ucraine, in particolare la Transcarpazia; nel periodo dal XIV all'inizio del XVII secolo iniziò la colonizzazione dello stato lituano, che conquistò Volyn, dal 1362 le terre di Kiev, Pereyaslav, Podolsk, Chernigov-Seversky, Polonia, che diffuse la sua influenza in Galizia e nell'Occidente Volyn, Moldavia, che ha messo gli occhi sulla Bucovina settentrionale e sulla regione del Danubio, sul Khanato di Crimea (zona di influenza - regioni del Mar Nero settentrionale e sull'Azov), sull'Impero turco.
Nel XVI secolo continuò il processo di arricchimento reciproco della cultura ucraina con la tradizione dominante di Cirillo e Metodio e con le conquiste culturali del mondo cattolico dell'Europa centrale e occidentale. Fu sulle terre ucraine che ebbe luogo la sintesi di due tradizioni culturali, la cui conseguenza fu la formazione di un nuovo tipo generale di cultura per i popoli dell'Europa centro-orientale.
A partire dalla seconda metà del XVII secolo, lo Stato russo esercitò l'influenza principale sullo sviluppo della cultura ucraina. Nel 1653, lo zar Alessio Mikhailovich convocò il Concilio Zemskij, che decise che, in nome della fede ortodossa e della Santa Chiesa di Dio, lo zar deve accettare gli ucraini "sotto la sua mano alta".
Ottimo russo e ucraino, le due varietà più grandi tra le tribù slave. Il destino storico li ha uniti più di una volta e nei primi secoli della loro vita storica il ruolo dell'architetto, l'elemento guida nella vita culturale e politica, l'elemento più importante nell'Europa orientale, è stato svolto dal popolo ucraino, ma è indubbia la loro appartenenza ad un unico consorzio etnico
Influenza della cultura precristiana e cristiana nella Rus' di Kiev
La scienza storica testimonia: a Kievan Rus, molto prima dell'adozione del cristianesimo, si sviluppò una cultura alta e originale. Non c’è dubbio che un secolo prima del battesimo ufficiale generale della Rus’, nel 988, a Kiev c’erano cristiani di origine russa e variaga, c’era una chiesa cattedrale a Podol, “sopra il Ruchai”, c’erano tumuli militari in cui i soldati morti venivano sepolti senza l'obbligatorio rogo pagano. E c'erano persone alfabetizzate. L'idea ingenua della completa ferocia degli slavi al momento del battesimo della Rus' corrisponde alla tesi della chiesa "Il paganesimo è oscurità, il cristianesimo è luce", ma non corrisponde affatto alla realtà storica. Per circa un secolo e mezzo, Kievan Rus esisteva come potenza pagana. Le città emerse - le corti di principi di vario rango, dal tribale "ogni principe" ai "principi brillanti" delle unioni tribali (Drevlyans, Krivichi, ecc.) allo stesso Granduca di Kiev, hanno da tempo superato la primitività e hanno diventare significativamente più forte. La nobiltà militare russa tracciava le rotte principali a sud - verso Bisanzio, e ad ovest - verso le terre tedesche lungo l'Alto Danubio e verso i favolosi paesi dell'Est. Le spedizioni commerciali a lunga distanza arricchirono i russi non solo con la seta, il broccato e le armi, ma anche con la conoscenza, ampliarono i loro orizzonti e li introdussero, per quanto possibile, nella cultura mondiale. I Rus' erano già conosciuti in tutto il Vecchio Mondo, dalla Francia a ovest all'Afghanistan a est.
Bisanzio portò il cristianesimo e una letteratura e un'arte altamente sviluppate nella Rus' di Kiev. Lo sradicamento del paganesimo e l'impianto del cristianesimo all'estero consentiranno successivamente di creare una potente ideologia che gradualmente entrò nella coscienza quotidiana delle persone. Inoltre, protetta dagli scritti slavi di Cirillo e Metodio, la potente ideologia sovrana del cristianesimo formò a immagine dei comandamenti di Cristo gli ideali duraturi di bontà, purezza spirituale, sincerità, fede nei miracoli e tormento apocalittico degli apostati nell'altro mondo. Bisanzio ebbe anche un'influenza significativa sulla formazione dell'ideologia e della visione del mondo dell'élite medievale slava. La potente introduzione nella coscienza quotidiana degli slavi di una cultura originaria basata sugli ideali del cristianesimo ortodosso influenzò direttamente la formazione della loro mentalità, e a tal punto che, per confronto, erano pronti a sottomettersi più rapidamente alle tribù mongole fedeli alla fede ortodossa che a quelle dell’Europa occidentale, potenze la cui cultura era basata sui valori della fede cattolica. Successivamente, ciò influenzò la formazione di una visione del mondo diversa da quella slava occidentale, ma come fattore causale. Durante il periodo di formazione della nazionalità ucraina, le tradizioni della reciproca comunicazione spirituale tra i popoli hanno continuato ad approfondirsi e ad arricchirsi. Furono preservati e sviluppati principalmente da centri di cultura spirituale come i monasteri ortodossi; all'inizio del XVIII secolo c'erano circa 50 monasteri nella Rus', di cui 17 nella sola Kiev.
Modo ucraino
Se ci si chiede chi siamo – come nazione, come popolo, come Stato, è necessario prima formulare il problema. In sintesi si può definire così: LA VIA UCRAINA.
Se guardiamo indietro al processo di formazione della moderna nazione ucraina, ricordiamo quando e come ciò è accaduto e, soprattutto, chi sono i motivatori spirituali e gli iniziatori di questo lavoro, allora torniamo inevitabilmente agli anni '30 e '40 del XIX secolo. . Inoltre, questo fu un periodo di rinascita nazionale non solo ucraina, ma anche paneuropea, al cui apogeo si verificarono una serie di rivoluzioni nazionali e democratiche nel 1848-49. Ecco perché quest’epoca della storia europea viene solitamente chiamata la “primavera delle nazioni”. E l’Ucraina non fa eccezione. Facendo quindi parte degli imperi russo e austro-ungarico, si risveglia e contemporaneamente su tutte le terre, sia occidentali che orientali. A Kiev si formò la Confraternita di Cirillo e Metodio, che operò fino al 1847 e fu distrutta dalla macchina autocratica zarista. Non ha avuto nemmeno il tempo di maturare pienamente come struttura politica e organizzativa. Ma ha dato all’Ucraina figure eccezionali come Taras Shevchenko, Nikolai Kostomarov, Panteleimon Kulish.
I fratelli consideravano la liberazione nazionale come una componente del movimento pan-slavo, politica - come la necessità di costruire una federazione di popoli uguali, al di fuori delle influenze imperiali, e sociale - principalmente come l'abolizione della servitù della gleba, l'introduzione dell'istruzione generale, ecc. .
Allo stesso tempo, nelle opinioni e nella creatività di Shevchenko, queste idee acquisirono le caratteristiche di un nuovo ideale socio-politico. La sua essenza era espressa dagli appelli alla completa liberazione nazionale e sociale, alla costruzione del proprio stato: "la propria casa ha la propria verità, forza e volontà".
Nell’Ucraina occidentale, che faceva parte dell’Impero austro-ungarico, i messaggeri della “primavera delle nazioni” furono le figure socio-politiche e spirituali-culturali di un gruppo di studenti del Seminario Teologico “Trinità Russa” di Lvov (Markian Shashkevich, Ivan Vagilevich, Yakov Golovatsky), che nel 1837 fu pubblicato l'almanacco "La Sirena del Dniester".
Nel 1848 fu creata a Lvov la prima organizzazione ucraina, la Rada principale russa, e iniziò a essere pubblicato il primo giornale ucraino, Zorya Galitskaya.
La caratteristica principale e la differenza del nuovo movimento democratico nazionale fu l’espansione delle rivendicazioni nazionali da quelle etnoculturali e linguistiche a quelle sociali e politiche, che includevano
struttura repubblicana, costituzione, abolizione della servitù della gleba, diritti civili, libertà di coscienza, stampa propria, ecc.
Populisti e popolo
I successori dei Cirilo-Metodiani nell'est furono i populisti e gli Hromadovtsy, e nell'ovest - i populisti. I più grandi successi degli immigrati provenienti dai paesi dell'Est, del Centro e del Sud furono la fondazione di una tipografia ucraina a San Pietroburgo, la pubblicazione lì della rivista Osnova, la creazione di comunità di massa a Kiev (più di 300 persone), Poltava, Odessa, ecc., così come i centri di trasferimento della lotta di liberazione nazionale dopo la repressione zarista all'estero.
La figura più importante di questo periodo fu Mikhail Drahomanov, che nel suo libro “La Polonia storica e la grande democrazia russa” (pubblicato nel 1882) e in una serie di altre opere formulò una nuova piattaforma per il movimento di liberazione ucraino, prendendo come base le libertà democratiche e il diritto di ogni popolo ad una vita politica indipendente.
Gli intellettuali popolari galiziani si chiamavano così, perché consideravano la cosa principale nelle loro attività la comunicazione con la gente, la difesa dei loro interessi e diritti. Quando arrivò il momento della reazione nella regione del Dnepr, accettarono personaggi sociali e politici e scrittori ucraini.
In Galizia furono aperti nuovi periodici, nacque la Società scientifica Prosvita e Shevchenko e si svilupparono condizioni favorevoli per l'emergere di partiti politici ucraini.
Quindi, proprio come un grande fiume è formato da molti corsi d’acqua e affluenti, così il movimento di liberazione nazionale ucraino della seconda metà del XIX secolo ha assorbito le idee e l’esperienza di molte comunità, organizzazioni e movimenti ucraini di direzione populista e democratica.
L'obiettivo principale di questo movimento a quel tempo era la liberazione dell'Ucraina dal giogo degli imperi e la creazione del proprio stato. Allo stesso tempo, molti democratici ucraini, compresi i loro leader Mikhail Drahomanov e Ivan Franko, non sfuggirono all’influenza dell’“epidemia” ideologica e politica della seconda metà del XIX secolo: il socialismo.
I primi partiti ucraini
A cavallo degli anni '90 del XIX secolo, i partiti politici raccolsero il testimone della lotta per gli ideali popolari e democratici. L’idea dell’indipendenza politica dell’Ucraina fu avanzata per la prima volta dal Partito radicale russo-ucraino, creato nel 1890 in Galizia. Era guidato da Ivan Franko, Mikhail Pavlik, Ostap Terletsky.
Dopo aver superato la tangibile influenza socialista di Mikhail Drahomanov, questo partito, invece dell'obiettivo principale di "organizzazione collettiva del lavoro e proprietà collettiva", nel 1895 annunciò l'idea dell'indipendenza statale dell'Ucraina. Nel 1899, altri due "si separarono" da questo partito: il Nazionaldemocratico e il Socialdemocratico.
Due anni prima si era svolto a Kiev il congresso delle comunità che si erano riunite in un’organizzazione apartitica tutta ucraina. Nel 1900, un gruppo di studenti di Kharkov guidati da Dmitry Antonovich annunciò la creazione del Partito Rivoluzionario Ucraino (RUP). Due anni dopo, da esso si separò un gruppo guidato da Nikolai Mikhnovsky, che creò il Partito popolare ucraino, e lo stesso RUP fu ribattezzato Partito socialdemocratico ucraino nel 1905.
Così, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, con l'emergere di numerosi partiti politici, il movimento nazionale ucraino fu diviso in tre movimenti: democratico popolare, democratico nazionale e socialdemocratico.
Nonostante alcune differenze nei programmi sociali e nella ricerca di sostegno in diversi segmenti della popolazione, tutti rimangono fedeli all’idea nazionale, che l’organo direttivo del Partito Nazionale Democratico Ucraino – il Comitato Popolare – dichiarò il giorno di Natale del 1900 nella sua indirizzo come segue: "Il nostro ideale dovrebbe essere una Rus'-Ucraina indipendente, in cui tutte le parti della nostra nazione si unirebbero in un nuovo stato culturale".
(Per “Stato culturale” si intende uno Stato con un alto livello di cultura in generale e di cultura democratica in particolare).
Tutti i partiti nazionali stavano quindi preparando le basi ideologiche e politiche per uno stato ucraino indipendente. Allo stesso tempo, la loro divisione alla fine portò a un tragico confronto politico e militare durante gli anni delle gare di liberazione rivoluzionaria e della guerra civile.
Lezioni dalla competizione di liberazione e dall'esperimento sovietico Entrambe le ondate del movimento di liberazione nazionale ucraino – negli anni '20 e '40 – fallirono, e il loro più grande risultato, la Repubblica popolare ucraina, fu di breve durata.
Secondo l'autore, le ragioni principali della sconfitta delle due rivoluzioni ucraine (o, più precisamente, delle due fasi della rivoluzione ucraina) sono le seguenti:
– il movimento di liberazione nazionale dell’Ucraina non è stato l’unico, non è riuscito a riunire la maggioranza del popolo ucraino sotto la sua bandiera, non ha unito le forze nella lotta per uno Stato indipendente che proteggesse gli interessi del popolo;
– l’ala sinistra del movimento di liberazione nazionale (socialdemocratici, socialisti rivoluzionari, socialisti e comunisti ucraini) spesso antepone i propri compiti di classe sociale e di partito internazionale agli interessi del popolo ucraino;
– la lotta per la realizzazione dei sogni secolari del popolo ucraino – riguardo al proprio Stato e alla sua struttura democratica – è stata notevolmente complicata da due conflitti militari mondiali. E poiché l’Ucraina era un campo di battaglia ed era divisa da fronti militari, le forze di liberazione nazionale praticamente non avevano alcuna possibilità di ottenere almeno
assistenza minima da parte delle democrazie europee (soprattutto occidentali);
cap. 2. Cambiare l'immagine dell'uomo nella storia della filosofia
Come abbiamo già notato nelle pagine precedenti, il tema dell'uomo è un tema trasversale che attraversa tutta la storia della filosofia dall'antichità ai giorni nostri. Naturalmente, in diversi periodi storici questo argomento si è fatto avanti, è diventato il leitmotiv del filosofare, oppure è passato in secondo piano, come se fosse nascosto all'ombra di altri potenti argomenti filosofici legati alla conoscenza, all'ordine mondiale o alla ricerca del divino. Eppure non è mai scomparsa del tutto, perché in questo caso la filosofia stessa scomparirebbe, trasformandosi in qualcos'altro, in una sorta di scienza concreta. In effetti, è così che storicamente le sue branche scientifiche figlie si separarono e si ramificarono dalla filosofia, ma il nucleo filosofico e antropologico rimase, sempre trasparente attraverso gli strati cognitivi, metodologici e teologici.
Si può presumere che i temi antropologici siano discussi in modo particolarmente acuto dai filosofi in epoche critiche, quando il crollo di valori e ideali precedenti, così come l'emergere di situazioni esistenziali acute, porta le persone a cercare consolazione, scegliere e creare nuove linee guida di vita , costringerli a ripensare se stessi, a comprendere il proprio posto nel mondo in modo diverso, altrimenti a vedere vizi e virtù. Tuttavia, nella storia dell'umanità è difficile trovare un'epoca che non rappresenti un punto di svolta. Anche se, dal punto di vista dell'eternità e degli scienziati storici, alcune epoche risultano relativamente calme (nei libri di testo sono designate come "periodi di prosperità" di un certo tipo di società), per le persone che vivono in "tempi tranquilli" la vita rimane ancora piena di prove, problemi e privazioni. Non sono solo le catastrofi e i disastri naturali a renderlo così, ma soprattutto le guerre e la crudeltà del potere. Le parole più comuni nei libri di storia che caratterizzano la situazione storica sono le parole “saccheggiato e bruciato”, seguite da numeri con molti zeri... Pertanto, anche nel periodo apparentemente più fertile, quando gli dei restano dei e la tradizione non viene soppiantata attraverso l'innovazione, la “persona media” ordinaria sperimenta collisioni che pongono problemi sia metafisici che etico-morali, e i pensatori dell'epoca si impegnano a rispondere a domande filosofiche che sorgono spontaneamente.
Consideriamo brevemente, sfogliando secoli e millenni, le principali tappe fondamentali dello sviluppo dei problemi antropologici nella storia del pensiero filosofico. Sarà questa un'escursione gratuita, uno sguardo veloce, non gravato di dettagli e citazioni, ma che permetterà di comprendere che, essendo sorta nel pensiero teorico dell'antichità, l'immagine filosofica dell'uomo rimane costantemente nella cultura, sebbene in ogni periodo della Il tempo lo si vede diversamente, acquisendo sotto lo sguardo dei ricercatori nuove caratteristiche e contorni. In questa recensione, ciò che è importante per noi sono le idee antropologiche chiave che sono ancora in discussione nella comunità filosofica. Nel considerare, ci limiteremo solo alla filosofia europea, senza toccare la vasta gamma di insegnamenti filosofici dell'Oriente.
Se aderiamo alla periodizzazione generalmente accettata, la storia della cultura europea può essere divisa nei periodi dell'antichità, il Medioevo, la New Age, i secoli XVIII e XIX si distinguono separatamente, e poi arriva la modernità, che copre il XX secolo insieme al presente (in questo caso non è necessario per noi distinguere tra modernità e postmodernità nella cultura, anche se toccheremo questi temi in seguito). Iniziamo con antichità.
Come sapete, i primi filosofi greci antichi erano impegnati con problemi cosmologici e ontologici, si preoccupavano del tema dell'esistenza, della ricerca della base della diversità delle cose, e l'uomo stesso rimaneva nell'ombra. Forse questo è accaduto anche perché l'uomo nell'antichità era percepito come un microcosmo, un analogo di un grande cosmo corporeo e animato. Se conosciamo il Cosmo, allora conosciamo anche l'uomo, anch'esso corporeo e animato. Le persone sono solo momenti dell’ordine globale; conoscere quest’ordine è più importante. Tuttavia, con Socrate inizia una nuova era nel pensiero filosofico antico, ha luogo una “rivoluzione socratica”, essenzialmente una rivoluzione etico-antropologica. Socrate, come descritto da Platone, conduce le sue conversazioni per trovare il bene umano, vuole condurre le persone alla conoscenza che consenta loro di essere virtuose e seguire la retta via. Socrate crede nella razionalità di una persona che, secondo le sue idee, non farà il male se sa cos'è il bene.
A prima vista può sembrare che Platone, fedele allievo di Socrate, si discosti dal percorso antropologico delineato dal suo maestro. Platone scrive del mondo delle idee, costruisce una cosmologia e crea un'immagine di uno stato ideale. Tuttavia, l'antropologia platonica consiste nell'indicare sia lo status dell'uomo nel mondo, sia la vita per lui più degna. Per Platone, che gli esoteristi moderni chiamano giustamente il “grande iniziato”, l'uomo è innanzitutto un'anima immortale che circola nel mondo delle idee. L'imperfezione e l'errore fanno sì che l'anima cada in un corpo mortale e il compito di ogni persona che lotta per la saggezza è tornare all'Iperurania, alla vita eterna e ai modelli perfetti. L'uomo saggio non ha paura della morte, perché la vita nel corpo è morte.
"Platone è mio amico, ma la verità è più cara" - queste parole sono abbastanza applicabili alla considerazione dell'uomo da parte di Aristotele. Aristotele è un filosofo di questo mondo; l'attrattiva dell'aldilà gli è estranea. Aristotele vede nell'uomo un essere attivo, attivo, politicamente impegnato, capace di trovare qui, nel mondo empirico, la pienezza della felicità. Non senza ragione, molti anni dopo, nel XX secolo, E. Fromm chiamerà Aristotele il fondatore dell'etica umanistica. Aristotele si occupa del tema delle passioni umane, del loro ragionevole contenimento e bilanciamento, sebbene comprenda chiaramente che per la felicità la ragione da sola non è sufficiente, anche la vita stessa è importante.
Il tema della ragione e delle passioni in generale è centrale negli studi antropologici dei filosofi antichi. Risulta essere il principale sia tra gli stoici che tra Epicuro. Pertanto, gli stoici - combattenti contro le passioni - vedono la felicità umana nella completa accettazione da parte dell'individuo del Logos mondiale, nella sottomissione cosciente ad esso, che è possibile solo quando si raggiunge l'apatia - la rinuncia ai propri desideri, alla paura e ad altre esperienze forti. Epicuro, riflettendo sulla felicità umana, classificando e classificando i tipi di piaceri, giunge infine, nell'ideale della serenità, alla fondamentale indipendenza dalle ansie interne ed esterne. L'atarassia del suo saggio è molto vicina all'apatia degli stoici: è davvero meraviglioso non temere nulla, né gli dei, né la necessità, né la morte. L'indipendenza è uno stato ideale per una persona, sebbene non neghi l'amicizia come libera comunicazione di individui che si sono scelti tra loro per le conversazioni.
Sia per Epicuro che per gli Stoici i problemi esistenziali prevalgono sui problemi dell'uomo generico: per loro è importante capire come vivere. Questo tema assume un'interpretazione drammatica negli stoici successivi, come Seneca, Marco Aurelio ed Epitteto, in cui i temi dell'amore e della redenzione, della salvezza e della sofferenza sono vividamente ascoltati, e l'immagine di una persona risulta essere più realistica di il ritratto ideale di un saggio severo dei primi stoici.
Non importa quanto diversi fossero i pensatori antichi (e il nome "antichità" copre un periodo di tempo enorme), per loro l'uomo era sempre, in un modo o nell'altro, iscritto nell'ordine del mondo. Anche se è “disordine”, caos, bisogna saperlo accettare, bisogna accettarlo quando si entra nell’emigrazione interna. L'uomo dal pensiero filosofico antico non va a combattere corpo a corpo il mondo, non cerca di trasformarlo nel suo saltyk, di conquistarlo e di renderlo suo servitore. Questa comprensione di se stessi come figura dipendente dal destino o da Dio esisterà nel pensiero filosofico per molto tempo, fino alla nascita del pathos titanico del Rinascimento.
A cavallo dell’epoca va menzionata la figura di Plotino, il cui pensiero centrale era l’idea della possibilità per ogni persona di trovare dentro di sé una scintilla divina. Il mondo è pieno di guai, e il corpo è mortale e cattivo, ma l'uomo non deve aspettare la fine dei tempi per scoprirlo: non è solo carne vecchia, dentro di sé è l'Uno, porta dentro di sé dall'inizio, e ha il potere di scoprire dentro di sé una particella di luce divina.
Un periodo della storia europea chiamato Medioevo, è un intero millennio. Il tema centrale della filosofia cristiana è Dio, la sua onnipotenza e onniscienza; l'uomo in sé, al di fuori di Dio, non è discusso dalla coscienza teologica; è possibile parlare di lui solo in relazione al principio creativo. È tipico del pensiero medievale assegnare all'uomo un posto speciale nella gerarchia dell'esistenza. Da un lato l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, dall'altro è completamente macchiato di peccato. Tutti i nati da Adamo ed Eva portano dentro di sé il momento del peccato originale; in sostanza, per questo nascono in un mondo terreno imperfetto, dove regnano la morte, la malattia e il conflitto. Questa idea di una bizzarra combinazione di bene e male nell'uomo è chiaramente espressa da Agostino il Beato, il quale crede che sia l'uomo la colpa dell'esistenza del male, poiché ha usato in modo errato la libertà datagli da Dio. L'uomo ha disobbedito all'Onnipotente e questa è diventata la sua colpa eterna. Tuttavia Agostino non si limita al tema dei danni causati dalla libertà umana. Possiamo dire che nell'alto medioevo Agostino era un pronunciato filosofo esistenziale, sollevando temi delle esperienze umane interne, del tempo interiore, dei temi della ricerca spirituale, della sofferenza e dell'abbandono da parte di Dio. Anche Tommaso d'Aquino, un altro pilastro del pensiero medievale, vissuto molto più tardi, sviluppando il suo potente sistema filosofico e teologico, non dimenticò l'uomo, ma piuttosto come ontologo, costruendo una gerarchia dell'essere, e come epistemologo, confrontando conoscenza e fede. Il suo pensiero razionalistico non conosce il turbamento emotivo, mostra a una persona il suo posto nel mondo.
Istituzione educativa non statale
ACCADEMIA UMANISTICA DI SAMARA
Facoltà di Filosofia e Filologia
Dipartimento di Filosofia
Specialità 020100 Filosofia
CONCETTI DI UOMO NELLA FILOSOFIA ANTICA
Lavoro del corso
Completato da uno studente del 1° anno del gruppo 2103
SM. Bulanova
L'opera è protetta "" 200 g.
Grado_______________________
Testa Dipartimento
Dottorato di ricerca, professore________ N.Yu. Voronina
Direttore scientifico
E. Yu. Mikhaleva
Samara 2006
Bulanova Marina Sergeevna
"Concetti dell'uomo nella filosofia antica"
Supervisore scientifico: Mikhaleva Elena Yurievna
Obiettivo: rivelare i concetti di base dell'esistenza umana nella filosofia antica.
Oggetto: persona
Oggetto: opere di pensatori antichi
Numero di fonti utilizzate – 13.
INTRODUZIONE………………………………4
1. L'uomo come oggetto di analisi filosofica………..6
2. Idee generali sull'esistenza umana tra i filosofi antichi…….9
3. La conoscenza di sé come problema principale della filosofia di Socrate……………….13
4. Concetti fondamentali dell'ideale secondo Platone……………16
5. L’idea aristotelica di bene personale e pubblico…………….19
CONCLUSIONE……………………...21
Elenco delle fonti utilizzate…………………22
introduzione
Una delle filosofie più interessanti è la filosofia dell'antichità. Ha avuto un'enorme influenza sull'ulteriore sviluppo della filosofia. La filosofia antica deve principalmente alla filosofia greca. Poiché furono i Greci a gettare le basi iniziali per lo sviluppo del pensiero antico.
L'apice del pensiero filosofico greco antico è considerato le conquiste filosofiche di Platone e Aristotele. Le potenti figure intellettuali del fondatore dell'Accademia e del fondatore del Liceo, insieme al loro immediato predecessore Socrate, stanno al centro della filosofia dell'antichità. L'influenza sul successivo sviluppo filosofico e culturale delle idee avanzate da Platone e Aristotele supera molte volte l'influenza di ciò che è stato creato dai loro predecessori. Senza approcci e concetti platonici e aristotelici, è impossibile comprendere qualsiasi sistema filosofico lungo l'intero lungo percorso dell'evoluzione successiva, compresa la modernità. Ecco perché l'assimilazione delle idee di questi due pensatori dovrebbe essere al centro dell'attenzione quando si studia la filosofia dell'antichità.
La storia dell'antica filosofia greca si apre con il nome di Talete di Mileto. Talete sosteneva che tutto nel mondo proviene dall'acqua. Tuttavia, l’affermazione di B. Russell nel suo caratteristico modo semi-ironico non è priva di fondamento: “In ogni corso di storia della filosofia per studenti, la prima cosa che dicono è che la filosofia è iniziata con Talete, il quale disse che tutto viene dall’acqua. Ciò è scoraggiante per il principiante che sta cercando, forse non molto duramente, di provare il rispetto per la filosofia che il curriculum sembra progettato per produrre. Tuttavia, Russell trova una via d'uscita nell'apprezzare molto Talete come "uomo di scienza", se la visione del grande Ione come filosofo non è impressionante.
Tuttavia, le affermazioni di Russell contengono la verità che una corretta comprensione delle idee dei primi filosofi, principalmente la loro preoccupazione per la ricerca del primo principio (che, insieme o a loro volta, sono acqua, aria, fuoco, terra), è possibile solo nel contesto di idee generali sulla cultura dell'antichità e sul suo significato. Qual è il mistero dell'attrattiva dell'antichità, perché nel corso di molti secoli si ritorna ripetutamente all'eredità antica e le nuove generazioni comprendono e ripensano le sue conquiste? Apparentemente contengono un segreto importante per lo sviluppo successivo, un segreto che viene costantemente scoperto, ma che rimane sempre un problema.
L'obiettivo principale del mio lavoro era identificare le caratteristiche principali della filosofia sull'uomo nell'antichità.
Il problema dell'uomo è rilevante in ogni momento, poiché l'uomo è uno degli oggetti più interessanti per la ricerca filosofica. Ma fu nell'antichità che iniziarono ad apparire le prime idee sull'esistenza umana, sugli obiettivi umani e sul significato della sua esistenza.
Questo problema è considerato in modo più chiaro e dettagliato da Socrate, Platone e Aristotele. Sono stati questi rappresentanti dell'antichità che ho studiato con grande attenzione.
1. L'uomo come oggetto di analisi filosofica.
Le prime idee sull'uomo sorgono molto prima della filosofia stessa. Nelle fasi iniziali della storia, le persone erano caratterizzate da forme mitologiche e religiose di autocoscienza. Nelle leggende, nei racconti e nei miti viene rivelata la comprensione della natura, dello scopo e del significato dell'uomo e della sua esistenza. La cristallizzazione della comprensione filosofica dell'uomo avviene proprio sulla base dei concetti, delle idee, delle immagini e dei concetti in essi incorporati e nel dialogo tra la filosofia emergente e la mitologia. È così che nascono i primi insegnamenti sull'uomo.
L'antica filosofia umana indiana è presentata, prima di tutto, nel monumento dell'antica letteratura indiana: i Veda, che esprimono contemporaneamente una visione del mondo mitologica, religiosa e filosofica. C'è un crescente interesse per l'uomo nei testi adiacenti ai Veda: le Upanshyad. Rivelano i problemi della moralità umana, nonché modi e mezzi per liberarlo dal mondo degli oggetti e delle passioni. Una persona è considerata tanto più perfetta e morale quanto più raggiunge il successo in materia di tale liberazione. Quest'ultima, a sua volta, si realizza attraverso la dissoluzione dell'anima individuale nell'anima del mondo, nel principio universale del mondo.
L'uomo nella filosofia dell'antica India è pensato come una parte dell'anima del mondo. Nella dottrina della trasmigrazione delle anime (samsara), il confine tra gli esseri viventi (piante, animali, esseri umani) e gli dei risulta essere valicabile e mobile. Ma è importante notare che solo l'uomo ha il desiderio di libertà, di liberarsi dalle passioni e dalle catene dell'esistenza empirica con la sua legge del samsara-karma. Questo è il pathos delle Upanshyad.
Le Upanshyad hanno avuto un'enorme influenza sullo sviluppo dell'intera filosofia umana in India. In particolare, la loro influenza sugli insegnamenti del giainismo, del buddismo, dell'induismo e dello yoga è grande. Questa influenza influenzò anche le opinioni del famoso filosofo indiano M.K. Gandhi.
La filosofia dell'antica Cina ha creato anche un insegnamento originale sull'uomo. Uno dei suoi rappresentanti più significativi, Confucio, ha sviluppato il concetto di "paradiso", che significa non solo una parte della natura, ma anche la più alta forza spirituale che determina lo sviluppo del mondo e dell'uomo. Ma al centro della sua filosofia non c'è il cielo, non il mondo naturale in generale, ma l'uomo, la sua vita ed esistenza terrena, cioè è di natura antropocentrica.
Preoccupato per il decadimento della società contemporanea, Confucio presta attenzione, prima di tutto, al comportamento morale umano. Ha scritto che dotato dal cielo di determinate qualità etiche, una persona è obbligata ad agire in conformità con la legge morale - Tao e a migliorare queste qualità nel processo di apprendimento. Lo scopo della formazione è raggiungere il livello di una “persona ideale”, un “nobile marito” (jun-tzu), il cui concetto fu sviluppato per la prima volta da Confucio. Per avvicinarsi agli Junzi bisogna seguire una serie di principi etici. Il posto centrale tra loro spetta al concetto di ren (umanità, umanità, amore per le persone), che esprime la legge dei rapporti ideali tra le persone nella famiglia e nello stato secondo la regola “non fare alle persone ciò che si non desiderare per te stesso. Questa regola, come imperativo morale, si ritroverà in diverse versioni più avanti negli insegnamenti dei “Sette Re Magi” nell'Antica Grecia, nella Bibbia, in Kant, in Vl. Solovyov e altri. Confucio presta particolare attenzione al principio dello xiao (pietà filiale e rispetto per i genitori e gli anziani), che è alla base di altre virtù e il metodo più efficace per governare un Paese considerato una “grande famiglia”. Ha anche prestato molta attenzione a principi di comportamento come l'etichetta e la giustizia.
Insieme agli insegnamenti di Confucio e dei suoi seguaci, nell'antica filosofia cinese va notata un'altra direzione: il taoismo. Il suo fondatore è Lao Tzu. L'idea iniziale del Taoismo è la dottrina del Tao (percorso, strada): questa è la legge invisibile, onnipresente, naturale e spontanea della natura, della società, del comportamento e del pensiero di un individuo. Una persona deve seguire il principio del Tao nella sua vita, cioè il suo comportamento deve essere coerente con la natura dell'uomo e dell'universo. Se si osserva il principio del Tao, è possibile l'inazione, la non azione, che tuttavia porta alla completa libertà, felicità e prosperità.
Caratterizzando l'antica filosofia umana orientale, notiamo che la sua caratteristica più importante è l'orientamento dell'individuo verso un atteggiamento estremamente rispettoso e umano nei confronti sia del mondo sociale che di quello naturale. Allo stesso tempo, questa tradizione filosofica si concentra sul miglioramento del mondo interiore dell'uomo. Migliorare la vita sociale, l’ordine, la morale, la gestione, ecc. è associato, prima di tutto, ai cambiamenti nell'individuo e al suo adattamento alla società, e non ai cambiamenti nel mondo e nelle circostanze esterni. L'uomo stesso determina i percorsi del proprio miglioramento ed è il proprio dio e salvatore. Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che un tratto caratteristico dell'antropologia filosofica è l'uomo, il suo mondo e il suo destino sono certamente associati al mondo trascendentale (oltre).
2.Idee generali sull'esistenza umana tra i filosofi antichi.
Si ritiene tradizionalmente che il primo creatore della dottrina dell'uomo, stiamo parlando dell'antica filosofia greca, che non toglie nulla al contributo degli antichi saggi indiani e degli antichi cinesi a questo problema, sia Socrate. Sebbene i suoi predecessori e contemporanei, ad esempio i sofisti, prestassero molta attenzione a questo problema, Socrate fu il primo degli antichi saggi che, secondo Cicerone, portarono la filosofia dal cielo dei problemi cosmici sulla terra, nelle città e case delle persone, costringendo i cittadini a pensare, riflettere prima sulla propria vita, sulla morale prevalente, sul bene e sul male. Socrate presta primaria attenzione alla vita interiore dell'uomo, concentrandosi sull'uomo che conosce. Il livello più alto di attività in cui un saggio dovrebbe impegnarsi è, secondo Socrate, lo studio dell'uomo, cioè la conoscenza che una persona può avere del suo “io” interiore. Se i suoi predecessori, in particolare i filosofi naturali, dichiara Socrate, cercavano di trovare una soluzione al problema: qual è la natura e la realtà ultima delle cose, allora a lui interessava la domanda: qual è l'essenza dell'uomo, qual è la la natura e la realtà ultima dell’uomo. E sebbene restringa il concetto di uomo al livello della moralità, la dottrina dell'anima, credendo che "l'uomo è l'anima" e "l'anima è l'uomo", si può giustamente affermare che le idee di Socrate hanno avuto una potente influenza sul ulteriore studio dell'essenza della persona.
“Tutti gli uomini”, scrive Aristotele, “per natura si sforzano di conoscere... È comune che gli uomini si rafforzino nella saggezza e conoscano se stessi. È impossibile vivere senza questo."
L'uomo è una creazione unica dell'Universo. È inspiegabile, misterioso. Quando i filosofi parlano della natura e dell'essenza dell'uomo, non si tratta tanto della divulgazione finale di questi concetti e del loro contenuto, ma piuttosto del desiderio di chiarire il ruolo di queste astrazioni nel pensiero filosofico sull'uomo. Innumerevoli sono i tentativi di definire l’uomo come un essere diverso dagli animali. Questo è l’“animale politico” di Aristotele, l’“animale costruttore di utensili” di Franklin, l’homo societas (“uomo sociale”) e l’homo sociologicus (“uomo sociologico”)... Dietro ciascuna di queste definizioni si nascondono alcuni sfaccettature reali di un fenomeno multiforme “Umano”.
Nel frattempo, le persone possono essere distinte dagli “animali” per la coscienza, per la religione – per qualsiasi cosa. Se il mondo animale, a differenza del mondo umano, è predeterminato dai suoi istinti e l'intera vita degli animali ruota attorno a questo epicentro degli istinti, allora l'epicentro dell'orbita del comportamento umano è l'apparato di abilità e valori (educazione, educazione , moralità, scienza). Le persone stesse iniziano a distinguersi dagli animali non appena iniziano a produrre i mezzi di sussistenza di cui hanno bisogno. Ma in larga misura cominciano a essere determinati dal loro modo di vivere e dal loro sistema di vita.
La mitologia e la filosofia più antiche non hanno smembrato l'immagine del mondo: in essa natura, uomo e divinità sono uniti. In generale, una persona nell'antico ordine mondiale è solo un materiale che promuove la familiarità con valori più alti ed extrapersonali. Una coscienza di questo tipo gravita naturalmente verso il potere, nel quale si esprime, come si suppone, l'assoluto ricercato. Il potere è inteso come valore incondizionato, come espressione più completa del mistero dell'essere. Sorge indipendentemente dall'uomo come riflesso dello spirito dell'Universo. Una persona deve sottomettersi consapevolmente a questo potere, senza nemmeno fingere di comprenderne il significato. Qui l'individuo non è considerato un valore; al contrario, ogni unicità della persona è valutata come un male, come un ostacolo. Tuttavia, questo predominio di universalità non esclude l’emergere di principi etici di misericordia, di umanità, di bontà, il risveglio del senso di autocoscienza dell’individuo, e già nel periodo tardoantico la parola “concittadino” diviene non più una frase vuota, ma porta con sé obblighi molto importanti e talvolta difficili.
Tuttavia, una persona di questo periodo non aveva ancora un senso di personalità consolidato. Per avvicinarsi al mistero dell'uomo era importante separare storicamente l'individuo dalla sostanza universale. L'antichità ha fatto solo un passo su questa strada. Il desiderio dei pensatori antichi, da Omero ad Aristotele, così come delle successive figure creative greco-romane, di considerare la natura umana da una posizione razionalistica, in particolare la sua sfera morale-soggettiva, la sottovalutazione del fattore irrazionale sia nella natura stessa dell'uomo che nella il suo comportamento, sia nella vita sociale che nel processo storico, furono una delle principali ragioni ideologiche e spirituali della caduta della filosofia e della cultura antiche. E in questo contesto appare un diverso orientamento di valore, diverse visioni del mondo e normative cognitive li sostituiscono nel Medioevo cristiano.
Come scrisse il filosofo russo N. Berdyaev, “il cristianesimo ha liberato l'uomo dal potere dell'infinito cosmico, in cui era immerso nel mondo antico, dal potere degli spiriti e dei demoni della natura. Lo ha rimesso in piedi, lo ha rafforzato, lo ha reso dipendente da Dio e non dalla natura”.
D'ora in poi l'uomo cominciò a essere visto come il centro e lo scopo più alto dell'universo. La natura, lo spazio, la realtà sociale cominciarono ad essere comprese attraverso un certo atteggiamento: ponendo l'uomo al centro dell'universo, definendo l'uomo come un valore incondizionato. Il cristianesimo nel suo insieme distingueva fondamentalmente l'uomo dall'immagine dell'uomo compreso nell'antichità. Enfatizzava l'individuo in lui, mentre il paganesimo dissolveva l'individualità nella comunità sociale.
Naturalmente, la filosofia medievale è fondamentalmente la filosofia della società feudale, è un riflesso ideologicamente trasformato dell'esistenza dell'uomo “feudale”. E in effetti, la filosofia del Medioevo non avrebbe potuto essere diversa da quella che era nelle condizioni di una società teocratica feudale. Di conseguenza, il suo carattere reazionario o progressista rispetto alla filosofia antica deve essere valutato secondo la nostra valutazione del feudalesimo. Il feudalesimo, rispetto alla formazione schiavista che lo precedette, fu senza dubbio un fenomeno progressista anche sul piano culturale: fu per l'Europa un'epoca di progressivo coinvolgimento nella sfera della cultura di una massa enorme di popoli che erano precedentemente situato nella lontana periferia della civiltà. Il mondo antico fu assorbito e dissolto dal mondo barbaro, e sebbene la “soluzione” risultante non avesse più la brillante colorazione culturale del mondo antico, non aveva più l’incolore culturale del mondo barbaro. Non dobbiamo però dimenticare che l'altra faccia della teologizzazione della filosofia era la filosofare e la razionalizzazione della teologia, la quale, pur rimanendo maestra del pensiero medievale, divenne grazie a questa razionalizzazione più tollerante nei confronti della filosofia stessa. E quindi il modo caratteristico del pensiero umano medievale in generale e del pensiero filosofico in particolare è la retrospettiva e il tradizionalismo della società, cioè attenzione della società al passato.
Ma se la società non è altro che un nome per l'aggregazione e l'interazione di singole persone, non è altro che una cosa artificiale che produciamo, ad es. la somma soggettiva della realtà delle singole persone, o la società, è un tipo di realtà veramente oggettiva, non un insieme esaustivo di individui inclusi nella sua composizione. Per non confondere questa questione puramente teorica con questioni e controversie di carattere pratico e valutativo, vale la pena utilizzare i termini “individualismo” e “collettivismo” per designare due tendenze sociali, come differenza comparativa tra i periodi dell’antichità e Il Medioevo e la persona in esso.
L'antica coscienza, cercando di modellare l'armonia, propone l'idea della trinità dei principi umani: fisico, intellettuale e spirituale. Ma allo stesso tempo, una persona ha continuato a occupare una certa posizione intermedia, mostrando l'attività di solo un contemplatore, il cui intervento nello stato di cose esistente non è stato in alcun modo incoraggiato dalla visione del mondo dominante.
Anche l'antico sistema di valori umani universali conteneva una contraddizione interna. L'individuo era subordinato al collettivo e in esso dissolto. Ai desideri e alle aspirazioni personali di una persona veniva negato il diritto di esistere se non corrispondevano agli interessi dell’intera comunità civile. Ciò spesso portava al conflitto tra individuo e società. In questo clima di crisi delle strutture e dei valori della polis civile e statale, si ricercavano altri orientamenti e una diversa spiritualità.
Il percorso di trasformazione dell'antica visione del mondo in quella medievale è stato definito come la ricerca di vie di salvezza. Il cristianesimo, in quanto nuova religiosità basata sui principi della rivelazione e del monoteismo, era estraneo all'antica visione del mondo religiosa e mitologica. Tuttavia, a partire dallo stato di illibertà umana, essa si è presentata nella vita spirituale delle società antiche come una via di salvezza individuale. Questa religione si è rivolta per la prima volta all'individuo, ponendo la persona debole e peccatrice al centro dell'universo. Il cristianesimo ha sviluppato una nuova etica di comportamento, la cui osservanza era nel potere di ogni persona, indipendentemente dal suo posto nella struttura sociale della società o dall'appartenenza a un particolare gruppo etnico.
Per la prima volta, la vita di una persona, il suo mondo interiore sono stati riconosciuti come il valore più alto, davanti al quale le strutture socio-politiche e i fenomeni della vita passavano in secondo piano. Questa è stata una grande conquista della coscienza umanistica, che, tuttavia, non è stata priva di perdite.
Avendo trasferito le conquiste della felicità nell'altro mondo, il cristianesimo ha messo in secondo piano importanti linee guida di valore come la cittadinanza attiva, la connessione dell'individuo con la collettività civile, il suo servizio e l'acquisizione congiunta della felicità nella vita reale. Avendo messo da parte l’antico sistema di valori civili, il cristianesimo ha ignorato anche l’essenza sociale della vita dell’individuo, che è indissolubilmente legata a lui quanto il suo mondo interiore.
In tali condizioni di collasso dell'antica civiltà, la coscienza umana non poteva semplicemente rimanere al suo posto, doveva, come minimo, avvicinarsi a una nuova visione del mondo e alla fine trasformarsi. Se nell'antichità questa era una persona “per un altro”, comunicandogli le sue conoscenze e idee. Ricordiamo le lettere a Lucinio Seneca: “Conosciamo cose che sono state create nella nostra memoria... Tutto questo è stato inventato da schiavi insignificanti. La saggezza sta più in alto: non insegna a lavorare con le mani, è maestra delle anime”. Nel Medioevo, questa è una persona rivolta a se stessa, che si oppone a se stessa e cerca la verità nella sua coscienza e anima. Solo con se stessi, ma alla presenza di Dio, miglioramento dell'anima: questo è probabilmente il contenuto principale dell'autocoscienza dell'uomo medievale.
Vale la pena notare che, sostenendo che la cultura pagana non raggiunge la dottrina della personalità assoluta, mentre l'immagine medievale del mondo non esiste più senza di essa. Il filosofo russo A.F. Losev vede in esso una lotta tra due visioni del mondo: una associata a una cosa, al corpo, alla natura e l'altra alla personalità, alla società, all'idea di un mondo ideale. Diventa ovvio che la discrepanza tra l'immagine del mondo caratteristica dell'antichità e l'immagine del mondo stabilita nel Medioevo è molto significativa. Ma una cosa rimane la cosa principale: l'Uomo e la ricerca dell'Uomo stesso.
Sulla base di quanto sopra possiamo trarre le seguenti conclusioni:
1. Innanzitutto vale la pena distinguere la società antica e la cultura antica da quella medievale. La cultura medievale non è antica. In primo piano ecco l'individuo, il soggetto e il suo potere, il suo benessere. Il soggetto sta qui al di sopra dell'oggetto, l'uomo è dichiarato non solo creato “a immagine e somiglianza” di Dio, ma è anche definito principio spirituale personale. Ciò che manca nella cultura antica è che qui la personalità non ha un significato così colossale e assoluto.
2. Se nella coscienza antica, l'uomo stesso esplorava il mondo come sistema. Era già nella coscienza medievale che veniva determinato il percorso di accettazione del mondo come sistema, che dava slancio allo sviluppo spirituale della personalità di una persona e, di conseguenza, alla sua salvezza. La posizione precristiana dell’uomo come individuo non era accettata; tutto era soggetto all’idea di società e al sistema polis. È stato il cristianesimo a mettere in primo piano l'uomo come persona, sebbene lo abbia subordinato a Dio, ma, subordinandosi, ha dato all'uomo il diritto di assumersi la responsabilità di se stesso.
3. L'uomo antico era libero e allo stesso tempo soggetto alla necessità. È cosmologico, impersonale. Ma l'uomo antico era anche proprietario di schiavi, il che di per sé è impersonale. Il Medioevo proponeva il sistema feudale della società, che definiva una persona come identificarsi in una classe o nell'altra e come risultato del suo adattamento alla definizione personale di una data società.
In conclusione di questo rapporto, vorrei rivolgermi al filosofo russo P.A. Sorokin, che ha analizzato la realtà storica come un'unità integrale di vari sistemi culturali soggetti a degenerazioni cicliche-evoluzionistiche. Sulla base di quanto sopra, si può determinare che nell'arena storica tutto è realmente interconnesso, e l'evoluzione generale della cultura e della società in misura maggiore porta non solo un nuovo ciclo storico, ma determina anche la trasformazione del vecchio in quello storico. nuovo, tenendo conto di alcune esigenze che il sé detta tempo. Bibliografia
- Berdiaev N.A. Uomo e macchina (Il problema della sociologia e della metafisica della tecnologia) // Domande di filosofia. – 1989. – N. 2.
- Zelinsky F.F. Storia della cultura antica. – M., 1989.
- Losev A.F. Storia dell'estetica antica: Aristotele e i tardi classici. – M., 1975.
- Mayorov G.G. Formazione della filosofia medievale. Patristica latina. – M., 1979.
- Ranovich A.B. Fonti primarie sulla storia del cristianesimo primitivo. Seneca. Lettere morali a Lucinio. – M., 1990.
- Reale J., Antiseri D. La filosofia occidentale dalle origini ai giorni nostri. Antichità. – San Pietroburgo, 1994.
- Frank S.L. Fondamenti spirituali della società / Uomo e società. Fondamenti della civiltà moderna. – M., 1992.
- L'uomo come oggetto di ricerca sociologica / ed. Spiridonov L.I., Gelinsky Ya.I. – Leningrado, 1977.
Istituto di Filosofia e Scienze Politiche del Comitato Scientifico del Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Repubblica del Kazakistan
1. Cultura antica. Un uomo dell'antichità.
Antichità
L'antica cultura del Mediterraneo è considerata una delle creazioni più importanti dell'umanità. Limitata nello spazio (principalmente la costa e le isole dell'Egeo e dello Ionio) e nel tempo (dal II millennio a.C. ai primi secoli del cristianesimo), la cultura antica ha ampliato i confini dell'esistenza storica, affermandosi di diritto con il significato universale dell'architettura e scultura, poesia epica e drammaturgia, scienze naturali e sapere filosofico.
Le antiche civiltà greca e romana occupavano territori geograficamente vicini l'uno all'altro ed esistevano quasi contemporaneamente, quindi non sorprende che siano strettamente imparentati tra loro. Entrambe le civiltà avevano culture diverse che si sviluppavano interagendo tra loro.
L'antichità ha mostrato al mondo varie forme di organizzazione della società umana: politica e sociale. La democrazia è nata nell’antica Grecia, aprendo enormi possibilità umanistiche per la libera espressione di cittadini a pieno titolo, la combinazione di libertà e azione politica organizzata. Roma ha fornito esempi di un sistema repubblicano ben consolidato di vita e di governo, e poi di un impero - non solo come stato, ma come una forma speciale di convivenza di molti popoli con un ruolo speciale per il governo centrale, come stato di "pacificazione" ” di molte tribù, lingue, religioni e terre. Roma ha rivelato al mondo il ruolo più importante del diritto e della regolamentazione di tutti i tipi di rapporti umani e ha mostrato che senza un diritto perfetto non può esistere una società normalmente esistente, che il diritto deve garantire i diritti dei cittadini e delle persone, e il compito di lo Stato deve vigilare sul rispetto della legge.
L'antichità ha trasmesso alle epoche successive la massima "l'uomo è la misura di tutte le cose" e ha mostrato quali vette può raggiungere una persona libera nell'arte, nella conoscenza, nella politica, nella costruzione dello stato e, infine, nella cosa più importante: nella conoscenza di sé e nella conoscenza di sé. miglioramento. Le bellissime statue greche divennero lo standard di bellezza del corpo umano, la filosofia greca divenne un esempio della bellezza del pensiero umano e le migliori azioni degli eroi romani divennero esempi della bellezza del servizio civile e della creazione dello stato.
Nel mondo antico fu compiuto un grandioso tentativo di unire l'Occidente e l'Oriente in un'unica civiltà, per superare la disunità dei popoli e delle tradizioni in una grande sintesi culturale, che rivelò quanto sia fruttuosa l'interazione e la compenetrazione delle culture. Uno dei risultati di questa sintesi fu l'emergere del cristianesimo, che nacque come religione di una piccola comunità alla periferia del mondo romano e si trasformò gradualmente in una religione mondiale.
Arte
Il senso dell’uomo come libero cittadino (un “essere politico”), senza precedenti nella storia, si è riflesso nella cultura artistica e nell’arte, e ha determinato la loro straordinaria ascesa e fioritura. Le conquiste degli antichi greci e romani sono così grandiose che l'intera storia dell'arte mondiale è impensabile senza soggetti antichi, mitologia greca e romana, canoni e campioni antichi.
L'arte antica (V-IV secolo a.C.) è giustamente definita classica, poiché era un modello nell'incarnazione della bellezza perfetta, dove la virtù dell'anima, la forza della mente, è completamente fusa con la bellezza del corpo . Ciò potrebbe essere espresso nel modo più completo nella scultura. Plutarco ha attirato l'attenzione sull'importanza della scultura nella vita dei Greci, notando che ad Atene c'erano più statue che persone viventi.
La scultura greca raggiunse la sua perfezione nell'opera del grande Fidia, che creò molte bellissime creazioni, tra cui spiccava la famosa statua di Zeus Olimpio, realizzata in avorio e oro. La maestosa statua di 14 metri di un formidabile dio seduto su un trono era l'incarnazione della saggezza e della filantropia. Era considerata una delle sette “meraviglie del mondo” ed è conosciuta solo attraverso descrizioni e immagini su monete antiche.
Tra gli altri scultori che glorificarono l'arte antica, si dovrebbero citare: Prassitele, che fu il primo nella storia a raffigurare Afrodite sotto forma di una bellissima donna nuda (Afrodite di Cnido); Lisippo, che lasciò ai suoi discendenti un bellissimo ritratto di Alessandro Magno (conservato anche in copia romana); Leochares, autore del leggendario Apollo Belvedere.
Architettura
Insieme alla scultura, l'architettura antica raggiunse il suo massimo splendore, molti monumenti dei quali, fortunatamente, sono sopravvissuti fino ad oggi. Il Grande Partenone e le rovine del Colosseo impressionano ancora oggi per la loro bellezza e imponenza.
Il principio fondamentale di opportunità, chiarezza e coraggio del pensiero ingegneristico ha permesso di soddisfare sia le esigenze quotidiane di una vasta popolazione sia il sofisticato gusto estetico degli aristocratici (le loro ville con parchi e palazzi avevano prezzi favolosi). Le tradizioni etrusche in architettura e l'invenzione del cemento permisero ai romani di passare dai semplici soffitti a travi ad archi, volte e cupole.
I romani passarono alla storia come costruttori eccezionali. Costruirono strutture monumentali, anche le cui rovine stupiscono ancora l'immaginazione. Questi includono anfiteatri, circhi, stadi, terme (bagni pubblici), palazzi di imperatori e nobili. A Roma costruirono condomini - insula - con 3-6, e talvolta anche 8 piani.
I templi romani, con la loro forma rettangolare e portici, somigliavano a quelli greci, ma a differenza di questi ultimi erano eretti su alte piattaforme con scale (podi). Nell'architettura del tempio romano veniva utilizzato il tipo di rotonda, cioè un tempio rotondo. Questo era uno dei templi più antichi: il Tempio di Vesta. Il risultato più significativo della tecnologia costruttiva romana fu il tempio di tutti gli dei: il Pantheon a Roma. La cupola del Pantheon con un diametro di 43 m era considerata la più grande del mondo.
Indubbiamente, l'edificio romano più grandioso è la costruzione dell'anfiteatro: il Colosseo, che era un'ellisse con una circonferenza di 524 metri, il muro del Colosseo era alto 50 metri ed era costituito da tre livelli.
Già nel II secolo. AVANTI CRISTO e. I costruttori romani inventarono il cemento, che contribuì alla diffusione delle strutture a volta ad arco, che divennero un elemento caratteristico dell'architettura romana, come gli archi di trionfo - monumenti di gloria militare e imperiale. Un certo numero di archi - portici furono utilizzati nella costruzione di ponti in pietra a più livelli, all'interno dei quali c'erano tubi che fornivano acqua alla città. Le fondamenta del Colosseo (I secolo) con una profondità di 5 m furono costruite in cemento, così come le fortezze, i ponti, gli acquedotti, i moli portuali e le strade.
Tra i vari divertimenti tanto amati nell'antichità, il teatro occupava un posto particolarmente importante nella vita degli antichi greci e romani: svolgeva varie funzioni, tra cui morali ed etiche, educative e umanistiche. Ad Atene nel V secolo. AVANTI CRISTO AC, che divenne il centro della creatività letteraria e poetica, fiorirono la tragedia e la commedia. La tragedia - una traduzione diretta di "canto delle capre" - nasce da un canto corale cantato da satiri vestiti di pelli di capra e raffiguranti i compagni costanti del dio del vino Dioniso. Divenne una forma ufficiale di creatività quando ad Atene fu approvata la festa nazionale del Grande Dionisio.
Le più popolari furono le tragedie dei tre più grandi drammaturghi ateniesi: Eschilo, Sofocle ed Euripide. Ognuno di loro ha risolto i problemi del bene e del male, del destino e della punizione, della gioia e della compassione a modo suo. Aristotele nella sua Poetica, definendo la tragedia, dice che essa “attraverso la compassione e la paura purifica tali passioni” e provoca la catarsi (purificazione).
Il fiorire di un altro genere - la commedia - è associato al nome di Aristotele. Le trame delle commedie furono tratte dall'allora vita politica di Atene, a differenza delle tragedie, le cui trame erano basate sul passato mitologico. Le immagini artistiche create da famosi drammaturghi si distinguono per la profondità delle loro caratteristiche psicologiche e per secoli hanno emozionato molte generazioni di spettatori. Prometeo, Edipo, Medea, Fedra personificano il passato leggendario dei secoli antichi.
Letteratura
Lo sviluppo della letteratura antica, nata dal folklore e dalle leggende eroiche del passato, è strettamente connesso con il teatro antico. Il periodo scritto della letteratura greca antica inizia con i poemi di Omero e continua nell'epopea didattica di Esiodo (Teogonia, Opere e Giorni). Uno dei migliori parolieri romani fu Catullo, che dedicò molte poesie sull'amore alla famosa bellezza Clodia. Tuttavia, l '"età dell'oro" per la poesia romana fu il regno di Ottaviano Augusto (27 a.C. - 14 d.C.). Nell'"età augustea" vissero e operarono i tre poeti romani più famosi: Virgilio, Orazio, Ovidio. L'Eneide incompiuta di Virgilio glorificava la grandezza di Roma e lo spirito romano. Orazio apprezzava molto l'obiettivo del poeta, espresso nel suo famoso "Monumento", imitato da molti poeti, tra cui A. S. Pushkin. L'indubbio apice della poesia d'amore romana è l'opera di Ovidio, che è stata incarnata in opere famose come le poesie "Metamorfosi", "La scienza dell'amore", ecc.
Il tutore di Nerone, il famoso filosofo Seneca, diede un contributo significativo allo sviluppo del genere tragico. È stata questa antica tragedia che i drammaturghi moderni hanno scelto come modello. Le tragedie di Seneca sono scritte nello spirito del "nuovo stile": monologhi patetici prolungati, metafore e confronti ingombranti sono destinati più al lettore che allo spettatore.
Olimpiadi
L'espressione più sorprendente dell'antico agon furono i famosi Giochi Olimpici, che la Grecia diede al mondo. Le origini delle prime Olimpiadi si perdono nell'antichità, ma nel 776 a.C. e. Era la prima volta che il nome del vincitore della gara veniva scritto su una tavoletta di marmo, e quest'anno è considerato l'inizio del periodo storico dei Giochi Olimpici. Il luogo dei festeggiamenti olimpici era il bosco sacro di Altis. Il posto è stato scelto molto bene. Tutti gli edifici, sia primi che successivi - templi, tesorerie, uno stadio, un ippodromo - furono eretti in una valle pianeggiante incorniciata da morbide colline ricoperte di fitta vegetazione. La natura di Olimpia sembra essere intrisa dello spirito di pace e prosperità instaurato durante i Giochi Olimpici. Migliaia di spettatori si accampano nel bosco sacro. Ma la gente è venuta qui non solo per il bene delle competizioni, qui sono stati conclusi accordi commerciali, poeti, oratori e scienziati si sono rivolti al pubblico con i loro nuovi discorsi e opere, artisti e scultori hanno presentato ai presenti i loro dipinti e sculture. Lo stato aveva il diritto di annunciare qui nuove leggi, trattati e altri documenti importanti. Una volta ogni quattro anni si teneva una vacanza, simile a quella che l'antichità non conosceva: una festa di comunicazione spirituale tra le migliori menti e i talenti più brillanti della Grecia.
È l'unità di due culture, l'antica greca e l'antica romana. Si distingue tre periodi principali: arcaico (VII - VI secolo aC), classico (V - IV secolo aC) ed ellenistico (III secolo aC - IV secolo dC). Se nell'era arcaica la cultura antica sta attraversando un periodo della sua formazione, non avendo ancora forme completate, allora l'era dei classici primi e maturi è giustamente considerata la “età dell'oro” dell'arte antica, ...
L'autorealizzazione creativa è stata di grande importanza per la formazione di idee sulla cultura. Il metodo utilizzato da Hegel per creare il suo sistema filosofico divenne la base per la successiva professionalizzazione della conoscenza della cultura. Hegel, come una volta fece I. Newton, percepiva l'universo come un ordine armonioso. Ma per lui l'Universo non era un meccanismo, bensì un organismo complesso sorto grazie a...