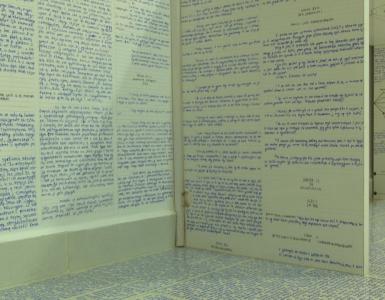Non ha la capacità di coagulare. Coagulazione e coagulazione del sangue: concetto, indicatori, test e norme. Fattori che impediscono la coagulazione del sangue
Coagulazione del sangue- questa è la fase più importante del sistema emostatico, responsabile dell'arresto del sanguinamento quando il sistema vascolare del corpo è danneggiato. Si forma la combinazione di vari fattori della coagulazione del sangue che interagiscono tra loro in modo molto complesso sistema di coagulazione del sangue.
La coagulazione del sangue è preceduta dallo stadio dell'emostasi vascolare-piastrinica primaria. Questa emostasi primaria è quasi interamente dovuta alla vasocostrizione e all'occlusione meccanica degli aggregati piastrinici nel sito del danno alla parete vascolare. Il tempo caratteristico per l'emostasi primaria in una persona sana è di 1-3 minuti. La stessa coagulazione del sangue (emocoagulazione, coagulazione, emostasi plasmatica, emostasi secondaria) è un complesso processo biologico di formazione dei fili proteici di fibrina nel sangue, che polimerizzano e formano coaguli di sangue, a seguito dei quali il sangue perde la sua fluidità, acquisendo un aspetto formaggioso consistenza. La coagulazione del sangue in una persona sana avviene localmente, nel sito di formazione del tappo piastrinico primario. Il tempo caratteristico per la formazione di un coagulo di fibrina è di circa 10 minuti. La coagulazione del sangue è un processo enzimatico.
Il fondatore della moderna teoria fisiologica della coagulazione del sangue è Alexander Schmidt. Nella ricerca scientifica del 21° secolo, condotta sulla base del Centro di ricerca ematologica sotto la guida di Ataullakhanova F.I., è stato dimostrato in modo convincente che la coagulazione del sangue è un tipico processo di autoonda in cui gli effetti della memoria della biforcazione giocano un ruolo significativo.
YouTube enciclopedico
-
1 / 5
Il processo di emostasi si riduce alla formazione di un coagulo piastrinico-fibrinico. Viene convenzionalmente suddiviso in tre fasi:
- vasospasmo temporaneo (primario);
- formazione di un tappo piastrinico dovuto all'adesione e aggregazione delle piastrine;
- retrazione (contrazione e compattazione) del tappo piastrinico.
Il danno vascolare è accompagnato dall'attivazione immediata delle piastrine. L'adesione (attaccamento) delle piastrine alle fibre del tessuto connettivo sui bordi della ferita è causata dalla glicoproteina del fattore von Willebrand. Contemporaneamente all'adesione, avviene l'aggregazione piastrinica: le piastrine attivate si attaccano ai tessuti danneggiati e tra loro, formando aggregati che bloccano il percorso verso la perdita di sangue. Appare un tappo piastrinico.
Dalle piastrine che hanno subito adesione e aggregazione, vengono secrete intensamente varie sostanze biologicamente attive (ADP, adrenalina, norepinefrina e altre), che portano all'aggregazione secondaria e irreversibile. Contemporaneamente al rilascio dei fattori piastrinici si forma la trombina, che agisce sul fibrinogeno per formare una rete di fibrina in cui i singoli globuli rossi e bianchi rimangono bloccati: si forma un cosiddetto coagulo piastrine-fibrina (tappo piastrinico). Grazie alla proteina contrattile trombostenina, le piastrine vengono attratte l'una verso l'altra, il tappo piastrinico si contrae e si ispessisce e avviene la sua retrazione.
Processo di coagulazione del sangue
Il processo di coagulazione del sangue è prevalentemente una cascata proenzima-enzima in cui i proenzimi, passando allo stato attivo, acquisiscono la capacità di attivare altri fattori della coagulazione del sangue. Nella sua forma più semplice, il processo di coagulazione del sangue può essere suddiviso in tre fasi:
- fase di attivazione include un complesso di reazioni sequenziali che portano alla formazione di protrombinasi e alla transizione della protrombina in trombina;
- fase di coagulazione- formazione di fibrina dal fibrinogeno;
- fase di retrazione- formazione di un denso coagulo di fibrina.
Questo schema fu descritto nel 1905 da Morawitz e non ha ancora perso la sua rilevanza.
Dal 1905 sono stati compiuti progressi significativi nella comprensione dettagliata della coagulazione del sangue. Sono state scoperte dozzine di nuove proteine e reazioni coinvolte nel processo di coagulazione del sangue, che ha una natura a cascata. La complessità di questo sistema è dovuta alla necessità di regolamentare questo processo.
Una rappresentazione moderna dal punto di vista fisiologico della cascata di reazioni che accompagnano la coagulazione del sangue è presentata in Fig. 2 e 3. A causa della distruzione delle cellule tissutali e dell'attivazione delle piastrine, vengono rilasciate proteine fosfolipoproteiche che, insieme ai fattori plasmatici X a e Va, nonché agli ioni Ca 2+, formano un complesso enzimatico che attiva la protrombina. Se il processo di coagulazione inizia sotto l'influenza delle fosfolipoproteine rilasciate dalle cellule dei vasi danneggiati o del tessuto connettivo, stiamo parlando di sistema esterno di coagulazione del sangue(via di attivazione estrinseca della coagulazione o via del fattore tissutale). I componenti principali di questa via sono 2 proteine: il fattore VIIa e il fattore tissutale, il complesso di queste 2 proteine è anche chiamato complesso della tenasi estrinseca.
Se l'inizio avviene sotto l'influenza dei fattori della coagulazione presenti nel plasma, viene utilizzato il termine sistema di coagulazione interna. Il complesso dei fattori IXa e VIIIa che si forma sulla superficie delle piastrine attivate è chiamato tenasi intrinseca. Pertanto, il fattore X può essere attivato sia dal complesso VIIa-TF (tenasi estrinseca) che dal complesso IXa-VIIIa (tenasi intrinseca). I sistemi di coagulazione del sangue esterno ed interno si completano a vicenda.
Durante il processo di adesione, la forma delle piastrine cambia: diventano cellule arrotondate con processi spinosi. Sotto l'influenza dell'ADP (parzialmente rilasciato dalle cellule danneggiate) e dell'adrenalina, aumenta la capacità delle piastrine di aggregarsi. Allo stesso tempo, da essi vengono rilasciati serotonina, catecolamine e una serie di altre sostanze. Sotto la loro influenza, il lume dei vasi danneggiati si restringe e si verifica un'ischemia funzionale. Alla fine i vasi vengono occlusi da una massa di piastrine che aderiscono ai bordi delle fibre di collagene ai margini della ferita.
In questa fase dell'emostasi, la trombina si forma sotto l'azione della tromboplastina tissutale. È lui che dà inizio all'aggregazione piastrinica irreversibile. Reagendo con specifici recettori presenti sulla membrana piastrinica, la trombina provoca la fosforilazione delle proteine intracellulari e il rilascio di ioni Ca 2+.
In presenza di ioni calcio nel sangue, sotto l'influenza della trombina, avviene la polimerizzazione del fibrinogeno solubile (vedi fibrina) e la formazione di una rete priva di struttura di fibre di fibrina insolubili. A partire da questo momento, gli elementi formatisi del sangue cominciano a filtrare in questi fili, creando ulteriore rigidità all'intero sistema, e dopo qualche tempo formando un coagulo piastrino-fibrinoso (trombo fisiologico), che ostruisce il sito di rottura, da un lato da una parte, prevenendo la perdita di sangue e, dall'altra, bloccando l'ingresso di sostanze e microrganismi esterni nel sangue. La coagulazione del sangue è influenzata da molte condizioni. Ad esempio, i cationi accelerano il processo e gli anioni lo rallentano. Inoltre, ci sono sostanze che bloccano completamente la coagulazione del sangue (eparina, irudina e altre) e la attivano (veleno di vipera, feracryl).
I disturbi congeniti del sistema di coagulazione del sangue sono chiamati emofilia.
Metodi per diagnosticare la coagulazione del sangue
L'intera varietà di test clinici del sistema di coagulazione del sangue può essere divisa in due gruppi:
- test globali (integrali, generali);
- test “locali” (specifici).
I test globali caratterizzano il risultato dell'intera cascata della coagulazione. Sono adatti per diagnosticare le condizioni generali del sistema di coagulazione del sangue e la gravità delle patologie, tenendo conto contemporaneamente di tutti i fattori che influenzano. I metodi globali svolgono un ruolo chiave nella prima fase della diagnosi: forniscono un quadro completo dei cambiamenti che si verificano nel sistema di coagulazione e consentono di prevedere la tendenza all'iper o all'ipocoagulazione nel suo insieme. I test "locali" caratterizzano il risultato del lavoro delle singole parti della cascata del sistema di coagulazione del sangue, nonché dei singoli fattori di coagulazione. Sono indispensabili per l'eventuale chiarimento della localizzazione della patologia con l'accuratezza del fattore di coagulazione. Per ottenere un quadro completo dell'emostasi del paziente, il medico deve poter scegliere di quale esame necessitare.
Test globali:
- determinazione del tempo di coagulazione del sangue intero (metodo Mas-Magro o metodo Morawitz);
- test di generazione della trombina (potenziale di trombina, potenziale di trombina endogena);
Prove "locali".:
- tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT);
- test del tempo di protrombina (o test della protrombina, INR, PT);
- metodi altamente specializzati per identificare cambiamenti nella concentrazione di fattori individuali.
Appartengono ai metodi di coagulazione (dall'inglese clot) tutti i metodi che misurano l'intervallo di tempo dal momento dell'aggiunta di un reagente (un attivatore che avvia il processo di coagulazione) fino alla formazione di un coagulo di fibrina nel plasma in esame.
Esempi di disturbi della coagulazione del sangue:
Guarda anche
Appunti
- Ataullakhanov F.I., Zarnitsyna V. I., Kondratovich A. Yu., Lobanova E. S., Sarbash V. I. Una classe speciale di autoonde – autoonde con arresto – determina la dinamica spaziale della coagulazione del sangue (russo) // UFN: diario. - 2002. - T. 172, n. 6. - P. 671-690. -
Uno dei processi più importanti che si verificano nel nostro corpo è la coagulazione del sangue. Il suo schema sarà descritto di seguito (sono fornite anche le immagini per chiarezza). E poiché si tratta di un processo complesso, vale la pena considerarlo in dettaglio.
Come sta andando tutto?
Pertanto, il processo designato è responsabile dell’arresto del sanguinamento che si verifica a causa di un danno a uno o un altro componente del sistema vascolare del corpo.
In termini semplici si possono distinguere tre fasi. Il primo è l'attivazione. Dopo il danno alla nave iniziano a verificarsi reazioni successive che alla fine portano alla formazione della cosiddetta protrombinasi. Questo è un complesso complesso costituito da V e X. Si forma sulla superficie fosfolipidica delle membrane piastriniche.
La seconda fase è la coagulazione. In questa fase, la fibrina è formata dal fibrinogeno, una proteina ad alto peso molecolare, che è la base dei coaguli di sangue, la cui comparsa implica la coagulazione del sangue. Il diagramma seguente mostra chiaramente questa fase.
E infine, la terza fase. Implica la formazione di un coagulo di fibrina con una struttura densa. Del resto, è lavandolo e asciugandolo che si ottiene il “materiale” che viene poi utilizzato per preparare pellicole sterili e spugne per arrestare le emorragie causate dalla rottura di piccoli vasi durante gli interventi chirurgici.

A proposito di reazioni
Lo schema è stato brevemente descritto sopra, ma tra l'altro è stato sviluppato nel 1905 da un coagulologo di nome Paul Oskar Morawitz. E non ha perso la sua rilevanza fino ad oggi.
Ma dal 1905 molto è cambiato nella comprensione della coagulazione del sangue come processo complesso. Grazie al progresso, ovviamente. Gli scienziati sono riusciti a scoprire decine di nuove reazioni e proteine coinvolte in questo processo. E ora il modello a cascata della coagulazione del sangue è più comune. Grazie a lei, la percezione e la comprensione di un processo così complesso diventano un po' più comprensibili.
Come puoi vedere nell’immagine qui sotto, ciò che sta accadendo è letteralmente “scomposto in mattoni”. Vengono presi in considerazione i sistemi interni ed esterni: sangue e tessuti. Ciascuno è caratterizzato da una certa deformazione che si verifica a seguito del danno. Nel sistema sanguigno vengono danneggiati le pareti vascolari, il collagene, le proteasi (enzimi di rottura) e le catecolamine (molecole mediatrici). Nel tessuto si osserva un danno cellulare, a seguito del quale viene rilasciata tromboplastina. Che è lo stimolatore più importante del processo di coagulazione (altrimenti chiamato coagulazione). Entra direttamente nel sangue. Questa è la sua “via”, ma ha un carattere protettivo. Dopotutto, è la tromboplastina che avvia il processo di coagulazione. Dopo il suo rilascio nel sangue iniziano le tre fasi sopra descritte.
Tempo
Quindi, cosa rappresenta approssimativamente la coagulazione del sangue, il diagramma ha aiutato a capire. Adesso vorrei parlare un po’ del tempo.
L'intero processo richiede un massimo di 7 minuti. La prima fase dura dalle cinque alle sette. Durante questo periodo si forma la protrombina. Questa sostanza è un tipo complesso di struttura proteica responsabile del processo di coagulazione e della capacità del sangue di addensarsi. Che viene utilizzato dal nostro corpo per formare un coagulo di sangue. Intasa l'area danneggiata, interrompendo l'emorragia. Tutto ciò richiede 5-7 minuti. La seconda e la terza fase si verificano molto più velocemente. In 2-5 secondi. Perché queste fasi della coagulazione del sangue (diagramma fornito sopra) influenzano i processi che si verificano ovunque. Ciò significa direttamente sul luogo del danno.
La protrombina, a sua volta, si forma nel fegato. E la sua sintesi richiede tempo. La velocità con cui viene prodotta una quantità sufficiente di protrombina dipende dalla quantità di vitamina K contenuta nel corpo. Se ciò non bastasse, sarà difficile fermare l’emorragia. E questo è un problema serio. Poiché la mancanza di vitamina K indica una violazione della sintesi della protrombina. E questa è una malattia che deve essere curata.

Stabilizzazione della sintesi
Bene, lo schema generale della coagulazione del sangue è chiaro: ora dovremmo prestare un po' di attenzione all'argomento su cosa è necessario fare per ripristinare la quantità necessaria di vitamina K nel corpo.
Per cominciare, mangia bene. La maggior quantità di vitamina K si trova nel tè verde: 959 mcg per 100 g! Tre volte di più, tra l'altro, che in nero. Pertanto, vale la pena berlo attivamente. Non dovresti trascurare le verdure: spinaci, cavolo bianco, pomodori, piselli, cipolle.
Anche la carne contiene vitamina K, ma non tutta: solo vitello, fegato di manzo e agnello. Ma la minima quantità si trova nell'aglio, nell'uvetta, nel latte, nelle mele e nell'uva.
Tuttavia, se la situazione è grave, sarà difficile aiutare solo con una varietà di menu. Di solito, i medici consigliano vivamente di combinare la dieta con i farmaci prescritti. Non è necessario ritardare il trattamento. È necessario avviarlo il prima possibile per normalizzare il meccanismo di coagulazione del sangue. Il regime terapeutico viene prescritto direttamente dal medico ed è anche obbligato ad avvertire cosa può accadere se le raccomandazioni vengono trascurate. E le conseguenze possono essere disfunzioni epatiche, sindrome tromboemorragica, malattie tumorali e danni alle cellule staminali del midollo osseo.
Schema di Schmidt
Alla fine del XIX secolo visse un famoso fisiologo e dottore in scienze mediche. Il suo nome era Alexander Alexandrovich Schmidt. Visse per 63 anni e dedicò la maggior parte del suo tempo alla ricerca su problemi di ematologia. Ma ha studiato con particolare attenzione il tema della coagulazione del sangue. È stato in grado di stabilire la natura enzimatica di questo processo, a seguito della quale lo scienziato ne ha offerto una spiegazione teorica. Ciò è chiaramente rappresentato dal diagramma della coagulazione del sangue riportato di seguito.
Innanzitutto la nave danneggiata si contrae. Quindi si forma un tappo piastrinico primario allentato nel sito del difetto. Poi si rafforza. Di conseguenza, si forma un coagulo di sangue rosso (altrimenti noto come coagulo di sangue). Dopo di che si dissolve parzialmente o completamente.
Durante questo processo compaiono alcuni fattori della coagulazione del sangue. Anche il diagramma, nella sua versione ampliata, li visualizza. Sono designati da numeri arabi. E ce ne sono 13 in totale e ognuno ha bisogno di essere raccontato.

Fattori
Uno schema completo di coagulazione del sangue è impossibile senza elencarli. Bene, vale la pena iniziare con il primo.
Il fattore I è una proteina incolore, il fibrinogeno. Sintetizzato nel fegato, disciolto nel plasma. Il fattore II è la protrombina, già menzionata sopra. La sua capacità unica è quella di legare gli ioni calcio. Ed è proprio dopo la scomposizione di questa sostanza che si forma un enzima della coagulazione.
Il fattore III è una lipoproteina, tromboplastina tissutale. È comunemente chiamato trasporto di fosfolipidi, colesterolo e triacilgliceridi.
Il fattore successivo, IV, sono gli ioni Ca2+. Gli stessi che si legano sotto l'influenza della proteina incolore. Sono coinvolti in molti processi complessi, oltre alla coagulazione, ad esempio nella secrezione dei neurotrasmettitori.
Il fattore V è una globulina. Che si forma anche nel fegato. È necessario per legare i corticosteroidi (sostanze ormonali) e il loro trasporto. Il fattore VI è esistito per un certo periodo, ma poi si è deciso di rimuoverlo dalla classificazione. Perché gli scienziati hanno scoperto che contiene il fattore V.
Ma non hanno cambiato la classificazione. Pertanto, dopo V viene il fattore VII. Compresa la proconvertina, con la partecipazione della quale si forma la protrombinasi tissutale (prima fase).
Il fattore VIII è una proteina espressa in una singola catena. Conosciuta come globulina antiemofila A. È a causa della sua carenza che si sviluppa una rara malattia ereditaria come l'emofilia. Il fattore IX è “correlato” a quello menzionato in precedenza. Poiché è una globulina antiemofila B. Il fattore X è una globulina diretta sintetizzata nel fegato.
E infine, gli ultimi tre punti. Questi sono il fattore Rosenthal, il fattore Hageman e la stabilizzazione della fibrina. Insieme influenzano la formazione di legami intermolecolari e il normale funzionamento di un processo come la coagulazione del sangue.
Lo schema di Schmidt include tutti questi fattori. Ed è sufficiente familiarizzare rapidamente con loro per capire quanto sia complesso e multivalore il processo descritto.

Sistema anticoagulante
Bisogna tenere presente anche questo concetto. Il sistema di coagulazione del sangue è stato descritto sopra: anche il diagramma mostra chiaramente il corso di questo processo. Ma avviene anche la cosiddetta “anticoagulazione”.
Per cominciare, vorrei sottolineare che nel corso dell'evoluzione gli scienziati hanno risolto due problemi completamente opposti. Hanno cercato di capire come riesce il corpo a impedire al sangue di fuoriuscire dai vasi danneggiati e allo stesso tempo a mantenerlo intatto allo stato liquido? Ebbene, la soluzione al secondo problema fu la scoperta del sistema anticoagulante.
È un certo insieme di proteine plasmatiche che possono ridurre la velocità delle reazioni chimiche. Cioè, inibire.
E l'antitrombina III è coinvolta in questo processo. La sua funzione principale è controllare il funzionamento di alcuni fattori che includono il processo di coagulazione del sangue. È importante chiarire: non regola la formazione di un coagulo di sangue, ma elimina gli enzimi non necessari che entrano nel flusso sanguigno dal luogo in cui si forma. Perché è necessario? Per prevenire la diffusione della coagulazione nelle aree del flusso sanguigno danneggiate.

Elemento ostruttivo
Parlando di cos'è il sistema di coagulazione del sangue (il cui diagramma è presentato sopra), non si può non notare una sostanza come l'eparina. È un glicosaminoglicano acido contenente zolfo (un tipo di polisaccaride).
Questo è un anticoagulante diretto. Una sostanza che inibisce l'attività del sistema di coagulazione. È l'eparina che impedisce la formazione di coaguli di sangue. Come avviene questo? L'eparina riduce semplicemente l'attività della trombina nel sangue. Tuttavia è una sostanza naturale. Ed è vantaggioso. Se introduci questo anticoagulante nel corpo, puoi favorire l'attivazione dell'antitrombina III e della lipoproteina lipasi (enzimi che scompongono i trigliceridi, le principali fonti di energia per le cellule).
Pertanto, l’eparina viene spesso utilizzata per trattare le condizioni trombotiche. Solo una sua molecola può attivare una grande quantità di antitrombina III. Di conseguenza, l'eparina può essere considerata un catalizzatore, poiché l'effetto in questo caso è molto simile all'effetto da loro causato.
Ci sono altre sostanze con lo stesso effetto contenute in Take, ad esempio l'α2-macroglobulina. Promuove la rottura dei coaguli di sangue, influenza il processo di fibrinolisi e funge da trasporto per gli ioni 2-valenti e alcune proteine. Inibisce inoltre le sostanze coinvolte nel processo di coagulazione.
Cambiamenti osservati
C'è un'altra sfumatura che il tradizionale diagramma della coagulazione del sangue non mostra. La fisiologia del nostro corpo è tale che molti processi comportano non solo cambiamenti chimici. Ma anche fisico. Se potessimo osservare la coagulazione ad occhio nudo, vedremmo che la forma delle piastrine cambia durante il processo. Si trasformano in cellule rotonde con caratteristici processi simili a spine, necessari per l'implementazione intensiva dell'aggregazione: la combinazione di elementi in un unico insieme.
Ma non è tutto. Durante il processo di coagulazione, le piastrine rilasciano varie sostanze: catecolamine, serotonina, ecc. Per questo motivo, il lume delle navi danneggiate si restringe. Cosa causa l’ischemia funzionale? L'afflusso di sangue all'area danneggiata è ridotto. E, di conseguenza, anche l'effusione viene gradualmente ridotta al minimo. Ciò dà alle piastrine l'opportunità di coprire le aree danneggiate. A causa dei loro processi spinosi, sembrano essere “attaccati” ai bordi delle fibre di collagene che si trovano ai margini della ferita. Ciò termina la prima fase di attivazione, la più lunga. Termina con la formazione di trombina. Seguono ancora alcuni secondi della fase di coagulazione e retrazione. E l'ultima fase è il ripristino della normale circolazione sanguigna. E conta molto. Poiché la completa guarigione della ferita è impossibile senza un buon apporto di sangue.

Buono a sapersi
Bene, questo è più o meno come appare a parole un diagramma semplificato della coagulazione del sangue. Tuttavia, ci sono alcune altre sfumature che vorrei notare.
Emofilia. È già stato menzionato sopra. Questa è una malattia molto pericolosa. Qualsiasi emorragia è difficile per la persona che ne soffre. La malattia è ereditaria e si sviluppa a causa di difetti nelle proteine coinvolte nel processo di coagulazione. Può essere rilevato in modo abbastanza semplice: con il minimo taglio una persona perderà molto sangue. E passerà molto tempo a fermarlo. E nelle forme particolarmente gravi, l'emorragia può iniziare senza motivo. Le persone affette da emofilia possono sperimentare una disabilità precoce. Poiché frequenti emorragie nel tessuto muscolare (ematomi comuni) e nelle articolazioni non sono rare. Esiste una cura per questo? Con difficoltà. Una persona deve letteralmente trattare il proprio corpo come un vaso fragile e stare sempre attenta. Se si verifica un sanguinamento, deve essere somministrato urgentemente sangue fresco di donatore contenente il fattore XVIII.
In genere, questa malattia colpisce gli uomini. E le donne fungono da portatrici del gene dell'emofilia. È interessante notare che la regina Vittoria britannica era una di queste. La malattia è stata trasmessa a uno dei suoi figli. Degli altri due non si sa. Da allora, l'emofilia, tra l'altro, è spesso chiamata la malattia reale.
Ma ci sono anche casi opposti. Ciò significa che se viene osservato, anche la persona non deve essere meno attenta. L'aumento della coagulabilità indica un alto rischio di formazione di trombi intravascolari. Che intasano interi vasi. Spesso la conseguenza può essere una tromboflebite, accompagnata da un'infiammazione delle pareti venose. Ma questo difetto è più facile da trattare. Spesso, a proposito, viene acquisito.
È incredibile quante cose succedono nel corpo umano quando ti tagli semplicemente con un pezzo di carta. Puoi parlare a lungo delle caratteristiche del sangue, della sua coagulazione e dei processi che lo accompagnano. Ma tutte le informazioni più interessanti, nonché i diagrammi che lo dimostrano chiaramente, sono riportate sopra. Il resto, se lo si desidera, può essere visualizzato individualmente.
La coagulazione del sangue - il passaggio dallo stato liquido a un coagulo gelatinoso - è una reazione protettiva biologicamente importante del corpo che impedisce la perdita di sangue.
Nel punto della lesione di un piccolo vaso sanguigno, viene creato un coagulo di sangue: un trombo, che è come un tappo che ostruisce il vaso e interrompe l'ulteriore sanguinamento. Quando la capacità del sangue di coagulare è ridotta, anche lesioni minori possono causare emorragie fatali.
Il sangue umano rilasciato dai vasi inizia a coagularsi dopo 3-4 minuti e dopo 5-6 minuti si trasforma completamente in un coagulo gelatinoso. Se il rivestimento interno (intima) dei vasi sanguigni è danneggiato e in caso di aumento della coagulazione del sangue, la coagulazione del sangue può verificarsi anche all'interno dei vasi sanguigni in tutto il corpo. In questo caso, si forma un coagulo di sangue all'interno della nave.
La coagulazione del sangue si basa su un cambiamento nello stato fisico-chimico della proteina contenuta nel plasma: il fibrinogeno. Quest'ultima passa dalla forma solubile a quella insolubile, trasformandosi in fibrina e formando un coagulo.
La fibrina cade sotto forma di fili lunghi e sottili, formando reti nei cui anelli vengono trattenuti gli elementi formati. Se il sangue rilasciato dalla nave viene battuto con una pannocchia, la maggior parte della fibrina formata rimane sulla pannocchia. La fibrina, ben lavata dai globuli rossi, ha un colore bianco e una struttura fibrosa.
Il sangue da cui è stata rimossa la fibrina in questo modo è chiamato defibrinato. È costituito da elementi formati e siero sanguigno. Di conseguenza, il siero del sangue differisce nella composizione dal plasma in assenza di fibrinogeno.
Il siero può essere separato da un coagulo di sangue lasciando per un po’ una provetta piena di sangue coagulato. In questo caso, il coagulo di sangue nella provetta viene compattato, serrato e da esso viene espulsa una certa quantità di siero.
Riso. 2. Diagramma della coagulazione del sangue.
Non solo il sangue intero, ma anche il plasma può coagulare. Se si separa il plasma dagli elementi formati mediante centrifugazione a freddo, che impedisce la coagulazione del sangue, e poi si scalda il plasma a 20-35°, si coagulerà rapidamente.
Sono state proposte numerose teorie per spiegare il meccanismo della coagulazione del sangue. Attualmente è generalmente accettata la teoria enzimatica della coagulazione del sangue, le cui basi furono gettate quasi un secolo fa da A. Schmidt.
Secondo questa teoria, lo stadio finale della coagulazione è la transizione del fibrinogeno disciolto nel plasma in fibrina insolubile sotto l'influenza dell'enzima trombina (Fig. 2, stadio III).
Non c'è trombina nel sangue circolante. È formato da una proteina del plasma sanguigno: la protrombina, sintetizzata dal fegato. Per la formazione della trombina è necessaria l'interazione della protrombina con la tromboplastina, che deve avvenire in presenza di ioni calcio (Fig. 2, stadio II).
Inoltre non c'è tromboplastina nel sangue circolante. Si forma quando le piastrine del sangue vengono distrutte (tromboplastina nel sangue) o il tessuto viene danneggiato (tromboplastina tissutale).
La formazione della tromboplastina nel sangue inizia con la distruzione delle piastrine del sangue e l'interazione delle sostanze rilasciate con la globulina presente nel plasma sanguigno - il fattore V (l'altro nome è globulina acceleratore) e con un'altra globulina nel plasma sanguigno - la così- chiamata globulina antiemofila (il suo altro nome è tromboplastinogeno), e anche con un'altra sostanza nel plasma sanguigno - il cosiddetto componente plasmatico della tromboplastina (il suo altro nome è fattore di Natale). Inoltre, la formazione della tromboplastina nel sangue richiede anche la presenza di ioni calcio (vedi Fig. 2, stadio I, a sinistra).
La formazione della tromboplastina tissutale avviene attraverso l'interazione delle sostanze rilasciate dalle cellule tissutali distrutte con la già menzionata globulina del plasma sanguigno - fattore V, nonché con la globulina del plasma sanguigno - fattore VII (il suo altro nome è proconvertina) e anche necessariamente in presenza di ioni calcio (Fig. 2, stadio I, a destra). Dopo la comparsa della tromboplastina, inizia rapidamente il processo di coagulazione del sangue.
Il diagramma sopra è lungi dall'essere completo, poiché in realtà molte più sostanze diverse prendono parte al processo di coagulazione del sangue.
In assenza della suddetta globulina antiemofila nel sangue, che prende parte alla formazione della tromboplastina, si verifica una malattia: l'emofilia, caratterizzata da una netta riduzione della coagulazione del sangue. Con l'emofilia, anche una piccola lesione può portare a una pericolosa perdita di sangue.
Sono stati sviluppati metodi chimici per estrarre la trombina dal plasma e ottenerla in grandi quantità (B. A. Kudryashov). Questo farmaco accelera significativamente la coagulazione del sangue. Pertanto, il sangue ossalato, in cui la trombina non si forma a causa della precipitazione del calcio, si coagula in una provetta entro 2-3 secondi dall'aggiunta della trombina. Se, quando un organo viene danneggiato (ad esempio fegato, milza, cervello), l'emorragia non può essere fermata legando i vasi, l'applicazione di una garza inumidita con una soluzione di trombina sulla loro superficie arresta rapidamente l'emorragia.
Dopo che il fibrinogeno si è trasformato in fibrina, il coagulo risultante diventa più denso, si stringe, in altre parole, avviene la sua retrazione. Questo processo avviene sotto l'influenza di una sostanza chiamata retractozyme, che viene rilasciata durante la degradazione delle piastrine del sangue. Esperimenti sui conigli hanno dimostrato che con una forte diminuzione del numero di piastrine, può verificarsi la coagulazione del sangue, ma il coagulo non si indurisce e rimane allentato, non fornendo una buona chiusura del vaso sanguigno danneggiato.
La coagulazione del sangue cambia sotto l'influenza del sistema nervoso. La coagulazione è accelerata da stimoli dolorosi. L’aumento della coagulazione del sangue previene la perdita di sangue. Quando il nodo simpatico cervicale superiore è irritato, il tempo di coagulazione del sangue si riduce e quando viene rimosso si allunga.
La coagulazione del sangue può anche cambiare condizionatamente. Pertanto, se un segnale viene ripetutamente combinato con una stimolazione dolorosa, quindi sotto l'influenza di un solo segnale, che in precedenza non aveva alcun effetto sulla coagulazione del sangue, questo processo accelera. Si potrebbe pensare che quando il sistema nervoso è irritato, nel corpo si formano alcune sostanze che accelerano la coagulazione del sangue. È noto, ad esempio, che l'adrenalina, il cui rilascio dalle ghiandole surrenali è stimolato dal sistema nervoso e aumenta durante gli stimoli dolorosi e gli stati emotivi, aumenta la coagulazione del sangue. Allo stesso tempo, l’adrenalina restringe le arterie e le arteriole e quindi aiuta anche a ridurre il sanguinamento in caso di lesioni dei vasi sanguigni. Il significato adattivo di questi fatti è chiaro.
Numerosi fattori fisici e composti chimici inibiscono la coagulazione del sangue. A questo proposito, va notato innanzitutto l'effetto del freddo, che rallenta notevolmente il processo di coagulazione del sangue.
La coagulazione del sangue viene rallentata anche se il sangue viene posto in un recipiente di vetro le cui pareti sono rivestite di paraffina o silicone, dopodiché non vengono bagnate dal sangue. In tale vaso, il sangue può rimanere liquido per diverse ore. In queste condizioni la distruzione delle piastrine e il rilascio nel sangue delle sostanze in esse contenute coinvolte nella formazione della trombina sono fortemente ostacolati.
I sali di ossalato e acido citrico prevengono la coagulazione del sangue. Quando il citrato di sodio viene aggiunto al sangue, gli ioni calcio si legano; L'ossalato di ammonio provoca la precipitazione del calcio. In entrambi i casi la formazione di tromboplastina e trombina diventa impossibile. Ossalati e citrati vengono utilizzati solo per prevenire la coagulazione del sangue all'esterno del corpo. Non possono essere introdotti nel corpo in grandi quantità, poiché il legame del calcio nel sangue nel corpo provoca gravi interruzioni delle funzioni vitali.
Alcune sostanze, chiamate anticoagulanti, eliminano completamente la possibilità di coagulazione del sangue. Questi includono l'eparina, rilasciata dal tessuto polmonare ed epatico, e l'irudina, rilasciata dalle ghiandole salivari della sanguisuga. L'eparina interferisce con l'azione della trombina sul fibrinogeno e inibisce anche l'attività della tromboplastina. L'irudina ha un effetto deprimente sulla terza fase del processo di coagulazione del sangue, cioè impedisce la formazione di fibrina.
Esistono anche anticoagulanti della cosiddetta azione indiretta. Senza influenzare direttamente il processo di coagulazione del sangue, inibiscono la formazione delle sostanze coinvolte in questo processo. Questi includono farmaci prodotti sinteticamente: dicumarina, pelentan, ecc., Che bloccano la sintesi della protrombina e del fattore VII nel fegato.
Un'altra sostanza è stata trovata nelle proteine del siero: la fibrinolisina, che dissolve la fibrina formata. Questa sostanza è un enzima presente nel plasma sanguigno in forma inattiva. Il suo precursore, la profibrinolisina, viene attivato dalla fibrinochinasi, presente in molti tessuti del corpo.
Da tutto quanto sopra ne consegue che nel sangue esistono due sistemi contemporaneamente: coagulazione e anticoagulazione. Normalmente si trovano in un certo equilibrio, che impedisce i processi di coagulazione intravascolare. Questo equilibrio viene interrotto da alcune malattie e lesioni.
L'importanza del sistema anticoagulante fisiologico è mostrata negli esperimenti di B. A. Kudryashov. Se una quantità sufficiente di trombina viene iniettata rapidamente nella vena di un animale, si verifica la morte a causa della coagulazione intravascolare. Se la stessa dose letale di trombina viene introdotta lentamente nel corpo, l'animale non muore, ma il suo sangue perde in gran parte la capacità di coagularsi.
Ciò ha portato alla conclusione che la somministrazione di trombina provoca la comparsa di sostanze nel corpo che impediscono la coagulazione del sangue. Il rilascio di queste sostanze è regolato dal sistema nervoso. Se denervi una zampa di un ratto e gli inietti lentamente la trombina nella vena, il sangue si coagulerà solo nei vasi della zampa denervata. Si ritiene che un aumento del livello di trombina nel letto vascolare provochi un rilascio riflesso di sostanze che impediscono la coagulazione dalla parete del vaso. La sezione dei nervi, così come l'esposizione a sostanze narcotiche, sopprimono questo riflesso.
Le piastrine (piastrine del sangue) si formano nel midollo osseo rosso. Il contenuto in 1 ml di sangue è 300mila. Durata della vita 7-9 giorni.
La coagulazione del sangue quando i vasi sanguigni sono danneggiati avviene in 2 fasi. Innanzitutto, le piastrine si uniscono e si forma un trombo temporaneo (fragile). Quindi, sotto l'azione dell'enzima trombina, la proteina fibrinogeno disciolta nel sangue viene convertita in fibrina insolubile, i fili di fibrina si uniscono e si ottiene un coagulo di sangue permanente.
L'incoagulabilità del sangue può essere causata da una carenza di calcio, vitamina K (prodotta dalla microflora intestinale) o da una malattia ereditaria (emofilia).
In una trasfusione di sangue “scorretta”, i globuli rossi trasfusi trasportano antigeni estranei, quindi vengono divorati dai fagociti locali. La massiccia distruzione dei globuli rossi porta alla coagulazione del sangue direttamente nei vasi. (Con una trasfusione di sangue “corretta”, gli anticorpi trasfusi (agglutinine) risultano essere particelle estranee; la loro distruzione da parte dei fagociti locali non porta a conseguenze negative.)
Test
1. L'essenza del processo di coagulazione del sangue è
A) adesione dei globuli rossi
B) la transizione della proteina fibrinogena solubile in proteina fibrina insolubile
C) un aumento del numero di elementi formati in 1 cm3 di sangue
D) accumulo di leucociti attorno a corpi estranei e microrganismi2. Partecipa alla coagulazione del sangue
A) globuli rossi
B) linfociti
B) leucociti
D) piastrine3. L'essenza della coagulazione del sangue è
A) adesione dei globuli rossi
B) conversione del fibrinogeno in fibrina
B) conversione dei leucociti in linfociti
D) incollaggio dei leucociti4. Prima dell'intervento chirurgico, viene determinato il numero di piastrine nel sangue del paziente
A) caratterizzare lo stato del sistema immunitario
B) determinare il contenuto di ossigeno nel sangue
C) identificare l'assenza (o la presenza) di un processo infiammatorio nell'organismo
D) determinare la velocità di coagulazione del sangue5. Il processo di coagulazione del sangue inizia con
A) aumento della pressione sanguigna
B) distruzione delle piastrine
B) accumulo di sangue venoso in una nave
D) formazione di un focolaio locale di infiammazione6. Uno degli stadi della formazione di trombi in un vaso sanguigno è
A) suppurazione della ferita
B) sintesi dell'emoglobina
B) formazione di fibrina
D) aumento della conta piastrinica7. Qual è la base di un coagulo di sangue?
A) anticorpi
B) emoglobina
B) colesterolo
D) fibrina8. Come vengono chiamati gli elementi del sangue privi di nucleo, la cui distruzione porta alla coagulazione del sangue?
A) globuli rossi
B) piastrine
B) linfociti
D) macrofagi9. Che ruolo svolgono le piastrine nel sangue umano?
A) trasporto dei prodotti finali del metabolismo
B) trasportare i nutrienti
B) partecipare alla fagocitosi
D) partecipare alla sua coagulazione10. Un trombo che ostruisce l'area danneggiata della nave è formato da una rete di fili
A) fibrina
B) trombina
B) fibrinogeno
D) collasso delle piastrine11. Quali cellule del sangue sono caratterizzate dalle seguenti caratteristiche: formazioni piatte, piccole, di forma irregolare, prive di nuclei che vivono per diversi giorni?
A) piastrine
B) linfociti
B) globuli rossi
D) fagociti12. In cosa consiste principalmente un coagulo sanguigno?
A) protrombina
B) trombina
B) fibrina
D) fibrinogeno13. Scegli l'opzione corretta che descrive la formazione di un coagulo di sangue: sotto l'influenza di X, Y disciolto nel sangue si trasforma in Z
A) X-trombina Y-fibrinogeno Z-fibrina
B) X-fibrina Y-trombina Z-fibrinogeno
B) X-fibrina Y-fibrinogeno Z-trombina
D) X-fibrinogeno Y-trombina Z-fibrinaIn caso di danno accidentale ai piccoli vasi sanguigni, l'emorragia risultante si interrompe dopo un po'. Ciò è dovuto alla formazione di un trombo o di un coagulo nel sito del danno alla nave. Questo processo è chiamato coagulazione del sangue.
Attualmente esiste una teoria enzimatica classica della coagulazione del sangue: Teoria di Schmidt-Morawitz. Le disposizioni di questa teoria sono presentate nel diagramma (Fig. 11):
Riso. 11. Diagramma della coagulazione del sangue
Il danno a un vaso sanguigno provoca una cascata di processi molecolari, che portano alla formazione di un coagulo di sangue, un trombo, che interrompe il flusso del sangue. Nel sito della lesione, le piastrine si attaccano alla matrice intercellulare aperta; si verifica un tappo piastrinico. Allo stesso tempo, viene attivato un sistema di reazioni che portano alla conversione del fibrinogeno, proteina plasmatica solubile, in fibrina insolubile, che si deposita nel tappo piastrinico e sulla sua superficie si forma un coagulo di sangue.
Il processo di coagulazione del sangue avviene in due fasi.
Nella prima fase la protrombina viene convertita nell'enzima attivo trombina sotto l'influenza della trombochinasi, contenuta nelle piastrine e rilasciata da esse durante la distruzione delle piastrine del sangue e degli ioni calcio.
Nella seconda fase sotto l'influenza della trombina formata, il fibrinogeno viene convertito in fibrina.
L'intero processo di coagulazione del sangue è rappresentato dalle seguenti fasi dell'emostasi:
a) contrazione del vaso danneggiato;
b) formazione nel sito della lesione di un tappo piastrinico allentato o di un trombo bianco. Il collagene nel vaso funge da centro legante per le piastrine. Durante l'aggregazione piastrinica vengono liberate ammine vasoattive che stimolano la vasocostrizione;
c) formazione di un trombo rosso (coagulo di sangue);
d) dissoluzione parziale o completa del coagulo.
Il trombo bianco è formato da piastrine e fibrina; contiene relativamente pochi globuli rossi (in condizioni di flusso sanguigno elevato). Un coagulo di sangue rosso è costituito da globuli rossi e fibrina (nelle aree di flusso sanguigno lento).
I fattori della coagulazione del sangue sono coinvolti nel processo di coagulazione del sangue. I fattori della coagulazione associati alle piastrine sono solitamente indicati con numeri arabi (1, 2, 3, ecc.), mentre i fattori della coagulazione presenti nel plasma sanguigno sono indicati con numeri romani.
Il fattore I (fibrinogeno) è una glicoproteina. Sintetizzato nel fegato.
Il fattore II (protrombina) è una glicoproteina. Sintetizzato nel fegato con la partecipazione della vitamina K. Capace di legare gli ioni calcio. La degradazione idrolitica della protrombina produce un enzima attivo della coagulazione del sangue.
Il fattore III (fattore tissutale o tromboplastina tissutale) si forma quando il tessuto è danneggiato. Lipoproteine.
Fattore IV (ioni Ca 2+). Necessario per la formazione del fattore X attivo e della tromboplastina tissutale attiva, dell'attivazione della proconvertina, della formazione di trombina e della labilizzazione delle membrane piastriniche.
Il fattore V (proaccelerina) è una globulina. Precursore dell'accelerina, sintetizzato nel fegato.
Il fattore VII (antifibrinolisina, proconvertina) è un precursore della convertina. Sintetizzato nel fegato con la partecipazione della vitamina K.
Il fattore VIII (globulina antiemofila A) è necessario per la formazione del fattore X attivo. La carenza congenita del fattore VIII è la causa dell'emofilia A.
Il fattore IX (globulina B antiemofila, fattore di Natale) partecipa alla formazione del fattore X attivo. Quando il fattore IX è carente si sviluppa l’emofilia B.
Il fattore X (fattore Stewart-Prower) è una globulina. Il fattore X è coinvolto nella formazione della trombina dalla protrombina. Sintetizzato dalle cellule del fegato con la partecipazione della vitamina K.
Il fattore XI (fattore Rosenthal) è un fattore proteico antiemofilico. La carenza si osserva nell'emofilia C.
Il fattore XII (fattore Hageman) è coinvolto nel meccanismo di attivazione della coagulazione del sangue, stimola l'attività fibrinolitica e altre reazioni protettive dell'organismo.
Fattore XIII (fattore stabilizzante la fibrina) - è coinvolto nella formazione di legami intermolecolari nel polimero di fibrina.
Fattori piastrinici. Attualmente sono noti circa 10 singoli fattori piastrinici. Ad esempio: Fattore 1: proaccelerina adsorbita sulla superficie delle piastrine. Fattore 4 - fattore antieparina.
In condizioni normali, non c'è trombina nel sangue, ma è formata dalla proteina plasmatica protrombina sotto l'azione dell'enzima proteolitico fattore Xa (indice a - forma attiva), che si forma durante la perdita di sangue dal fattore X. Il fattore Xa converte protrombina in trombina solo in presenza di ioni Ca 2 + e altri fattori della coagulazione.
Il fattore III, che passa nel plasma sanguigno quando il tessuto è danneggiato, e il fattore piastrinico 3 creano i prerequisiti per la formazione di una quantità seme di trombina dalla protrombina. Catalizza la conversione di proaccelerina e proconvertina in accelerina (fattore Va) e convertina (fattore VIIa).
Quando questi fattori interagiscono, così come gli ioni Ca 2+, si forma il fattore Xa. La trombina viene quindi formata dalla protrombina. Sotto l'influenza della trombina, il fibrinogeno viene separato da 2 peptidi A e 2 peptidi B. Il fibrinogeno viene convertito in un monomero di fibrina altamente solubile, che polimerizza rapidamente in un polimero di fibrina insolubile con la partecipazione del fattore XIII stabilizzante la fibrina (enzima transglutaminasi) nel la presenza di ioni Ca 2+ (Fig. 12).
Il trombo di fibrina si attacca alla matrice nell'area del danno vascolare con la partecipazione della proteina fibronectina. In seguito alla formazione dei filamenti di fibrina avviene la loro contrazione che richiede l'energia dell'ATP e del fattore piastrinico 8 (trombostenina).
Nelle persone con difetti ereditari della transglutaminasi, il sangue coagula allo stesso modo delle persone sane, ma il coagulo è fragile, quindi si verifica facilmente un sanguinamento secondario.
Il sanguinamento dai capillari e dai piccoli vasi si interrompe quando si forma un tappo piastrinico. Per arrestare il sanguinamento dai vasi più grandi è necessaria la rapida formazione di un forte coagulo per ridurre al minimo la perdita di sangue. Ciò si ottiene attraverso una cascata di reazioni enzimatiche con meccanismi di amplificazione in molti passaggi.
Esistono tre meccanismi per attivare gli enzimi a cascata:
1. Proteolisi parziale.
2. Interazione con proteine attivatrici.
3. Interazione con le membrane cellulari.
Gli enzimi della via procoagulante contengono acido γ-carbossiglutammico. I radicali dell'acido carbossiglutammico formano siti di legame per gli ioni Ca 2+. In assenza di ioni Ca 2+, il sangue non coagula.
Vie esterne ed interne della coagulazione del sangue.
In via estrinseca della coagulazione del sangue tromboplastina (fattore tissutale, fattore III), proconvertina (fattore VII), fattore Stewart (fattore X), proaccelerina (fattore V), nonché Ca 2+ e fosfolipidi delle superfici della membrana su cui si forma un trombo. Gli omogenati di molti tessuti accelerano la coagulazione del sangue: questa azione è chiamata attività tromboplastinica. Probabilmente è associato alla presenza di alcune proteine speciali nei tessuti. I fattori VII e X sono proenzimi. Vengono attivati mediante proteolisi parziale, trasformandosi in enzimi proteolitici, rispettivamente i fattori VIIa e Xa. Il fattore V è una proteina che, sotto l'azione della trombina, viene convertita in fattore V, che non è un enzima, ma attiva l'enzima Xa mediante un meccanismo allosterico; l'attivazione è potenziata in presenza di fosfolipidi e Ca 2+.
Il plasma sanguigno contiene costantemente tracce di fattore VIIa. Quando le pareti dei tessuti e dei vasi vengono danneggiate viene rilasciato il fattore III, un potente attivatore del fattore VIIa; l'attività di quest'ultimo aumenta di oltre 15.000 volte. Il fattore VIIa taglia parte della catena peptidica del fattore X, convertendola nell'enzima fattore Xa. Allo stesso modo, Xa attiva la protrombina; la trombina risultante catalizza la conversione del fibrinogeno in fibrina, nonché la conversione del precursore della transglutaminasi nell'enzima attivo (fattore XIIIa). Questa cascata di reazioni ha cicli di feedback positivi che migliorano il risultato finale. Il fattore Xa e la trombina catalizzano la conversione del fattore VII inattivo nell'enzima VIIa; la trombina converte il fattore V in fattore V che, insieme ai fosfolipidi e al Ca 2+, aumenta di 10 4–10 5 volte l'attività del fattore Xa. Grazie al feedback positivo, la velocità di formazione della trombina stessa e, di conseguenza, la conversione Il tasso di fibrinogeno in fibrina aumenta come una valanga, ed entro 10-12 il sangue coagula.
Coagulazione del sangue meccanismo interno avviene molto più lentamente e richiede 10-15 minuti. Questo meccanismo è detto intrinseco perché non necessita di tromboplastina (fattore tissutale) e tutti i fattori necessari sono contenuti nel sangue. Il meccanismo della coagulazione interna rappresenta anche una cascata di attivazioni sequenziali di proenzimi. A partire dalla fase di trasformazione del fattore X in Xa, le vie esterne ed interne sono le stesse. Come la via estrinseca, la via intrinseca della coagulazione ha un feedback positivo: la trombina catalizza la conversione dei precursori V e VIII negli attivatori V e VIII, che alla fine aumentano la velocità di formazione della trombina stessa.
I meccanismi esterni ed interni della coagulazione del sangue interagiscono tra loro. Il fattore VII, che è specifico per la via della coagulazione estrinseca, può essere attivato dal fattore XIIa, che è coinvolto nella via della coagulazione intrinseca. Ciò trasforma entrambi i percorsi in un unico sistema di coagulazione del sangue.
Emofilia. I difetti ereditari delle proteine coinvolte nella coagulazione del sangue si manifestano con un aumento del sanguinamento. La malattia più comune causata dall'assenza del fattore VIII è l'emofilia A. Il gene del fattore VIII è localizzato sul cromosoma X; Il danno a questo gene si manifesta come un tratto recessivo, quindi le donne non soffrono di emofilia A. Negli uomini con un cromosoma X, l’ereditarietà del gene difettoso provoca l’emofilia. I segni della malattia vengono solitamente rilevati nella prima infanzia: con il minimo taglio o addirittura sanguinamento spontaneo; caratteristiche sono le emorragie intrarticolari. La frequente perdita di sangue porta allo sviluppo di anemia da carenza di ferro. Per arrestare l'emorragia nell'emofilia, viene somministrato sangue fresco di donatore contenente fattore VIII o preparati di fattore VIII.
Emofilia B. L'emofilia B è causata da mutazioni nel gene del fattore IX che, come il gene del fattore VIII, è localizzato sul cromosoma sessuale; le mutazioni sono recessive, pertanto l'emofilia B si manifesta solo negli uomini. L'emofilia B si manifesta circa 5 volte meno frequentemente dell'emofilia A. L'emofilia B viene trattata somministrando farmaci a base di fattore IX.
A aumento della coagulazione del sangue Possono formarsi coaguli di sangue intravascolari, che ostruiscono i vasi intatti (condizioni trombotiche, trombofilia).
Fibrinolisi. Il trombo si dissolve entro pochi giorni dalla formazione. Il ruolo principale nella sua dissoluzione appartiene all'enzima proteolitico plasmina. La plasmina idrolizza i legami peptidici nella fibrina formata da residui di arginina e triptofano e si formano peptidi solubili. Il precursore della plasmina, il plasminogeno, si trova nel sangue circolante. Viene attivato dall'enzima urochinasi, che si trova in molti tessuti. Il plaminogeno può essere attivato dalla callicreina, presente anche nel coagulo sanguigno. La plasmina può anche essere attivata nel sangue circolante senza danneggiare i vasi sanguigni. Lì la plasmina viene rapidamente inattivata dall'inibitore proteico α 2 - antiplasmina, mentre all'interno del trombo è protetta dall'azione dell'inibitore. L'urochinasi è un rimedio efficace per sciogliere i coaguli di sangue o prevenirne la formazione in caso di tromboflebite, embolia polmonare, infarto miocardico e interventi chirurgici.
Sistema anticoagulante. Nello sviluppo del sistema di coagulazione del sangue nel corso dell'evoluzione sono stati risolti due compiti opposti: impedire la fuoriuscita di sangue in caso di danni ai vasi sanguigni e mantenere il sangue allo stato liquido nei vasi non danneggiati. Il secondo problema è risolto dal sistema anticoagulante, che è rappresentato da un insieme di proteine plasmatiche che inibiscono gli enzimi proteolitici.
La proteina plasmatica antitrombina III inibisce tutte le proteinasi coinvolte nella coagulazione del sangue, ad eccezione del fattore VIIa. Non agisce sui fattori che fanno parte di complessi con fosfolipidi, ma solo su quelli che si trovano nel plasma allo stato disciolto. Pertanto, è necessario non per regolare la formazione di un coagulo di sangue, ma per eliminare gli enzimi che entrano nel flusso sanguigno dal sito di formazione del trombo, prevenendo così la diffusione della coagulazione del sangue nelle aree danneggiate del flusso sanguigno.
L'eparina è usata come farmaco che impedisce la coagulazione del sangue. L'eparina potenzia l'effetto inibitorio dell'antitrombina III: l'aggiunta di eparina induce cambiamenti conformazionali che aumentano l'affinità dell'inibitore per la trombina e altri fattori. Dopo che questo complesso si è combinato con la trombina, l'eparina viene rilasciata e può combinarsi con altre molecole di antitrombina III. Pertanto, ciascuna molecola di eparina può attivare un gran numero di molecole di antitrombina III; sotto questo aspetto l'effetto dell'eparina è simile all'effetto dei catalizzatori. L'eparina è utilizzata come anticoagulante nel trattamento delle condizioni trombotiche. Esiste un difetto genetico noto in cui la concentrazione di antitrombina III nel sangue è la metà di quella normale; queste persone spesso soffrono di trombosi. L'antitrombina III è il componente principale del sistema anticoagulante.
Ci sono altre proteine nel plasma sanguigno: inibitori della proteinasi, che possono anche ridurre la probabilità di coagulazione intravascolare. Tale proteina è l'α 2 - macroglobulina, che inibisce molte proteinasi e non solo quelle coinvolte nella coagulazione del sangue. α 2 -La macroglobulina contiene sezioni della catena peptidica che sono substrati di molte proteinasi; Le proteinasi si attaccano a questi siti, idrolizzano alcuni legami peptidici in essi, a seguito dei quali la conformazione dell'α 2 -macroglobulina cambia e cattura l'enzima, come una trappola. L'enzima in questo caso non viene danneggiato: in combinazione con un inibitore è in grado di idrolizzare peptidi a basso peso molecolare, ma il centro attivo dell'enzima non è accessibile alle grandi molecole. Il complesso α 2 -macroglobulina con l'enzima viene rapidamente eliminato dal sangue: la sua emivita nel sangue è di circa 10 minuti. Con un massiccio ingresso di fattori di coagulazione del sangue attivati nel flusso sanguigno, la potenza del sistema anticoagulante potrebbe essere insufficiente e vi è il pericolo di trombosi.
Vitamina K Le catene peptidiche dei fattori II, VII, IX e X contengono un amminoacido insolito: la γ-carbossiglutammina. Questo amminoacido è formato dall'acido glutammico come risultato della modificazione post-traduzionale delle seguenti proteine:

Le reazioni a cui partecipano i fattori II, VII, IX e X sono attivate da ioni Ca 2+ e fosfolipidi: i radicali dell'acido γ-carbossiglutammico formano centri di legame Ca 2+ su queste proteine. I fattori elencati, così come i fattori V" e VIII", si attaccano alle membrane fosfolipidiche a doppio strato e tra loro con la partecipazione di ioni Ca 2+, e in tali complessi avviene l'attivazione dei fattori II, VII, IX e X. Lo ione Ca 2+ attiva anche alcune altre reazioni di coagulazione: il sangue decalcificato non coagula.
La conversione del residuo glutammico in un residuo di acido γ-carbossiglutammico è catalizzata da un enzima il cui coenzima è la vitamina K. La carenza di vitamina K si manifesta con aumento del sanguinamento, emorragie sottocutanee ed interne. In assenza di vitamina K si formano i fattori II, VII, IX e X che non contengono residui di γ-carbossiglutammina. Tali proenzimi non possono essere convertiti in enzimi attivi.