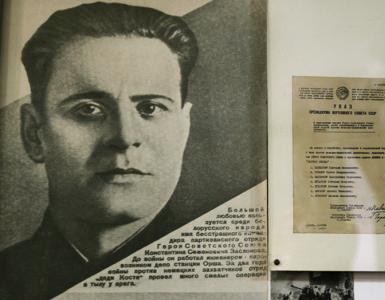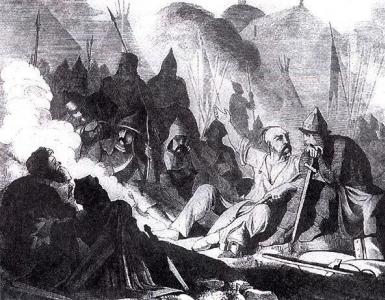Tipi di emodinamica. Valutazione della gravità dei disturbi emodinamici centrali in pazienti con tubercolosi polmonare nel periodo preoperatorio. Manifestazioni di rachitismo nei bambini con ridotta formazione delle articolazioni dell'anca
Tutte le costanti fisiologiche possono essere divise in 3 gruppi. Il primo gruppo comprende quelli che non differiscono tra loro in persone diverse (sane): pH del sangue, temperatura corporea, ecc. Il secondo gruppo è costituito da costanti che non sono le stesse per tutte le persone sane, ma solo per alcuni specifici gruppi-tipo, accomunati da qualche caratteristica comune.
Tali caratteristiche unificanti includono, ad esempio, il tipo di costituzione psicosomatica, il gruppo sanguigno, ecc. Questi sono i cosiddetti indicatori standard. E infine, il terzo gruppo comprende caratteristiche puramente individuali che esistono solo al singolare e sono caratteristiche solo di questa particolare persona. Questo è il genotipo, il modello papillare delle dita, ecc. Questi tre gruppi di costanti fisiologiche sono intrecciati e costituiscono un'unica, unica individualità umana.
Sulla base di questa idea dei tre gruppi di costanti fisiologiche, diventa ovvio che è possibile calcolare le medie per tutte le persone solo sulla base degli indicatori relativi al primo gruppo di costanti. Fare la media degli indicatori del secondo tipo senza prima dividere i soggetti in gruppi secondo determinati tipi porta a errori.
Per quanto riguarda gli indicatori del terzo gruppo, non è possibile mediarli affatto.
Purtroppo non sempre tutto questo viene preso in considerazione. Facendo la media degli indicatori del secondo gruppo (e sono la maggioranza) senza tener conto delle caratteristiche tipiche, si ottiene un'enorme diffusione della “norma”. È questo gruppo che include indicatori di gittata cardiaca: volume sistolico (SV) e CIO.
Secondo il concetto di N.N. Savitsky (1968), la funzione dell'apparato circolatorio è determinata dal livello dei processi metabolici nel corpo. Sulla base di ciò è stato proposto di calcolare i valori corretti di MOC-DMOC e la corretta resistenza periferica del letto vascolare - DPS.
Secondo N.N. Savitsky e i suoi studenti (1968), i valori effettivi degli indicatori IOC e PS ottenuti in condizioni metaboliche basali in persone sane non dovrebbero differire da DMOC e DPS di oltre il 10%. I dati di un sondaggio condotto su persone sane hanno smentito questa affermazione.
Per massimizzare l'individualizzazione di questi indicatori, è stato proposto di ridurli alla dimensione della superficie corporea (SB). Pertanto, è apparso l'indice cardiaco (CI), pre-132
che rappresenta la relazione del CIO con il PT e l'IU, vale a dire rapporto tra MA e PT. Tuttavia, questi indici hanno mostrato una gamma significativa di fluttuazioni. È diventato ovvio che questi indicatori appartengono al secondo gruppo di costanti fisiologiche, ad es. Questi sono indicatori tipici. Pertanto, le persone sane hanno diverse opzioni emodinamiche o tipi di circolazione sanguigna (GL. Apanasenko, 1976; I.K. Shakhvatsabaya, 1981). Anche N.N. Savitsky, considerando varie opzioni patogenetiche per lo sviluppo dell'ipertensione, ha identificato 3 tipi di circolazione sanguigna (BC): ipocinetica, eucinetica e ipercinetica. Nelle persone sane (con livelli di pressione arteriosa normali), il tipo ipocinetico è caratterizzato da un SI basso (inferiore a 2,75 l/(min m2). In questo tipo si determinano anche valori relativamente elevati di resistenza vascolare periferica. Con TC ipercinetico, SI>3,5 l/(min m2) e valori PS corrispondentemente bassi. Nell'intervallo SI di 2,75-3,5 l/(min m2) TC è considerato eucinetico.
Secondo la maggior parte dei ricercatori che hanno studiato i tipi di circolazione sanguigna nelle persone sane, nel tipo ipercinetico il cuore funziona nella modalità meno economica e la gamma delle capacità compensative di questo tipo è limitata.
In questo caso si verifica un'elevata attività del sistema simpatico-surrenale. Al contrario, il TC ipocinetico è il più economico e il sistema cardiovascolare con questo tipo di circolazione sanguigna ha un ampio range di mobilizzazione funzionale. Pertanto, con il tipo ipercinetico, l'adattamento allo stress fisico avviene a causa della mobilitazione delle funzioni estranee e cronotrope del miocardio senza il coinvolgimento del meccanismo di Frank-Starling. Nel tipo ipocinetico, questo meccanismo viene attivato, indicando una modalità di adattamento più economica. Pertanto, i tipi di circolazione sanguigna differiscono l'uno dall'altro non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. Ciò significa che individui con diversi tipi di circolazione sanguigna hanno diverse capacità adattative e quindi diversi gradi di resistenza alle influenze estreme (Tabella 1). I dati presentati nella tabella mostrano che gli individui con TC ipercinetico (40% delle reazioni ipertensive) hanno la minore resistenza agli effetti di un complesso di fattori ambientali sfavorevoli, mentre quelli con TC eucinetico hanno la resistenza maggiore. Per quanto riguarda il tipo ipocinetico, occupa mediamente una posizione intermedia. Tuttavia, consente una considerazione più dettagliata dello stato delle funzioni delle persone con TC ipocinetico
Tabella 1. Alcuni indicatori dello stato funzionale di giovani uomini sani prima (numeratore) e dopo (denominatore) un'esposizione di 102 giorni a un complesso di fattori sfavorevoli (permanenza in una stanza isolata di piccolo volume, ipercapnia 1,5-2,3%, ipocinesia, alto stress nervoso - mentale); secondo GL Apanasenko, 1975
|
Tipo di circolazione sanguigna |
Frequenza del polso, battiti/min |
Tempo di trattenere il respiro |
Indice di due minuti |
Proporzione di persone che presentano |
La quantità totale di calore |
La quota di ipertesi |
|
lamentele riguardo |
||||||
|
violazione |
||||||
|
soggettivo- |
persona |
|||||
|
in piedi, % |
||||||
|
tic, 11=20 |
||||||
|
netico, n=20 |
||||||
|
nontico, n=15 |
per stabilire l'eterogeneità di questo gruppo: comprende sia individui con un'elevata riserva di funzioni, altamente resistenti alle influenze estreme, sia individui con forme iniziali di disregolazione del tono del letto precapillare, caratterizzati da bassa resistenza agli effetti dei fattori di stress. Il criterio per distinguere questi sottogruppi alternativi può essere il risultato di test funzionali con attività fisica (Tabella 2).
Pertanto, gli individui con TC eucinetico e ipocinetico (come risultato dell'economizzazione delle funzioni con una buona preparazione fisica) hanno una maggiore resistenza ai fattori di stress rispetto ai rappresentanti ipocinetici con un punteggio basso di test funzionali e TC ipercinetico. Questa conclusione è confermata dai risultati delle osservazioni sistematiche di atleti di alta classe: all'aumentare dell'abilità sportiva e dell'aumento del livello delle riserve funzionali, l'SI diminuisce e aumenta la percentuale di atleti con TC ipocinetico. E viceversa: il detraining e il fallimento dei meccanismi di adattamento sono accompagnati da un aumento e da una gradualità dell'IS
Tabella 2. Dipendenza dell'indice del test del passo di due minuti dal tipo di circolazione sanguigna (secondo G.L. Apanasenko, 1975)
|
Valutazione dell'indice del test a passi |
||||
|
Tipo di circolazione sanguigna |
Insoddisfacente |
Soddisfa-crea- |
Buono, 45.1- |
Eccellente, |
È consuetudine distinguere tra 3 tipi di circolazione sanguigna (BC): ipo-, eu- e ipercinetica (Savitsky N.N., 1974). La divisione si basa sul calcolo dell'indice cardiaco (CI). Il tipo ipocinetico di circolazione sanguigna (HTC) è caratterizzato da CI basso e valori relativamente alti di TPSS e UPSS.
Con il tipo ipercinetico di circolazione sanguigna (HTC), vengono determinati i valori più alti di SI e UI, IOC e SV e, di conseguenza, TPSS e UPSS bassi. E infine, con il tipo eucinetico (ETK), i valori di tutti questi parametri emodinamici si trovano nel mezzo dell'intervallo di fluttuazioni.
N.N. Savitsky riteneva che i TC si formassero dalle malattie stesse e derivassero dai diversi effetti patogenetici dello stress sull'emodinamica, che sono uniformi in tutte le persone sane. Da queste posizioni, vale a dire l'omogeneità della norma emodinamica delle persone sane e la diversa influenza dei meccanismi patogenetici della malattia, oggi vengono considerate numerose malattie del sistema cardiovascolare (iper e ipotensione arteriosa, ecc.).
Allo stesso tempo, ulteriori ricerche da parte del personale della clinica G.F. Lang negli anni '30, effettuato per studiare il sistema circolatorio in individui sani, diede motivo di supporre l'esistenza di un'eterogeneità emodinamica nelle persone sane. È quest'ultima circostanza, e non solo l'influenza di influenze patologiche, che determina l'eterogeneità emodinamica dei pazienti.
I.K. Shkhvatsabaya et al. (1981), utilizzando un approccio simile per valutare la norma emodinamica, hanno confermato che una significativa dispersione dei parametri emodinamici (3-4 volte) è effettivamente spiegata dall'eterogeneità emodinamica delle persone sane e che hanno tutti TC che rappresentano una variante della norma emodinamica norma.
Secondo la maggior parte degli autori che studiano la TC nei pazienti, con l'HTC il cuore funziona nella modalità meno economica e la gamma delle capacità compensatorie di questo tipo è limitata. Con questo tipo, l'attività del sistema simpatico-adrenalina è elevata (Makolkin V.I., Abakumov S.A., 1985). Al contrario, HTC è il sistema più economico e cardiovascolare, mentre TC ha un'ampia gamma dinamica.
Pertanto, con HTC, l'adattamento all'attività fisica avviene a causa delle funzioni estranee e cronotrope del miocardio senza il coinvolgimento del meccanismo di Frank-Sterling. Per quanto riguarda l'HTC, con questa tipologia durante l'attività fisica si attiva il meccanismo di Frank-Starling, il che indica senza dubbio una natura di adattamento più economica.
Esiste, tuttavia, un punto di vista secondo cui è HTC il più economico e con esso si osservano prestazioni più elevate (Tszi-zinsky V.V. et al., 1984), e se con HTC durante l'attività fisica si verifica uno spostamento verso valori inferiori costi energetici , quindi il livello caratteristico dei tipi iper ed eucinetici non viene raggiunto.
Secondo G.I. Sidorenko et al. (1984), la tolleranza all’esercizio non dipende dal TC, ma la gamma di capacità di riserva degli individui con TC ipercinetico è ridotta.
In un modo o nell'altro, è ovvio che i TC differiscono tra loro non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. Ciò significa che le persone con diverse TC hanno diverse capacità adattative, utilizzano diversi modi di adattare il sistema circolatorio per raggiungere l'ottimale e sono caratterizzate da diversi processi patologici. Inoltre, al momento non vi è dubbio che anche la circolazione sanguigna nelle persone sane sia eterogenea e che abbiano le stesse TC che si verificano nei pazienti.
Allo stesso tempo, una serie di questioni legate ai problemi di valutazione del TC rimangono irrisolte. Innanzitutto la questione dell'origine del TC non è stata risolta. Inoltre, non c’è chiarezza sulla prevalenza delle varie TC nelle persone sane. I dati di diversi autori sulla prevalenza del TC nella popolazione variano in modo significativo. Le ragioni dell'incoerenza delle pubblicazioni su questo tema sono, a nostro avviso, la mancanza di criteri generalmente accettati per la valutazione del TC, l'insufficiente accuratezza di un numero di metodi per valutare i parametri emodinamici e la convenzionalità del concetto stesso di "salute".
Eppure, l'uso di approcci all'eterogeneità emodinamica iniziale di individui sani e all'esistenza di vari TC è di grande importanza per risolvere una serie di problemi nella cardiologia dello sport. Gli studi condotti nel campo della cardiologia dello sport negli ultimi dieci anni (Dembo A.G. et al., 1986; Kalugin G.E., 1987; Shkolnik I.M., 1987, 1991) non solo hanno confermato l'esistenza di eterogeneità emodinamica negli atleti e la fattibilità dell'isolamento del TC, ma ha anche rivelato l’esistenza di differenze nella natura dei cambiamenti adattivi negli atleti con diversi TC.
Pertanto, è stato riscontrato che la distribuzione dell'SI in 65 atleti della 1a categoria e diverse direzioni del processo di allenamento, secondo l'esame a riposo utilizzando il metodo della respirazione artificiale, varia in un ampio intervallo, superiore a 3 l, e il coefficiente di variazione (KB) di SI per il gruppo in generale è del 20%, il che indica l'eterogeneità emodinamica del gruppo (Dembo A.G. et al., 1986).
Dopo la formazione di tre gruppi omogenei secondo il criterio KB< 10%, обозначенных в дальнейшем как группы спортсменов с ГТК, ЭТК и ГрТК, проведен анализ гемодинамики в покое и при физической нагрузке. Физическая нагрузка выполнялась на велоэргометре в течение 5 мин и дозировалась из расчета 3,3 Вт/кг массы тела.
Nella tabella Le Figure 32 e 33 presentano dati su alcuni parametri emodinamici a riposo per vari TC. Come si può vedere dalle tabelle, non ci sono differenze nei livelli di pressione arteriosa tra atleti con diversi TC. Allo stesso tempo, con HTK, la frequenza cardiaca è più elevata e UPSS è significativamente inferiore rispetto a ETC e HTK. Pertanto, è ovvio che in condizioni di riposo fisiologico negli atleti con HTK, il livello richiesto di afflusso di sangue viene mantenuto, principalmente a causa dell'elevato UPSS, e in HTK, a causa dell'aumento della SV.
Ciò significa che, a seconda della TC, i meccanismi per mantenere lo stesso livello di un indicatore omogeneo (pressione sanguigna) sono diversi. Differenze significative nei meccanismi di regolazione della circolazione sanguigna nei diversi TC sono evidenziate anche dai nostri dati sulla stretta relazione tra il valore di SV e la frequenza cardiaca. È noto che un aumento della gittata sistolica provoca una reciproca inibizione dell'automatismo del nodo senoatriale e porta ad una diminuzione della frequenza cardiaca.
Questo meccanismo, che funziona secondo il principio del feedback, garantisce che il CIO sia mantenuto a un livello sostenibile. Secondo Z.L. Karpman e B.G. Lyubina (1982), tra gli atleti questa connessione può essere tracciata solo a livello di tendenza, poiché esiste solo una correlazione moderatamente stretta tra questi indicatori.
Tabella 32
Principali indicatori emodinamici negli atleti con diversi tipi di circolazione sanguigna a riposo (M±w)*
| Indice | Tipo di circolazione sanguigna | Significato delle differenze | ||||
| ipocinetico | eucinetico | ipercinetico | I-II | I-III | II-III | |
| Sistema di pressione sanguigna, mm Hg. Arte. | 116+7,2 | 117+8,6 | 116+7,0 | - | - | - |
| Diametro della pressione arteriosa, mm Hg. Arte. | 79+9,2 | 74+9,8 | 76+9,6 | - | - | - |
| Frequenza cardiaca, battiti/min | 58+6,6 | 61+9,0 | 63+7,0 | - | - | - |
| Volume della corsa, ml | 80+11,4 | 91+18,7 | 107+23,6 | <0,06 | <0,01 | <0,10 |
| Resistività | 886,2±47 | 739,4+84 | 561,1+47,8 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
*M - valore medio; m - deviazione dal valore medio.
Un'analisi dei valori di SV e frequenza cardiaca, effettuata tenendo conto dei tipi di circolazione sanguigna, ha permesso di stabilire che la relazione tra questi indicatori non appare nella stessa misura nei diversi TC. Una stretta correlazione inversa tra volume sistolico e frequenza cardiaca si verifica durante ETC e GrTK negli atleti. Nel caso di HTC non è stata trovata alcuna connessione affidabile tra questi indicatori.
Di conseguenza, a riposo negli atleti con GCT, il meccanismo cronoinotropo non è praticamente coinvolto nel garantire la gittata cardiaca, il che è in buon accordo con le idee sull'economizzazione della funzione del sistema circolatorio, particolarmente pronunciate durante l'allenamento di resistenza. D’altro canto, la stretta connessione tra SV e frequenza cardiaca durante ETC e GrTC dà motivo di considerare gli atleti con questi TC
in quanto non sufficientemente adattati per svolgere lavori di resistenza. Continuando la trattazione del ruolo del TC nella valutazione dello stato di adattamento del sistema circolatorio all'attività fisica, ci soffermeremo sulla connessione tra TC e la direzione del processo di allenamento.
Tra gli atleti che sviluppano principalmente resistenza, l'HTC si verifica in circa tre casi; tra gli atleti che sviluppano prevalentemente agilità e forza, solo nel 6% dei casi, e tra gli atleti che sviluppano velocità, GTK non è stato trovato affatto (F.E. Zemtsovsky).
La relazione opposta si verifica quando si confronta la frequenza di TC. Mentre tra gli atleti che sviluppano resistenza, il TC è stato riscontrato solo nell’11% degli esaminati, tra gli atleti che sviluppano velocità, GrTK è stato rilevato in più della metà dei casi. Pertanto, la direzione del processo formativo è in un certo senso collegata al TC. Ciò è pienamente coerente con le idee sull’economizzazione di una funzione che si forma come una “traccia strutturale” nel processo di adattamento a lungo termine al lavoro ciclico di potenza moderata.
1 È chiaro che nel processo di allenamento per eseguire un lavoro a breve termine di massima potenza, quando al corpo dell'atleta è richiesto di mantenere costantemente l'apparato circolatorio in uno stato di "alta allerta", sono principalmente i meccanismi di adattamento urgente che sono migliorati.
Ciò, a sua volta, porta all'inclusione predominante del meccanismo cronotropo durante l'esecuzione del carico per garantire il mantenimento del livello richiesto di circolazione sanguigna. Tuttavia, non si può prestare attenzione al fatto che tra gli atleti che sviluppano resistenza ci sono ancora persone con HTC.
Ciò dà motivo di supporre che la formazione dell'uno o dell'altro MC sia determinata non solo dalla natura del processo di allenamento, ma anche, in una certa misura, sia geneticamente determinata, proprio come le riserve per l'adattamento del cuore all'iperfunzione sono geneticamente determinato. La validità di tale proposta è confermata dal fatto già accertato dell'esistenza del TC tra i giovani che non praticano sport.
L'importanza del livello di sportività nella formazione delle abilità tecniche può essere illustrata dal seguente esempio. Tra 37 atleti di sprint di altissimo livello sportivo, nei quali è stato studiato lo stato emodinamico utilizzando il metodo EchoCG, l'ETC è stato rilevato nel 70% dei casi e il GrTC è stato rilevato solo nell'11% dei casi. Ricordiamo che nei risultati sopra riportati dello studio dell'emodinamica nei velocisti di 1a categoria, non abbiamo identificato in nessun caso l'HTC.
Questi dati danno motivo di ritenere che i carichi dinamici gradualmente crescenti di alta potenza, così come i carichi di potenza moderata e bassa, contribuiscano alla formazione di HTC. Tuttavia, questo tipo più economico di regolazione del sistema circolatorio si forma in loro molto più tardi rispetto agli atleti che allenano la resistenza, ad es. ad un livello più alto di sportività.
EL ha ottenuto dati importanti che contribuiscono a una comprensione più profonda della natura della formazione di MC. Lopukhina (1987). Ha basato il suo studio dei parametri emodinamici sul metodo dell'impedenziografia corporea.
I limiti per il riconoscimento del TC sono stati chiariti durante l'esame di 71 uomini e 67 donne di età compresa tra 17 e 22 anni senza alterazioni dello stato di salute. Come si può vedere dalla tabella. 33, i valori soglia SI per la valutazione del TC negli uomini sono notevolmente più alti che nelle donne.
Tabella 33
Criteri per tipi diagnosticamente diversi di circolazione sanguigna nei ragazzi e nelle ragazze
Sulla base dei suddetti standard, E.L. Lopukhina ha studiato la distribuzione del TC tra gli atleti che allenano la resistenza. Come ci si aspetterebbe, la distribuzione del TC negli atleti di resistenza differisce nettamente da quella degli individui non allenati ed è spostata verso la predominanza di HTK. Ciò indica in modo convincente che carichi dinamici regolari e gradualmente crescenti contribuiscono alla formazione di HTC. Se consideriamo che i valori medi della frequenza cardiaca in gruppi con diversi TC sono quasi gli stessi, allora diventa chiaro che nella formazione dell'HTC negli atleti, il ruolo centrale appartiene alla diminuzione del valore della SV.
Un'altra importante conclusione è stata fatta da E.L. Lopukhina durante l'analisi dello stato di salute degli atleti con diversi TC. Si è scoperto che nel gruppo di atleti con GTC all'ECG a riposo e con aritmie cardiache sono state rilevate solo nel 7,2%, con ETC 1 nel 443% e con GrTC nel 54% dei casi.
La conferma dell'indubbia connessione tra le caratteristiche dello stato dell'emodinamica centrale e lo stato di salute degli atleti è stata ottenuta anche durante le osservazioni dinamiche. Sulla base di queste osservazioni, si è riscontrato che il deterioramento delle condizioni dell’atleta era accompagnato da una transizione da ipoTC a eu- o ipercinetico TC.
Consideriamo ad esempio la dinamica dell'IS nel ciclo di allenamento annuale dell'atleta 3 (21 anni, mezzofondo). Nel periodo preparatorio, esami ripetuti hanno rivelato regolarmente valori SI bassi corrispondenti all'HTC. Alla fine del periodo preparatorio, l'atleta ha soddisfatto lo standard di maestro dello sport. Nel periodo pre-gara, i valori SI sono leggermente aumentati, ma non sono andati oltre i limiti del Comitato doganale statale. All'inizio del periodo agonistico, l'atleta si è esibito con successo nelle competizioni, stabilendo un record personale. Tuttavia, presto sono comparsi segni di DMFP, accompagnati da un pronunciato aumento di CI a valori corrispondenti a GrTK. Una settimana dopo, l'atleta ha interrotto l'allenamento a causa di una laringotracheite acuta. Con il progredire del recupero, è stata notata una diminuzione dei valori SI e all'inizio del periodo preparatorio successivo i valori SI corrispondevano al limite superiore dell'HTC.
I dati presentati ci permettono di giungere alla conclusione che la valutazione del TC è senza dubbio di grande importanza nel valutare lo stato di adattamento del sistema circolatorio. Ci sono tutte le ragioni per affermare che nel processo di adattamento a lungo termine ai carichi dinamici si forma l'HTC. La sua formazione è determinata principalmente da una diminuzione della gittata sistolica, che corrisponde alle idee classiche sull’economizzazione della funzione cardiaca dell’atleta a riposo.
Altrettanto importante è la necessità di un esame clinico approfondito degli atleti per identificare condizioni prepatologiche e cambiamenti patologici nel cuore.
L'articolo descrive un metodo per determinare i tipi di emodinamica basato sull'analisi della deviazione del volume minuto misurato in un paziente dal volume minuto corretto. È stata effettuata un'analisi dei parametri emodinamici in individui sani e pazienti con ipertensione arteriosa in base al tipo di emodinamica centrale.
A una tecnica di definizione di tipi di dinamica haemo centrale in pratica clinica
Nell'articolo viene descritta la tecnica per definire i tipi di emodinamica sulla base dell'analisi della deviazione del volume minuto misurato al paziente dal volume minuto dovuto. Viene effettuata l'analisi degli indicatori dinamici haemo nelle persone sane e nei pazienti con ipertensione arteriosa a seconda del tipo di dinamica haemo centrale.
La determinazione del tipo di circolazione sanguigna in individui sani e con ipertensione arteriosa, oltre all'interesse scientifico, sta diventando sempre più pratica. In particolare, numerose osservazioni cliniche confermano il fatto che la differenziazione emodinamica dell'ipertensione arteriosa è necessaria per la scelta dei metodi di trattamento più razionali ed efficaci. Nello sviluppo di idee sulla patogenesi e sulla clinica dell'ipertensione, la ricerca ha svolto un certo ruolo, consentendo di caratterizzare in dettaglio le caratteristiche dei cambiamenti nell'emodinamica centrale e lo stato funzionale dei meccanismi pressori e depressori per la regolazione del sistema circolatorio e della pressione sanguigna nei pazienti con ipertensione. Come risultato di questi lavori, molti ricercatori sono giunti al consenso sul fatto che l'ipertensione è una malattia molto eterogenea, all'interno della quale si possono distinguere numerose varianti cliniche e patogenetiche, che differiscono nella natura e nella gravità dei cambiamenti nell'emodinamica, nello stato del meccanismi fisiologici di regolazione della pressione arteriosa e omeostasi salino-acqua.
La corretta determinazione delle caratteristiche emodinamiche del processo patologico è impossibile senza la conoscenza dell'intero spettro di varianti normali dei corrispondenti indicatori di circolazione sanguigna. Allo stesso tempo, numerosi studi sul sistema cardiovascolare di una popolazione sana hanno dimostrato che i valori massimo e minimo di molti parametri emodinamici studiati in condizioni prossime alle condizioni del metabolismo basale differiscono tra loro 2-4 volte. Questo è ugualmente caratteristico del volume sistolico cardiaco (SV), del volume minuto della circolazione sanguigna (MCV) e della resistenza vascolare periferica totale (TPVR). La diffusione dei parametri emodinamici viene rilevata già nell'infanzia, il che rende possibile ipotizzarne l'origine genetica. Esiste quindi un'eterogeneità emodinamica nella popolazione sana e ciò consente di identificare alcune varianti emodinamiche al suo interno.
Attualmente è accettato distinguere tre tipi emodinamici di emodinamica centrale: eucinetica, ipercinetica e ipocinetica. Le opere di I.K. hanno svolto un ruolo importante nel determinare queste opzioni. Shkhvatsabaya, E.N. Konstantinova, I.A. Gundarova, Yu.T. Pushkar. Gli autori hanno suddiviso le tipologie di emodinamica in base all’indice cardiaco (CI), che è il valore normalizzato del CIO per unità di superficie corporea del paziente. Tutti i valori SI sono stati divisi in tre parti uguali: i valori SI più alti sono stati assegnati al tipo di circolazione sanguigna ipercinetica, i valori più piccoli al tipo ipocinetico e i valori medi al tipo eucinetico. I valori SI per uomini e donne sono stati analizzati separatamente. È difficile essere d'accordo con questo approccio nell'identificazione dei tipi di emodinamica. L'SI dipende dal CIO e dall'area del corpo umano, che viene calcolata in base al peso e all'altezza del paziente, ovvero l'età e il sesso non vengono presi in considerazione. Allo stesso tempo, è noto che il CIO cambia con l’età, riflettendo i cambiamenti nei processi ossidativi del corpo. A questo proposito, secondo N.N. Savitsky, SI non può essere un valore strettamente costante per persone di sesso ed età diversi, e dal suo valore medio è impossibile calcolare il valore del volume minuto corretto. Pertanto, per determinare i criteri per dividere i pazienti per tipo di emodinamica, è necessario selezionare un intervallo di valori SI per diversi tipi di emodinamica in ciascuna fascia di età di individui sani con differenziazione per sesso, oppure utilizzare un altro criterio per dividendosi in tipi di emodinamica, che terranno conto delle differenze di sesso, età, altezza e peso del paziente. Un insieme statistico di dati sull'IS in ciascuna fascia di età sana è un compito piuttosto difficile ed è possibile principalmente solo negli individui giovani e di mezza età, poiché non ci sono praticamente individui sani nelle fasce di età più anziane. Con l'età si sviluppa l'arteriosclerosi, che è addirittura considerata un fenomeno fisiologico dell'invecchiamento. Rappresenta la degenerazione mediale primaria dell'aorta toracica e delle arterie centrali. L'arteriosclerosi provoca la loro dilatazione, ipertrofia diffusa e aumento della rigidità. Lo sviluppo dell'arteriosclerosi e dell'aterosclerosi, anch'essi legati all'età, non può che influenzare i parametri emodinamici e questi pazienti non possono essere classificati come individui sani.
A questo proposito, è necessario sviluppare un sistema di standard che consenta di dividere gli individui sani e i pazienti con varie patologie in tipi emodinamici, e questi standard dovrebbero essere individuali, tenendo conto del sesso, dell'età, dell'altezza e del peso del paziente, ad es. pensato per ogni persona.
N.N. Savitsky ha proposto di determinare il valore del volume minuto corretto (DMV) in base ai valori del metabolismo basale corretto (BME), cioè tenendo conto dell'intensità dei processi metabolici a seconda dell'età e del sesso.
Secondo la formula di N.N. Savitsky DMO (l/min) = DOO/281.
Per calcolare il TOO si possono utilizzare le formule di Harris e Benedict, tenendo conto che il metabolismo basale dipende dal sesso, dall’età e dall’altezza del paziente:
per gli uomini: DOO (kcal) = 13,75M+5R-6,75B+66,77;
Per le donne: DOO (kcal) = 6,56M+1,85P+4,67B+65,09;
dove M è il peso in kg, P è l'altezza in cm, B è l'età in anni.
%MOK=100*(MOK-DMOC)/DMOC
Considerando che la precisione accettata per la misurazione dei parametri fisiologici è ±20%, A.A. Antonov propone che il valore dei parametri emodinamici di una persona sana, determinato nelle condizioni del metabolismo basale, sia considerato il limite minimo della norma e il valore medio della norma sia del 20% in più rispetto al valore minimo. Poiché nella pratica clinica le condizioni per il metabolismo basale sono quasi impossibili da raggiungere, ad es. l'errore di misurazione sarà verso valori più alti del CIO, siamo d'accordo che sia necessario concentrarsi non sulle cifre minime della norma, ma sui suoi valori medi.
Proponiamo di utilizzare il valore DMOC calcolato come criterio per dividere i pazienti in tipologie emodinamiche. Per fare ciò, la percentuale di deviazione del MOC misurato dal DMOC calcolato viene calcolata utilizzando la formula:
%MOK=100*(MOK-DMOC)/DMOC. Il valore medio di DMOC (srMOK) sarà pertanto maggiore del 20% e sarà srDMOC = DMOC + (0,2*DMOC). Abbiamo attribuito una deviazione dallo smOC superiore al 30% al tipo ipercinetico dell'emodinamica centrale, inferiore al -30% al tipo ipocinetico e un intervallo compreso tra -30% e 30% al tipo eucinetico. Dopo semplici trasformazioni matematiche, siamo arrivati al seguente algoritmo per la suddivisione in tipi di emodinamica centrale in base ai dati MOC misurati e al DMOC calcolato, tenendo conto del sesso, dell'età, del peso e dell'altezza del paziente.
- Ipercinetico: %MOK>50%
- Eucinetico: -10%≥%IOC≤50%
- Ipocinetico: %MOK<-10%
Per valutare la possibilità di utilizzo clinico della tecnica proposta, è stato condotto uno studio clinico.
Scopo dello studio: studiare gli indicatori dell'emodinamica centrale in individui sani e pazienti con ipertensione a seconda del tipo di emodinamica.
Sono stati esaminati 2 gruppi di pazienti. Il 1° gruppo comprendeva 35 individui sani: 21 donne e 14 uomini di età compresa tra 21 e 45 anni (M±σ - 25,2±6,17). I criteri per selezionare i pazienti nel gruppo 1 erano: assenza di malattie cardiovascolari, inclusa ipertensione arteriosa, malattie del sistema endocrino, malattie renali, anemia, indicatori normali del metabolismo lipidico (colesterolo, trigliceridi, lipidi ad alta e bassa densità), pressione sanguigna in i pazienti durante lo studio non hanno superato i 130/90 mm Hg. Arte.
Il gruppo 2 era composto da 64 pazienti con ipertensione senza segni di malattia coronarica, CHF e insufficienza renale cronica di età compresa tra 18 e 77 anni (M±σ - 48,9±12,4), di cui 22 donne e 42 uomini. La pressione arteriosa durante lo studio in questi pazienti era ≥140 mmHg. Arte.
Metodi di ricerca:
La pressione sanguigna ABP e ABP sono state determinate mediante il metodo dell'auscultazione
La pressione emodinamica media (MAP) è stata determinata utilizzando la formula di Wetzler-Boger (media PA = 0,42 ADS + 0,58 ADD)
Volume sistolico (SV), frequenza cardiaca - determinato mediante ecocardiografia utilizzando il metodo Teicholz
L'OPSS è stato calcolato utilizzando la formula 1332*ADsr/MO
L'SI è stato calcolato utilizzando la formula MOK/S, dove S è la superficie corporea in l/m2
Prima di eseguire un esame ecocardiografico e misurare la pressione arteriosa, il paziente è rimasto in posizione orizzontale per 30 minuti.
I dati dello studio sono presentati nella Tabella 1.
Tabella 1.
Parametri emodinamici in individui sani e pazienti con ipertensione con diversi tipi di emodinamica centrale
|
Gruppi di pazienti |
Tipo di emodinamica |
din*sec/ml |
|||
|
Salutare |
Ipercinetico |
||||
|
Eucinetico |
|||||
|
Ipocinetico |
|||||
|
Ipercinetico |
|||||
|
Eucinetico |
|||||
|
Ipocinetico |
|||||
|
Probabilità di differenze intergruppo |
L'elaborazione statistica dei dati ottenuti è stata effettuata utilizzando il programma informatico Statistica 8.0. La probabilità delle differenze intergruppo è stata determinata mediante analisi della varianza a una via.
Nel gruppo dei soggetti sani, il 28,6% è stato identificato con una circolazione sanguigna di tipo ipercinetico, 54,3 con eucinetica e 17,1 con ipocinetica. Nel nostro lavoro, la distribuzione dei tipi emodinamici tra le persone sane è abbastanza vicina agli studi di I.K. Shkhvatsabay, dove, utilizzando il metodo sopra descritto, sono stati identificati il 23,7% di tipi di emodinamica ipercinetica, il 46,5% eucinetica e il 29,8% ipocinetica in individui sani di età compresa tra 15 e 34 anni (età media - 20,5 anni). I.A. Gundarov et al. in individui sani di età compresa tra 15 e 49 anni, utilizzando la tecnica di I.K. Shkhvatsabay, ma evidenziando valori normali nei sottogruppi di età, ha ricevuto il 25,4% con tipi ipercinetici, 49,2% con eucinetici e 28,7% con tipi ipocinetici di emodinamica centrale.
Nei nostri studi su individui sani e pazienti con ipertensione in sottogruppi con diversi tipi di emodinamica, non sono state determinate differenze legate all'età statisticamente significative. Differenze statisticamente significative sono state rivelate nei parametri dell'emodinamica centrale (CI, IOC e TPR) sia nel gruppo di individui sani che in pazienti con ipertensione con diversi tipi di emodinamica. Pertanto, i sottogruppi da noi identificati sulla base del DMOC con diversi tipi di emodinamica differiscono significativamente nei principali parametri emodinamici. Allo stesso tempo, è interessante notare che i sottogruppi con diversi tipi di emodinamica, sia nelle persone sane che nei pazienti con ipertensione, includevano individui con gli stessi valori SI (Tabella 1). Pertanto, se utilizziamo il metodo della divisione in tipi emodinamici secondo i dati SI, nei singoli casi si osserveranno false determinazioni del tipo emodinamico. Ciò conferma la nostra ipotesi iniziale secondo cui l'utilizzo dell'IC come criterio per la suddivisione in tipi di emodinamica, senza tenere conto dell'età e del sesso, non è corretto.
Pertanto, il metodo per determinare i tipi di emodinamica centrale - ipercinetica, eucinetica, ipocinetica secondo DMOC può essere utilizzato sia per individui sani che per pazienti con patologie cardiache, in particolare ipertensione.
Yu.E. Teregulov
Ospedale Clinico Repubblicano, Kazan
Università medica statale di Kazan
Teregulov Yuri Emilievich - Candidato di scienze mediche, capo del dipartimento di diagnostica funzionale dell'ospedale clinico repubblicano del Ministero della sanità della Repubblica del Tatarstan, professore associato del dipartimento di terapia ospedaliera del KSMU
Letteratura:
1. Gundarov I.A., Pushkar Yu.T., Konstantinov E.N. Sugli standard di emodinamica centrale determinati con il metodo della reografia toracica tetrapolare / Ter. arco. - 1983. - N. 4. - P. 26-28.
2. Shkhvatsabaya I.K. Geodinamica intracardiaca e varianti cliniche e patogenetiche del decorso dell'ipertensione / Cardiologia. - 1977. - N. 10. - P. 8-18.
3. Shkhvatsabaya I.K., Konstantinov E.N., Gundarov I.A. / Su un nuovo approccio alla comprensione della norma emodinamica / Cardiologia. - 1981. - N. 3. - P. 10-14.
4. Arshakuni R.O. Davitanidze N.L. - Nel libro: L'ipertensione sistolica nell'aspetto dell'età. - M., 1976. - P. 25-27.
5. Baevskij R.M. Previsione di condizioni al confine tra normale e patologico. - M., 1979. - 44 p.
6. Davitanidze N.L., Olkhin V.A. - Nel libro: L'ipertensione sistolica nell'aspetto dell'età. - M., 1976. - P. 37-41.
7. Pavelski S., Zavadski 3. Costanti fisiologiche nella clinica delle malattie interne. - M., 1964. - P. 120-121.
8. Kozharskaya L.G., Goldovskaya D.Sh. - Nel libro: Diagnostica funzionale nell'infanzia. - Sofia, 1979. - 209 pag.
9. Savitsky N.N. Fondamenti biofisici della circolazione sanguigna e metodi clinici per lo studio dell'emodinamica. - M.: Medicina 1974. - 307 p.
10. Orlova Ya.A., Ageev F.T. Rigidità arteriosa come indicatore integrale del rischio cardiovascolare: fisiologia, metodi di valutazione e correzione farmacologica / Cuore. - 2006. - T. 5. - N. 2. - P. 65-69.
11. Londra G.M. La malattia cardiovascolare nell'insufficienza renale cronica: aspetti fisiopatologici. Quadrante Semin. 2003; 16(2): 85-94.
12. O'Rourke M.E. Principi meccanici nella malattia arteriosa. Ipertensione. 1995; 26(1); 2-9.
13. Metodi strumentali per lo studio del sistema cardiovascolare (Manuale) / ed. ed. T.S. Vinogradova. - M.: Medicina, 1986. - 416 p.
14. Antonov A.A. Emodinamica per il clinico (aspetti fisiologici). Arkomis-ProfiTT. - 2004. - 99 pag.
15. Glanz S. Statistiche mediche e biologiche. - M: Praktika, 1999. - 459 pag.
La quantità di sangue espulsa dal cuore nella circolazione sistemica- la gittata cardiaca - è, come il metabolismo basale, una costante e viene misurata su una scala temporale - in 1 minuto - volume minuto di circolazione sanguigna (MCV) o in una contrazione - volume sistolico (SV).
Il corretto valore del CIO dipende dall'altezza e dal peso del soggetto, pertanto Grollman nel 1932 introdusse il concetto di indici cardiaci e di ictus (SI e SI). Questi valori rappresentano le emissioni per metro quadrato di superficie corporea.
Sono abbastanza stabili nelle persone sane in condizioni metaboliche basali e variano poco a seconda del sesso e dell’età. G. A. Glezer (1970) ottenuto in persone sotto i 40 anni SI = 3,3 + 3,4 l/min 2, sopra i 40 anni - 3 l/min m 2, SI, rispettivamente = 43 - 45 e 41 - 42 ml /m2.
Tra tre quantità che caratterizzano l'emodinamica sistemica: volume circolatorio (Q), pressione emodinamica media (p) e resistenza periferica totale (W) esiste una stretta relazione e dipendenza. O. Frank ha proposto di esprimere questa dipendenza matematicamente in modo simile alla resistenza in un circuito di corrente elettrica continua, utilizzando la formula di Ohm, dove la resistenza periferica totale W = p / Q.
Delle tre grandezze considerate, solo due possono essere misurate: p e Q. Il volume della circolazione sanguigna può essere determinato determinando la differenza artero-venosa nel contenuto di ossigeno - il metodo Fick diretto (richiede la puntura delle arterie e il cateterismo dell'atrio destro), secondo la diluizione di un colorante (blu di Evans, T-1824) o un isotopo radioattivo, un metodo fisico, ad esempio con l'aiuto di un meccanocardiografo N.N. Savitsky, che registra anche la pressione emodinamica media.
Si presume che la pressione emodinamica media approssimativa per gli uomini di età inferiore a 35 anni sia pari a 80 mmHg. Art., da 36 a 50 anni - 85 mm, oltre 50 anni - 90 mm Hg. Arte.
"Ipertensione arteriosa"
E.E. Gogin, A.N. Senenko, E.I. Tyurin
Durante un test ortostatico, l'influenza del sistema nervoso è quella di attivare la cosiddetta “pompa venosa” e utilizzare la riserva di sangue accumulata in posizione orizzontale in un piccolo cerchio. La possibilità di una certa deviazione della gittata cardiaca dal volume sincrono del ritorno venoso è creata dalla presenza di volume sanguigno residuo nelle cavità dei ventricoli e nel serbatoio polmonare. Volume residuo (fine sistolico) del ventricolo sinistro negli esseri umani in ...
I disturbi neurogeni della regolazione circolatoria si manifestano prevalentemente sotto forma di ipertensione ipercinetica. La transizione graduale dell'emodinamica in questi pazienti all'ipertensione resistente è associata ad una diminuzione della densità relativa dei fattori regolatori neurogeni e alla loro sostituzione con altri: renali, salini, endocrini (aldosterone). Molti attribuiscono un'importanza decisiva nella trasformazione dell'ipertensione da rilascio in ipertensione da resistenza al meccanismo di autoregolazione vascolare locale, tenendo conto ...
Nelle osservazioni di volontari sani, è stato dimostrato che l'ipertensione causata dalla somministrazione di mineralcorticoidi nelle prime settimane si presenta anche come ipercinetica: pressione media (+ 6 mm Hg) e gittata cardiaca (+ 1,4 l) aumentano, le resistenze periferiche diminuiscono (- 19 %), si registra un aumento di peso (2,4 kg). Ma dopo 6 settimane l'ipertensione si trasforma in resistiva: la pressione media...
Lo sviluppo della sindrome circolatoria ipercinetica può essere causato dalla destabilizzazione dei meccanismi nervosi di regolazione della circolazione sanguigna, spesso causata da fattori esterni. L'emodinamica diventa, prima di tutto, insufficientemente economica ed equilibrata: la "sindrome cardiaca ipercinetica". In condizioni di riposo, la circolazione sanguigna rimane ad un livello che normalmente viene stabilito solo durante l'esecuzione di un carico o durante il periodo di preparazione ad esso (reazione pre-avvio). C'è un costante sovraccarico del cuore...
Le fistole artero-venose possono essere congenite o di origine traumatica. La diagnosi di quest'ultimo è facilitata dalle indicazioni anamnestiche, dalla presenza di cicatrici e dal rumore locale pronunciato con amplificazione sistolica. La creazione di fistole congenite può essere molto più difficile, soprattutto se lo shunt è localizzato in profondità. La diagnosi clinica delle fistole artero-venose degli arti inferiori è della massima importanza pratica. La presenza di scarico congenito di sangue da un'arteria in una vena può essere accompagnata da parziale...
Nel gozzo tireotossico, il principale meccanismo patogenetico per l'aumento della pressione sanguigna è un forte e costante aumento del volume della circolazione sanguigna. In questo caso, gli indicatori PS, di regola, non aumentano; la pressione diastolica può addirittura diminuire. La diagnosi differenziale viene solitamente effettuata con la distonia neurocircolatoria (NCD) di tipo ipertensivo o cardiaco (dolore al cuore, tachicardia, disturbi del ritmo). Stabilire la diagnosi corretta è facilitato dalle caratteristiche caratteristiche della tireotossicosi...
Con tireotossicosi, anemia, mal di montagna, processi infettivi cronici (tubercolosi, tonsillite, ecc.), La tachicardia è solitamente più pronunciata e più forte dell'ipertensione, e quest'ultima nella stragrande maggioranza dei casi è puramente sistolica con un'elevata ampiezza del polso e una diastolica normale pressione sanguigna. Tuttavia, in alcuni casi, i problemi della diagnosi differenziale non sono così facilmente risolvibili, soprattutto durante i periodi...
Per ogni persona, a seconda della sua altezza, peso, età e sesso, è possibile calcolare il valore individuale della resistenza periferica e il volume della gittata cardiaca individuale. Durante l'esercizio, il volume della gittata cardiaca aumenta fisiologicamente, a volte più volte. Tuttavia, la pressione emodinamica media in condizioni normali in persone con sufficientemente allenate ...
N.I. Arinchin e G.V. Kulago hanno cercato di presentare le varianti emodinamiche in esame come "forme patogenetiche" di ipertensione e hanno identificato due tipi estremi di autoregolazione della circolazione sanguigna: "cardiaca" (corrispondente all'ipercinetica) e "vascolare", causata da un aumento nel tono arteriolare. Si è scoperto che l'ipertensione neurocircolatoria e gli stadi iniziali dell'ipertensione sono più caratterizzati da un'emodinamica di tipo ipercinetico, sebbene alcuni casi di ipertensione inizino senza...
La regolazione del volume circolatorio o della gittata cardiaca è stata studiata meno bene della regolazione della pressione sanguigna, principalmente perché determinare la MR in clinica è metodologicamente più difficile che misurare la pressione sanguigna. L'attività del cuore è controllata, da un lato, dall'entità del ritorno venoso - "all'ingresso" - e dal livello di pressione nell'aorta - "all'uscita", dall'altro da influenze neuroumorali dirette sul funzionale...
|
Profilo emodinamico |
SI, l/min/m2 |
OPSS, din/s/cm 5 |
LVDP, mmHg |
|
Ipocinetico | |||
|
"" stagnante | |||
|
Ipovolemico | |||
|
Normocinetico | |||
|
Atonico ipercinetico | |||
|
Spastico ipercinetico |
Nella tabella 10.4 non mostra tutte le opzioni emodinamiche. Il vantaggio di questi parametri è la possibilità della loro determinazione senza sangue. I valori di SI, OPSS e LVDN possono variare ampiamente a seconda del metodo di determinazione. I risultati più accurati nei pazienti critici si ottengono utilizzando metodi di ricerca invasivi.
Come gestire l'emodinamica? Innanzitutto è necessario familiarizzare con le leggi e le formule che determinano l'interdipendenza dei parametri emodinamici più importanti. Devi sapere che la pressione sanguigna dipende da CO e TPSS. La formula che definisce questa dipendenza può essere presentata come segue:
PAS = SV x OPSS,
dove SBP è la pressione arteriosa media, CO è la gittata cardiaca, TPVR è la resistenza vascolare periferica totale. L'SV viene calcolato utilizzando la formula:
CO = HR x SV.
Normalmente, CO o MOC è pari a 5-7 l/min. UO, cioè la quantità di sangue espulso dal cuore in una sistole è di 70-80 ml e dipende dal volume di sangue che scorre al cuore e dalla contrattilità del miocardio. Questa dipendenza è determinata dalla legge di Frank-Starling: maggiore è il riempimento delle camere cardiache, maggiore è la gittata sistolica. Questa posizione è corretta per un cuore sano che funziona normalmente. È chiaro che il volume sistolico può essere regolato creando un adeguato afflusso venoso, ad es. un volume di sangue determinato dalla capacità del cuore di funzionare come una pompa. La contrattilità del muscolo cardiaco può essere aumentata somministrando agenti inotropi positivi. In questo caso bisogna sempre tenere presente lo stato di precarico. L'entità del precarico dipende dal riempimento del letto venoso e dal tono venoso. È possibile ridurre il tono venoso con vasodilatatori e quindi ridurre il precarico. Azioni errate da parte del medico possono aumentare notevolmente il precarico (ad esempio, a causa di un'eccessiva terapia di infusione) e creare condizioni sfavorevoli per il funzionamento del cuore. Se il flusso venoso è ridotto, l’uso di agenti inotropi positivi non sarà giustificato.
Quindi, il problema della riduzione del volume sanguigno dovrebbe essere risolto innanzitutto con un'adeguata terapia infusionale. Con relativa ipovolemia associata a vasodilatazione e ridistribuzione del sangue, il trattamento inizia anche con un aumento del volume del sangue, prescrivendo contemporaneamente farmaci che aumentano il tono venoso. Nei pazienti con contrattilità miocardica insufficiente si osserva quasi sempre un aumento del riempimento delle camere cardiache, che porta ad un aumento della pressione di riempimento ventricolare ed edema polmonare. In tali situazioni cliniche, la terapia infusionale è controindicata; il trattamento consiste nella prescrizione di agenti che riducono il pre e il postcarico. Con l'anafilassi, una diminuzione del postcarico porta ad una diminuzione della pressione sanguigna e determina l'uso di farmaci che aumentano il tono arteriolare.
La CO e la pressione sanguigna possono essere significativamente ridotte in caso di tachicardia o bradicardia grave. Questi cambiamenti possono essere associati sia a fattori cardiaci (difficoltà di conduzione e automatismo) che extracardiaci (ipossia, ipovolemia, influenza dell'aumento del tono vagale, ecc.). Se è possibile trovare la causa dei disturbi del ritmo, il trattamento eziologico di questi disturbi sarà più corretto.
La condizione più importante per la normale funzione cardiaca è l’equilibrio dell’ossigeno. Il muscolo cardiaco, che svolge un'enorme quantità di lavoro, ha un livello estremamente elevato di consumo di ossigeno. La saturazione di ossigeno del sangue nel seno coronarico è del 25%, cioè molto meno che nel sangue venoso misto. Più il cuore lavora, maggiore è il suo bisogno di ossigeno e sostanze nutritive. Non è difficile immaginare che nel miocardio sano non ischemico il consumo di ossigeno dipenda dalla frequenza cardiaca, dalla contrattilità e dalla resistenza alla contrazione delle fibre cardiache. L'apporto di ossigeno al cuore è assicurato dal normale contenuto di trasportatori di ossigeno, ad es. emoglobina, PaO 2, 2,3-DPG, circolazione generale e coronarica. Qualsiasi diminuzione nell'apporto di ossigeno o incapacità di consumare ossigeno (blocco dell'arteria coronaria) porta immediatamente a una disfunzione del sistema cardiovascolare. Il flusso sanguigno coronarico è direttamente proporzionale alla pressione e al raggio del vaso e inversamente proporzionale alla viscosità del sangue e alla lunghezza del vaso (legge di Hagen-Poiseuille). Questa relazione non è lineare perché il vaso coronarico non è un tubo a flusso laminare. Il deterioramento della circolazione coronarica e l'aumento dell'EDP del ventricolo sinistro portano ad una diminuzione della circolazione sanguigna nella zona subendocardica. La viscosità del sangue aumenta con un'elevata concentrazione di emoglobina, un numero elevato di ematocrito e un aumento della concentrazione di proteine (soprattutto fibrinogeno) nel plasma. Riducendo la viscosità del sangue prescrivendo soluzioni cristalloidi e agenti reologici, mantenendo il numero di ematocrito al 30-40% e la concentrazione delle proteine plasmatiche leggermente al di sotto del normale, creiamo condizioni ottimali per il flusso sanguigno coronarico.
Le esigenze metaboliche del cuore sono soddisfatte al massimo in condizioni di glicolisi aerobica. Normalmente il fabbisogno energetico del miocardio è soddisfatto principalmente grazie al metabolismo aerobico del glucosio, a riposo principalmente dai carboidrati e, solo in minima parte, dagli acidi grassi. Ipossia e acidosi, cambiamenti nel metabolismo di potassio, magnesio e altri elettroliti sono accompagnati da un'interruzione del normale metabolismo del muscolo cardiaco.
Per controllare l'emodinamica è necessario il monitoraggio del sistema cardiovascolare. Nelle unità di terapia intensiva generale, si dovrebbe dare la preferenza all’uso di metodi non invasivi (per quanto possibile). Tra gli indicatori invasivi è particolarmente importante il PDLC. L'emodinamica è strettamente correlata alla funzione del sistema nervoso centrale, dei polmoni, dei reni e di altri organi e sistemi.