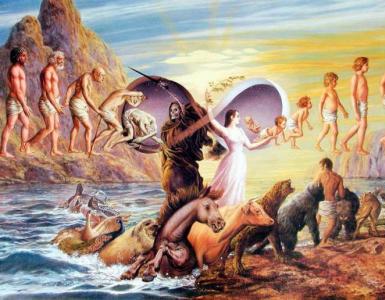Che piaga. Eziologia e patogenesi. Piaga bubbonica
La peste (pestis) è una malattia infettiva focale naturale zoonotica acuta con un meccanismo di trasmissione prevalentemente patogeno trasmissibile, caratterizzato da intossicazione, danni ai linfonodi, alla pelle e ai polmoni. È classificata come una malattia convenzionale particolarmente pericolosa.
Codici secondo ICD -10
A20.0. Piaga bubbonica.
A20.1. Peste cellulocutanea.
A20.2. Peste polmonare.
A20.3. Meningite da peste.
A20.7. Peste setticemica.
A20.8. Altre forme di peste (abortive, asintomatiche, minori).
A20.9. Peste non specificata.
Eziologia (cause) della peste
L'agente eziologico è un piccolo bacillo gram-negativo polimorfico non mobile Yersinia pestis della famiglia delle Enterobacteriaceae del genere Yersinia. Ha una capsula mucosa e non forma spore. Anaerobio facoltativo. Tinto con coloranti all'anilina bipolari (più intensi ai bordi). Del batterio della peste esistono varietà di ratto, marmotta, roditore, campo e lancia di sabbia. Cresce su terreni nutritivi semplici con l'aggiunta di sangue emolizzato o solfato di sodio, la temperatura ottimale per la crescita è di 28°C. Si presenta sotto forma di ceppi virulenti (forme R) e avirulenti (forme S). Yersinia pestis ha più di 20 antigeni, incluso un antigene capsulare termolabile, che protegge l'agente patogeno dalla fagocitosi da parte dei leucociti polimorfonucleati, un antigene somatico termostabile, che include antigeni V e W, che proteggono il microbo dalla lisi nel citoplasma delle cellule mononucleari , garantendo la riproduzione intracellulare, LPS ecc. I fattori di patogenicità dell'agente patogeno sono l'eso- e l'endotossina, nonché gli enzimi di aggressione: coagulasi, fibrinolisina e pesticine. Il microbo è stabile nell'ambiente: persiste nel suolo fino a 7 mesi; nei cadaveri sepolti nel terreno, fino a un anno; nel bubo pus - fino a 20-40 giorni; su articoli per la casa, in acqua - fino a 30–90 giorni; tollera bene il congelamento. In caso di riscaldamento (a 60 °C muore in 30 s, a 100 °C - istantaneamente), essiccazione, esposizione alla luce solare diretta e disinfettanti (alcol, cloramina, ecc.), l'agente patogeno viene rapidamente distrutto. È classificato come gruppo di patogenicità 1.
Epidemiologia della peste
Il ruolo principale nella conservazione dell'agente patogeno in natura è svolto dai roditori, i principali sono marmotte (tarbagan), scoiattoli di terra, arvicole, gerbilli e lagomorfi (lepri, pika). Il serbatoio principale e la fonte dei focolai antroporgici sono i ratti grigi e neri, meno spesso: topi domestici, cammelli, cani e gatti. Una persona che soffre di peste polmonare è particolarmente pericolosa. Tra gli animali, il principale distributore (vettore) della peste è la pulce, che può trasmettere l’agente patogeno 3-5 giorni dopo l’infezione e rimane infettiva fino a un anno. I meccanismi di trasmissione sono vari:
- trasmissibile - se morso da una pulce infetta;
- contatto - attraverso la pelle danneggiata e le mucose quando si scuoiano animali malati; macellazione e taglio di carcasse di cammello, lepre, nonché di ratti, tarbagan, che in alcuni paesi vengono utilizzati come cibo; a contatto con le secrezioni di una persona malata o con oggetti da lui contaminati;
- fecale-orale - quando si mangia carne non sufficientemente trattata termicamente da animali infetti;
- aspirazione - da una persona affetta da forme polmonari di peste.
Le malattie nell'uomo sono precedute da epizoozie tra i roditori. La stagionalità della malattia dipende dalla zona climatica e nei paesi a clima temperato si registra da maggio a settembre. La suscettibilità umana è assoluta in tutte le fasce di età e per qualsiasi meccanismo di infezione. Un paziente con la forma bubbonica della peste prima dell'apertura del bubbone non rappresenta un pericolo per gli altri, ma quando passa alla forma settica o polmonare, diventa altamente infettivo, rilasciando l'agente patogeno con espettorato, secrezioni di bubbone, urina e feci. L'immunità è instabile, sono stati descritti casi ripetuti della malattia.
Focolai naturali di infezione esistono in tutti i continenti, ad eccezione dell'Australia: in Asia, Afghanistan, Mongolia, Cina, Africa, Sud America, dove si registrano circa 2mila casi all'anno. In Russia ci sono circa 12 zone focali naturali: nel Caucaso settentrionale, Cabardino-Balcaria, Daghestan, Transbaikalia, Tuva, Altai, Kalmykia, Siberia e nella regione di Astrakhan. Specialisti anti-peste ed epidemiologi monitorano la situazione epidemica in queste regioni. Negli ultimi 30 anni, nel paese non sono state registrate epidemie a grappolo e il tasso di incidenza è rimasto basso: 12-15 episodi all'anno. Ogni caso di malattia umana deve essere segnalato al centro territoriale di Rospotrebnadzor sotto forma di notifica di emergenza, seguita dall'annuncio di quarantena. Le norme internazionali specificano che la quarantena dura 6 giorni, l'osservazione delle persone in contatto con la peste è di 9 giorni.
Attualmente, la peste è inclusa nell'elenco delle malattie, il cui agente eziologico può essere utilizzato come mezzo di armi batteriologiche (bioterrorismo). I laboratori hanno ottenuto ceppi altamente virulenti resistenti ai comuni antibiotici. In Russia esiste una rete di istituzioni scientifiche e pratiche per combattere le infezioni: istituti antipeste a Saratov, Rostov, Stavropol, Irkutsk e stazioni antipeste nelle regioni.
Misure di prevenzione della peste
Non specifico
- Sorveglianza epidemiologica dei focolai naturali di peste.
- Riduzione del numero dei roditori, effettuando derattizzazioni e disinfestazioni.
- Monitoraggio costante della popolazione a rischio di infezione.
- Preparare le istituzioni mediche e il personale medico a lavorare con i malati di peste, conducendo un lavoro di sensibilizzazione tra la popolazione.
- Prevenzione dell’importazione di agenti patogeni da altri paesi. Le misure da adottare sono stabilite nel Regolamento sanitario internazionale e nel Regolamento sanitario.
Specifica
La prevenzione specifica consiste nell'immunizzazione annuale con un vaccino vivo contro la peste delle persone che vivono in epidemie epizootiche o vi si recano. Alle persone che entrano in contatto con malati di peste, con i loro averi e con cadaveri di animali viene somministrata la chemioprofilassi di emergenza (Tabella 17-22).
Tabella 17-22. Schemi per l'uso di farmaci antibatterici per la prevenzione d'emergenza della peste
| Una droga | Modalità di applicazione | Dose singola, g | Frequenza di applicazione al giorno | Durata del corso, giorni |
| Ciprofloxacina | Dentro | 0,5 | 2 | 5 |
| Ofloxacina | Dentro | 0,2 | 2 | 5 |
| Pefloxacina | Dentro | 0,4 | 2 | 5 |
| Doxiciclina | Dentro | 0,2 | 1 | 7 |
| Rifampicina | Dentro | 0,3 | 2 | 7 |
| Rifampicina + ampicillina | Dentro | 0,3 + 1,0 | 1 + 2 | 7 |
| Rifampicina + ciprofloxacina | Dentro | 0,3 + 0,25 | 1 | 5 |
| Rifampicina + ofloxacina | Dentro | 0,3 + 0,2 | 1 | 5 |
| Rifampicina + pefloxacina | Dentro | 0,3 + 0,4 | 1 | 5 |
| Gentamicina | V/m | 0,08 | 3 | 5 |
| Amikacina | V/m | 0,5 | 2 | 5 |
| Streptomicina | V/m | 0,5 | 2 | 5 |
| Ceftriaxone | V/m | 1 | 1 | 5 |
| Cefotaxima | V/m | 1 | 2 | 7 |
| Ceftazidima | V/m | 1 | 2 | 7 |
Patogenesi della peste
L'agente eziologico della peste entra nel corpo umano più spesso attraverso la pelle, meno spesso attraverso le mucose delle vie respiratorie e del tratto digestivo. Raramente si sviluppano cambiamenti nella pelle nel sito di penetrazione dell'agente patogeno (focalizzazione primaria - phlyctena). Linfogenamente dal sito di introduzione, il batterio entra nel linfonodo regionale, dove si moltiplica, accompagnato dallo sviluppo di infiammazione sierosa-emorragica, diffusione ai tessuti circostanti, necrosi e suppurazione con formazione di un bubbone della peste. Quando la barriera linfatica sfonda, si verifica la diffusione ematogena dell'agente patogeno. L'ingresso dell'agente patogeno per via aerogena favorisce lo sviluppo di un processo infiammatorio nei polmoni con scioglimento delle pareti degli alveoli e concomitante linfoadenite mediastinica. La sindrome da intossicazione è caratteristica di tutte le forme della malattia, è causata dall'azione complessa delle tossine patogene ed è caratterizzata da neurotossicosi, ITS e sindrome tromboemorragica.
Quadro clinico (sintomi) della peste
Il periodo di incubazione dura da alcune ore a 9 giorni o più (in media 2-4 giorni), accorciandosi nella forma polmonare primaria e allungandosi negli individui vaccinati.
o ricevere farmaci profilattici.
Classificazione
Esistono forme di peste localizzate (cutanea, bubbonica, bubbonica cutanea) e generalizzate: setticemica primaria, polmonare primaria, settica secondaria, polmonare secondaria e intestinale.
Principali sintomi e dinamiche del loro sviluppo
Indipendentemente dalla forma della malattia, la peste di solito inizia all'improvviso e il quadro clinico fin dai primi giorni della malattia è caratterizzato da una sindrome da intossicazione pronunciata: brividi, febbre alta (≥39 ° C), grave debolezza, mal di testa, dolori muscolari , sete, nausea e talvolta vomito. La pelle è calda, secca, il viso è rosso e gonfio, la sclera è iniettata, la congiuntiva e le mucose dell'orofaringe sono iperemiche, spesso con emorragie puntiformi, la lingua è secca, ispessita, ricoperta da uno spesso rivestimento bianco (“ gessoso”). Successivamente, nei casi più gravi, il viso diventa smunto, con una tinta cianotica e occhiaie sotto gli occhi. I lineamenti del viso diventano più nitidi, appare un'espressione di sofferenza e orrore ("maschera della peste"). Con il progredire della malattia, la coscienza è compromessa, possono svilupparsi allucinazioni, deliri e agitazione. Il discorso diventa confuso; la coordinazione dei movimenti è compromessa. L'aspetto e il comportamento dei pazienti ricordano uno stato di intossicazione da alcol. Caratterizzato da ipotensione arteriosa, tachicardia, mancanza di respiro, cianosi. Nei casi più gravi della malattia sono possibili sanguinamento e vomito mescolati a sangue. Il fegato e la milza sono ingranditi. Si nota oliguria. La temperatura rimane costantemente elevata per 3-10 giorni. Nel sangue periferico - leucocitosi neutrofila con spostamento a sinistra. Oltre alle manifestazioni generali descritte della peste, si sviluppano lesioni caratteristiche delle singole forme cliniche della malattia.
Forma cutaneaè raro (3-5%). Nel sito della porta d'ingresso dell'infezione appare una macchia, poi una papula, una vescicola (flittena), piena di contenuto sieroso-emorragico, circondata da una zona infiltrata con iperemia ed edema. Phlyctena è caratterizzata da un forte dolore. Quando viene aperto si forma un'ulcera con una crosta scura sul fondo. Un'ulcera da peste ha un decorso lungo e guarisce lentamente, formando una cicatrice. Se questa forma è complicata da setticemia, si verificano pustole e ulcere secondarie. È possibile lo sviluppo di un bubbone regionale (forma bubbonica cutanea).
Forma bubbonica si verifica più spesso (circa l'80%) e si distingue per il suo decorso relativamente benigno. Fin dai primi giorni della malattia compare un dolore acuto nell'area dei linfonodi regionali, che rende difficili i movimenti e costringe il paziente ad assumere una posizione forzata. Il bubbone primario, di regola, è singolo; i bubboni multipli si osservano meno spesso. Nella maggior parte dei casi sono colpiti i linfonodi inguinali e femorali e, meno frequentemente, i linfonodi ascellari e cervicali. La dimensione del bubbone varia da una noce ad una mela di media grandezza. Le caratteristiche vivide sono dolore acuto, consistenza densa, adesione ai tessuti sottostanti, levigatezza dei contorni dovuta allo sviluppo della periadenite. Il bubbone comincia a formarsi dal secondo giorno di malattia. Man mano che si sviluppa, la pelle sopra di essa diventa rossa, lucida e spesso ha una tinta cianotica. All'inizio è denso, poi si ammorbidisce, appaiono le fluttuazioni e i contorni diventano poco chiari. Al 10°-12° giorno di malattia si apre sotto forma di fistola e ulcerazione. Con un decorso benigno della malattia e la moderna terapia antibiotica, si osserva il suo riassorbimento o sclerosi. Come risultato dell'introduzione ematogena dell'agente patogeno, si possono formare bubboni secondari, che compaiono più tardi e sono di piccole dimensioni, meno dolorosi e, di regola, non suppurano. Una grave complicazione di questa forma può essere lo sviluppo di una forma polmonare secondaria o settica secondaria, che peggiora drasticamente le condizioni del paziente, portandolo anche alla morte.
Forma polmonare primaria Si manifesta raramente, durante i periodi di epidemia nel 5-10% dei casi e rappresenta la forma clinica più pericolosa epidemiologicamente e grave della malattia. Inizia in modo brusco, violento. Sullo sfondo di una sindrome da intossicazione pronunciata, fin dai primi giorni compaiono tosse secca, grave mancanza di respiro e dolore tagliente al petto. La tosse diventa poi produttiva, con la produzione di espettorato, la cui quantità può variare da pochi sputi a quantità enormi, raramente è del tutto assente. L'espettorato, dapprima schiumoso, vitreo, trasparente, assume poi un aspetto sanguinante, in seguito diventa puramente sanguigno, e contiene un'enorme quantità di batteri della peste. Di solito ha una consistenza liquida - uno dei segni diagnostici. I dati fisici sono scarsi: un leggero accorciamento del suono della percussione sul lobo interessato; all'auscultazione non si notano molti sibili sottili, il che chiaramente non corrisponde alla gravità generale delle condizioni del paziente. Il periodo terminale è caratterizzato da un aumento della mancanza di respiro, cianosi, sviluppo di stupore, edema polmonare e ITS. La pressione sanguigna diminuisce, il polso accelera e diventa filiforme, i suoni cardiaci sono ovattati, l'ipertermia viene sostituita dall'ipotermia. Senza trattamento, la malattia termina con la morte entro 2-6 giorni. Con l'uso precoce di antibiotici, il decorso della malattia è benigno e differisce poco dalla polmonite di altre eziologie, per cui è possibile il riconoscimento tardivo della forma polmonare della peste e dei casi della malattia nell'ambiente del paziente.
Forma settica primaria Succede raramente - quando una dose massiccia dell'agente patogeno entra nel corpo, solitamente tramite goccioline trasportate dall'aria. Inizia all'improvviso, con sintomi pronunciati di intossicazione e il successivo rapido sviluppo di sintomi clinici: emorragie multiple sulla pelle e sulle mucose, sanguinamento dagli organi interni ("peste nera", "morte nera"), disturbi mentali. Segni di progresso dell'insufficienza cardiovascolare. La morte del paziente avviene entro poche ore dall'ITS. Non ci sono cambiamenti nel sito di introduzione dell'agente patogeno e nei linfonodi regionali.
Forma settica secondaria complica altre forme cliniche di infezione, solitamente bubboniche. La generalizzazione del processo peggiora significativamente le condizioni generali del paziente e aumenta il suo pericolo epidemiologico per gli altri. I sintomi sono simili al quadro clinico sopra descritto, ma differiscono per la presenza di bubboni secondari e per una maggiore durata. Con questa forma della malattia si sviluppa spesso la meningite da peste secondaria.
Forma polmonare secondaria poiché una complicazione si verifica nelle forme localizzate di peste nel 5-10% dei casi e peggiora drasticamente il quadro generale della malattia. Oggettivamente, ciò è espresso da un aumento dei sintomi di intossicazione, comparsa di dolore toracico, tosse, seguito dal rilascio di espettorato sanguinante. I dati fisici consentono di diagnosticare la polmonite lobulare, meno spesso pseudolobare. Il decorso della malattia durante il trattamento può essere benigno, con una lenta guarigione. L’aggiunta della polmonite alle forme di peste a bassa contagiosità rende i pazienti i più pericolosi in termini epidemiologici, quindi ciascuno di questi pazienti deve essere identificato e isolato.
Alcuni autori distinguono separatamente la forma intestinale, ma la maggior parte dei medici tende a considerare i sintomi intestinali (forte dolore addominale, feci abbondanti con muco e sangue, vomito con sangue) come manifestazioni della forma settica primaria o secondaria.
Nei casi ripetuti della malattia, così come nella peste nelle persone che sono state vaccinate o hanno ricevuto chemioprofilassi, tutti i sintomi iniziano e si sviluppano gradualmente e sono più facilmente tollerabili. In pratica, tali condizioni sono chiamate peste “minore” o “ambulatoriale”.
Complicazioni della peste
Esistono complicazioni specifiche: ITS, insufficienza cardiopolmonare, meningite, sindrome tromboemorragica, che portano alla morte dei pazienti, e complicazioni non specifiche causate dalla flora endogena (flemmone, erisipela, faringite, ecc.), che si osservano spesso in un contesto di miglioramento della condizione.
Mortalità e cause di morte
Nella forma polmonare primaria e settica primaria senza trattamento, la mortalità raggiunge il 100%, molto spesso entro il 5° giorno di malattia. Nella forma bubbonica della peste, il tasso di mortalità senza trattamento è del 20-40%, dovuto allo sviluppo di una forma polmonare secondaria o settica secondaria della malattia.
Diagnosi di peste
Diagnosi clinica
Dati clinici ed epidemiologici consentono di sospettare la peste: grave intossicazione, presenza di ulcera, bubbone, grave polmonite, setticemia emorragica in persone situate nella zona focale naturale della peste, che vivono in luoghi in cui si sono verificate epizoozie (morti) tra i roditori. osservati o vi è indicazione di casi di malattia registrati. Ogni paziente sospetto dovrebbe essere esaminato.
Diagnostica di laboratorio specifica e non specifica
Il quadro ematico è caratterizzato da leucocitosi significativa, neutrofilia con spostamento a sinistra e aumento della VES. Le proteine si trovano nelle urine. Durante un esame a raggi X degli organi del torace, oltre ai linfonodi mediastinici ingrossati, si può vedere una polmonite focale, lobulare, meno spesso pseudolobare e, nei casi più gravi, RDS. In presenza di segni meningei (muscoli del collo rigidi, segno di Kernig positivo), è necessaria una puntura spinale. Nel liquido cerebrospinale vengono rilevati più spesso pleocitosi neutrofila a tre cifre, un moderato aumento del contenuto proteico e una diminuzione dei livelli di glucosio. Per la diagnostica specifica, vengono esaminati il bubbone puntato, la secrezione dell'ulcera, il carbonchio, l'espettorato, lo striscio nasofaringeo, il sangue, l'urina, le feci, il liquido cerebrospinale e il materiale sezionale. Le regole per la raccolta del materiale e il suo trasporto sono strettamente regolate dal Regolamento Sanitario Internazionale. Il materiale viene raccolto utilizzando stoviglie, contenitori e disinfettanti speciali. Il personale lavora in tute anti-peste. Una conclusione preliminare viene data sulla base dell'esame microscopico di strisci colorati con Gram, blu di metilene o trattati con uno specifico siero luminescente. Il rilevamento di bastoncini bipolari ovoidali con colorazione intensa ai poli (colorazione bipolare) suggerisce una diagnosi di peste entro un'ora. Per la conferma definitiva della diagnosi, isolamento e identificazione della coltura, il materiale viene seminato su agar in una capsula Petri o in brodo. Dopo 12-14 ore, appare una crescita caratteristica sotto forma di vetro rotto (“pizzo”) sull'agar o “stalattiti” nel brodo. L'identificazione finale della cultura viene effettuata il 3°-5° giorno.
La diagnosi può essere confermata da studi sierologici su sieri accoppiati nell'RPGA, ma questo metodo ha un valore diagnostico secondario. I cambiamenti patologici nei topi e nelle cavie infetti per via intraperitoneale vengono studiati dopo 3-7 giorni, con l'inoculazione di materiale biologico. Metodi simili di isolamento in laboratorio e identificazione dell'agente patogeno vengono utilizzati per identificare le epizoozie della peste in natura. Per la ricerca, i materiali vengono prelevati dai roditori e dai loro cadaveri, nonché dalle pulci.
Diagnosi differenziale
L'elenco delle nosologie con cui effettuare la diagnosi differenziale dipende dalla forma clinica della malattia. La forma cutanea della peste è differenziata dalla forma cutanea dell'antrace, bubbonica - dalla forma cutanea della tularemia, linfoadenite purulenta acuta, sodoku, linforeticolosi benigna, granuloma venereo; forma polmonare - da polmonite lobare, forma polmonare di antrace. La forma settica della peste deve essere distinta dalla meningococcemia e dalle altre setticemia emorragica. La diagnosi dei primi casi della malattia è particolarmente difficile. I dati epidemiologici sono di grande importanza: permanenza in focolai di infezione, contatto con roditori affetti da polmonite. Va tenuto presente che l'uso precoce degli antibiotici modifica il decorso della malattia. Anche la forma polmonare della peste in questi casi può essere benigna, ma i pazienti rimangono comunque contagiosi. Considerando queste caratteristiche, in presenza di dati epidemici, in tutti i casi di malattie che si manifestano con febbre alta, intossicazione, lesioni della pelle, dei linfonodi e dei polmoni, dovrebbe essere esclusa la peste. In tali situazioni è necessario effettuare esami di laboratorio e coinvolgere gli specialisti del servizio antipeste. I criteri per la diagnosi differenziale sono presentati nella tabella (Tabelle 17-23).
Tabella 17-23. Diagnosi differenziale della peste
| Forma nosologica | Sintomi generali | Criteri differenziali |
| Antrace, forma cutanea | Febbre, intossicazione, carbonchio, linfoadenite | A differenza della peste, la febbre e l'intossicazione compaiono al 2°-3° giorno di malattia, il carbonchio e la zona circostante l'edema sono indolori, si osserva una crescita eccentrica dell'ulcera |
| Tularemia, forma bubbonica | Febbre, intossicazione, bubbone, sindrome epatolienale | A differenza della peste, febbre e intossicazione sono moderate, il bubbone è poco dolente, mobile, a contorni netti; la suppurazione è possibile nella 3a-4a settimana e successivamente, dopo che la temperatura si è normalizzata e le condizioni del paziente sono soddisfacenti, possono comparire bubboni secondari |
| Linfoadenite purulenta | Poliadenite con dolore locale, febbre, intossicazione e suppurazione | A differenza della peste, c'è sempre un focolaio purulento locale (crimine criminale, abrasione suppurante, ferita, tromboflebite). La comparsa dei sintomi locali è preceduta da febbre, generalmente moderata. L'intossicazione è lieve. Non c'è periadenite. La pelle sopra il linfonodo è di colore rosso vivo, il suo ingrossamento è moderato. Non esiste una sindrome epatolienale |
| Polmonite lobare | Esordio acuto, febbre, intossicazione, possibile espettorato misto a sangue. Segni fisici di polmonite | A differenza della peste, l’intossicazione aumenta dal 3° al 5° giorno di malattia. I sintomi dell'encefalopatia non sono tipici. I segni fisici di polmonite sono chiaramente espressi, l'espettorato è scarso, "arrugginito", viscoso |
Indicazioni per la consultazione con altri specialisti
Di solito vengono effettuate consultazioni per chiarire la diagnosi. Se si sospetta la forma bubbonica è indicato il consulto con un chirurgo; se si sospetta la forma polmonare è indicato il consulto con uno pneumologo.
Un esempio di formulazione diagnostica
A20.0. Peste, forma bubbonica. Complicazione: meningite. Corrente forte.
Tutti i pazienti con sospetta peste sono soggetti a ricovero d'urgenza con trasporto speciale in un ospedale per malattie infettive, in una scatola separata, nel rispetto di tutte le misure antiepidemiche. Il personale che si prende cura dei malati di peste deve indossare una tuta protettiva antipeste. Gli oggetti domestici nel reparto e le escrementi dei pazienti sono soggetti a disinfezione.
Trattamento della peste
Modalità. Dieta
Riposo a letto durante il periodo febbrile. Non è prevista alcuna dieta speciale. Si consiglia una dieta delicata (tabella A).
Terapia farmacologica
La terapia etiotropica deve essere iniziata se si sospetta la peste, senza attendere la conferma batteriologica della diagnosi. Include l'uso di farmaci antibatterici. Durante lo studio dei ceppi naturali dei batteri della peste in Russia, non è stata riscontrata alcuna resistenza ai comuni farmaci antimicrobici. Il trattamento etiotropico viene effettuato secondo schemi approvati (Tabelle 17-24–17-26).
Tabella 17-24. Schema per l'uso di farmaci antibatterici nel trattamento della peste bubbonica
| Una droga | Modalità di applicazione | Dose singola, g | Frequenza di applicazione al giorno | Durata del corso, giorni |
| Doxiciclina | Dentro | 0,2 | 2 | 10 |
| Ciprofloxacina | Dentro | 0,5 | 2 | 7–10 |
| Pefloxacina | Dentro | 0,4 | 2 | 7–10 |
| Ofloxacina | Dentro | 0,4 | 2 | 7–10 |
| Gentamicina | V/m | 0,16 | 3 | 7 |
| Amikacina | V/m | 0,5 | 2 | 7 |
| Streptomicina | V/m | 0,5 | 2 | 7 |
| Tobramicina | V/m | 0,1 | 2 | 7 |
| Ceftriaxone | V/m | 2 | 1 | 7 |
| Cefotaxima | V/m | 2 | 3–4 | 7–10 |
| Ceftazidima | V/m | 2 | 2 | 7–10 |
| Ampicillina/sulbactam | V/m | 2/1 | 3 | 7–10 |
| Aztreon | V/m | 2 | 3 | 7–10 |
Tabella 17-25. Schema per l'uso di farmaci antibatterici nel trattamento delle forme polmonari e settiche di peste
| Una droga | Modalità di applicazione | Dose singola, g | Frequenza di applicazione al giorno | Durata del corso, giorni |
| Ciprofloxacina* | Dentro | 0,75 | 2 | 10–14 |
| Pefloxacina* | Dentro | 0,8 | 2 | 10–14 |
| Ofloxacina* | Dentro | 0,4 | 2 | 10–14 |
| Doxiciclina* | Dentro | 0,2 al 1° appuntamento, poi 0,1 ciascuno | 2 | 10–14 |
| Gentamicina | V/m | 0,16 | 3 | 10 |
| Amikacina | V/m | 0,5 | 3 | 10 |
| Streptomicina | V/m | 0,5 | 3 | 10 |
| Ciprofloxacina | IV | 0,2 | 2 | 7 |
| Ceftriaxone | V/m, i.v. | 2 | 2 | 7–10 |
| Cefotaxima | V/m, i.v. | 3 | 3 | 10 |
| Ceftazidima | V/m, i.v. | 2 | 3 | 10 |
| Cloramfenicolo (cloramfenicolo sodico succinato**) | V/m, i.v. | 25-35 mg/kg | 3 | 7 |
**Utilizzato per trattare la peste che colpisce il sistema nervoso centrale.
Tabella 17-26. Schemi per l'uso di combinazioni di farmaci antibatterici nel trattamento delle forme di peste polmonare e settica
| Una droga | Modalità di applicazione | Dose singola, g | Frequenza di applicazione al giorno | Durata del corso, giorni |
| Ceftriaxone + streptomicina (o amikacina) | V/m, i.v. | 1+0,5 | 2 | 10 |
| Ceftriaxone + gentamicina | V/m, i.v. | 1+0,08 | 2 | 10 |
| Ceftriaxone + rifampicina | IV, interno | 1+0,3 | 2 | 10 |
| Ciprofloxacina* + rifampicina | Dentro, dentro | 0,5+0,3 | 2 | 10 |
| Ciprofloxacina + streptomicina (o amikacina) | Dentro, per via endovenosa, intramuscolare | 0,5+0,5 | 2 | 10 |
| Ciprofloxacina + gentamicina | Dentro, per via endovenosa, intramuscolare | 0,5+0,08 | 2 | 10 |
| Ciprofloxacina* + ceftriaxone | IV, IV, IM | 0,1–0,2+1 | 2 | 10 |
| Rifampicina + gentamicina | Dentro, per via endovenosa, intramuscolare | 0,3+0,08 | 2 | 10 |
| Rifampicina + streptomicina (o amikacina) | Dentro, per via endovenosa, intramuscolare | 0,3+0,5 | 2 | 10 |
* Esistono forme di iniezione del farmaco per la somministrazione parenterale.
Nei casi più gravi si raccomanda di utilizzare combinazioni compatibili di agenti antibatterici nelle dosi indicate nei regimi durante i primi quattro giorni di malattia. Nei giorni successivi il trattamento viene continuato con un farmaco. Per i primi 2-3 giorni i farmaci vengono somministrati per via parenterale e successivamente si passa alla somministrazione orale.
Insieme al trattamento specifico, viene effettuato un trattamento patogenetico volto a combattere l'acidosi, l'insufficienza cardiovascolare e il DN, i disturbi del microcircolo, l'edema cerebrale e la sindrome emorragica.
La terapia disintossicante consiste nell'infusione endovenosa di soluzioni colloidali (reopoliglucina, plasma) e cristalloidi (glucosio 5–10%, soluzioni poliioniche) fino a 40–50 ml/kg al giorno. Il siero antipeste e le gammaglobuline specifiche precedentemente utilizzati si sono rivelati inefficaci durante il processo di osservazione e attualmente non vengono utilizzati nella pratica, né viene utilizzato il batteriofago della peste. I pazienti vengono dimessi dopo la completa guarigione (per la forma bubbonica non prima della 4a settimana, per la forma polmonare - non prima della 6a settimana dal giorno della guarigione clinica) e un risultato negativo di tre volte ottenuto dopo coltura del bubbone puntato, espettorato o sangue, che viene effettuato il 2°, 4°, 6° giorno dopo la cessazione del trattamento. Dopo la dimissione, l'osservazione medica viene effettuata per 3 mesi.
(lat. peste) è una malattia infettiva focale naturale acuta del gruppo delle infezioni da quarantena, che si manifesta con condizioni generali estremamente gravi, febbre, danni ai linfonodi, ai polmoni e ad altri organi interni, spesso con sviluppo di sepsi. La malattia è caratterizzata anche da un'elevata mortalità.
Bacillo della peste al microscopio a fluorescenza L'agente eziologico è il bacillo della peste (lat. Yersinia pestis), scoperto nel 1894 contemporaneamente dal francese Yersin e dal giapponese Kitasato.
Il periodo di incubazione dura da alcune ore a 3-6 giorni. Le forme più comuni di peste sono bubbonica e polmonare. Il tasso di mortalità per la peste bubbonica varia dal 27 al 95%, per la peste polmonare - quasi il 100%.
Le famose epidemie di peste, che causarono milioni di vittime, lasciarono un segno profondo nella storia dell'umanità.
Storia
La peste è una malattia conosciuta fin dall'antichità; le prime notizie possibili al riguardo risalgono alla fine del II e all'inizio del III secolo d.C. La più famosa è la cosiddetta “peste di Giustiniano” (551-580), che ebbe origine nell’Impero Romano d’Oriente e colpì l’intero Medio Oriente. Più di 20 milioni di persone morirono a causa di questa epidemia. Nel X secolo si verificò una grande epidemia di peste in Europa, in particolare in Polonia e nella Rus di Kiev. Nel 1090, oltre 10.000 persone morirono di peste a Kiev in due settimane. Nel XII secolo si verificarono più volte epidemie di peste tra i crociati. Nel XIII secolo si verificarono diverse epidemie di peste in Polonia e Rus'. Nel XIV secolo, una terribile epidemia della “morte nera”, portata dalla Cina orientale, colpì l’Europa. Nel 1348 morirono quasi 15 milioni di persone, ovvero un quarto dell'intera popolazione europea. Nel 1346 la peste venne portata in Crimea, e nel 1351 in Polonia e Rus'. Successivamente, in Russia furono osservate epidemie di peste nel 1603, 1654, 1738-1740 e 1769. Un'epidemia di peste bubbonica colpì Londra nel 1664-1665, uccidendo più del 20% della popolazione della città.
Si registrano ancora casi isolati di infezione da peste bubbonica.
La peste colpisce gli operai di una tipografia (incisione 1500 g) Nel Medioevo la diffusione della peste fu facilitata dalle condizioni antigeniche che regnavano nelle città. Non esisteva un sistema fognario e tutti i rifiuti scorrevano lungo le strade, che fungevano da ambiente ideale per la vita dei topi.
Secondo Alberti Siena “perde molto... per la mancanza di pozzi neri. Per questo tutta la città emette un fetore non solo durante la prima e l’ultima vigilia della notte, quando dalle finestre si riversano i recipienti con i liquami accumulati, ma anche nelle altre ore è disgustoso e molto inquinato”. Inoltre, in molti luoghi, la causa della peste fu dichiarata dai gatti, presumibilmente servi del diavolo e infettanti le persone. Lo sterminio di massa dei gatti portò ad un aumento ancora maggiore del numero dei ratti. La causa dell'infezione sono spesso i morsi delle pulci che precedentemente vivevano su ratti infetti.
La peste come arma biologica
L'uso dell'agente patogeno della peste come arma biologica ha profonde radici storiche.
In particolare, gli eventi avvenuti nell’antica Cina e nell’Europa medievale hanno visto l’uso di carcasse di animali infetti (cavalli e mucche) e di corpi umani da parte di Unni, Turchi e Mongoli per contaminare le fonti d’acqua e i sistemi di approvvigionamento idrico. Esistono segnalazioni storiche di casi di espulsione di materiale infetto durante l'assedio di alcune città.
Bomba in ceramica contenente materiale infetto dalla peste: una colonia di pulci Durante la seconda guerra mondiale, le forze armate giapponesi utilizzarono elementi di armi biologiche sotto forma di agenti della peste. Gli aerei giapponesi effettuarono un massiccio lancio di portatori di peste appositamente preparati: pulci infette. Il distaccamento speciale 731 ha deliberatamente infettato civili e prigionieri in Cina, Corea e Manciuria per ulteriori ricerche ed esperimenti medici e per studiare le prospettive delle armi biologiche di distruzione di massa. Il gruppo ha sviluppato un ceppo di peste 60 volte più virulento del ceppo originale, una sorta di arma di distruzione di massa assolutamente efficace a diffusione naturale. Sono state sviluppate varie bombe aeree e proiettili per lanciare e disperdere i portatori infetti, come bombe terrestri, bombe aerosol e proiettili a frammentazione che danneggiano i tessuti umani. Le bombe in ceramica erano popolari, tenendo conto delle peculiarità dell'uso degli organismi viventi: le pulci e della necessità di mantenere la loro attività e vitalità in condizioni di scarico, per le quali venivano create speciali condizioni di supporto vitale (in particolare, veniva pompato ossigeno).
Infezione
L'agente causale della peste è resistente alle basse temperature, si conserva bene nell'espettorato, ma a una temperatura di 55°C muore entro 10-15 minuti e, quando bollito, quasi immediatamente. Entra nel corpo attraverso la pelle (da un morso di pulce, solitamente Xenopsylla cheopis), le mucose del tratto respiratorio, il tratto digestivo e la congiuntiva.
In base al vettore principale, i focolai naturali della peste si dividono in scoiattoli terricoli, marmotte, gerbilli, arvicole e pika. Oltre ai roditori selvatici, il processo epizootico comprende talvolta i cosiddetti roditori sinantropici (in particolare ratti e topi), nonché alcuni animali selvatici (lepri, volpi) oggetto di caccia. Tra gli animali domestici, i cammelli soffrono di peste.
In un'epidemia naturale, l'infezione avviene solitamente attraverso il morso di una pulce che in precedenza si nutriva di un roditore malato; la probabilità di infezione aumenta significativamente quando i roditori sinantropici vengono inclusi nell'epizoozia. L'infezione si verifica anche durante la caccia ai roditori e la loro ulteriore lavorazione. Enormi malattie umane si verificano quando un cammello malato viene macellato, scuoiato, macellato o lavorato. Una persona infetta, a seconda della forma della malattia, può a sua volta trasmettere la peste attraverso goccioline trasportate dall'aria o attraverso il morso di alcuni tipi di pulci.
La pulce xenopsylla cheopis è la principale portatrice della peste Le pulci sono un portatore specifico dell'agente patogeno della peste. Ciò è dovuto alle peculiarità del sistema digestivo delle pulci: appena prima dello stomaco, nell'esofago delle pulci si forma un ispessimento: un gozzo. Quando un animale infetto (ratto) viene morso, il batterio della peste si deposita nel raccolto delle pulci e inizia a moltiplicarsi intensamente, intasandolo completamente. Il sangue non può entrare nello stomaco, quindi
Una tale pulce è costantemente tormentata da una sensazione di fame. Si sposta da un ospite all'altro nella speranza di ottenere la sua parte di sangue e riesce a infettare un numero abbastanza elevato di persone prima di morire (tali pulci vivono non più di dieci giorni).
Quando una persona viene morsa da pulci infette da batteri della peste, nel sito del morso può comparire una papula o una pustola piena di contenuto emorragico (forma cutanea). Quindi il processo si diffonde attraverso i vasi linfatici senza la manifestazione della linfangite. La proliferazione dei batteri nei macrofagi dei linfonodi porta al loro forte aumento, fusione e formazione di un conglomerato (forma bubbonica). Un'ulteriore generalizzazione dell'infezione, che non è strettamente necessaria, soprattutto nelle condizioni della moderna terapia antibatterica, può portare allo sviluppo di una forma settica, accompagnata da danni a quasi tutti gli organi interni.
Tuttavia, da un punto di vista epidemiologico, il ruolo più importante è svolto dallo “schermamento” dell’infezione nel tessuto polmonare con lo sviluppo della forma polmonare della malattia. Dal momento in cui si sviluppa la polmonite da peste, la persona malata stessa diventa una fonte di infezione, ma allo stesso tempo la forma polmonare della malattia si trasmette già da persona a persona - estremamente pericolosa, con un decorso molto rapido.
Sintomi
Forma bubbonica
la peste è caratterizzata dalla comparsa di conglomerati fortemente dolorosi, il più delle volte nei linfonodi inguinali da un lato. Il periodo di incubazione è di 2-6 giorni (meno spesso 1-12 giorni). Nel corso di diversi giorni, la dimensione del conglomerato aumenta e la pelle sopra di esso può diventare iperemica. Allo stesso tempo appare un aumento di altri gruppi di linfonodi: bubboni secondari. I linfonodi del focolaio primario subiscono un rammollimento; alla puntura si ottengono contenuti purulenti o emorragici, la cui analisi microscopica rivela un gran numero di bastoncini Gram-negativi con colorazione bipolare. In assenza di terapia antibatterica, i linfonodi in suppurazione vengono aperti. Quindi avviene la guarigione graduale della fistola. La gravità delle condizioni dei pazienti aumenta gradualmente entro il 4-5° giorno, la temperatura può aumentare, a volte compare immediatamente una febbre alta, ma all'inizio le condizioni dei pazienti spesso rimangono generalmente soddisfacenti. Questo spiega il fatto che una persona malata di peste bubbonica può volare da una parte all'altra del mondo, ritenendosi sana.
Tuttavia, in qualsiasi momento, la forma bubbonica della peste può causare la generalizzazione del processo e trasformarsi in una forma settica secondaria o polmonare secondaria. In questi casi, le condizioni dei pazienti diventano molto rapidamente estremamente gravi. I sintomi di intossicazione aumentano di ora in ora. La temperatura dopo forti brividi sale a livelli febbrili elevati. Si notano tutti i segni di sepsi: dolore muscolare, grave debolezza, mal di testa, vertigini, congestione della coscienza, fino alla sua perdita, a volte agitazione (il paziente si precipita a letto), insonnia. Con lo sviluppo della polmonite, la cianosi aumenta, appare una tosse con il rilascio di espettorato schiumoso e sanguinante contenente un'enorme quantità di bacilli della peste. È questo espettorato che diventa la fonte di infezione da persona a persona con lo sviluppo della peste polmonare ormai primaria.
Settico e polmonare
si verificano forme di peste, come ogni sepsi grave, con manifestazioni di sindrome della coagulazione intravascolare disseminata: sono possibili piccole emorragie sulla pelle, è possibile sanguinamento dal tratto gastrointestinale (vomito di masse sanguinanti, melena), grave tachicardia, rapida e che richiede correzione ( dopamina) abbassano la pressione sanguigna.
Quadro clinico
Il quadro clinico della peste è differenziato a seconda del metodo di infezione del paziente. Di norma, si distinguono le seguenti forme della malattia: forma locale ( cutanea, bubbonica e cutaneo-bubbonica
) - in questa forma il microbo della peste praticamente non entra nell'ambiente esterno.
Forma generalizzata (settica primaria e secondaria) con maggiore dispersione del microbo nell'ambiente esterno, polmonare primario, polmonare secondario e intestinale
con abbondante rilascio del microbo. Allo stesso tempo, la forma intestinale della peste è isolata esclusivamente come complicazione di altre forme di questa malattia e, di regola, non è presente nella classificazione delle forme della malattia. Il periodo di incubazione della peste varia dalle 72 alle 150 ore, nella maggior parte dei casi non supera i tre giorni. In casi eccezionali, con una serie di forme della malattia, la sua riduzione è possibile. Una caratteristica della malattia è il suo modello di sviluppo. I segni della malattia compaiono improvvisamente, senza sintomi preliminari dello sviluppo primario. Di norma, non si osservano brividi e debolezza, la temperatura sale a 39-40 gradi si verifica all'improvviso, il paziente avverte forti mal di testa, spesso attacchi di vomito. Vengono registrati arrossamento (iperemia) del viso, congiuntiva delle palpebre e bulbo oculare, dolore muscolare e sensazione di debolezza. Segni caratteristici
malattie: patina bianca sulla superficie della lingua, narici notevolmente dilatate, labbra secche evidenti. Di norma, si osserva un aumento della temperatura della pelle, la sua secchezza e può comparire un'eruzione cutanea, tuttavia, in alcuni casi (in particolare, con debolezza cardiaca, la manifestazione esterna del sudore è possibile quando la pelle del paziente è relativamente Freddo). Una caratteristica della peste è la costante sensazione di sete del paziente. La malattia è caratterizzata da un elevato grado di danno al sistema nervoso centrale del paziente a causa di una grave intossicazione, con conseguente insonnia o agitazione. In alcuni casi si manifesta delirio e perdita di coordinazione dei movimenti. Il paziente è caratterizzato da irrequietezza, pignoleria e maggiore mobilità. In alcuni casi si registrano indigestione, difficoltà a urinare e dolori addominali al contatto diretto. Di norma, il sangue del paziente mostrerà leucocitosi polinucleare da venti a cinquantamila con uno spostamento della formula del sangue a sinistra con un leggero cambiamento nel sangue, un numero normale di globuli rossi ed emoglobina e un ROE accelerato. La morte del paziente è causata da grave sepsi e grave tossinemia. La forma clinica della peste non è formata dai suoi sintomi, ma, di regola, da casi di danno locale al paziente, vale a dire manifestazioni di peste bubbonica, settica e, meno comunemente, polmonare.
Peste cutanea
La penetrazione del microbo della peste attraverso la pelle non provoca una reazione primaria; solo nel 3% dei casi si osserva arrossamento e ispessimento della pelle con dolore evidente. Allo stesso tempo, la papula rossastra primaria si trasforma in una vescicola e una pustola, dopo di che il dolore diminuisce e quindi i segni esterni non compaiono più. Tuttavia, il processo infiammatorio progredisce, appare un carbonchio che si trasforma in un'ulcera che, dopo la guarigione, forma una cicatrice. In alcuni casi, quando vengono colpiti i linfonodi, si registra la forma bubbonica della peste.
Peste bubbonica cutanea
La forma bubbonica cutanea della peste si fissa quando il microbo penetra attraverso la pelle. Il microbo della peste, penetrato sotto la pelle con il flusso della linfa, viene trasportato nel linfonodo del paziente, provocando un processo infiammatorio che si diffonde ai tessuti vicini, creando il cosiddetto bubbone, piuttosto doloroso alla palpazione. Allo stesso tempo, i processi infiammatori vengono ridotti.
Piaga bubbonica
Piaga bubbonica La forma bubbonica della peste è caratterizzata dall'assenza di reazione nel sito di introduzione del microbo, a differenza della forma cutanea. I sintomi si riscontrano sui linfonodi del paziente, molto spesso si notano i bubboni inguinali e femorali, meno spesso quelli ascellari e cervicali. Il primo segno di peste bubbonica è un dolore acuto nella sede del bubbone in via di sviluppo, che si nota sia durante il movimento che a riposo. Nella fase primaria della peste, i singoli linfonodi ipertrofizzati possono essere palpati nel sito della malattia. Il bubbone poi si sintetizza con i tessuti circostanti in un'unica formazione, costituendo così una caratteristica importante della peste da bubbone. Quando si palpa un singolo bubbone, si avverte un tumore, denso solo al centro, dove si trovano i linfonodi. La pelle nella zona del bubbone acquisisce tinte rosse, al centro può diventare blu. È importante notare che la dimensione del bubbone caratterizza il decorso della malattia: con decorso benigno, il bubbone si sviluppa e raggiunge le dimensioni di un uovo di gallina o più, la fase infiammatoria dura dai sei agli otto giorni. Quindi si verificano suppurazione e riassorbimento, sclerosi del bubbone. Al contrario, nei casi gravi di peste, il bubbone non si sviluppa, il microbo supera i confini dei linfonodi, utilizzando il flusso della lima, diffondendosi in tutto il corpo, il che può portare a un esito fatale senza una terapia speciale. Dovrebbe
Va notato che il processo negativo, di norma, può essere evitato utilizzando antibiotici, provocando il riassorbimento del bubbone, evitando la diffusione del microbo. Di significato diagnostico è la discrepanza tra la risposta della temperatura corporea e la frequenza cardiaca del paziente, poiché il polso è di 140 battiti al minuto e si nota l'aritmia. In genere, la pressione sanguigna massima diminuisce. Nei casi critici, la pressione massima viene abbassata a 90 - 80, quella minima a 45 - 40. Attualmente, i pazienti con la forma bubbonica della peste muoiono estremamente raramente, cosa che si ottiene con l'uso di antibiotici, tuttavia, la forma bubbonica della peste può causare la polmonite da peste come complicazione, che ha un effetto negativo durante il decorso della malattia e crea un grande pericolo di diffusione del microbo della peste attraverso goccioline trasportate dall'aria. Una forma separata di complicanza è la meningite, caratterizzata da forte mal di testa, tensione dolorosa nei muscoli della parte posteriore della testa, danni ai nervi cranici e un segno di Kernig positivo, le convulsioni non sono escluse. Nelle donne in gravidanza non si può escludere un aborto o un parto prematuro.
Forma setticemica di peste
Forma settica di peste che colpisce gli arti Nella forma settica primaria della peste, il microbo penetra nella pelle o attraverso le mucose, il che è associato all'elevata virulenza del microbo, alla sua massiccia dose infettiva e alla bassa resistenza del corpo del paziente, che consente all'agente patogeno di penetrare nel il sangue del paziente senza alcun cambiamento esterno evidente, superando i meccanismi di difesa del corpo. Il segno principale della malattia è la temperatura elevata del paziente e l'aumento viene registrato inaspettatamente per il paziente. Accompagnato da mancanza di respiro, polso rapido, delirio, debolezza, prostrazione. È possibile che sulla pelle del paziente compaia un'eruzione cutanea caratteristica. Se non trattata, la morte avviene entro due o quattro giorni. In casi eccezionali, in condizioni negative, è stato osservato un esito fatale entro 24 ore, la cosiddetta forma di peste fulminante”, senza alcun segno clinico caratteristico.
Peste polmonare
La forma polmonare della peste è la polmonite primaria e si sviluppa quando una persona viene infettata da goccioline trasportate dall'aria del suo sistema respiratorio. La forma polmonare è caratterizzata dallo sviluppo di focolai di infiammazione nei polmoni come sintomi principali della peste. Ci sono due stadi della peste polmonare. Il primo stadio è caratterizzato dalla predominanza dei sintomi generali della peste, nel secondo stadio della forma polmonare si osservano bruschi cambiamenti nei polmoni del paziente. In questa forma della malattia c'è un periodo di eccitazione febbrile, un periodo al culmine della malattia e un periodo terminale con progressiva mancanza di respiro e coma. Il periodo più pericoloso è caratterizzato dal rilascio di microbi nell'ambiente esterno: il secondo periodo della malattia, che ha un significato epidemico critico. Il primo giorno di malattia, un paziente con una forma polmonare di peste avverte brividi, mal di testa, dolore alla parte bassa della schiena, agli arti, debolezza, spesso nausea e vomito, arrossamento e gonfiore del viso, un aumento della temperatura a 39 - 41 gradi, dolore e sensazione di oppressione al petto, difficoltà di respirazione, irrequietezza, polso rapido e spesso aritmico. Quindi, di regola, sono presenti respiro accelerato e mancanza di respiro. Nel periodo agonale si osservano respiro superficiale e adinamia pronunciata. Si registra una tosse debole, l'espettorato contiene strisce di sangue e una quantità significativa di microbi della peste. In questo caso, occasionalmente, l'espettorato è assente o ha un carattere atipico. La clinica della polmonite da peste è caratterizzata da una marcata scarsità di dati oggettivi nei pazienti, che non è paragonabile alle condizioni oggettivamente gravi dei pazienti; i cambiamenti nei polmoni sono praticamente assenti o insignificanti in tutte le fasi della malattia. Il respiro sibilante non è praticamente udibile, la respirazione bronchiale si sente solo in aree limitate. Allo stesso tempo, i pazienti con la forma polmonare primaria di peste senza il trattamento necessario muoiono entro due o tre giorni, mentre sono caratteristici la mortalità assoluta e un decorso rapido della malattia.
Diagnosi
Il ruolo più importante nella diagnosi nelle condizioni moderne è giocato dall'anamnesi epidemiologica. Arrivo da zone endemiche per la peste (Vietnam, Birmania, Bolivia, Ecuador, Turkmenistan, Karakalpakstan, ecc.), o da stazioni antipeste di un paziente con i segni della forma bubbonica sopra descritta o con segni della forma più grave - con emorragie ed espettorato con sangue - polmonite con grave linfoadenopatia è un argomento sufficientemente serio affinché il medico di primo contatto adotti tutte le misure per localizzare la sospetta peste e diagnosticarla con precisione. Va sottolineato in particolare che nelle condizioni della moderna prevenzione farmacologica, la probabilità di malattia tra il personale che è stato in contatto per qualche tempo con un paziente affetto da tosse è molto ridotta. Attualmente non si registrano casi di peste polmonare primaria (cioè casi di infezione da persona a persona) tra il personale medico. Una diagnosi accurata deve essere fatta utilizzando studi batteriologici. Il materiale per loro è il punto di un linfonodo in suppurazione, l'espettorato, il sangue del paziente, la secrezione di fistole e ulcere.
La diagnosi di laboratorio viene effettuata utilizzando un antisiero specifico fluorescente, utilizzato per colorare strisci di secrezioni da ulcere, linfonodi puntati e colture ottenute su agar sangue.
Trattamento
Se si sospetta la peste viene immediatamente allertata la stazione sanitaria ed epidemiologica della zona. La notifica viene compilata dal medico che sospetta un'infezione e la sua trasmissione è assicurata dal primario dell'istituto in cui è stato trovato il paziente.
Il paziente deve essere immediatamente ricoverato nell'ospedale di malattie infettive. Un medico o un operatore paramedico di un istituto medico, quando scopre un malato o sospettato di avere la peste, è obbligato a interrompere l'ulteriore ricovero dei pazienti e a vietare l'ingresso e l'uscita dall'istituto medico. L'operatore sanitario, restando nello studio o nel reparto, deve informare in modo accessibile il primario dell'identificazione del paziente e richiedere tute antipeste e disinfettanti.
In caso di accoglienza di un paziente con danno polmonare, prima di indossare una tuta anti-peste completa, l'operatore sanitario è obbligato a trattare le mucose degli occhi, della bocca e del naso con una soluzione di streptomicina. Se non c'è tosse puoi limitarti a trattare le mani con una soluzione disinfettante. Dopo aver adottato misure per separare la persona malata da quella sana, in un istituto medico oa casa viene compilato un elenco delle persone che hanno avuto contatti con il paziente, indicando il cognome, nome, patronimico, età, luogo di lavoro, professione, indirizzo di casa.
Fino all’arrivo del consulente dell’istituto anti-peste, l’operatore sanitario resta nel focolaio. La questione del suo isolamento viene decisa individualmente in ciascun caso specifico. Il consulente preleva il materiale per l'esame batteriologico, dopodiché può iniziare il trattamento specifico del paziente
antibiotici.
Quando si identifica un paziente su un treno, un aereo, una nave, un aeroporto o una stazione ferroviaria, le azioni degli operatori sanitari rimangono le stesse, anche se le misure organizzative saranno diverse. È importante sottolineare che la separazione di un paziente sospetto dagli altri dovrebbe iniziare immediatamente dopo la sua identificazione.
Il primario dell'istituto, dopo aver ricevuto un messaggio sull'identificazione di un paziente sospettato di peste, adotta misure per interrompere la comunicazione tra i reparti dell'ospedale e i piani della clinica e vieta di lasciare l'edificio in cui è stato trovato il paziente. Allo stesso tempo, organizza la trasmissione dei messaggi di emergenza ad un'organizzazione superiore e all'istituzione antipeste. La forma delle informazioni può essere arbitraria con la presentazione obbligatoria dei seguenti dati: cognome, nome, patronimico, età del paziente, luogo di residenza, professione e luogo di lavoro, data di rilevamento, ora di insorgenza della malattia, dati oggettivi, diagnosi preliminare, misure primarie adottate per localizzare il focolaio, posizione e cognome del medico che ha diagnosticato il paziente. Insieme alle informazioni, il gestore richiede consulenti e l'assistenza necessaria.
Tuttavia, in alcune situazioni, può essere più appropriato effettuare il ricovero ospedaliero (prima di stabilire una diagnosi accurata) nell'istituto in cui si trova il paziente al momento in cui si presume abbia la peste. Le misure terapeutiche sono inseparabili dalla prevenzione dell'infezione del personale, che deve indossare immediatamente maschere di garza a 3 strati, copriscarpe, una sciarpa composta da 2 strati di garza che copra completamente i capelli e occhiali protettivi per impedire l'ingresso di schizzi di espettorato la mucosa degli occhi. Secondo le regole stabilite nella Federazione Russa, il personale deve indossare una tuta anti-peste o utilizzare speciali mezzi di protezione anti-infettiva con proprietà simili. Tutto il personale che ha avuto contatti con il paziente resta per fornirgli ulteriore assistenza. Un'apposita postazione medica isola il compartimento in cui si trova il paziente e il personale che lo cura dal contatto con altre persone. Il compartimento isolato dovrebbe includere un bagno e una sala per i trattamenti. Tutto il personale riceve immediatamente un trattamento antibiotico profilattico, che proseguirà durante i giorni trascorsi in isolamento.
Il trattamento della peste dovrebbe essere completo e includere l'uso di agenti etiotropici, patogenetici e sintomatici. Gli antibiotici della serie streptomicina sono più efficaci nel trattamento della peste: streptomicina, diidrostreptomicina, pasomicina. In questo caso, la streptomicina è quella più utilizzata. Nella forma bubbonica della peste, al paziente viene somministrata streptomicina per via intramuscolare 3-4 volte al giorno (dose giornaliera di 3 g), antibiotici tetraciclinici (vibromicina, morfociclina) per via endovenosa a 4 g/die. In caso di intossicazione, le soluzioni saline e l'hemodez vengono somministrati per via endovenosa. Un calo della pressione sanguigna nella forma bubbonica dovrebbe essere considerato di per sé come un segno di generalizzazione del processo, un segno di sepsi; in questo caso sono necessarie misure di rianimazione, somministrazione di dopamina e installazione di un catetere permanente. Per le forme di peste polmonare e settica, la dose di streptomicina viene aumentata a 4-5 g/giorno e di tetraciclina a 6 g. Per le forme resistenti alla streptomicina, il cloramfenicolo succinato può essere somministrato fino a 6-8 g per via endovenosa. Quando la condizione migliora, la dose di antibiotici viene ridotta: streptomicina - fino a 2 g/giorno fino alla normalizzazione della temperatura, ma per almeno 3 giorni, tetracicline - fino a 2 g/giorno al giorno per via orale, cloramfenicolo - fino a 3 g/giorno al giorno, per un totale di 20-25 g.Il biseptolo viene utilizzato con grande successo anche nella cura della peste.
In caso di forma polmonare, settica, sviluppo di emorragia, iniziano immediatamente ad alleviare la sindrome della coagulazione intravascolare disseminata: viene eseguita la plasmaferesi (la plasmaferesi intermittente in sacchetti di plastica può essere eseguita su qualsiasi centrifuga con raffreddamento speciale o ad aria con una capacità dei suoi bicchieri di 0,5 litri o più) nel volume di plasma rimosso 1-1,5 litri quando sostituito con la stessa quantità di plasma fresco congelato. In presenza di sindrome emorragica la somministrazione giornaliera di plasma fresco congelato non deve essere inferiore a 2 litri. Fino a quando le manifestazioni acute della sepsi non vengono interrotte, la plasmaferesi viene eseguita quotidianamente. La scomparsa dei segni della sindrome emorragica e la stabilizzazione della pressione sanguigna, solitamente nella sepsi, sono motivo per interrompere le sessioni di plasmaferesi. Allo stesso tempo, l'effetto della plasmaferesi nel periodo acuto della malattia si osserva quasi immediatamente, i segni di intossicazione diminuiscono, la necessità di dopamina per stabilizzare la pressione sanguigna diminuisce, il dolore muscolare diminuisce e la mancanza di respiro diminuisce.
L'équipe di personale medico che fornisce cure a un paziente affetto da forma di peste polmonare o settica deve includere uno specialista di terapia intensiva.
Stato attuale
Ogni anno il numero dei malati di peste è di circa 2,5mila persone, senza alcuna tendenza al ribasso. Per la Russia, la situazione è complicata dall’identificazione annuale di nuovi casi negli stati confinanti con la Russia (Kazakistan, Mongolia, Cina) e dall’importazione di uno specifico portatore della peste, la pulce Xenopsylla cheopis, attraverso i trasporti e i flussi commerciali dai paesi del sud-est asiatico.
Secondo i dati disponibili, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 15 anni sono stati registrati circa quarantamila casi in 24 paesi, con un tasso di mortalità pari a circa il 7% del numero dei casi. In diversi paesi dell’Asia (Kazakistan, Cina, Mongolia e Vietnam), dell’Africa (Tanzania e Madagascar) e dell’emisfero occidentale (Stati Uniti, Perù), quasi ogni anno si registrano casi di infezione umana.
Negli ultimi 5 anni in Russia sono stati registrati 752 ceppi dell'agente patogeno della peste. Al momento, i focolai naturali più attivi si trovano nei territori della regione di Astrakhan, delle repubbliche Cabardino-Balcanica e Karachay-Cherkess, nelle repubbliche di Altai, Daghestan, Kalmykia e Tyva. Particolarmente preoccupante è la mancanza di un monitoraggio sistematico dell’attività dei focolai localizzati nelle Repubbliche Inguscesca e Cecena.
Allo stesso tempo, sul territorio della Russia non sono stati registrati casi di peste dal 1979, anche se ogni anno nel territorio dei focolai naturali (con una superficie totale di oltre 253mila kmq) vengono uccise oltre 20mila persone. a rischio di infezione.
Allo stesso tempo, nel 2001-2003, nella Repubblica del Kazakistan sono stati registrati 7 casi di peste (con un decesso), in Mongolia - 23 (3 decessi), in Cina nel 2001-2002 si sono ammalate 109 persone (9 decessi ). Le previsioni per la situazione epizootica ed epidemica nei focolai naturali della Repubblica del Kazakistan, della Cina e della Mongolia adiacenti alla Federazione Russa rimangono sfavorevoli.
Previsione
Con la terapia moderna, la mortalità nella forma bubbonica non supera il 5-10%, ma in altre forme il tasso di recupero è piuttosto elevato se il trattamento viene iniziato precocemente. In alcuni casi è possibile una forma settica transitoria della malattia, difficile da diagnosticare e trattare.
(“forma fulminante di peste”).
Personaggi famosi morti di peste Simeone il Superbo Tra i personaggi famosi che morirono di peste c'è il principe russo Simeone il Fiero, figlio di Ivan I Kalita.
La peste bubbonica è una forma di malattia peste. La peste è una malattia infettiva causata dal batterio Yersinia Pestis. Questo batterio vive su piccoli animali e sulle pulci che vivono su di essi. L’infezione avviene attraverso una via trasmissibile, cioè. attraverso un morso di pulce, nonché attraverso il contatto diretto e goccioline trasportate dall'aria. Capiremo come avviene l'infezione da peste bubbonica, come procedono il periodo di incubazione e i sintomi dell'infezione da peste, il trattamento con antibiotici e la prevenzione di questa malattia oggi più pericolosa. Vediamo come appare al microscopio e con la microscopia a fluorescenza l'agente causale della peste, il batterio Yersinia Pestis. Cominciamo con il contesto degli ultimi casi di infezione da peste e le loro conseguenze per molte migliaia di persone.
Importante! La peste bubbonica è caratterizzata da linfonodi dolorosi e infiammati ed è la forma più comune della malattia.
Storia delle recenti infezioni da peste bubbonica
Nel XVI secolo la peste bubbonica si diffuse in tutta Europa e uccise un terzo della popolazione. I ratti divennero i suoi portatori. Fino al 19 ° secolo, non sapevano come curare la malattia, quindi il tasso di mortalità era quasi del 100% e alcuni guarivano miracolosamente da soli.

E ad oggi sono stati registrati casi di infezione da peste bubbonica, la maggior parte dei casi di infezione si osserva in Asia centrale e nella Cina settentrionale.
L'agente eziologico, il batterio Yersinia Pestis, fu scoperto solo nel 1894, quindi, allo stesso tempo, gli scienziati furono in grado di studiare il decorso della malattia e sviluppare un vaccino. Ma prima di allora morirono milioni di persone. La più famosa epidemia di peste bubbonica colpì l'Europa nel 1346-1353. Presumibilmente ha avuto origine da un centro naturale nel Gobi, per poi diffondersi nel territorio dell'India, della Cina e dell'Europa insieme alle carovane.
In video il film Dark Ages of the Middle Ages: Black Death
Nel corso di 20 anni, la peste bubbonica uccise almeno 60 milioni di persone. Nel Medioevo non c'era salvezza da una simile malattia: cercavano di curarla con salassi, il che complicò ulteriormente le condizioni dei pazienti, poiché perdevano le ultime forze.
Nel 1361 e nel 1369 si verificarono ripetute epidemie di peste bubbonica. La malattia ha colpito tutti gli ambiti della vita delle persone. La storia indica che dopo la peste bubbonica la situazione demografica raggiunse la stabilità solo 400 anni dopo la fine della malattia.
Esistono diverse forme della malattia, a seconda della quale acquisisce un corso specifico.
Importante! Le forme in cui sono colpiti i polmoni sono altamente contagiose, poiché portano alla rapida diffusione dell'infezione attraverso le goccioline trasportate dall'aria. Con la peste bubbonica, i pazienti non sono praticamente contagiosi.
L'agente eziologico della peste bubbonica è il batterio Yersinia Pestis
Spoiler con esempio di foto lieve shock, manifestazioni di peste bubbonica sulla gamba destra.
 Manifestazione di peste bubbonica sulla gamba destra.
Manifestazione di peste bubbonica sulla gamba destra.
[crollo]
Una volta nel corpo, l'infezione inizia a svilupparsi rapidamente e si può osservare la resistenza ai farmaci usati per trattare la peste bubbonica, il batterio Yersinia Pestis.
La durata della vita del batterio nell'espettorato è di circa 10 giorni. Può persistere anche più a lungo (diverse settimane) sui vestiti, nelle secrezioni della peste e nei cadaveri di persone morte a causa della malattia, fino a diversi mesi. I processi di congelamento e le basse temperature non distruggono l'agente patogeno della peste.
Importante! Pericolosi per il batterio della peste bubbonica sono la luce solare e le alte temperature. Nel giro di un’ora muore il batterio della peste Yersinia Pestis; ad una temperatura di 60 gradi, quando sale a 100, sopravvive solo pochi minuti.
Il periodo di incubazione dopo l'infezione da peste bubbonica è piuttosto breve: 1-3 giorni, mentre in alcune persone può durare solo poche ore a causa dell'immunità indebolita. L'obiettivo dell'agente patogeno è il sistema linfatico umano. Penetrando nel flusso linfatico, l'infezione si diffonde istantaneamente in tutto il corpo. Allo stesso tempo, i linfonodi smettono di funzionare e i batteri patogeni iniziano ad accumularsi in essi.
Esistono forme di peste cutanea e bubbonica. Nella forma cutanea, nella sede del morso appare una papula che si ulcera rapidamente. Successivamente compaiono una crosta e una cicatrice. Quindi, di solito iniziano a comparire segni più gravi della malattia.
La forma bubbonica inizia con un aumento dei linfonodi più vicini al sito del morso.
Wikipedia afferma che i linfonodi in qualsiasi area possono essere colpiti. In questo caso, i linfonodi della zona inguinale sono più spesso colpiti, meno spesso quelli ascellari.


Sintomi dell'infezione da peste bubbonica
I sintomi nella fase iniziale dell'infezione con il batterio della peste Yersinia Pestis non sono specifici e nelle loro manifestazioni ricordano un raffreddore. Il paziente sperimenta i seguenti cambiamenti:
- Nel sito del morso appare un grande gonfiore rosso, che in apparenza ricorda una reazione allergica;
- la macchia risultante si trasforma gradualmente in una papula piena di sangue e contenuto purulento;
- l'apertura della papula porta alla comparsa di un'ulcera in questo sito, che non guarisce per molto tempo.
Allo stesso tempo, la peste bubbonica presenta anche altri sintomi, come:
- aumento della temperatura;
- segni caratteristici di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, ecc.;
- aumento delle dimensioni dei linfonodi (prima alcuni, poi la malattia colpisce il resto);
- mal di testa simili alla meningite.
Dopo un paio di giorni, i linfonodi aumentano notevolmente di dimensioni, smettono di funzionare, perdono mobilità e si verifica dolore quando li tocchi.
Spoiler con una foto shock della peste bubbonica, 10 giorni dopo il contagio.

[crollo]
Dopo altri 4-5 giorni, i linfonodi diventano morbidi e pieni di liquido. Quando viene toccato, puoi sentire le sue vibrazioni. Il 10° giorno i nodi vengono aperti e si formano fistole non cicatrizzate.
Nella foto a destra sono visibili tutte queste manifestazioni, clicca sulla foto per ingrandirla.
La peste bubbonica si verifica spesso in combinazione con la meningite. Il paziente avverte forti mal di testa e crampi in tutto il corpo.
La forma bubbonica non è accompagnata dallo sviluppo di una reazione locale al morso, a differenza della peste bubbonica cutanea. Nel secondo caso, il microbo penetra nella pelle e poi entra nei linfonodi attraverso il flusso linfatico.
Forma settica primaria e forma settica secondaria
La penetrazione dell'agente patogeno nel sangue è accompagnata dalla comparsa di forme generalizzate della malattia. Esistono forme settiche primarie e forme settiche secondarie.
Forma settica primaria di peste bubbonica si sviluppa nei casi in cui l'infezione entra nel sangue senza colpire i linfonodi. I segni di intossicazione si osservano quasi immediatamente. Poiché l'infezione si diffonde istantaneamente in tutto il corpo, si verificano molti focolai di infiammazione in tutto il corpo. Si sviluppa la sindrome della coagulazione intravascolare disseminata, accompagnata da danni a tutti gli organi. Un paziente affetto da peste bubbonica muore a causa di shock tossico-infettivo.

Forma settica secondaria di peste accompagnato dallo sviluppo di sepsi infettiva.
Complicazioni. La peste bubbonica può essere complicata dalla polmonite. In questi casi, diventa una forma polmonare.
Forma polmonare di peste bubbonica si manifesta con febbre, forti mal di testa, polmonite, dolore toracico, tosse ed espettorazione di sangue. L'infezione avviene tramite goccioline trasportate dall'aria, ma può svilupparsi come forma secondaria da bubbonica o settica. La malattia si diffonde rapidamente in tutto il corpo, ma i moderni farmaci antibatterici possono affrontarla con successo. Sfortunatamente, anche il trattamento intensivo non può garantire l’eliminazione della morte.
Con forma settica di peste i segni della malattia comprendono febbre, brividi, dolore addominale ed emorragie interne. Si osserva una massiccia necrosi dei tessuti, molto spesso muoiono i tessuti sulle dita delle estremità. I bubboni non si formano in questa forma, ma i disturbi del sistema nervoso si verificano quasi immediatamente. Se non trattata, la morte è quasi garantita, ma con una terapia adeguata anche la probabilità di guarigione è alta.
Trattamento della peste bubbonica
Spoiler con foto shock del processo di necrotizzazione della mano durante la peste bubbonica.

[crollo]
Nel Medioevo, i medici non potevano offrire metodi di trattamento efficaci contro la peste bubbonica. In primo luogo, ciò era dovuto alla medicina praticamente non in via di sviluppo, poiché la religione occupava il posto principale e la scienza non era supportata. In secondo luogo, la maggior parte dei medici aveva semplicemente paura di contattare gli infetti, per non morire loro stessi.
Tuttavia furono fatti tentativi per curare la peste, anche se non produssero alcun risultato. Ad esempio, i bubboni venivano aperti e cauterizzati. Poiché la peste era considerata un avvelenamento dell'intero corpo, si tentò di utilizzare antidoti. Rane e lucertole sono state applicate sulle aree colpite. Naturalmente, tali metodi non potrebbero aiutare.
Le città erano schiavizzate dal panico. Un esempio interessante di come la malattia sia stata in qualche modo contenuta sono le misure amministrative adottate a Venezia. Lì è stata organizzata una speciale commissione sanitaria. Tutte le navi che arrivavano venivano sottoposte a un'ispezione speciale e, se venivano trovati cadaveri o persone infette, venivano bruciate. Merci e viaggiatori sono stati messi in quarantena per 40 giorni. I cadaveri dei morti furono immediatamente raccolti e sepolti in una laguna separata ad una profondità di almeno 1,5 metri.
La peste esiste ancora oggi
Non pensate che questa malattia sia rimasta solo nei libri di storia. La peste bubbonica in Altai è stata registrata lo scorso anno (2016) e in generale si registrano circa 3.000 casi di infezione all'anno. Non si è verificata alcuna epidemia nel territorio dell'Altai, ma sono state adottate tutte le misure per prevenire la diffusione dell'infezione e le persone che hanno avuto contatti con la persona infetta sono state messe in quarantena.
Il metodo principale e moderno per trattare la peste bubbonica nel nostro tempo è l'uso di antibiotici. I farmaci vengono somministrati per via intramuscolare e nei bubboni stessi. Di norma, per il trattamento vengono utilizzate tetraciclina e streptomicina.
Importante! I pazienti affetti da peste bubbonica infettati dal batterio Yersinia Pestis sono soggetti a ricovero obbligatorio e vengono collocati in reparti speciali. Tutti gli oggetti personali e gli indumenti sono soggetti a disinfezione. Il contatto con un paziente infetto da peste richiede il rispetto delle misure di sicurezza da parte del personale medico: l'uso di tute protettive è obbligatorio.
È obbligatorio il trattamento sintomatico delle manifestazioni di peste e delle manifestazioni di bubboni sul corpo umano, il cui scopo è alleviare le condizioni del paziente ed eliminare le complicazioni.
Per confermare il recupero, viene effettuata una coltura batterica per il batterio Yersinia Pestis e l'analisi viene ripetuta 3 volte. E anche dopo, il paziente rimane in ospedale per un altro mese. Dopo la dimissione dovrà essere monitorato da uno specialista in malattie infettive per 3 mesi.
In video: 10 fatti interessanti sulla peste, da Dameoz
Nel video del programma Live Healthy si parlerà della peste bubbonica, dell'infezione da parte del batterio della peste Yersinia Pestis e del trattamento:
Appestare- un'infezione zoonotica trasmissibile acuta, particolarmente pericolosa con grave intossicazione e infiammazione sierosa-emorragica nei linfonodi, nei polmoni e in altri organi, nonché il possibile sviluppo di sepsi.
Brevi notizie storiche
Non esiste nessun'altra malattia infettiva nella storia dell'umanità che porterebbe a una devastazione e a una mortalità così colossali tra la popolazione come la peste. Sin dai tempi antichi, sono state conservate informazioni sulla peste, che si è verificata nelle persone sotto forma di epidemie con un gran numero di morti. È stato notato che le epidemie di peste si sviluppavano a seguito del contatto con animali malati. A volte, la diffusione della malattia era simile a quella di una pandemia. Sono tre le pandemie di peste conosciute. La prima, conosciuta come Peste di Giustiniano, imperversò in Egitto e nell'Impero Romano d'Oriente dal 527 al 565. La seconda, detta la “grande” o “nera”, nel 1345-1350. copriva la Crimea, il Mediterraneo e l'Europa occidentale; questa pandemia devastante ha causato circa 60 milioni di vittime. La terza pandemia iniziò nel 1895 a Hong Kong per poi diffondersi in India, dove morirono oltre 12 milioni di persone. All'inizio furono fatte importanti scoperte (l'agente patogeno fu isolato, fu dimostrato il ruolo dei ratti nell'epidemiologia della peste), che permisero di organizzare la prevenzione su base scientifica. L'agente eziologico della peste fu scoperto da G.N. Minkh (1878) e indipendentemente da lui A. Yersin e S. Kitazato (1894). Dal XIV secolo, la peste ha ripetutamente visitato la Russia sotto forma di epidemie. Lavorando sulle epidemie per prevenire la diffusione della malattia e curare i pazienti, gli scienziati russi D.K. hanno dato un grande contributo allo studio della peste. Zabolotny, N.N. Klodnitsky, I.I. Mechnikov, N.F. Gamaleya e altri Nel XX secolo N.N. Zhukov-Verezhnikov, E.I. Korobkova e G.P. Rudnev ha sviluppato i principi della patogenesi, della diagnosi e del trattamento dei pazienti affetti da peste e ha anche creato un vaccino contro la peste.
L'emergere della malattia della peste
L'agente eziologico è un batterio gram-negativo, non mobile, anaerobico facoltativo Y. pestis del genere Yersinia della famiglia delle Enterobacteriaceae. In molte caratteristiche morfologiche e biochimiche, il bacillo della peste è simile ai patogeni della pseudotubercolosi, della yersiniosi, della tularemia e della pasteurellosi, che causano gravi malattie sia nei roditori che nell'uomo. Si distingue per un polimorfismo pronunciato, i più tipici sono i bastoncini ovoidali che si colorano bipolarmente, esistono diverse sottospecie dell'agente patogeno, che differiscono per virulenza. Cresce su terreni nutritivi regolari con l'aggiunta di sangue emolizzato o solfito di sodio per stimolare la crescita. Contiene più di 30 antigeni, eso- ed endotossine. Le capsule proteggono i batteri dall'assorbimento da parte dei leucociti polimorfonucleati e gli antigeni V e W li proteggono dalla lisi nel citoplasma dei fagociti, che ne garantisce la riproduzione intracellulare. L'agente eziologico della peste è ben conservato negli escrementi dei pazienti e degli oggetti dell'ambiente esterno (nel pus del bubbone persiste per 20-30 giorni, nei cadaveri di persone, cammelli, roditori - fino a 60 giorni), ma è altamente sensibile alla luce solare, all'ossigeno atmosferico, alla temperatura elevata, alle reazioni ambientali (soprattutto acide), alle sostanze chimiche (compresi i disinfettanti). Sotto l'influenza del cloruro di mercurio ad una diluizione di 1:1000 muore in 1-2 minuti. Tollera bene le basse temperature e il gelo.
Epidemiologia
Una persona malata può, in determinate condizioni, diventare una fonte di infezione: con lo sviluppo della peste polmonare, il contatto diretto con il contenuto purulento di un bubbone della peste, nonché come conseguenza dell'infezione da pulci su un paziente con setticemia da peste. I cadaveri delle persone morte a causa della peste sono spesso la causa diretta dell'infezione di altri. I pazienti affetti da peste polmonare sono particolarmente pericolosi.
Meccanismo di trasmissione diverse, molto spesso trasmissibili, ma sono possibili anche goccioline trasportate dall'aria (con forme polmonari di peste, infezione in condizioni di laboratorio). I portatori dell'agente patogeno sono le pulci (circa 100 specie) e alcuni tipi di zecche, che in natura supportano il processo epizootico e trasmettono l'agente patogeno a roditori sinantropici, cammelli, gatti e cani, che possono trasportare le pulci infette nelle abitazioni umane. Una persona viene infettata non tanto attraverso un morso di pulce quanto dopo aver strofinato sulla pelle le sue feci o le masse rigurgitate durante l'alimentazione. I batteri che si moltiplicano nell'intestino delle pulci secernono la coagulasi, che forma un “tappo” (blocco della peste) che impedisce il flusso di sangue nel suo corpo. I tentativi di un insetto affamato di succhiare il sangue sono accompagnati dal rigurgito di masse infette sulla superficie della pelle nel punto del morso. Queste pulci sono affamate e spesso cercano di succhiare il sangue dell'animale. La contagiosità delle pulci dura in media circa 7 settimane e, secondo alcuni dati, fino a 1 anno.
Sono possibili il contatto (attraverso la pelle danneggiata e le mucose) durante il taglio delle carcasse e la lavorazione delle pelli di animali infetti uccisi (lepri, volpi, saiga, cammelli, ecc.) e le vie nutrizionali (mangiando la loro carne) di infezione da peste.
La predisposizione naturale delle persone è molto elevata, assoluta in tutte le fasce di età e attraverso qualsiasi via di infezione. Dopo una malattia si sviluppa un'immunità relativa, che non protegge dalla reinfezione. I casi ripetuti della malattia non sono rari e non sono meno gravi di quelli primari.
Principali caratteristiche epidemiologiche. I focolai naturali di peste occupano il 6-7% della superficie terrestre del globo e sono registrati in tutti i continenti, escluse l'Australia e l'Antartide. Ogni anno in tutto il mondo si registrano diverse centinaia di casi di peste tra gli esseri umani. Nei paesi della CSI sono stati identificati 43 focolai naturali di peste con una superficie totale di oltre 216 milioni di ettari, situati nelle regioni di pianura (steppa, semideserto, deserto) e di alta montagna. Esistono due tipi di focolai naturali: focolai di “selvaggio” e focolai di peste dei ratti. Nei focolai naturali, la peste si manifesta come epizoozia tra roditori e lagomorfi. L'infezione da roditori che non dormono d'inverno (marmotte, roditori, ecc.) avviene nella stagione calda, mentre da roditori e lagomorfi che non dormono d'inverno (gerbilli, arvicole, pikas, ecc.), l'infezione ha due picchi stagionali , che è associato ai periodi di riproduzione degli animali. Gli uomini si ammalano più spesso delle donne a causa delle attività professionali e rimangono in un focolaio naturale di peste (transumanza, caccia). Nei focolai antroporgici il ruolo di serbatoio dell’infezione è svolto dai ratti neri e grigi. L’epidemiologia della peste bubbonica e polmonare presenta differenze significative nelle sue caratteristiche più importanti. La peste bubbonica è caratterizzata da un aumento relativamente lento della malattia, mentre la peste polmonare, a causa della facile trasmissione dei batteri, può diffondersi in breve tempo. I pazienti affetti dalla forma bubbonica della peste sono poco contagiosi e praticamente non infettivi, poiché le loro secrezioni non contengono agenti patogeni e ce ne sono pochi o nessun agente patogeno nel materiale dei bubboni aperti. Quando la malattia passa alla forma settica, così come quando la forma bubbonica è complicata dalla polmonite secondaria, quando l'agente patogeno può essere trasmesso da goccioline trasportate dall'aria, si sviluppano gravi epidemie di peste polmonare primaria con una contagiosità molto elevata. Tipicamente, la peste polmonare segue la peste bubbonica, si diffonde insieme ad essa e diventa rapidamente la principale forma epidemiologica e clinica. Recentemente è stata sviluppata intensamente l'idea che l'agente causale della peste possa rimanere a lungo nel terreno in uno stato incolto. L'infezione primaria dei roditori può verificarsi quando si scavano buche in aree infette del terreno. Questa ipotesi si basa sia su studi sperimentali che su osservazioni sull'inutilità della ricerca dell'agente patogeno tra i roditori e le loro pulci durante i periodi interepizootici.
Decorso della malattia Peste
I meccanismi di adattamento umano non sono praticamente adatti a resistere all'introduzione e allo sviluppo del bacillo della peste nel corpo. Ciò si spiega con il fatto che il bacillo della peste si moltiplica molto rapidamente; i batteri producono grandi quantità di fattori di permeabilità (neuraminidasi, fibrinolisina, pesticina), antifagini che sopprimono la fagocitosi (F1, HMWPs, V/W-Ar, PH6-Ag), che contribuiscono alla rapida e massiccia diffusione linfogena ed ematogena principalmente negli organi mononucleari fagocitici sistema con la sua successiva attivazione. L'antigenemia massiccia, il rilascio di mediatori infiammatori, comprese le citochine shockogene, porta allo sviluppo di disturbi microcircolatori, sindrome DIC, seguita da shock tossico-infettivo.
Il quadro clinico della malattia è in gran parte determinato dal sito di introduzione dell'agente patogeno, che penetra attraverso la pelle, i polmoni o il tratto gastrointestinale.
La patogenesi della peste comprende tre fasi. Innanzitutto, l'agente patogeno si diffonde per via linfogena dal sito di introduzione ai linfonodi, dove indugia per un breve periodo. In questo caso si forma un bubbone della peste con lo sviluppo di alterazioni infiammatorie, emorragiche e necrotiche nei linfonodi. I batteri entrano quindi rapidamente nel flusso sanguigno. Nella fase di batteriemia si sviluppa una grave tossicosi con cambiamenti nelle proprietà reologiche del sangue, disturbi della microcircolazione e manifestazioni emorragiche in vari organi. E infine, dopo che l'agente patogeno supera la barriera reticoloistiocitica, si diffonde in vari organi e sistemi con lo sviluppo della sepsi.
I disturbi microcircolatori causano cambiamenti nel muscolo cardiaco e nei vasi sanguigni, nonché nelle ghiandole surrenali, che causano insufficienza cardiovascolare acuta.
Con la via aerogena dell'infezione, gli alveoli vengono colpiti e in essi si sviluppa un processo infiammatorio con elementi di necrosi. La successiva batteriemia è accompagnata da intensa tossicosi e dallo sviluppo di manifestazioni settico-emorragiche in vari organi e tessuti.
La risposta anticorpale alla peste è debole e si forma nelle fasi avanzate della malattia.
Sintomi della malattia della peste
Il periodo di incubazione è di 3-6 giorni (nelle epidemie o nelle forme settiche si riduce a 1-2 giorni); Il periodo massimo di incubazione è di 9 giorni.
Caratterizzato da un'esordio acuto della malattia, espresso da un rapido aumento della temperatura corporea a numeri elevati con brividi sbalorditivi e dallo sviluppo di grave intossicazione. I pazienti tipicamente lamentano dolore all'osso sacro, ai muscoli e alle articolazioni e mal di testa. Si verificano vomito (spesso sanguinante) e sete atroce. Già dalle prime ore della malattia si sviluppa l'agitazione psicomotoria. I pazienti sono irrequieti, eccessivamente attivi, cercano di correre (“corre come un matto”), sperimentano allucinazioni e deliri. Il linguaggio diventa confuso e l’andatura è instabile. In casi più rari, sono possibili letargia, apatia e la debolezza raggiunge un livello tale che il paziente non riesce ad alzarsi dal letto. Esternamente si notano iperemia e gonfiore del viso e iniezione sclerale. Sul viso c'è un'espressione di sofferenza o orrore (“maschera della peste”). Nei casi più gravi può comparire un'eruzione emorragica sulla pelle. Segni molto caratteristici della malattia sono l'ispessimento e il rivestimento della lingua con uno spesso strato bianco ("lingua gessosa"). Dal sistema cardiovascolare si notano tachicardia pronunciata (fino all'embriocardia), aritmia e un progressivo calo della pressione sanguigna. Anche nelle forme locali della malattia si sviluppano tachipnea, oliguria o anuria.
Questa sintomatologia si manifesta, soprattutto nel periodo iniziale, in tutte le forme di peste.
Secondo la classificazione clinica della peste proposta da G.P. Rudnev (1970), distinguono forme locali della malattia (cutanea, bubbonica, cutaneo-bubbonica), forme generalizzate (settica primaria e settica secondaria), forme disseminate esternamente (polmonare primaria, polmonare secondaria e intestinale).
Forma cutanea. Caratteristica è la formazione di un carbonchio nel sito di introduzione dell'agente patogeno. Inizialmente, sulla pelle appare una pustola molto dolorosa con contenuto rosso scuro; è localizzato sul tessuto sottocutaneo edematoso ed è circondato da una zona di infiltrazione e iperemia. Dopo l'apertura della pustola si forma un'ulcera dal fondo giallastro, che tende ad aumentare di dimensioni. Successivamente, il fondo dell'ulcera viene coperto da una crosta nera, dopo la quale si formano cicatrici.
Forma bubbonica. La forma più comune di peste. Caratterizzato da danno ai linfonodi regionali al sito di introduzione dell'agente patogeno: inguinale, meno spesso ascellare e molto raramente cervicale. Di solito i bubboni sono singoli, meno spesso multipli. Sullo sfondo di una grave intossicazione, il dolore si verifica nell'area della futura localizzazione del bubbone. Dopo 1-2 giorni si possono palpare linfonodi fortemente dolorosi, dapprima di consistenza dura, per poi ammorbidirsi e diventare pastosi. I nodi si fondono in un unico conglomerato, inattivo per la presenza di periadenite, fluttuante alla palpazione. La durata del culmine della malattia è di circa una settimana, dopodiché inizia un periodo di convalescenza. I linfonodi possono risolversi da soli o diventare ulcerati e sclerotici a causa dell'infiammazione sieroso-emorragica e della necrosi.
Forma bubbonica cutanea. È una combinazione di lesioni cutanee e cambiamenti nei linfonodi.
Queste forme locali della malattia possono svilupparsi in sepsi da peste secondaria e polmonite secondaria. Le loro caratteristiche cliniche non differiscono rispettivamente dalle forme settiche primarie e dalle forme polmonari primarie.
Forma settica primaria. Si manifesta dopo un breve periodo di incubazione di 1-2 giorni ed è caratterizzata da uno sviluppo fulmineo di intossicazione, manifestazioni emorragiche (emorragie cutanee e mucose, sanguinamento gastrointestinale e renale) e dalla rapida formazione di un quadro clinico di infezioni infettive. -shock tossico. Senza trattamento, è fatale nel 100% dei casi.
Forma polmonare primaria. Si sviluppa durante l'infezione aerogena. Il periodo di incubazione è breve, da alcune ore a 2 giorni. La malattia inizia in modo acuto con manifestazioni della sindrome da intossicazione caratteristica della peste. Nel 2-3o giorno di malattia compaiono una forte tosse, un forte dolore al petto e mancanza di respiro. La tosse è accompagnata dal rilascio di espettorato prima vitreo e poi liquido, schiumoso e sanguigno. I dati fisici provenienti dai polmoni sono scarsi; le radiografie mostrano segni di polmonite focale o lobare. Aumenta l'insufficienza cardiovascolare, espressa in tachicardia e un progressivo calo della pressione sanguigna, e lo sviluppo di cianosi. Nella fase terminale, i pazienti sviluppano prima uno stato stuporoso, accompagnato da una maggiore mancanza di respiro e manifestazioni emorragiche sotto forma di petecchie o emorragie estese, e poi coma.
Forma intestinale. Sullo sfondo della sindrome da intossicazione, i pazienti avvertono forti dolori addominali, vomito ripetuto e diarrea con tenesmo e abbondanti feci mucose e sanguinanti. Poiché manifestazioni intestinali possono essere osservate in altre forme della malattia, fino a tempi recenti la questione dell'esistenza della peste intestinale come forma indipendente, apparentemente associata all'infezione enterale, rimane controversa.
Diagnosi differenziale
Le forme cutanee, bubboniche e cutanee di peste bubbonica dovrebbero essere distinte dalla tularemia, dai carbonchi, da varie linfoadenopatie, dalle forme polmonari e settiche - dalle malattie infiammatorie polmonari e dalla sepsi, inclusa l'eziologia meningococcica.
In tutte le forme di peste già nel periodo iniziale sono allarmanti segni in rapido aumento di grave intossicazione: temperatura corporea elevata, brividi tremendi, vomito, sete lancinante, agitazione psicomotoria, irrequietezza, delirio e allucinazioni. Quando si esaminano i pazienti, si attira l'attenzione su un linguaggio confuso, un'andatura instabile, un viso gonfio e iperemico con iniezione sclerale, un'espressione di sofferenza o orrore ("maschera della peste") e una "lingua gessosa". I segni di insufficienza cardiovascolare, la tachipnea aumentano rapidamente e l'oliguria progredisce.
Le forme di peste cutanea, bubbonica e bubbonica cutanea sono caratterizzate da forte dolore nel sito della lesione, fasi di sviluppo del carbonchio (pustola - ulcera - crosta nera - cicatrice), fenomeni pronunciati di periadenite durante la formazione del bubbone della peste .
Le forme polmonari e settiche si distinguono per lo sviluppo fulmineo di grave intossicazione, manifestazioni pronunciate di sindrome emorragica e shock tossico-infettivo. Se i polmoni sono colpiti, si notano dolore acuto al petto e tosse grave, separazione dell'espettorato sanguigno vitreo e poi liquido e schiumoso. Gli scarsi dati fisici non corrispondono alla condizione generale estremamente grave.
Diagnosi della malattia della peste
Diagnostica di laboratorio
Basato sull'uso di metodi microbiologici, immunosierologici, biologici e genetici. L'emogramma mostra leucocitosi, neutrofilia con spostamento a sinistra e aumento della VES. L'isolamento dell'agente patogeno viene effettuato in laboratori specializzati di alta sicurezza per lavorare con agenti patogeni di infezioni particolarmente pericolose. Vengono condotti studi per confermare casi clinicamente significativi della malattia, nonché per esaminare persone con temperatura corporea elevata che sono alla fonte dell'infezione. Il materiale dei malati e dei morti viene sottoposto ad esame batteriologico: punti di bubboni e carbonchi, secrezione di ulcere, espettorato e muco dell'orofaringe, sangue. Il passaggio viene effettuato su animali da laboratorio (cavie, topi bianchi), che muoiono il 5-7° giorno dopo l'infezione.
Tra i metodi sierologici utilizzati ci sono RNGA, RNAT, RNAG e RTPGA, ELISA.
I risultati positivi della PCR 5-6 ore dopo la sua somministrazione indicano la presenza di DNA specifico del microbo della peste e confermano la diagnosi preliminare. La conferma finale dell'eziologia della peste della malattia è l'isolamento di una coltura pura dell'agente patogeno e la sua identificazione.
Trattamento della malattia della peste
I malati di peste vengono curati solo in ambito ospedaliero. La scelta dei farmaci per la terapia etiotropica, le loro dosi e i regimi di utilizzo sono determinati dalla forma della malattia. Il corso della terapia etiotropica per tutte le forme della malattia è di 7-10 giorni. In questo caso viene utilizzato quanto segue:
Per la forma cutanea - cotrimossazolo 4 compresse al giorno;
Per la forma bubbonica: cloramfenicolo alla dose di 80 mg/kg/die e contemporaneamente streptomicina alla dose di 50 mg/kg/die; i farmaci vengono somministrati per via endovenosa; Anche la tetraciclina è efficace;
Nelle forme polmonari e settiche della malattia, l'associazione di cloramfenicolo con streptomicina viene integrata con la somministrazione di doxiciclina alla dose di 0,3 g/die o di tetraciclina alla dose di 4-6 g/die per via orale.
Allo stesso tempo, viene effettuata una terapia di disintossicazione massiccia (plasma fresco congelato, albumina, reopoliglucina, hemodez, soluzioni cristalloidi endovenose, metodi di disintossicazione extracorporea), vengono prescritti farmaci per migliorare la microcircolazione e la riparazione (trental in combinazione con solcoseryl, picamilon), forzando diuresi, nonché glicosidi cardiaci, analettici vascolari e respiratori, antipiretici e agenti sintomatici.
Il successo del trattamento dipende dalla tempestività della terapia. I farmaci etiotropi vengono prescritti al primo sospetto di peste, sulla base di dati clinici ed epidemiologici.
Prevenzione della malattia della peste
Sorveglianza epidemiologica
Il volume, la natura e la direzione delle misure preventive sono determinati dalla previsione della situazione epizootica ed epidemica relativa alla peste in specifici focolai naturali, tenendo conto dei dati sul monitoraggio del movimento della morbilità in tutti i paesi del mondo. Tutti i paesi sono tenuti a segnalare all’OMS l’insorgenza di malattie legate alla peste, lo spostamento di morbilità, le epizoozie tra i roditori e le misure per combattere le infezioni. Il Paese ha sviluppato e gestisce un sistema per la certificazione dei focolai naturali di peste, che ha permesso di effettuare la zonizzazione epidemiologica del territorio.
Azioni preventive
Le indicazioni per l'immunizzazione preventiva della popolazione sono l'epizoozia della peste tra i roditori, l'identificazione degli animali domestici affetti da peste e la possibilità che l'infezione venga introdotta da una persona malata. A seconda della situazione epidemica, la vaccinazione viene effettuata in un territorio rigorosamente delimitato a tutta la popolazione (universalmente) e selettivamente a contingenti particolarmente a rischio - persone che hanno legami permanenti o temporanei con i territori in cui si osserva l'epizoozia (allevatori di bestiame, agronomi, cacciatori, raccoglitori, geologi, archeologi, ecc.). d.). In caso di rilevamento di un malato di peste, tutte le istituzioni mediche e preventive devono disporre di una certa fornitura di medicinali e mezzi di protezione e prevenzione personale, nonché di uno schema per avvisare il personale e trasmettere informazioni verticalmente. Le misure per prevenire l'infezione da peste nelle aree enzootiche delle persone, le persone che lavorano con agenti patogeni di infezioni particolarmente pericolose, nonché per prevenire la diffusione dell'infezione oltre i focolai in altre aree del paese sono attuate da anti-peste e altri servizi sanitari istituzioni.
Attività durante l'epidemia
Quando compare una persona malata di peste o sospettata di questa infezione, vengono adottate misure urgenti per localizzare ed eliminare l'epidemia. I confini del territorio in cui vengono introdotte determinate misure restrittive (quarantena) sono determinati in base alla specifica situazione epidemiologica ed epizootologica, ai possibili fattori operativi della trasmissione dell'infezione, alle condizioni sanitarie e igieniche, all'intensità della migrazione della popolazione e ai collegamenti di trasporto con altri territori. La gestione generale di tutte le attività legate all'epidemia di peste è affidata alla Commissione antiepidemica di emergenza. Allo stesso tempo, il regime antiepidemico viene rigorosamente osservato utilizzando tute anti-peste. La quarantena è introdotta con decisione della Commissione antiepidemica di emergenza, che copre l'intero territorio dell'epidemia.
I pazienti affetti da peste e i pazienti sospettati di avere questa malattia sono ricoverati in ospedali appositamente organizzati. Il trasporto di un malato di peste deve essere effettuato in conformità con le norme sanitarie vigenti per la sicurezza biologica. I pazienti affetti da peste bubbonica vengono collocati in gruppi di più persone in una stanza, mentre i pazienti affetti da forma polmonare vengono collocati solo in stanze separate. I pazienti con peste bubbonica vengono dimessi non prima di 4 settimane, con peste polmonare - non prima di 6 settimane dalla data del recupero clinico e dei risultati negativi dell'esame batteriologico. Dopo la dimissione dall'ospedale il paziente viene posto sotto controllo medico per 3 mesi.
La disinfezione attuale e finale viene effettuata nel focolaio. Le persone che sono venute in contatto con malati di peste, cadaveri, cose contaminate, che hanno partecipato alla macellazione forzata di un animale malato, ecc., sono sottoposte a isolamento e osservazione medica (6 giorni). Per la peste polmonare si effettua l'isolamento individuale (per 6 giorni) e la profilassi con antibiotici (streptomicina, rifampicina, ecc.) per tutte le persone che potrebbero essersi infettate.