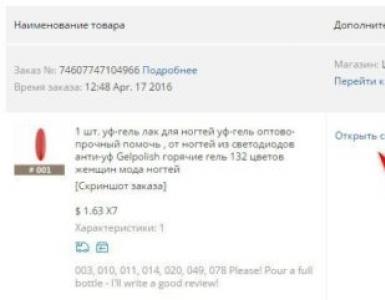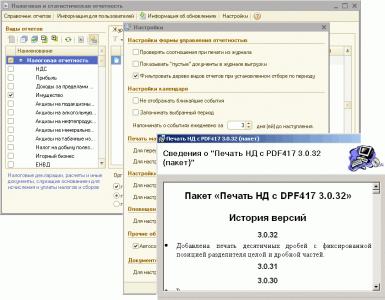I principali problemi della filosofia antica. I principali problemi della filosofia antica (caratteri generali). Filosofia antica del periodo presocratico
I problemi dell'antica filosofia orientale erano determinati dalla crudele divisione e disuguaglianza delle caste e dall'influenza della mitologia zoomorfa. A causa del totemismo e del culto degli antenati, questo tipo di filosofia non è sufficientemente razionalizzata. Nella filosofia dell'antica India, è consuetudine distinguere le seguenti scuole: ortodossa (yoga, Vedanta, Mimamsa, Samkhya) ed eterodossa (Charvaka Lokayata, Buddismo, Giainismo). La maggior parte di essi definisce chiaramente il concetto di karma, la legge da cui dipende interamente il destino di ogni persona. Un altro concetto fondamentale era il "samsara": la catena delle incarnazioni degli esseri viventi nel mondo. L'uscita da questa catena è moksha, ma i suoi diversi principi distinguevano le scuole filosofiche dell'antica India.
Nell'antica filosofia cinese, che si formò nella stessa epoca dell'antica filosofia indiana, spiccavano due tendenze: materialistica e mistica. La prima presupponeva la presenza di cinque elementi primari (metallo, acqua, legno), principi opposti (yang e yin). L'antica filosofia cinese di solito include il confucianesimo, il legalismo, lo yijinismo e il moismo.
Filosofia antica
La filosofia antica, formata nell'antica Grecia e nell'antica Roma, ha attraversato diverse fasi del suo sviluppo. La prima fase è l’emergere della filosofia. A lui è associato l'emergere della scuola milesia, alla quale appartenevano Anassimene, Talete, Anassimandro e i loro studenti. La seconda fase è associata alla ricerca di filosofi come Aristotele, Platone, Socrate. Durante il periodo di massimo splendore della filosofia antica, ebbe luogo la formazione della scuola di sofisti, atomisti e pitagorici. La terza fase non è più quella greca antica, ma quella romana antica. Comprende movimenti come lo scetticismo, lo stoicismo.
I filosofi antichi osservavano i fenomeni naturali, cercando di spiegarli. Il “cuore” degli insegnamenti della filosofia antica può essere chiamato cosmocentrismo. L'uomo è un microcosmo che esiste nel macrocosmo: la natura e gli elementi. La filosofia di questo periodo è caratterizzata da una combinazione unica di osservazioni scientifiche naturali con coscienza estetica e mitologica. La filosofia antica è costituita da dozzine di idee filosofiche che spesso erano direttamente opposte tra loro. Ma proprio questo ha determinato sempre più tipi di filosofia.
Filosofia medievale
Nell'era del feudalesimo, a cui appartiene la filosofia medievale, l'uomo era subordinato agli interessi della chiesa e da essa strettamente controllato. I dogmi religiosi venivano difesi con zelo. L'idea principale di questo tipo di filosofia è il monoteismo di Dio. Non sono gli elementi o il macrocosmo la forza principale che governa il mondo, ma solo Dio, il creatore di tutte le cose. La filosofia medievale si basava su diversi principi:
- creazionismo (creazione del mondo da parte di Dio dal vuoto);
- provvidenzialismo (la storia dell'umanità è un disegno inventato in anticipo da Dio per la salvezza dell'uomo);
- simbolismo (la capacità di vedere il significato nascosto nell'ordinario);
- realismo (Dio è in ogni cosa: nelle cose, nelle parole, nei pensieri).
La filosofia medievale è solitamente divisa in patristica e scolastica.
Filosofia rinascimentale
Durante il periodo in cui emersero le relazioni capitaliste nell'Europa occidentale (XV-XVI secolo), iniziò a svilupparsi un nuovo tipo di filosofia. Ora al centro dell'universo non c'è Dio, ma l'uomo (antropocentrismo). Dio è percepito come creatore, l'uomo formalmente dipende da lui, ma l'uomo è praticamente uguale a Dio, perché è capace di pensare e creare. Il mondo è visto attraverso il prisma della percezione soggettiva della sua personalità. Durante il periodo della filosofia rinascimentale apparve prima una visione del mondo umanistico-panteistica, e successivamente una visione naturalistico-deistica. Rappresentanti di questo tipo di filosofia sono N. Cusansky, G. Bruno, G. Pico Della Mirandola, Leonardo da Vinci, N. Copernicus.
Filosofia della nuova era
Lo sviluppo della matematica e della meccanica come scienze, la crisi del feudalesimo, le rivoluzioni borghesi, la formazione del capitalismo: tutto ciò divenne i prerequisiti per l'emergere di un nuovo tipo di filosofia, che in seguito sarebbe stata chiamata la filosofia della New Age. Si basa sullo studio sperimentale dell'esistenza e sulla sua comprensione. La ragione era riconosciuta come la massima autorità alla quale tutto il resto era subordinato. I filosofi della New Age pensavano alla forma razionale e sensoriale della conoscenza, che determinò l'emergere di due movimenti principali: razionalismo ed empirismo. Rappresentanti della filosofia della New Age sono F. Bacon, R. Descartes, G. Leibniz, D. Diderot, J. Berkeley, T. Hobbes e altri.
Filosofia classica tedesca
Le trasformazioni sociali della fine del XVIII secolo avvenute in Germania, così come nella borghesia francese, divennero i prerequisiti per l'emergere di un nuovo tipo di filosofia, il cui fondatore è considerato Immanuel Kant. Ha esplorato questioni di scienze naturali. Fu Kant a formulare l’ipotesi che la rotazione terrestre rallenti a causa delle maree e che il sistema solare sia nato da una nebulosa di gas. Qualche tempo dopo, Kant si dedicò ai problemi delle capacità cognitive umane, sviluppando la sua teoria della conoscenza nella chiave dell'agnosticismo e dell'apriorismo. Secondo Kant la natura non ha “ragione”, ma è un insieme di idee umane su di essa. Ciò che è creato dall'uomo è conoscibile (in contrapposizione al mondo caotico e irregolare dei fenomeni). Il concetto epistemologico di Kant comprende 3 fasi della cognizione: la cognizione sensoriale, l'area della ragione e l'area della ragione che guida l'attività dell'intelletto. Le idee di Kant furono sviluppate da I.G. Fichte, F. Schelling. La filosofia classica tedesca comprende G. Hegel, L. Feuerbach e altri.
Filosofia dei tempi moderni
Questo tipo di filosofia nel XIX secolo. L'idea fondamentale era che la conoscenza umana è illimitata ed è questa la chiave per realizzare gli ideali dell'umanesimo. Al centro della filosofia c'è il culto della ragione. I principi originali della filosofia classica furono ripensati da Nietzsche, Kierkegaard e Schopenhauer. Le loro teorie furono chiamate filosofia neoclassica. Gli scienziati della Scuola di Baden hanno suggerito che esistono scienze storiche e scienze naturali. Le prime riguardano gli eventi, le seconde sono le scienze le leggi. Riconoscevano come realmente esistente solo la cognizione individuale, considerando tutto il resto un'astrazione.
Le opere di Karl Marx sono considerate una parte importante della filosofia dei tempi moderni. Tra le altre cose, formula il concetto di alienazione e il principio dell'eliminazione rivoluzionaria dell'alienazione, la creazione di una società comunista in cui ogni persona può lavorare liberamente. Marx è convinto che la base della conoscenza sia la pratica, che porta a una comprensione materialistica della storia.
Filosofia russa
La filosofia russa è sempre stata originale, come del resto lo è stato l'intero sviluppo culturale e storico della Russia. Sorse un po' più tardi che in Europa, e inizialmente professò le idee del pensiero antico e bizantino, per poi essere influenzato dalle tendenze dell'Europa occidentale. La filosofia russa è strettamente connessa con la religione, la creatività artistica e l'attività socio-politica. Si concentra non su questioni epistemologiche, ma sull’ontologismo (conoscenza attraverso la conoscenza intuitiva). Particolare importanza nella filosofia russa è data all'esistenza umana (antropocentrismo). Questo è un tipo di filosofia storiosofica, poiché una persona non può vivere e pensare al di fuori dei problemi storico-sociali. Molta attenzione nella filosofia russa è rivolta al mondo interiore dell'uomo. Rappresentanti della filosofia russa possono essere considerati G. Nyssky, I. Damaskin, K. Turovsky, N. Sorsky, Elder Philofey, V. Tatishchev, M. Lomonosov, G. Skovoroda, A. Radishchev, P. Chaadaev, A. Khomyakov, A. Herzen, N. Chernyshevskij, F. Dostoevskij, L. Tolstoj, V. Solovyov, V. Vernadsky, N. Berdyaev, V. Lenin e altri.
Filosofia dell'ultimo quarto del XX secolo
Nell’ultimo quarto del secolo scorso, i filosofi di tutto il mondo si sono rivolti alla ricerca di una nuova razionalità. Ci sono tre svolte nello sviluppo della filosofia: storica, linguistica e sociologica. Stanno emergendo delle tendenze all’interno delle tradizioni teologiche. Parallelamente a questo avviene un processo di elaborazione riflessiva dei prodotti della creazione del mito. I filosofi “ripuliscono” il marxismo dall’utopismo e dalle interpretazioni politiche dirette. La filosofia dell'ultimo quarto del 20 ° secolo è aperta, tollerante, non ci sono scuole e movimenti dominanti al suo interno, poiché i confini ideologici tra loro sono stati cancellati. La filosofia è parzialmente integrata con le scienze umane e naturali. Rappresentanti della filosofia dell'ultimo quarto del XX secolo sono G. Gadamer, P. Ricoeur, C. Lévi-Strauss, M. Foucault, J. Lacan, J. Derrida, R. Rorty.
La filosofia antica è rappresentata da pensatori famosi come Socrate, Platone, Talete, Pitagora, Aristotele e altri. Il pensiero antico si è sviluppato dallo spazio all'uomo, dando vita a nuove tendenze che sono ancora oggetto di studio da parte degli scienziati moderni.
Tre periodi della filosofia antica
La filosofia antica interessa molti ricercatori e pensatori del nostro tempo. Al momento, ci sono tre periodi di sviluppo di questa filosofia:
Il primo periodo va da Talete ad Aristotele;
Il secondo periodo è la filosofia dei Greci nel mondo romano;
Il terzo periodo è la filosofia neoplatonica.
Il primo periodo è caratterizzato dallo sviluppo di insegnamenti filosofici sulla natura. Nel secondo periodo si sviluppa l'idea dei problemi antropologici. Socrate gioca qui il ruolo principale. Il terzo periodo è anche chiamato età dell'ellenismo. Vengono studiati il mondo soggettivo di una comprensione individuale e religiosa del mondo circostante.
Problemi di filosofia antica
Se si considera la filosofia antica nel suo complesso, i problemi possono essere così definiti:
Cosmologia. È stato sviluppato da filosofi naturali che hanno studiato la natura e lo spazio. I filosofi naturali hanno discusso di come è nato il cosmo, perché è esattamente così com'è e quale sia il ruolo dell'uomo in questo intero processo universale. A poco a poco il pensiero si sposta dall'altra parte del problema: la persona. Ecco come appare la moralità.
Moralità. È stato sviluppato dai sofisti. L'argomento più importante è la conoscenza del mondo umano e delle sue caratteristiche. C'è una transizione dall'universo a una persona specifica. Per analogia con la filosofia orientale, iniziano a sorgere affermazioni secondo cui conoscendo una persona, puoi conoscere il mondo che ti circonda. Lo sguardo filosofico si muove all'interno del mondo umano, nel tentativo di trovare risposte a domande globali. Alla ricerca di una connessione tra il mondo visibile e quello invisibile, sorgono metodi metafisici per comprendere il mondo.
Metafisica. Il suo aspetto è associato agli insegnamenti di Platone. Il famoso scienziato e i suoi seguaci sostengono che l'esistenza e la realtà sono eterogenee. Allo stesso tempo, il mondo ideologico è molto più alto di quello sensoriale. I seguaci dell'insegnamento metafisico studiano i problemi della genesi e della natura della conoscenza del mondo. Appaiono interi rami dell'insegnamento: estetica, fisica, logica. Alla fine sorgono problemi mistico-religiosi caratteristici dell'era finale dell'antichità.
Quanti insegnamenti c'erano nell'antica Grecia?
Secondo una ricerca condotta dagli scienziati, l'antica Grecia ha almeno 288 insegnamenti. Le scuole più famose studiate scrupolosamente nel nostro tempo sono l'Accademia di Platone, il Liceo di Aristotele, la Scuola Stoica, la Scuola Epicurea, la Scuola Ionica. La filosofia antica non ha fornito risposte a tutte le domande, ma ha fornito molti pensieri e detti saggi che ancora costringono il pensiero umano a svilupparsi.
Problemi della filosofia antica I problemi complessivi della filosofia antica possono essere tematicamente così definiti: la cosmologia (filosofi naturali), nel suo contesto, la totalità del reale era vista come “physis” (natura) e come cosmos (ordine), il la domanda principale è: “Come è nato il cosmo?”; la moralità (sofisti) era il tema determinante nella conoscenza dell'uomo e delle sue capacità specifiche; la metafisica (Platone) dichiara l'esistenza della realtà intelligibile, afferma che la realtà e l'esistenza sono eterogenee e il mondo delle idee è superiore a quello sensoriale; la metodologia (Platone, Aristotele) sviluppa i problemi della genesi e della natura della conoscenza, mentre il metodo della ricerca razionale è inteso come espressione delle regole del pensiero adeguato; l'estetica si sta sviluppando come una sfera di risoluzione del problema dell'arte e della bellezza in sé; le problematiche della filosofia proto-aristotelica possono essere raggruppate come una gerarchia di problemi generalizzanti: fisica (ontologia-teologia-fisica-cosmologia), logica (epistemologia), etica; e alla fine dell'era della filosofia antica si formano problemi mistico-religiosi, caratteristici del periodo cristiano della filosofia greca.
Va notato che, in linea con l'antica capacità di percepire filosoficamente questo mondo, il pensiero filosofico teorico sembra essere il più importante per il successivo sviluppo della conoscenza filosofica.
Almeno, la dottrina della filosofia come vita ha subito oggi un cambiamento significativo: la filosofia non è più solo vita, ma proprio vita nella conoscenza. Naturalmente mantengono il loro significato anche elementi di filosofia pratica che sviluppano le idee dell'antica filosofia pratica: idee di etica, politica, retorica, teoria dello Stato e del diritto.
Pertanto, è stata la teoria che può essere considerata la scoperta filosofica dell'antichità a determinare non solo il pensiero dell'uomo moderno, ma anche la sua vita e, senza dubbio, l '"influenza inversa" dei meccanismi di cognizione generati dagli antichi greci la coscienza ha avuto un impatto molto forte sulla struttura stessa della vita cosciente di una persona.
In questo senso, se la teoria come principio di organizzazione della conoscenza e i suoi risultati sono completamente verificati, allora il suo effetto “inverso” come principio inverso di organizzazione della coscienza non è ancora del tutto chiaro. Scuole di filosofia antica. Secondo gli storici romani, nell'antica Grecia c'erano 288 insegnamenti filosofici, tra cui, oltre alle grandi scuole filosofiche, spicca l'insegnamento dei filosofi cinici e cirenei. Ad Atene c'erano quattro grandi scuole: l'Accademia di Platone, il Liceo di Aristotele, Portico (scuola stoica) e Giardino (scuola epicurea). La scuola ionica (o milesiana, a seconda del luogo di provenienza) è la più antica scuola filosofica naturale.
Secondo AN Chanyshev, "La filosofia ionica è proto-filosofia. È anche caratterizzata dall'assenza di polarizzazione in materialismo e idealismo..., dalla presenza di molte immagini della mitologia, da elementi significativi di antropomorfismo, panteismo, dall'assenza di adeguate terminologia, la presentazione dei processi fisici nel contesto delle questioni morali”. Ma la filosofia ionica è già filosofia nel senso fondamentale del termine, perché già i suoi primi creatori - Talete, Anassimandro, Anassimene - cercavano di comprendere questo o quel principio come una sostanza (acqua, aria, fuoco, ecc.). La loro origine è sempre una (in questo senso i filosofi ionici sono monisti), è materiale, ma anche ragionevole, addirittura divina.
Ciascuno dei filosofi identificò uno degli elementi come questo principio: Talete è il fondatore della scuola milesia, o ionica, la prima scuola filosofica.
Fu uno dei fondatori della filosofia e della matematica, il primo a formulare teoremi geometrici, e studiò l'astronomia e la geometria dai sacerdoti egiziani. Talete divenne il fondatore della filosofia naturale e ne formulò i due problemi principali: l'inizio e l'universale. Considerava l'inizio come l'acqua su cui poggia la terra, e considerava il mondo pieno di dei e animato. Talete divise anche l'anno in 365 giorni. Eraclito diceva che tutto nasce dal fuoco attraverso la rarefazione e la condensazione e si brucia dopo determinati periodi.
Il fuoco simboleggia la lotta degli opposti nello spazio e il suo movimento costante. Eraclito introdusse anche il concetto di Logos (Parola), il principio di unità razionale, che ordina il mondo da principi opposti. Il Logos governa il mondo e il mondo può essere conosciuto solo attraverso di esso. Anassimandro (610 - ca. 540 aC) considerava l'inizio di tutto nella natura infinita, qualcosa tra i quattro elementi, e affermava che la creazione e la distruzione dei mondi è un processo ciclico eterno.
Anassimene (morto nel 525 a.C.), allievo di Anassimandro, considerava l'aria il primo principio. Quando l’aria si assottiglia diventa fuoco; quando si addensa diventa vento, acqua e terra. Anassagora, allievo di Anassimene, introdusse il concetto di Nous (Mente), organizzando il cosmo a partire da una miscela di elementi disordinati. Alla scuola ionica è associata l'emergere dei fondamenti dell'astronomia, della matematica, della geografia, della fisica, della biologia e di altre scienze . Indipendentemente da questi antichi Ioni dell'Asia Minore, nelle colonie greche dell'Italia inferiore apparvero pensatori imbevuti della stessa idea di unità del mondo.
Questi includono, prima di tutto, Pitagora e i suoi studenti, che esplorarono il mondo intero. Notarono innanzitutto la correttezza nel movimento dei corpi celesti e da essi cercarono di trasferire questa correttezza ai fenomeni terreni, fenomeni del mondo fisico e morale.La scuola pitagorica fu fondata da Pitagora a Crotone (Italia meridionale) e esisteva fino all'inizio del IV secolo. a.C., anche se la persecuzione iniziò quasi subito dopo la morte di Pitagora nel 500 a.C. Si trattava essenzialmente di una confraternita aristocratica religiosa e filosofica; esercitò una grande influenza sulle città-stato greche dell'Italia meridionale e della Sicilia.
L'unione si distingueva per costumi rigorosi e alta moralità. Tuttavia, sia l’apparenza che il comportamento erano solo una conseguenza delle visioni dei filosofi sull’anima umana e sulla sua immortalità, che implicavano una certa educazione in questa vita terrena.La scuola pitagorica gettò le basi per le scienze matematiche. I numeri erano intesi come l'essenza di tutto ciò che esiste; ad essi veniva dato un significato mistico.
La base della matematica pitagorica è la dottrina della decade: 1+2+3+4=10. Questi quattro numeri descrivono tutti i processi che si verificano nel mondo. Consideravano l’ordine mondiale come la regola dei numeri; e in questo senso trasferiscono al mondo, «nel suo insieme, il concetto di cosmo, che originariamente significava ordine, decorazione». Se ti poni la domanda sull'orientamento filosofico di Pitagora, allora sembra che possiamo dire con assoluta certezza che si trattava principalmente di una filosofia del numero, in questo differiva nettamente dalla filosofia naturale ionica, che cercava di ridurre tutto ciò che esiste all’uno o all’altro elemento materiale, sottolineandone l’originalità qualitativa (acqua, aria, fuoco, terra).” I Pitagorici appartengono alla dottrina della musica delle sfere e della scala musicale, che riflette l'armonia del sistema solare, dove ogni pianeta corrisponde ad una certa nota, e insieme creano intervalli della scala musicale.
Gettarono anche le basi per la psicologia musicale: la musica era usata come mezzo per educare e curare l'anima e il corpo. L'astronomia e la medicina iniziarono a svilupparsi nella scuola pitagorica.
Realizzò numerosi commenti allegorici di Omero e una grammatica della lingua greca, per cui i pitagorici possono essere considerati i fondatori delle scienze umane, naturali, esatte e sistematiche. La scuola eleatica è il nome dato all'antica scuola filosofica greca, i cui insegnamenti si svilupparono a partire dalla fine del VI secolo. fino all'inizio della seconda metà del V secolo. AVANTI CRISTO. con i maggiori filosofi: Parmenide, Zenone e Melisso.
I primi due - Parmenide e Zenone - vivevano nella piccola città italiana di Elea, e il terzo - Melisso - era originario di Samo, lontano da Elea. Ma poiché gli insegnamenti principali della scuola furono sviluppati da Parmenide e Zenone, cittadini di la città di Elea, la scuola nel suo insieme ricevette il nome Eleatica E se i Pitagorici consideravano l'ordine mondiale esclusivamente dal suo lato quantitativo, allora in contrasto con loro nel VI secolo emersero tendenze che, come gli antichi pensatori ionici, comprendevano qualitativamente l'idea dell'unità del mondo, tuttavia vedevano l'unità del mondo non in un'unica sostanza mondiale, ma in un unico principio dominante del mondo, in un unico concetto che domina il cambiamento di tutti i fenomeni. Per gli Eleati questo concetto è l’essere, che rimane costante nonostante cambino le cose.
L'emergere della scuola dei sofisti fu una risposta al bisogno di democrazia nell'educazione e nella scienza: insegnanti itineranti potevano insegnare a chiunque l'arte della parola in cambio di denaro. Il loro obiettivo principale era preparare i giovani alla vita politica attiva.
L'attività dei sofisti, che relativizzavano ogni verità, segnò l'inizio della ricerca di nuove forme di attendibilità della conoscenza, che potessero resistere al tribunale della riflessione critica. Queste ricerche furono continuate dal grande filosofo ateniese Socrate (470 ca. - 399 a.C.), prima allievo dei sofisti, poi loro critico. La differenza tra Socrate e i sofisti è che per lui il criterio per valutare le azioni è la considerazione di quali motivazioni determinano la decisione su cosa è utile e cosa è dannoso. I pensieri di Socrate servirono come base per lo sviluppo della maggior parte delle scuole filosofiche successive, fondate dai suoi studenti, inclusa l'Accademia di Platone.
Ha spiegato l'essenza della sua filosofia in una frase: "So solo una cosa, che non so nulla". Nelle sue conversazioni Socrate non risponde alle domande, le pone, incoraggiando artificialmente l'interlocutore a cercare autonomamente la verità e, quando sembra vicino ad essa, trova nuovi argomenti e ragioni per dimostrare l'inutilità di questi tentativi.
Il principale interesse filosofico di Socrate si concentra sulla questione di cosa sia una persona, cosa sia la coscienza umana. “Conosci te stesso” è il detto preferito di Socrate. Platone unì nel suo insegnamento i valori dei suoi due grandi predecessori: Pitagora e Socrate. Dai Pitagorici adottò l'arte della matematica e l'idea di creare una scuola filosofica, che incarnò nella sua Accademia di Atene. Gli allievi di Platone erano per lo più “elegante giovane gentiluomo” di famiglie aristocratiche (si ricorda almeno il suo allievo più famoso, Aristotele). Per le lezioni, in un angolo pittoresco della periferia nord-occidentale della città, fu costruita un'Accademia.
La famosa scuola filosofica esistette fino alla fine dell'antichità, fino al 529, quando l'imperatore bizantino Giustiniano la chiuse. Anche se Platone, come Socrate, credeva che far pagare la saggezza non fosse meglio che far pagare l’amore, e, come lui, chiamava i sofisti “prostitute della filosofia” perché chiedevano denaro ai loro studenti, ciò non impediva a Platone di accettare ricchi doni e tutti i tipi di aiuto da parte dei poteri costituiti. Da Socrate Platone apprese il dubbio, l'ironia e l'arte della conversazione.
I dialoghi di Platone suscitano interesse e insegnano a riflettere su problemi molto seri della vita, che non sono cambiati molto in duemila anni e mezzo. Le idee più significative nella filosofia di Platone sono le idee sulle Idee, la Giustizia e lo Stato, e lui cercò di combinare il filosofico e il politico.
Nella sua scuola formò governanti filosofi capaci di governare equamente, basandosi sui principi del bene comune. Nel 335 a.C. Aristotele, uno studente di Platone, fondò la sua scuola: il Liceo, o Peripatos, che si distingueva per il suo orientamento esclusivamente filosofico. Tuttavia, è difficile sintetizzare il sistema coerente di Aristotele dalle sue opere, che spesso sono raccolte di conferenze e corsi.Uno dei risultati più importanti delle attività di Aristotele in politica fu l’educazione di Alessandro Magno.
Dalle rovine del Grande Impero sorsero stati ellenistici e nuovi filosofi. Se i precedenti insegnamenti etici vedevano nella sua inclusione nell'insieme sociale il principale mezzo di miglioramento morale dell'individuo, ora, al contrario, i filosofi considerano la condizione di una vita virtuosa e felice la liberazione di una persona dal potere del potere mondo esterno, e soprattutto dalla sfera politica e sociale: questa è in larga misura l’installazione della scuola stoica.
Questa scuola, fondata da Zenone alla fine del IV sec. aC esisteva durante l'Impero Romano. La filosofia per gli stoici non è solo scienza, ma, soprattutto, via della vita, saggezza della vita. Solo la filosofia è in grado di insegnare a una persona a mantenere l'autocontrollo e la dignità nella difficile situazione sorta in epoca ellenistica, soprattutto nel tardo impero romano, dove il decadimento della morale nei primi secoli della nuova era raggiunse il suo punto più alto Gli stoici considerano la libertà dal potere del mondo esterno su una persona la virtù principale di un saggio; La sua forza sta nel fatto che non è schiavo delle proprie passioni.
Un vero saggio, secondo gli stoici, non ha paura nemmeno della morte; È dagli stoici che viene la comprensione della filosofia come scienza della morte. L'idea principale dello stoicismo è la sottomissione al destino e alla fatalità di tutte le cose. Zenone disse degli stoici: "Vivi coerentemente, cioè secondo un'unica e armoniosa regola di vita, perché coloro che vivono incoerentemente sono infelici". Per uno stoico, la natura è destino o destino: fare pace con il destino, non resistergli: questo è uno dei comandamenti di Seneca.
Il completo rifiuto dell’attivismo sociale in etica si trova nel famoso materialista Epicuro (341 – 270 a.C.). Il più famoso degli epicurei romani fu Lucrezio Caro (99-55 d.C. circa). L’individuo, e non l’insieme sociale, è il punto di partenza dell’etica epicurea. Epicuro rivede così la definizione di uomo data da Aristotele: l'individuo è primario; tutte le connessioni sociali, tutte le relazioni umane dipendono dagli individui, dai loro desideri soggettivi e dalle considerazioni razionali di beneficio e piacere.
L'unione sociale, secondo Epicuro, non è il fine supremo, ma solo un mezzo per il benessere personale degli individui; a questo punto Epicuro risulta essere vicino ai sofisti. Nel 306 a.C. ad Atene fondò una scuola. A differenza dell’etica stoica, l’etica epicurea è edonistica: Epicuro considerava la felicità, intesa come piacere, lo scopo della vita umana, ma Epicuro vedeva il vero piacere non affatto nell’indulgere in rozzi piaceri sensuali senza alcuna misura.
Come la maggior parte dei saggi greci, era devoto all'ideale della moderazione. Il piacere più alto era considerato, come tra gli stoici, l'equanimità dello spirito (atarassia), la pace mentale e la serenità, e tale stato può essere raggiunto solo se una persona impara a moderare le proprie passioni e desideri carnali, subordinandoli alla ragione. Gli epicurei prestano particolare attenzione alla lotta con le superstizioni, inclusa la religione tradizionale greca. 3. Le opere di Platone e Aristotele rappresentano un risultato eccezionale nella storia della cultura mondiale.
Platone e Aristotele hanno creato le loro immagini filosofiche del mondo in un'epoca di grandi sconvolgimenti nella società contemporanea. Da questo punto di vista, quando si studiano le visioni filosofiche e politiche di Platone e Aristotele, sarebbe interessante considerare le visioni del mondo di questi filosofi non in forma completa, ma per seguirne lo sviluppo, come gli eventi turbolenti della vita sociale nell'era di Platone e Aristotele si riflettessero nella formazione dei loro sistemi filosofici.
La questione del significato millenario di Platone sorge per tutti coloro che sono entrati in contatto con la sua visione del mondo e con lo stile artistico delle sue opere. L'interesse per l'antico filosofo greco Platone e la sua opera non si è indebolito, forse addirittura intensificato nel nostro tempo.In primo luogo, l'opinione anche della persona più comune vissuta duemila e mezzo anni fa è di per sé interessante. Naturalmente, l'interesse aumenta molte volte se questa persona è Platone. “Platone è uno dei maestri dell’umanità.
Senza i suoi libri non solo capiremmo peggio chi erano gli antichi greci, cosa hanno dato al mondo, capiremmo peggio noi stessi, capiremmo meno cosa sono la filosofia, la scienza, l'arte, la poesia, l'ispirazione, cos'è l'uomo, cosa sono le difficoltà delle sue ricerche e dei suoi risultati”, ha scritto V.F. Asmus. Platone è il primo rappresentante coerente dell'idealismo oggettivo in Europa, il fondatore di questa filosofia.
L'idealismo oggettivo di Platone è la dottrina dell'esistenza indipendente delle idee come concetti generali e generici. Platone è il primo filosofo in Europa a gettare le basi dell'idealismo oggettivo e a svilupparlo nella sua interezza. Il mondo secondo Platone non è né un cosmo corporeo, privo di individualità, né le singole cose materiali che riempiono l'Universo. Il bellissimo cosmo materiale, che ha raccolto molti individui in un tutto indivisibile, vive e respira, è tutto pieno di infinite cose fisiche. forze, ma è governato da leggi che sono al di fuori di esso, al di là di esso.
Questi sono gli schemi più generali secondo i quali vive e si sviluppa l'intero cosmo. Costituiscono uno speciale mondo supercosmico e sono chiamati da Platone il mondo delle idee. Puoi vederli non con la visione fisica, ma con quella mentale, mentalmente. Le idee che governano l’Universo sono primarie. Determinano la vita del mondo materiale. Il mondo delle idee è fuori dal tempo, non vive, ma dimora, riposa nell'eternità, e l'idea più alta delle idee è un bene astratto, identico alla bellezza assoluta.
L’idealismo di Platone è chiamato oggettivo perché riconosce l’esistenza di un essere completamente reale, indipendente dalla coscienza umana, cioè un essere ideale oggettivo. Platone creò una teoria del generale come legge dell'individuo, una teoria delle leggi necessarie ed eterne della natura e della società, opponendosi alla loro attuale confusione e cieca indivisibilità, opponendosi a qualsiasi comprensione prescientifica. Era questo aspetto dell'insegnamento di Platone sulle idee che ne ha in gran parte determinato la millenaria importanza nella storia del pensiero umano. Lo studente di Platone, Aristotele, sviluppò e riconsiderò criticamente la filosofia del suo insegnante.
Sulle vie della comprensione artistica della realtà, dovette affrontare la visione distorta di Platone secondo cui le idee sono nettamente opposte al mondo delle cose: le idee delle cose che esistono da qualche parte nei cieli inaccessibili furono messe in primo piano e le cose furono gettate nella realtà. mondo senza alcun contenuto ideologico. Secondo Aristotele, nella vita reale è assolutamente impossibile separare le une dalle altre e stabilire una netta opposizione tra cose e idee. Pertanto, lo stesso Aristotele non negò il ruolo delle idee nella comprensione del mondo materiale, ma, intraprendendo la strada della critica all'idealismo estremo, cercò di utilizzare il proprio insegnamento sulle idee esclusivamente per il bene degli obiettivi della vita e per il bene della comprensione di tutti della realtà come opera d’arte, intrisa del significato ideologico più profondo.
Aristotele crea il primo sistema logico nella storia: la sillogistica, il cui compito principale vede nello stabilire regole per ottenere conclusioni affidabili da determinate premesse.
Il centro della logica aristotelica è la dottrina delle inferenze e delle prove basate sulle relazioni tra il generale e il particolare. La logica formale, creata da Aristotele, è servita per molti secoli come principale mezzo prova scientifica... La portata e la fioritura senza precedenti del pensiero filosofico di Platone e Aristotele sono sempre state combinate con un'attività politica molto attiva.
Come i veri greci, erano infinitamente devoti ai loro interessi patriottici e con tutte le loro forze volevano preservare la Grecia proprio durante il suo periodo classico. Ma già qui dovettero affrontare il durissimo destino della polis classica greca, che si avviava rapidamente verso la sua inevitabile morte. Il sistema di opinioni politiche di Aristotele è presentato in modo più ricco e completo rispetto a quello di Platone: nelle opere di Aristotele si possono trovare una descrizione di circa 420 sistemi legislativi e strutture governative esistenti ai suoi tempi.
Aristotele, a differenza di Platone, non si concentra sulla costruzione di una sorta di migliore struttura statale, ma considera i principi di base del funzionamento dello stato, descrivendo allo stesso tempo diversi tipi di sistemi statali sia positivi che negativi, a suo avviso. Platone, a sua volta, era convinto che esistesse la verità assoluta, e tutta la tragedia della sua posizione sta nel fatto che credeva nella realizzazione immediata e completa di questa verità.
Essendo appunto il restauratore dell'antichità perduta, Platone volle rimanere e di fatto rimase sempre soprattutto l'ideologo dei classici greci del lungo periodo delle guerre greco-persiane. L’armonia della personalità umana, della società umana e di tutta la natura che circonda l’uomo è l’ideale costante e immutabile di Platone durante tutta la sua carriera creativa. Anche il lavoro degli antichi filosofi Platone e Aristotele è interessante perché hanno avuto una rara opportunità di attuare praticamente i loro sistemi filosofici.
Platone fece molti sforzi per illuminare il tiranno siracusano Dionisio il Giovane; Aristotele ebbe una grande influenza sull'imperatore Alessandro Magno e fu il suo insegnante. Lui e i suoi studenti proposero sistemi legislativi per le nuove città e colonie greche. Se studi la biografia di Aristotele in dettaglio, non puoi che rimanere sorpreso da come la teoria filosofica e la pratica di vita di Aristotele coincidano in modo coerente e naturale.
La vita è tragica. Ma questa tragedia della vita può essere compresa solo da coloro che, nel profondo di questa tragedia, vedono non una realtà tragica, ma puramente eidetica, o ideale. Il destino degli eroi nella tragedia greca testimonia semplicemente l'esistenza di fondamenti superiori della vita, capaci solo di comprendere il destino tragico della realtà, e Aristotele lo ha dimostrato sia nella sua teoria filosofica che nella sua vita pratica e nel suo lavoro; per lui , la morte stessa rimaneva un atto di saggezza e di calma indisturbata. Impulso ideologico, disposizione di principio, servizio disinteressato all'ideale: tutto ciò ha reso necessarie le filosofie di Platone e Aristotele per interi millenni.
Aristotele diceva che Platone era suo amico, ma la verità era per lui più preziosa.SOCRATE, IL SUO INSEGNAMENTO E METODI FILOSOFICI La vita e l'opera di Socrate, uno dei più grandi filosofi dell'antica Grecia, possono essere apprese solo dalle opere dei suoi contemporanei e gli studenti, in primis Platone, perché lo stesso Socrate non ha lasciato dietro di sé fonti scritte.
Platone incontrò Socrate otto anni prima della morte di quest'ultimo, quando Socrate aveva già più di sessant'anni, e questo incontro produsse una rivoluzione nell'animo del futuro famoso filosofo. Platone scrisse anche l'“Apologia di Socrate”, dalla quale si possono conoscere alcuni aspetti della filosofia di Socrate. "L'Apologia di Socrate" è il discorso di assoluzione di Socrate, da lui pronunciato alla corte ateniese nel 399 a.C. dopo che furono ascoltati i discorsi dei suoi accusatori.
Va notato che questa è una riproduzione artistica del discorso di Platone e, dal punto di vista della sua abilità artistica, merita un grande elogio. La composizione prevede: 1. Discorso dopo l'accusa, che precede il verdetto. In esso Socrate critica i precedenti e i nuovi accusatori di diffamazione e dà una descrizione generale di se stesso: dice che non ha paura della morte, ma ha paura solo della codardia e della vergogna; che sarà sempre impegnato nella filosofia; che il suo omicidio sarà terribile per i giudici, perché dopo la morte di Socrate difficilmente c'è una persona che li costringerà a lottare per la verità.
Il filosofo dice anche che una voce interiore gli impedisce di prendere parte agli affari pubblici pieni di ingiustizia, afferma di non aver insegnato nulla a nessuno, ma solo di non avergli impedito di fare domande e di rispondere - questo è stato affidato a Socrate da Dio, e non ci sono testimoni che possano sostenere che Socrate abbia parlato di cose malvagie e corruttrici. 2. Discorso di Socrate dopo l'accusa generale.
È sorpreso che l'accusa abbia ottenuto il sostegno di una piccola maggioranza di voti e afferma che i giudici non gli credono e quindi non lo capiranno. 3. Discorso di Socrate dopo la condanna a morte. Coloro che hanno votato per la pena di morte, dice Socrate, hanno fatto del male a se stessi, perché tutti li biasimeranno e lui sarà considerato un saggio. Socrate non ha abbastanza spudoratezza e audacia per umiliarsi davanti a giudici che non lo capiscono, in questo caso Socrate riconosce la morte come una benedizione e se questa è, come si suol dire, un passaggio all'Ade, allora è anche un guadagno : là troverà giusti giudici e diventerà immortale. In conclusione, Socrate dice che morirà, ma i suoi accusatori continueranno a vivere. Ma non è chiaro cosa sia meglio e cosa sia peggio. A volte Platone nella sua opera, apparentemente nel tentativo di mostrare Socrate nella luce più favorevole, commette errori logici: la semplice negazione del fatto che cita (non era coinvolto nella filosofia naturale) non è ancora prova della sua assenza.
Permette anche un ragionamento molto formale: “Se sono ateo, non ho introdotto nuove divinità” e viceversa.
Nell'Apologia, Socrate afferma di non essere coinvolto negli affari pubblici, e allo stesso tempo afferma di aver combattuto e combatterà l'ingiustizia, che la sua filosofia è la lotta per il bene pubblico e per i fondamenti dello Stato. Inoltre, il metodo originale e acuto di domande e risposte della filosofia di Socrate non viene praticamente presentato, ad eccezione dei luoghi in cui Socrate entra mentalmente, per così dire, in una conversazione con Meleto. Il tono dell'eroe Socrate è piuttosto sicuro di sé, cosa che, secondo altri contemporanei, non era affatto caratteristica di lui .
Quindi, nonostante tutte le polemiche della fonte scritta più significativa che racconta ai posteri il più notevole filosofo dell'antichità, l'“Apologia” ci dà un'idea, anche se non completa, della filosofia di Socrate e dei suoi metodi: chi era questo strano uomo che non scrisse un solo libro, eppure rimase per secoli una delle personalità più brillanti dell'antica Grecia? Socrate era una persona originale nella vita di tutti i giorni, un eccentrico in filosofia, il suo comportamento non era sempre consueto.
Veniva da una famiglia semplice e povera: era figlio di uno scalpellino e quindi non ricevette durante l'infanzia e l'adolescenza l'educazione e l'educazione raffinata che erano obbligatorie per i giovani provenienti da famiglie aristocratiche. Esteriormente, il filosofo era calvo, tozzo, con il successivo famoso bernoccolo sulla fronte. Il suo naso era appiattito, le sue labbra erano spesse, i suoi occhi erano sporgenti e si vestiva quasi peggio degli schiavi e non cambiava vestiti a seconda del tempo.
Non aveva alcuna specialità; cosa facesse per vivere è sconosciuto. È vero, ha partecipato tre volte a campagne militari, come molti concittadini, e ha visitato l'Assemblea popolare, ma regolarmente non ha fatto nulla né nel campo pubblico né in quello statale. Tuttavia, era una persona molto popolare tra la gente, e quindi nel 404 a.C. il governo dei Trenta Tiranni avrebbe addirittura voluto portarlo dalla propria parte, ma Socrate declinò tale “onorevole” fiducia, infatti la sua unica occupazione era quella di porre domande.
Un piacere speciale per Socrate fu una conversazione con un uomo soddisfatto di sé che, completamente confuso nelle sue domande difficili, perse tutta la sua arroganza. Socrate, tuttavia, si dipingeva come un sempliciotto e attribuiva a se stesso i fallimenti del suo avversario, ridendo gentilmente e bonariamente del suo interlocutore. Va detto che questo metodo - domanda e risposta - era nuovo nella filosofia dei tempi di Socrate e con il suo aiuto era possibile abbattere facilmente le idee filistee sul mondo e sulla sua struttura.
Naturalmente, la forma del dialogo domanda-risposta è stata utilizzata da altri filosofi. Quindi, anche i sofisti amavano le controversie, ma piuttosto come processo, argomento per il gusto di discutere, l'argomento dei sofisti alla fine divenne fine a se stesso. Socrate non raggiunse mai il punto delle chiacchiere e della mancanza di principi. A differenza dei filosofi naturali, le domande poste da Socrate non riguardavano principalmente la natura, le scienze o gli dei, ma riguardavano la coscienza umana, l'anima, la moralità e lo scopo della vita umana, la politica e l'estetica. Socrate fu essenzialmente il primo a rivolgersi all'uomo e ai suoi essenza.
Ha cercato di scoprire cosa è il bene e il male, la giustizia e la legge, il bello e il brutto, cioè... trovare risposte a domande che riguardano non solo la visione filosofica del mondo, ma anche l'estetica: una scienza basata sulla fusione di filosofia, arte e storia dell'arte. Platone nell'“Apologia di Socrate” cita i seguenti giudizi dell'insegnante: una ragazza può essere bello, ma cosa è bello in sé? Dopotutto, un cavallo può essere bello, quindi cos'è la bellezza? Per risolvere questa questione non basta considerare un cavallo o una ragazza, e non basta studiare tanti cavalli e ragazze.
È così che è apparso il metodo induttivo-definitivo della ricerca della verità. L'induzione è un altro metodo della filosofia socratica, che consente di esaminare un argomento da diverse angolazioni, con una varietà di opinioni e processi. Aristotele successivamente credette che Socrate stesse cercando formulazioni di concetti generali basati sullo studio di cose individuali che possono essere sussunto sotto questi concetti.
È partito dal fatto che la persona media spesso sostituisce il concetto con una rappresentazione o una caratteristica di una cosa ben nota e separata. E dopo le spiegazioni di Socrate, i concetti chiari degli interlocutori divennero vaghi, richiedendo ulteriori chiarimenti. Socrate ridusse in mille pezzi le idee filistee. Socrate utilizzava un altro metodo: la maeutica, cioè una forma di conversazione in cui la capacità di condurre un dialogo significava la capacità di porre domande importanti. Un altro metodo di Socrate era l'ironia.
Questo, come l'effetto magico dei discorsi di Socrate, fu notato da molti contemporanei. Socrate poneva domande in forma ironica e affascinava il suo interlocutore con la sua “ignoranza”. Naturalmente non a tutti è piaciuto un approccio così ironico e di nascosto beffardo. È necessario dire alcune parole sull'epoca in cui visse Socrate: la democrazia ateniese del suo tempo aveva perso i suoi ideali semplici, duri e belli, che erano nella prima metà del V secolo a.C. Furono dimenticati nella ricerca del profitto, di nuovi territori e degli schiavi.
A quel tempo, Atene viveva in guerre predatorie e la democrazia degenerava. Socrate, in mezzo alla gente, conversava e con le sue domande apparentemente semplici sconcertava i sostenitori del regime demagogico: gli aristocratici lo consideravano un cittadino comune che si concedeva molto, e i democratici avevano paura della sua pungente esposizione. , Socrate era troppo popolare. Le sue infinite controversie furono per il momento tollerate, ma nel 399 a.C. Le autorità "democratiche" processarono il filosofo ed emisero un verdetto giudiziario palese: la prima condanna a morte ad Atene per disaccordi ideologici astratti.
A Socrate, tuttavia, fu data l'opportunità di fuggire segretamente dalla prigione e andare in esilio, ma rimase fedele alla sua visione del mondo e bevve la tazza di cicuta preparata. La sua ultima richiesta prima della sua morte fu una richiesta di sacrificio al dio guaritore Asclepio. Un tale sacrificio veniva fatto in caso di guarigione riuscita, e qui Socrate era ironico: per guarigione intendeva partire per un'altra vita.
I metodi di Socrate sono già stati menzionati sopra. Un altro, il più famoso, è la dialettica socratica. La filosofia di Socrate mirava alla ricerca della verità positiva. L'interesse per l'uomo era una caratteristica comune tra Socrate e i sofisti, in contrasto con i filosofi naturali, che erano interessati alla natura e alla scienza. Ma la sofistica era semplicemente una bella arte oratoria, mentre Socrate, sforzandosi di raggiungere la verità positiva, non aveva fretta di affermarla e formularla. La dialettica nel suo senso positivo, nella sua costante ricerca della verità oggettiva, distingueva la filosofia di Socrate dalla filosofia naturale e sofismi.
È molto più facile capire come insegnava Socrate che determinare cosa insegnava. Come già detto, anche nell'Apologia gli aspetti della filosofia socratica praticamente non vengono presentati. Ma alcuni problemi possono ancora essere identificati. Uno dei problemi che preoccupavano i filosofi antichi era il problema della religione. Durante il processo Socrate fu accusato di aver introdotto nuove divinità e di aver corrotto i giovani, ma d'altra parte non era un ateo né un pio difensore del panteismo esistente. Naturalmente, non si può credere ad Aristofane, che nella commedia "Nuvole" ha fatto emergere Socrate come un fan di nuove divinità: le Nuvole.
Socrate rimase un razionalista, un dialettico che non aveva paura di parlare, se non degli dei tradizionali, quindi delle forze superiori che controllano opportunamente l'uomo. Il principio della giustizia suprema, umana e globale, non aveva nome per Socrate, ma le discussioni su di esso erano accettate dai contemporanei come discussioni su un nuovo dio, non antropomorfo e senza nome.
Una divinità così non mitologica e non legata al culto era feroce per i contemporanei ateniesi. Lo stato e la società occupavano anche Socrate, sebbene evitasse qualsiasi attività pubblica e statale, Socrate non simpatizzava con il sistema statale che esisteva in Grecia, con la società con la sua morale e costumi della polis morente. Il tempo era strano: non era passato nemmeno un secolo dal periodo di massimo splendore della società al suo declino.
All'inizio del secolo, Atene era una giovane polis di una democrazia schiavista, conquistatrice della Persia. A metà del secolo iniziò l '"età dell'oro" della democrazia ateniese, che durò solo pochi decenni, e nella seconda metà del secolo scoppiò la tragica guerra del Peloponneso, i vecchi ideali furono distrutti, Sparta tradì Atene ed entrò in un'alleanza con la Persia, nel 404 a.C. avviene un colpo di stato oligarchico, la democrazia ad Atene viene formalmente restaurata, ma nella seconda metà del IV secolo a.C. La Grecia diventa inevitabilmente una miserabile provincia che ha perso la sua indipendenza.
Sentendo il fallimento sia degli aristocratici che dei democratici, vedendo le violazioni della legge della giustizia da entrambe le parti, Socrate non poteva schierarsi dalla parte di nessuna delle classi ed evitava sia simpatie che antipatie socio-politiche. Gli antichi cinesi dicevano: “Dio ti proibisce di nascere in un’era di cambiamento”. Ma sono stati proprio questi periodi di transizione a creare i geni. Socrate fu uno dei primi, entrò nella filosofia e nella letteratura antica come un brillante interlocutore, un perspicace dibattitore e dialettico, un eterno studioso che traeva conoscenza anche da persone di scarso talento e scarsa istruzione, uno spirito ironico ma bonario, un amante della verità, che ha smascherato le falsità con le sue domande innocenti e la sua arroganza.
Quest'uomo è diventato l'intersezione di molte tendenze ideologiche. È a Socrate che dobbiamo l'apparizione del filosofo Platone. Platone, a sua volta, divenne il fondatore del platonismo, il maestro di Aristotele, e da queste forti radici sorsero molti rami filosofici: stoicismo, edonismo ed epicureismo, pitagorismo, scetticismo, Neoplatonismo, che determinò l'emergere della filosofia moderna.
Naturalmente, senza Socrate, la filosofia moderna non sarebbe quella che è. Idee filosofiche di Platone Lo sviluppo dell'antica filosofia greca prima di Socrate fu, in generale, la storia dell'emergere e dello sviluppo del materialismo - da Talete a Democrito.Lo stato delle cose cambiò con l'inizio del IV secolo. AVANTI CRISTO. Platone, con un talento raro nella storia del pensiero, crea la dottrina dell'idealismo oggettivo, che non è solo diretto contro le conquiste di pensatori e scienziati materialisti, ma anche e soprattutto utilizzato per giustificare un sistema di opinioni sociali e politiche reazionarie.
Platone spiega che oggetto di studio non è solo ciò che sembra bello, e non ciò che solo sembra essere bello, ma ciò che è veramente bello, cioè bello in sé, l'essenza della bellezza, non dipendente dall'accidentale, la sua temporaneità, mutevole e relative manifestazioni.
Dopo ulteriori discussioni si scopre che la questione non riguarda le cose belle in senso relativo, ma quella cosa incondizionatamente bella, che sola conferisce alle singole cose la qualità o la proprietà della bellezza. La descrizione più completa della "vista", o "idea", è stata sviluppata da Platone nel suo studio sull'essenza del bello. Secondo Platone, chiunque superi costantemente gli stadi della contemplazione del bello vedrà qualcosa di bello, sorprendente. in natura.
Il bello non apparirà a chi ne contempla la “idea” sotto forma di qualsiasi forma, o di mani, o di qualsiasi altra parte del corpo. La bellezza di Platone è una “visione” (“eidos”), o “idea”, nel senso specificamente platonico di questo concetto, cioè un essere realmente esistente, soprasensibile, compreso solo dalla ragione; in altre parole, il bello è la causa soprasensibile e l'esempio di tutte le cose chiamate belle nel mondo sensibile, la fonte incondizionata della loro realtà nella misura in cui ciò è loro possibile.
In questo senso Platone contrasta nettamente l'“idea” con tutte le sue somiglianze sensoriali e i suoi riflessi nel mondo delle cose che percepiamo, mentre al “tipo” o “idea” del bello, cioè il bello in sé, esso stesso, il bello realmente esistente, non è soggetto ad alcun cambiamento o trasformazione, è completamente identico ed è un'essenza eterna, sempre uguale a se stesso. In quanto “idea”, la bellezza è un'essenza non percepibile attraverso i sensi ed è addirittura brutta e informe.
Quindi, solo in un senso improprio e, per di più, estremamente impreciso, le definizioni di spazio, tempo e numero possono essere applicate alle “idee” di Platone. Nel senso stretto del termine, le "idee", come le intende Platone, sono completamente trascendentali, inesprimibili in qualsiasi immagine dell'esperienza sensoriale, in qualsiasi concetto e categoria di numero, spazio e tempo. In questa esistenza oggettiva, la bellezza è uno dei le “idee” più elevate. Ma la più alta, secondo Platone, l'“idea” è l'“idea” del bene.
L'insegnamento di Platone sull '"idea" del bene come "idea" più alta è estremamente importante per l'intero sistema della sua visione del mondo. Questo insegnamento conferisce alla filosofia di Platone il carattere non solo di idealismo oggettivo, ma anche di idealismo teleologico. La teleologia è la dottrina dell'opportunità: poiché, secondo Platone, l'“idea” del bene domina tutto, ciò significa, in altre parole, che l'ordine prevalente nel mondo è un ordine conveniente: tutto è diretto verso uno scopo buono. Ogni esistenza temporanea e relativa ha come meta un essere oggettivo.
Sforzandosi di possedere la bontà, l'anima si sforza di conoscere la bontà. Poiché il criterio di ogni bene relativo è il bene incondizionato, il più alto di tutti gli insegnamenti della filosofia è la dottrina dell '"idea" del bene. Solo quando è guidato dall’“idea” del bene il giusto diventa idoneo e utile”. Senza l’“idea” del bene tutta la conoscenza umana, anche la più completa, sarebbe completamente inutile.Quanto più acutamente Platone caratterizzava la natura ideale e soprasensibile delle “eidos”, o delle “idee”, tanto più difficile era per lui spiegare come la loro essenza soprasensibile possa essere oggetto della conoscenza umana.
Già comprendere l’“idea” di bellezza è un compito molto arduo. Infatti. Il bello come “idea” è eterno; le cose sensoriali, chiamate belle, sono transitorie: sorgono e periscono. Il bello è immutabile, le cose sensuali sono mutevoli. Il bello è identico, le cose sensuali esistono nel regno del non identico, l'altro. Il bello non dipende dalle definizioni e dalle condizioni dello spazio e del tempo, le cose sensuali esistono nello spazio, sorgono, cambiano e muoiono nel tempo.
Nella visione del mondo di Platone, un posto importante appartiene alle sue opinioni sulla società e sullo stato. Era estremamente interessato alla questione di come dovrebbe essere una comunità perfetta e di quale tipo di educazione le persone dovrebbero essere preparate per la creazione e il mantenimento di una tale comunità. Platone dedicò due delle sue opere più dettagliate a questioni socio-politiche: “Il Stato” e “Leggi”. Le forme imperfette esistenti di convivenza statale furono precedute, secondo Platone, nell'antichità, nell'epoca del regno di Crono, da una forma di convivenza perfetta.
In questa fase gli uomini erano liberi dall’obbligo di combattere la natura ed erano uniti da vincoli di amicizia, ma non è possibile prendere questo sistema come modello del miglior ordine possibile, le condizioni materiali dell’esistenza non lo consentono : il bisogno di autoconservazione, la lotta contro la natura e contro i popoli ostili.
Il tipo iniziale di vita comunitaria come tipo ideale fu rappresentato da Platone non solo nella Repubblica, ma anche nelle Leggi, dove descrisse le condizioni di vita delle persone che furono salvate sulle cime delle montagne durante il diluvio, che non erano più così idilliaco come nell'era di Chronos. Platone contrapponeva il tipo ideale a un tipo negativo di struttura sociale, in cui il principale motore del comportamento delle persone sono le preoccupazioni e gli incentivi materiali. Il tipo negativo di Stato appare in quattro forme: timocrazia, oligarchia, democrazia e tirannia.
Rispetto allo stato ideale, ciascuna di queste forme è un costante deterioramento o distorsione della forma ideale. Secondo Platone, la prima di queste forme negative ad emergere è stata la timocrazia, cioè il potere basato sul dominio di persone ambiziose: già con i primi segni di declino nascono la passione per l'arricchimento e il desiderio di acquisizione. Nella timocrazia si sono inizialmente conservate le caratteristiche di un sistema perfetto: qui i governanti sono onorati, i guerrieri sono liberi dal lavoro agricolo e artigianale e da ogni preoccupazione materiale, ecc. Inizia così il passaggio dalla timocrazia all'oligarchia – il dominio dei pochi sui maggioranza.
Questo è un governo basato sul censimento e sulla valutazione delle proprietà, in modo che i ricchi vi governino e i poveri non abbiano alcuna parte nel governo. In uno stato oligarchico non viene rispettata la legge fondamentale della vita sociale, secondo cui secondo Platone ogni membro della società “fa le sue cose” e, inoltre, “solo le sue cose”. Al contrario, in un'oligarchia, in primo luogo, una parte dei membri della società è impegnata in un'ampia varietà di attività: agricoltura, artigianato e guerra.
In secondo luogo, in un'oligarchia, il diritto di una persona alla vendita completa dei propri beni accumulati porta al fatto che tale persona si trasforma in un membro della società completamente inutile: non facendo parte dello Stato, è solo una persona povera e indifesa. dentro. L'ulteriore sviluppo dell'oligarchia porta, secondo Platone, al suo sviluppo coerente in una forma di governo ancora peggiore: la democrazia.
Questo è il potere e il governo della maggioranza, ma il governo in una società in cui l’opposizione tra ricchi e poveri è ancora più acuta che in un’oligarchia. Il crescente risentimento dei poveri contro i ricchi porta ad una ribellione. Se la rivolta si conclude con la vittoria dei poveri, allora una parte dei ricchi viene distrutta, l'altra parte viene espulsa e il potere statale e le funzioni gestionali vengono divisi tra tutti i restanti membri della società. Platone riconosceva la tirannia come la peggiore forma di deviazione dalla norma. sistema statale ideale.
Questo è il potere di uno su tutti nella società. Questo potere nasce, come le forme precedenti, come una degenerazione della precedente forma di governo democratica. Secondo Platone tutto ciò che viene fatto troppo viene ricompensato con un grande cambiamento nella direzione opposta. Pertanto, la tirannia deriva proprio dalla democrazia, così come la schiavitù più crudele deriva dalla libertà più alta: un tiranno, se vuole conservare il potere, sarà costretto a distruggere gradualmente i suoi condannatori, «finché non gli rimangano né amici né nemici da cui potrebbe aspettarsi qualcosa di qualsiasi utilità." Platone contrappone tutte le cattive forme di stato all'utopia, o al progetto di uno stato e di un governo migliori.
Questo Stato è guidato, come in un’oligarchia, da pochi. Ma, a differenza dell'oligarchia, questi pochi possono diventare solo persone veramente capaci di gestire bene lo Stato: in primo luogo, per inclinazioni e talenti naturali; in secondo luogo, a causa di molti anni di preparazione preliminare.
Platone considera la giustizia il principio fondamentale di un sistema di governo ideale. La giustizia assegna a ciascun cittadino dello Stato un'occupazione speciale e una posizione speciale. Il regno della giustizia unisce le diverse ed anche eterogenee parti dello Stato in un tutto improntato all'unità e all'armonia. Tale Stato, in primo luogo, deve avere la forza della propria organizzazione e i mezzi di protezione, sufficienti a contenere e respingere un ambiente ostile e, in secondo luogo, deve provvedere sistematicamente a fornire a tutti i membri della società i beni materiali di cui hanno bisogno; in terzo luogo, deve guidare e dirigere l'alto sviluppo dell'attività spirituale e della creatività.
L'adempimento di tutti questi compiti significherebbe l'attuazione dell'idea del bene come la più alta "idea” che governa il mondo. Nello stato di Platone, le funzioni e i tipi di lavoro necessari per la società nel suo insieme sono divisi in categorie speciali dei suoi cittadini, ma nel complesso formano una combinazione armoniosa.
Come base per la distribuzione dei cittadini in categorie, Platone ha preso la differenza tra singoli gruppi di persone in base alle loro inclinazioni e proprietà morali, ma considera questa differenza per analogia con la divisione del lavoro economico. Nella divisione del lavoro Platone vede il fondamento dell'intero sistema sociale e statale contemporaneo, esplora l'origine della specializzazione esistente nella società e la composizione dei rami della conseguente divisione del lavoro.
L'idea principale di Platone è che i bisogni dei cittadini che compongono la società sono diversi, ma la capacità di ciascun individuo di soddisfare questi bisogni è limitata. La posizione principale di Platone "è che è l'operaio a doversi adattare al lavoro e non il lavoro all'operaio" (Marx). Nella divisione del lavoro egli vede non solo la base della divisione della società in classi, ma anche la base fondamentale della divisione della società in classi. principio della struttura dello stato.In accordo con quanto sopra, la struttura razionale di uno stato perfetto, secondo Platone, dovrebbe basarsi principalmente sui bisogni.
L'enumerazione dei bisogni dimostra che in una città-stato devono esserci numerosi rami della divisione sociale del lavoro - non solo lavoratori che procurano cibo, costruttori di case, produttori di abbigliamento, ma anche lavoratori che producono strumenti e strumenti per tutti questi specialisti di cui hanno bisogno Oltre a loro, sono necessari anche produttori specializzati di tutti i tipi di lavori ausiliari, ad esempio allevatori di bestiame, fornitura di mezzi per il trasporto di persone e merci, estrazione di lana e cuoio. Il commercio richiede la specializzazione e l'attività degli intermediari nell'acquisto e nella vendita, nell'importazione e nell'esportazione.
La categoria dei commercianti si aggiunge così alle categorie già considerate di divisione del lavoro. Ma la complicazione della specializzazione non si limita a questo: il commercio via mare crea la necessità di diverse categorie di persone coinvolte nel trasporto delle merci. Per la piena attuazione della vita economica dello Stato, Platone ritiene inoltre necessario disporre di uno speciale categoria di lavoratori salariati in servizio che vendono il proprio lavoro dietro compenso.
Platone chiama tali “mercenari” coloro che vendono l’utilità della propria forza e chiama il suo prezzo salario: queste categorie di lavoro sociale specializzato esauriscono i lavoratori che producono i prodotti necessari allo Stato o che in un modo o nell’altro contribuiscono a questa produzione e al creazione dei valori di consumo da essa generati.
Questa è la classe o il grado più basso di cittadini nella gerarchia dello stato. Sopra di lui in Platone ci sono le classi superiori: guerrieri-guardie e governanti. Passando dalla classe dei lavoratori produttivi alla classe dei guerrieri-guardiani, colpisce che Platone violi il principio di divisione. Egli caratterizza le differenze tra le singole categorie della classe dei lavoratori produttori in base alle differenze nelle loro funzioni professionali, presupponendo che per quanto riguarda i tratti morali tutte queste categorie siano allo stesso livello: agricoltori, artigiani e commercianti.
Un'altra cosa sono le guardie-guerrieri e i filosofi-governanti. Per loro, la necessità di isolarsi dai gruppi di lavoratori al servizio dell’economia non si basa più sulle loro caratteristiche professionali, ma sulla differenza tra le loro qualità morali e le qualità morali dei lavoratori della produzione. Vale a dire: Platone pone le caratteristiche morali dei lavoratori agricoli inferiori alle virtù morali delle guardie di guerra e soprattutto inferiori a quelle dei governanti dello stato.Filosofia di Aristotele e Platone.
Aristotele (384-322 a.C.) fu allievo di Platone. Era motivato dall'amore per la verità, e in questo rimase fedele al suo maestro, anche se su altre questioni le loro opinioni divergevano.Prima di analizzare la radice delle differenze tra Platone e Aristotele, consideriamo, sulla base dell'analisi di un frammento dall'Etica Nicomachea, quanto Aristotele valorizzi la verità (ci basiamo sull'interpretazione di San Tommaso d'Aquino a questo frammento): “Sembra migliore, cioè più degno e conforme alla buona morale e del tutto necessario, che una persona non dovrebbe aver paura di confrontarsi con i suoi vicini per salvare la verità.
Infatti questo è così necessario per i buoni costumi che senza di esso non si può conservare la virtù: se infatti uno preferisse il prossimo alla verità, ne conseguirebbe che darebbe giudizi falsi e darebbe false testimonianze a protezione degli amici, ciò è contrario alla virtù. Da qui il detto di Platone: "Socrate è mio amico, ma la verità è la mia più grande amica. Ci si dovrebbe preoccupare poco di Socrate, ma molto della verità". Che la verità debba essere preferita agli amici è dimostrato da questo argomento: ciò che è un grande amico dovrebbe essere preferito.
Se proviamo sentimenti amichevoli per entrambi, ad es. alla verità e all'uomo, allora dobbiamo amare la verità più dell'uomo, perché dobbiamo amare l'uomo innanzitutto per amore della verità e della virtù, come si dirà nel libro ottavo. C'è anche qualcosa di divino nella verità, perché la verità è innanzitutto si trova in Dio, e da ciò Aristotele conclude che è sacro preferire la verità agli amici.
E l’Andronico peripatetico dice che la santità è ciò che rende gli uomini fedeli e attenti a ciò che appartiene a Dio”. Per quanto riguarda la differenza principale tra la filosofia di Aristotele e la filosofia di Platone, essa si manifesta in relazione al mondo terreno. Dal punto di vista di Platone, il nostro mondo è una grotta, cupa e oscura, e non c'è nulla di veramente buono in esso. Il bene è nel mondo delle idee. Dal punto di vista di Aristotele, al contrario, il nostro mondo è buono; il male è solo una deviazione dalla natura delle cose.
Sembrerebbe che Aristotele dovrebbe guardare alla società umana con ottimismo: dopotutto, secondo Aristotele, la maggior parte degli eventi che accadono in essa dovrebbero avvenire secondo natura, cioè secondo natura. Allo stesso modo, da Platone dovremmo aspettarci un completo pessimismo in relazione alla struttura sociale di questo mondo. Ma quando ci rivolgiamo agli insegnamenti di Aristotele e Platone sullo Stato, vediamo che tutto è diverso.
Nel suo insegnamento sociale, Aristotele è un pessimista: crede che poiché la virtù è la via di mezzo tra due vizi opposti (ad esempio, il coraggio è la via di mezzo tra l'incoscienza e la codardia), sia difficile da realizzare, per analogia con un arciere che la trova difficile colpire il centro del bersaglio. Al contrario, Platone coltivò il concetto di una società ideale, che delineò nei suoi dialoghi “Stato” e “Leggi” e che volle attuare sulla terra.Nell'ottavo libro dell'Etica Nicomachea, Aristotele scrive dell'amicizia e della ruolo dell'amicizia nel preservare le basi della società. “Il proverbio popolare Aristotele dice che gli amici hanno tutto in comune.
L'amicizia consiste dunque nella comunicazione e nel possesso congiunto." Tommaso d'Aquino commenta così queste parole di Aristotele: "Dimostra che l'amicizia differisce a seconda dei diversi tipi di comunicazione. E quindi, tra i rapporti amichevoli, alcuni sono più stretti, cioè tra coloro che hanno più cose in comune e alcune sono meno strette, ad es. tra coloro che comunicano in piccoli modi.
E da ciò è chiarissimo che se in qualche cosa non c'è comunicazione, non può esserci amicizia». Più avanti nei commenti di san Tommaso leggiamo del ruolo che Aristotele attribuiva all'amicizia nel preservare i fondamenti della società: «E dice che grazie all'amicizia, a quanto pare, gli stati si preservano, quindi i legislatori cercano più di preservare l'amicizia tra cittadini che addirittura di mantenere la giustizia, che a volte non viene osservata, ad esempio, per quanto riguarda l'imposizione delle punizioni, così che la discordia non si presenta.
E questo risulta evidente dal fatto che l’accordo è paragonato all’amicizia. I legislatori desiderano al massimo grado l’armonia e cercano di fermare la discordia tra i cittadini perché la discordia è nemica della conservazione della società e poiché ogni filosofia morale sembra mirare al bene comune, conviene alla filosofia morale riguardano anche l'amicizia." Notiamo come siano diverse le posizioni di Aristotele e del filosofo inglese del XV secolo Thomas Hobbes, e ancor più dei filosofi europei successivi.
Hobbes credeva che nella società regnasse una "guerra di tutti contro tutti", mentre Kant in Antropologia sostiene che l'inimicizia e la competizione tra le persone non solo non sono dannose, ma alla fine portano al progresso. Il tema dell'amicizia è così importante che continuiamo la presentazione delle opinioni di Aristotele sull'amicizia, utilizzando i commenti di San Tommaso d'Aquino: “E dice (Aristotele - I.L.) che l'amicizia è inerente anche alla natura di chi partorisce chi nasce.
E questo è vero non solo tra le persone, ma anche tra gli uccelli, che dedicano un tempo notevolmente lungo all'allevamento della prole. E lo stesso vale per gli altri animali: l'amicizia naturale è caratteristica anche di coloro che appartengono allo stesso genere. E l'amicizia che collega tutte le persone tra loro a causa della somiglianza della natura e delle specie è estremamente naturale. Ed è per questo che glorifichiamo i filantropi, ad es. coloro che amano le persone perché realizzano ciò che è inerente all'uomo per natura, il che è più evidente quando si sceglie un percorso. Perché ciascuno mette in guardia l'altro, anche l'estraneo e l'estraneo, dal fare una scelta sbagliata, come se ogni uomo fosse per natura vicino e amico di ogni uomo." Quanto questo sia in contrasto con le idee di Darwin sulla lotta per l'esistenza e la sopravvivenza del più adatto Quanto lontano dalle idee di Aristotele Nietzsche Pensiamo anche se il trasferimento della conoscenza scientifica di generazione in generazione sarebbe possibile se le persone fossero nemiche tra loro.
Forse l'ostilità reciproca è la ragione dell'arretratezza culturale di molte tribù e popoli? Nel libro “Etica Nicomachea” siamo attratti anche dall'interessante contrasto tra prudenza e saggezza.
Così S. commenta il frammento che ci interessa. Tommaso d'Aquino: “Quindi (Aristotele) dice, in primo luogo, che la prudenza si riferisce al bene umano, e la saggezza a ciò che è migliore dell'uomo; perciò la gente chiama Anassagora e un altro filosofo chiamato Talete, e altri come loro, saggi, ma irragionevoli , dovuto al fatto che le persone vedono di non sapere ciò che è utile a se stesse, e dicono di sapere inutile e sorprendente, come se superassero le idee umane ordinarie, e complesse, che richiedono un'attenta ricerca, e divine , a causa della nobiltà di La natura del conoscibile. Egli prende un esempio speciale dalla vita di Talete, così come da quella di Anassagora, perché di questo furono rimproverati soprattutto: quando Talete, una volta uscito di casa per osservare le stelle, cadde in uno stato di inquietudine. buca e gemette, e poi una certa vecchia gli disse: "Tu, Talete, non vedi ciò che è sotto i tuoi piedi, ma pensi di sapere cosa c'è nel cielo?" Anassagora, essendo nobile e ricco, distribuì il dono di suo padre eredità ai suoi parenti e si abbandonava a pensieri sui fenomeni naturali, senza preoccuparsi della politica: quindi fu condannato come una persona pigra e indifferente.
A chi gli chiedeva: “Non ti importa del destino della tua patria?” - ha risposto: "Sono molto preoccupato per il destino della mia patria, ma il cielo è soprattutto". Una serie di importanti problemi legati alla filosofia della scienza sono considerati da Aristotele nel suo libro "Politica". Innanzitutto soffermiamoci sulla tesi: “Se molte persone ignoranti scelgono e giudicano correttamente qualcosa, allora sarà una coincidenza casuale”. Così S. commenta questa posizione di Aristotele. Tommaso d'Aquino: "Ciò che riguarda il giudizio riguarda anche la scelta: cioè solo una persona informata può fare la scelta giusta e questo è affare suo, proprio come un geometra giudica correttamente le cose relative alla geometria. Se una persona ignorante prende la decisione giusta in qualcosa per scelta, quindi non come chi sa, ma per caso. I saggi non agiscono in questo modo. Da ciò Aristotele conclude che al popolo non dovrebbe essere dato il potere di eleggere e correggere le autorità, perché la maggior parte delle persone sono ignoranti e irragionevoli. " Qui troviamo la risposta alla domanda perché Aristotele non era un utopista in politica.
Ciò è ulteriormente chiarito da altre due tesi aristoteliche: 1. “La politica non rifa le persone, ma le accetta come la natura le ha create e le usa come tali”. 2. “È facile commettere un errore, ma è difficile fare la cosa giusta”. Lasciarsi guidare da questi due principi è il miglior rimedio contro ogni utopia.
Tommaso d'Aquino così spiega la seconda tesi nei suoi commenti: «Come la salute e la bellezza si verificano in un solo modo, e la malattia e la bruttezza in molti modi, anzi in un numero infinito di modi, così la correttezza di un'azione si ottiene in un modo e nell'altro. unico modo, e l'errore in azione - in un numero infinito di modi.
E perciò è facile peccare: perché lo si può fare in molti modi.
È difficile agire correttamente, perché esiste un solo modo per agire correttamente." Aristotele apprezzava così tanto la virtù che considerava possibile persino morire per amore della virtù: "Il filosofo (cioè Aristotele - I.L.) dice che Tommaso d'Aquino scrive nei suoi commenti che al defunto per amore della virtù rimarrà la gloria postuma, perché perseverare coraggiosamente nel bene della virtù è un bene tale che la lunga vita che una persona perde quando muore non può essere paragonata ad essa. un'importante osservazione sulla prudenza: «La prudenza non riguarda solo le cose generali, ma anche le cose private, perché i giovani diventano geometri e matematici, e in essi diventano sapienti, cioè raggiungere la perfezione in tali scienze; ma allo stesso tempo non si può definire prudente il giovane.
La ragione di ciò è che la prudenza ha per oggetto l'individuo, che conosciamo attraverso l'esperienza.
Un giovane non può essere esperto, perché ci vuole molto tempo per acquisire esperienza." Qualche parola sul legame tra l'etica aristotelica e quella cristiana.
Tommaso d'Aquino considerava l'etica aristotelica, con le sue quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, moderazione e coraggio, come la base dell'etica cristiana, con le sue tre virtù teologali aggiuntive: fede, speranza e amore. Per quanto riguarda la cosmologia di Aristotele, è esposta nel libro “Sul cielo”. Come abbiamo già detto, Aristotele considerava la terra sferica.
Secondo Aristotele il centro della terra coincide con il centro del mondo. Il mondo o universo secondo Aristotele è una sfera. Il confine di questa sfera è la sfera delle stelle fisse (come tutti gli antichi, Aristotele credeva che tutte le stelle fisse fossero equidistanti dalla terra). Aristotele ha anche diviso il mondo in sopralunare e sublunare. Il mondo sublunare, secondo Aristotele, è costituito da quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Questi elementi corrispondono a certe combinazioni di qualità fondamentali: freddo, caldo, secco, umido, cioè terra - fredda, secca; acqua: fredda, bagnata; aria: calda, umida; fuoco: caldo, secco.
Il mondo superlunare è costituito dal quinto elemento: l'etere. Nel mondo sublunare avvengono le interconversioni degli elementi e le loro mescolanze; il mondo superlunare è immutabile ed eterno. Il confine dei due mondi, secondo Aristotele, è la sfera della Luna. Il Sole e ciascuno dei cinque pianeti conosciuti nell'antichità hanno sfere: Saturno, Giove, Marte, Venere, Mercurio.La Terra, secondo Aristotele, è immobile.
Pertanto, la cosmologia aristotelica era il Sig.
Cosa faremo con il materiale ricevuto:
Se questo materiale ti è stato utile puoi salvarlo sulla tua pagina sui social network:
soggetto:
"FILOSOFIA ANTICA: principali problemi, concetti e scuole"
introduzione
1 Scuola milesia e scuola di Pitagora. Eraclito e gli Eleati. Atomisti
2 Scuole di Socrate, Sofisti e Platone
3 Aristotele
4 Filosofia del primo ellenismo (stoicismo, epicureismo, scetticismo)
5 Neoplatonismo
Conclusione
Elenco della letteratura usata
introduzione
La maggior parte dei ricercatori è unanime sul fatto che la filosofia come fenomeno integrale della cultura è la creazione del genio degli antichi greci (VII-VI secolo aC). Già nelle poesie di Omero ed Esiodo vengono fatti tentativi impressionanti di immaginare il mondo e il posto dell'uomo in esso. L'obiettivo desiderato viene raggiunto principalmente attraverso i mezzi caratteristici dell'arte (immagini artistiche) e della religione (credenza negli dei).
La filosofia ha integrato miti e religioni rafforzando le motivazioni razionali e sviluppando l'interesse per il pensiero razionale sistematico basato su concetti. Inizialmente, la formazione della filosofia nel mondo greco fu facilitata dalle libertà politiche raggiunte dai greci nelle città-stato. I filosofi, il cui numero aumentò e la cui attività divenne sempre più professionale, poterono resistere alle autorità politiche e religiose. Fu nel mondo greco antico che la filosofia si costituì per la prima volta come entità culturale indipendente, esistente accanto all'arte e alla religione, e non come una componente di esse.
La filosofia antica si sviluppò durante i secoli XII-XIII, a partire dal VII secolo. AVANTI CRISTO. al VI secolo ANNO DOMINI Storicamente, la filosofia antica può essere divisa in cinque periodi:
1) il periodo naturalistico, dove l'attenzione principale era rivolta ai problemi della natura (fusis) e del Cosmo (milesiani, pitagorici, eleatici, insomma presocratici);
2) il periodo umanistico con la sua attenzione ai problemi umani, principalmente ai problemi etici (Socrate, Sofisti);
3) il periodo classico con i suoi grandiosi sistemi filosofici di Platone e Aristotele;
4) il periodo delle scuole ellenistiche (stoici, epicurei, scettici), impegnate nello sviluppo morale delle persone;
5) Il neoplatonismo, con la sua sintesi universale, portava all'idea dell'Unico Bene.
Il lavoro presentato esamina i concetti di base e le scuole della filosofia antica.
1 Scuola filosofica milesiana e scuola di Pitagora. Eraclito e gli Eleati. Atomisti.
Una delle scuole filosofiche più antiche è considerata Mileto (VII-V secolo a.C.). Pensatori della città di Mileto (antica Grecia) - Talete, Anassimene e Anassimandro.
Tutti e tre i pensatori hanno compiuto passi decisivi verso la demitizzazione dell'antica visione del mondo. "Di cosa è fatto tutto?" - questa è la domanda che interessava in primo luogo i milesiani. La formulazione stessa della domanda è a suo modo ingegnosa, perché ha come premessa la convinzione che tutto può essere spiegato, ma per questo è necessario trovare un'unica fonte per tutto. Talete considerava l'acqua una tale fonte, Anassimene - aria, Anassimandro - un principio illimitato ed eterno, apeiron (il termine "apeiron" significa letteralmente "illimitato"). Le cose nascono come risultato di quelle trasformazioni che avvengono con la materia primaria: condensazioni, rarefazione, evaporazione. Secondo i Milesi alla base di tutto c'è una sostanza primaria. La sostanza, per definizione, è qualcosa che non ha bisogno di altro per la sua spiegazione. L'acqua di Talete, l'aria di Anassimene sono sostanze.
Per valutare le opinioni dei Milesi, passiamo alla scienza. Postulato dai Milesi I Milesi non riuscirono ad andare oltre il mondo degli eventi e dei fenomeni, ma tentarono di farlo, e nella giusta direzione. Cercavano qualcosa di naturale, ma lo immaginavano come un evento.
Scuola di Pitagora. Anche Pitagora si occupa del problema delle sostanze, ma fuoco, terra e acqua non gli si addicono più come tali. Giunge alla conclusione che “tutto è un numero”. I Pitagorici vedevano nei numeri le proprietà e le relazioni inerenti alle combinazioni armoniche. Ai Pitagorici non sfuggiva il fatto che se le lunghezze delle corde di uno strumento musicale (monocordo) sono messe in relazione tra loro come 1:2, 2:3, 3:4, allora gli intervalli musicali risultanti corrisponderanno a quelli che vengono chiamati ottava, quinta e quarta. Semplici relazioni numeriche iniziarono ad essere ricercate in geometria e astronomia. Pitagora, e prima di lui Talete, apparentemente usarono le dimostrazioni matematiche più semplici, che, molto probabilmente, furono prese in prestito dall'Oriente (in Babilonia). L'invenzione delle dimostrazioni matematiche è stata cruciale per lo sviluppo del tipo di razionalità caratteristico dell'uomo civilizzato moderno.
Nel valutare il significato filosofico delle opinioni di Pitagora, si dovrebbe rendere omaggio alla sua intuizione. Da un punto di vista filosofico, il richiamo al fenomeno dei numeri era di particolare importanza. I Pitagorici spiegavano gli eventi sulla base dei numeri e delle loro relazioni e in tal modo superarono i Milesiani, poiché arrivavano quasi al livello delle leggi della scienza. Qualsiasi assolutizzazione dei numeri, così come dei loro modelli, è una rinascita dei limiti storici del pitagorismo. Ciò vale pienamente per la magia dei numeri, alla quale, va detto, i pitagorici rendevano omaggio con tutta la generosità di un'anima entusiasta.
Infine, una menzione speciale va fatta alla ricerca dei Pitagorici dell’armonia in ogni cosa, della bella coerenza quantitativa. Tale ricerca è in realtà finalizzata alla scoperta di leggi, e questo è uno dei compiti scientifici più difficili. Gli antichi greci amavano moltissimo l'armonia, la ammiravano e sapevano crearla nella loro vita.
Eraclito e gli Eleati. L'ulteriore sviluppo del pensiero filosofico è presentato in modo più convincente nel noto confronto tra gli insegnamenti di Eraclito di Efeso e Parmenide e Zenone di Ele.
Entrambe le parti concordano sul fatto che i sensi esterni non sono in grado di fornire da soli la vera conoscenza; la verità si raggiunge attraverso la riflessione. Eraclito crede che il mondo sia governato dal logos. L’idea dei loghi può essere considerata una comprensione ingenua della legge. Nello specifico intendeva dire che tutto nel mondo è costituito da opposti, opposizione, tutto avviene attraverso la discordia, la lotta. Di conseguenza tutto cambia, scorre; in senso figurato, non puoi entrare due volte nello stesso fiume. Nella lotta degli opposti si rivela la loro identità interiore. Ad esempio, "la vita di alcuni è la morte di altri" e, in generale, la vita è morte. Poiché tutto è interconnesso, ogni proprietà è relativa: “gli asini preferirebbero la paglia all’oro”. Eraclito si fida ancora eccessivamente del mondo degli eventi, che determina sia i lati deboli che quelli forti delle sue opinioni. Da un lato, nota, anche se in forma ingenua, le proprietà più importanti del mondo degli eventi: la loro interazione, coerenza, relatività. D'altra parte, non sa ancora come analizzare il mondo degli eventi dalle posizioni caratteristiche di uno scienziato, ad es. con prove e concetti. Il mondo per Eraclito è il fuoco, e il fuoco è un'immagine di movimento e cambiamento eterni.
La filosofia eraclitea dell'identità degli opposti e delle contraddizioni fu aspramente criticata dagli Eleatici. Parmenide considerava quindi quelle persone per le quali “essere” e “non essere” sono considerati la stessa cosa e non la stessa cosa, e per ogni cosa c'è una via di ritorno (questa è una chiara allusione a Eraclito), “a due teste. "
Gli Eleatici prestarono particolare attenzione al problema della molteplicità; a questo proposito inventarono una serie di paradossi (aporie), che ancora oggi causano grattacapi a filosofi, fisici e matematici. Un paradosso è un'affermazione inaspettata, un'aporia è una difficoltà, uno smarrimento, un problema intrattabile.
Secondo gli Eleati la pluralità non può essere concepita malgrado le impressioni sensoriali. Se le cose possono essere infinitesimali, la loro somma non darà in alcun modo qualcosa di finito, una cosa finita. Se le cose sono finite, allora tra le due cose finite ce n'è sempre una terza; arriviamo di nuovo a una contraddizione, perché una cosa finita consiste in un numero infinito di cose finite, il che è impossibile. Non solo la molteplicità è impossibile, ma anche il movimento. L’argomento della “dicotomia” (divisione in due) dimostra: per percorrere un certo cammino bisogna prima percorrerne la metà, e per percorrerlo bisogna percorrere un quarto e poi un ottavo. del percorso, e così via all'infinito. Si scopre che è impossibile arrivare da un dato punto a quello più vicino, perché in realtà non esiste. Se il movimento è impossibile, il veloce Achille non potrà raggiungere la tartaruga e dovrà ammettere che la freccia volante non vola.
Quindi Eraclito è interessato, prima di tutto, al cambiamento e al movimento, alle loro origini, alle ragioni che vede nella lotta degli opposti. Gli Eleatici si preoccupano principalmente di come capire, come interpretare ciò che tutti considerano cambiamento e movimento. Secondo il pensiero eleatico, la mancanza di una spiegazione coerente della natura del movimento mette in dubbio la sua realtà.
Atomisti. La crisi provocata dalle aporie di Zenone fu molto profonda; per superarlo almeno in parte erano necessarie alcune idee speciali e insolite. Ci riuscirono gli antichi atomisti, tra i quali i più importanti furono Leucippo e Democrito.
Per eliminare una volta per tutte la difficoltà di comprendere il cambiamento, si è ipotizzato che gli atomi siano immutabili, indivisibili e omogenei. Gli atomisti, per così dire, “riducono” il cambiamento all’immutabile, agli atomi.
Secondo Democrito esistono gli atomi e il vuoto. Gli atomi differiscono per forma, posizione e peso. Gli atomi si muovono in direzioni diverse. Terra, acqua, aria, fuoco sono i gruppi primari di atomi. Combinazioni di atomi formano interi mondi: nello spazio infinito ci sono infiniti mondi. Naturalmente anche l'uomo è un insieme di atomi. L'anima umana è composta da atomi speciali. Tutto avviene secondo necessità, non esiste il caso.
2. Fasi di sviluppo. I principali problemi e scuole di filosofia antica.
Fasi di sviluppo.
Molti eminenti filosofi scrivono sulla periodizzazione della filosofia antica, come A.N. Chanyshev. (Corso di lezioni di filosofia antica, M., 1981), Smirnov I.N., Titov V.F. (“Filosofia”, M., 1996), Asmus V.F. (Storia della filosofia antica M., 1965), Bogomolov A.S. (“Filosofia antica”, Università statale di Mosca, 1985). Per comodità di analisi, è necessario utilizzare una periodizzazione più concisa presentata da I.N. Smirnov. Pertanto, osserva che quando si analizza la filosofia greca, si distinguono tre periodi: il primo - da Talete ad Aristotele, il secondo - la filosofia greca nel mondo romano e, infine, il terzo - la filosofia neoplatonica.
La storia della filosofia greca rappresenta un'immagine individuale generale e allo stesso tempo vivente dello sviluppo spirituale in generale. Il primo periodo, secondo gli interessi prevalenti in esso, può essere chiamato filosofico cosmologico, etico-politico ed etico-religioso. Assolutamente tutti i filosofi-scienziati notano che questo periodo di sviluppo della filosofia antica fu il periodo della filosofia naturale. Una caratteristica peculiare della filosofia antica era la connessione dei suoi insegnamenti con gli insegnamenti della natura, da cui successivamente si svilupparono scienze indipendenti: astronomia, fisica, biologia. Nei secoli VI e V. AVANTI CRISTO. la filosofia non esisteva ancora separatamente dalla conoscenza della natura, e la conoscenza della natura separatamente dalla filosofia. Speculazione cosmologica del VII e VI secolo a.C. pone la questione del fondamento ultimo delle cose. Appare così il concetto di unità del mondo, che si oppone alla moltitudine di fenomeni e attraverso il quale si cerca di spiegare la connessione di questa moltitudine e diversità, così come il modello che si manifesta principalmente nei processi cosmici più generali, nel cambiamento di giorno e notte, nel movimento delle stelle. La forma più semplice è il concetto di un'unica sostanza mondiale, dalla quale nascono le cose in eterno movimento e nella quale si trasformano nuovamente.
Il secondo periodo della filosofia greca (V-VI secolo aC) inizia con la formulazione di problemi antropologici. Il pensiero filosofico naturale raggiunse limiti oltre i quali allora non poteva andare. Questo periodo è rappresentato dai Sofisti, Socrate e dai Socratici. Nella sua attività filosofica, Socrate era guidato da due principi formulati dagli oracoli: "la necessità che tutti conoscano se stessi e il fatto che nessuno sa nulla con certezza e solo un vero saggio sa di non sapere nulla". Socrate conclude il periodo filosofico naturale nella storia dell'antica filosofia greca e inizia una nuova fase associata alle attività di Platone e Aristotele. Platone va ben oltre i confini dello spirito socratico. Platone è un idealista oggettivo cosciente e coerente. Fu il primo tra i filosofi a porre la questione principale della filosofia, la questione del rapporto tra spirito e materia. A rigor di termini, si può parlare con un grado significativo di certezza della filosofia nell'antica Grecia solo a partire da Platone.
Il terzo periodo della filosofia antica è l'età dell'ellenismo. Ciò include gli stoici, gli epicurei e gli scettici. Comprende il periodo del primo ellenismo (III-I secolo a.C.) e il periodo del tardo ellenismo (I-V secolo d.C.). La cultura del primo ellenismo era caratterizzata principalmente dall'individualismo, condizionato dalla liberazione della personalità umana dalla dipendenza politica, economica e morale dalla polis. L'oggetto principale della ricerca filosofica è il mondo soggettivo dell'individuo. Durante il periodo del tardo ellenismo, le principali tendenze nello sviluppo del pensiero filosofico antico furono portate alla loro logica conclusione. C'è stato, per così dire, un ritorno alle idee dei classici, ai suoi insegnamenti filosofici sull'essere (neopitagorismo, neoplatonismo), ma un ritorno arricchito dalla conoscenza del mondo soggettivo dell'individuo. L'interazione con le culture orientali nel quadro dell'Impero Romano unito portò il pensiero filosofico a un parziale allontanamento dal razionalismo e ad una svolta verso il misticismo. La filosofia del tardo ellenismo, liberandosi dal libero pensiero del primo ellenismo, seguì la via della comprensione sacra, cioè religiosa, del mondo.
Problemi di filosofia antica.
La problematica complessiva della filosofia antica può essere tematicamente definita come segue: la cosmologia (filosofi naturali), nel suo contesto, la totalità del reale era vista come “physis” (natura) e come cosmos (ordine), la questione principale è: “ Come è nato il cosmo?”; la moralità (sofisti) era il tema determinante nella conoscenza dell'uomo e delle sue capacità specifiche; la metafisica (Platone) dichiara l'esistenza della realtà intelligibile, afferma che la realtà e l'esistenza sono eterogenee e il mondo delle idee è superiore a quello sensoriale; la metodologia (Platone, Aristotele) sviluppa i problemi della genesi e della natura della conoscenza, mentre il metodo della ricerca razionale è inteso come espressione delle regole del pensiero adeguato; l'estetica si sta sviluppando come una sfera di risoluzione del problema dell'arte e della bellezza in sé; le problematiche della filosofia proto-aristotelica possono essere raggruppate come una gerarchia di problemi generalizzanti: fisica (ontologia-teologia-fisica-cosmologia), logica (epistemologia), etica; e alla fine dell'era della filosofia antica si formano problemi mistico-religiosi, caratteristici del periodo cristiano della filosofia greca.
Va notato che, in linea con l'antica capacità di percepire filosoficamente questo mondo, il pensiero filosofico teorico sembra essere il più importante per il successivo sviluppo della conoscenza filosofica. Almeno, la dottrina della filosofia come vita ha subito oggi un cambiamento significativo: la filosofia non è più solo vita, ma proprio vita nella conoscenza. Naturalmente mantengono il loro significato anche elementi di filosofia pratica che sviluppano le idee dell'antica filosofia pratica: idee di etica, politica, retorica, teoria dello Stato e del diritto. Pertanto, è la teoria che può essere considerata la scoperta filosofica dell'antichità che ha determinato non solo il pensiero dell'uomo moderno, ma anche la sua vita. E senza dubbio, l '"influenza inversa" dei meccanismi cognitivi generati dall'antica coscienza greca ha avuto un impatto molto forte sulla struttura stessa della vita cosciente di una persona. In questo senso, se la teoria come principio di organizzazione della conoscenza e i suoi risultati sono completamente verificati, allora il suo effetto “inverso” come principio inverso di organizzazione della coscienza non è ancora del tutto chiaro.
Scuole di filosofia antica.
Secondo gli storici romani, nell'antica Grecia c'erano 288 insegnamenti filosofici, tra cui, oltre alle grandi scuole filosofiche, spiccano gli insegnamenti dei filosofi cinici e cirenei. C'erano quattro grandi scuole ad Atene: l'Accademia di Platone, il Liceo di Aristotele, il Portico (scuola stoica) e il Giardino (scuola epicurea).
La scuola ionica (o milesiana, a seconda del luogo di provenienza) è la più antica scuola filosofica naturale. Secondo AN Chanyshev, “la filosofia ionica è proto-filosofia. È anche caratterizzato dall'assenza di polarizzazione in materialismo e idealismo..., dalla presenza di molte immagini della mitologia, da elementi significativi di antropomorfismo, panteismo, dall'assenza di una terminologia filosofica adeguata, dalla presentazione dei processi fisici nel contesto di questioni morali .” Ma la filosofia ionica è già filosofia nel senso fondamentale del termine, perché già i suoi primi creatori - Talete, Anassimandro, Anassimene - cercavano di comprendere questo o quel principio come una sostanza (acqua, aria, fuoco, ecc.). La loro origine è sempre una (in questo senso i filosofi ionici sono monisti), è materiale, ma anche ragionevole, addirittura divina. Ciascuno dei filosofi ha identificato uno degli elementi come questo inizio. Talete è il fondatore della scuola milesia, o ionica, la prima scuola filosofica. Fu uno dei fondatori della filosofia e della matematica, il primo a formulare teoremi geometrici, e studiò l'astronomia e la geometria dai sacerdoti egiziani. Talete divenne il fondatore della filosofia naturale e ne formulò i due problemi principali: l'inizio e l'universale. Considerava l'inizio come l'acqua su cui poggia la terra, e considerava il mondo pieno di dei e animato. Anche Talete divise l'anno in 365 giorni. Eraclito diceva che tutto nasce dal fuoco attraverso la rarefazione e la condensazione e si brucia dopo determinati periodi. Il fuoco simboleggia la lotta degli opposti nello spazio e il suo movimento costante. Eraclito introdusse anche il concetto di Logos (Parola) - il principio di unità razionale, che ordina il mondo da principi opposti. Il Logos governa il mondo e il mondo può essere conosciuto solo attraverso di esso. Anassimandro (610 - ca. 540 a.C.) considerava l'inizio di tutto la natura infinita, qualcosa tra i quattro elementi. Ha detto che la creazione e la distruzione dei mondi è un processo ciclico eterno. Anassimene (morto nel 525 a.C.), allievo di Anassimandro, considerava l'aria il primo principio. Quando l’aria si assottiglia diventa fuoco; quando si addensa diventa vento, acqua e terra. Anassagora, allievo di Anassimene, introdusse il concetto di Nous (Mente), organizzando il cosmo a partire da una mescolanza di elementi disordinati. Alla scuola ionica è associata l'origine dei fondamenti dell'astronomia, della matematica, della geografia, della fisica, della biologia e di altre scienze.
Indipendentemente da questi antichi Ioni dell'Asia Minore, nelle colonie greche dell'Italia inferiore apparvero pensatori imbevuti della stessa idea di unità del mondo. Questi includono, prima di tutto, Pitagora e i suoi studenti, che esplorarono il mondo intero. Notarono, prima di tutto, la correttezza nel movimento dei corpi celesti e da essi cercarono di trasferire questa correttezza ai fenomeni terreni, fenomeni del mondo fisico e morale. La scuola pitagorica fu fondata da Pitagora a Crotone (Italia meridionale) ed esistette fino all'inizio del IV secolo. a.C., anche se la persecuzione iniziò quasi subito dopo la morte di Pitagora nel 500 a.C. Si trattava essenzialmente di una confraternita aristocratica religiosa e filosofica; esercitò una grande influenza sulle città-stato greche dell'Italia meridionale e della Sicilia. L'unione si distingueva per costumi rigorosi e alta moralità. Tuttavia, sia l’apparenza che il comportamento erano solo una conseguenza delle opinioni dei filosofi sull’anima umana e sulla sua immortalità, che implicavano una certa educazione in questa vita terrena. La scuola pitagorica pose le basi per le scienze matematiche. I numeri erano intesi come l'essenza di tutto ciò che esiste; ad essi veniva dato un significato mistico. La base della matematica pitagorica è la dottrina della decade: 1+2+3+4=10. Questi quattro numeri descrivono tutti i processi che si verificano nel mondo. Consideravano l’ordine mondiale come la regola dei numeri; e in questo senso trasferiscono al mondo, «nel suo insieme, il concetto di cosmo, che originariamente significava ordine, decorazione». Se ti poni la domanda sull'orientamento filosofico di Pitagora, allora sembra che possiamo dire con assoluta certezza che si trattava principalmente di una filosofia del numero, in questo differiva nettamente dalla filosofia naturale ionica, che cercava di ridurre tutto ciò che esiste all’uno o all’altro elemento materiale, sottolineandone l’originalità qualitativa (acqua, aria, fuoco, terra).”
I Pitagorici appartengono alla dottrina della musica delle sfere e della scala musicale, che riflette l'armonia del sistema solare, dove ogni pianeta corrisponde ad una certa nota, e insieme creano intervalli della scala musicale. Gettarono anche le basi per la psicologia musicale: la musica era usata come mezzo per educare e curare l'anima e il corpo. L'astronomia e la medicina iniziarono a svilupparsi nella scuola pitagorica. Ha creato molti commenti allegorici su Omero, nonché una grammatica della lingua greca. Pertanto, i Pitagorici possono essere considerati i fondatori delle scienze umanistiche, naturali, esatte e sistematiche.
La scuola eleatica è il nome dato all'antica scuola filosofica greca, i cui insegnamenti si svilupparono a partire dalla fine del VI secolo. fino all'inizio della seconda metà del V secolo. AVANTI CRISTO. con i maggiori filosofi: Parmenide, Zenone e Melisso. I primi due - Parmenide e Zenone - vivevano nella piccola città italiana di Elea, e il terzo - Melisso - era originario di Samo, lontano da Elea. Ma poiché gli insegnamenti principali della scuola furono sviluppati da Parmenide e Zenone, cittadini della città di Elea, la scuola nel suo insieme ricevette il nome Eleatica. E se i Pitagorici consideravano l'ordine mondiale esclusivamente dal suo lato quantitativo, allora in contrasto con loro nel VI secolo emersero tendenze che, come gli antichi pensatori ionici, comprendevano qualitativamente l'idea dell'unità del mondo, tuttavia vedevano l'unità del mondo non in un'unica sostanza mondiale, ma in un unico principio dominante del mondo, in un unico concetto che domina il cambiamento di tutti i fenomeni. Per gli Eleati questo concetto è l’essere, che rimane costante nonostante cambino le cose.
L'emergere della scuola sofista fu una risposta al bisogno di democrazia nell'educazione e nella scienza. Gli insegnanti viaggianti potevano insegnare a chiunque l'arte della parola in cambio di denaro. Il loro obiettivo principale era preparare i giovani alla vita politica attiva. L'attività dei sofisti, che relativizzavano ogni verità, segnò l'inizio della ricerca di nuove forme di attendibilità della conoscenza, che potessero resistere al tribunale della riflessione critica. Questa ricerca fu continuata dal grande filosofo ateniese Socrate (470 circa - 399 a.C.), prima allievo dei sofisti e poi loro critico. La differenza tra Socrate e i sofisti è che il criterio per valutare le azioni per lui è la considerazione di quali motivi determinano la decisione di ciò che è utile e di ciò che è dannoso. I pensieri di Socrate servirono come base per lo sviluppo della maggior parte delle scuole filosofiche successive, fondate dai suoi studenti, inclusa l'Accademia di Platone. Ha spiegato l'essenza della sua filosofia in una frase: "So solo una cosa, che non so nulla". Nelle sue conversazioni, Socrate non risponde alle domande, le pone, incoraggiando artificialmente l'interlocutore a cercare autonomamente la verità. E quando sembra esserle vicino, trova nuovi argomenti e argomentazioni per dimostrare l'inutilità di questi tentativi. Il principale interesse filosofico di Socrate si concentra sulla questione di cosa sia una persona, cosa sia la coscienza umana. “Conosci te stesso” è il detto preferito di Socrate.
Platone unì nel suo insegnamento i valori dei suoi due grandi predecessori: Pitagora e Socrate. Dai Pitagorici adottò l'arte della matematica e l'idea di creare una scuola filosofica, che incarnò nella sua Accademia ad Atene. Gli studenti di Platone erano principalmente “eleganti giovani gentiluomini” provenienti da famiglie aristocratiche (si può ricordare almeno il suo allievo più famoso, Aristotele). Per le lezioni, in un angolo pittoresco della periferia nord-occidentale della città, fu costruita un'Accademia. La famosa scuola filosofica esistette fino alla fine dell'antichità, fino al 529, quando l'imperatore bizantino Giustiniano la chiuse. Anche se Platone, come Socrate, credeva che far pagare la saggezza non fosse meglio che far pagare l’amore, e, come lui, chiamava i sofisti “prostitute della filosofia” perché chiedevano denaro ai loro studenti, ciò non impediva a Platone di accettare ricchi doni e tutti i tipi di aiuto da parte dei poteri costituiti. Da Socrate Platone apprese il dubbio, l'ironia e l'arte della conversazione. I dialoghi di Platone suscitano interesse e insegnano a riflettere su problemi molto seri della vita, che non sono cambiati molto in duemila anni e mezzo. Le idee più significative nella filosofia di Platone sono le idee sulle Idee, sulla Giustizia e sullo Stato. Ha cercato di combinare il filosofico e il politico. Nella sua scuola formò governanti filosofi capaci di governare equamente, basandosi sui principi del bene comune.
Nel 335 a.C. Aristotele, uno studente di Platone, fondò la sua scuola: il Liceo, o Peripatos, che si distingueva per il suo orientamento esclusivamente filosofico. Tuttavia, è difficile sintetizzare il sistema coerente di Aristotele a partire dalle sue opere, che spesso sono raccolte di conferenze e corsi. Uno dei risultati più importanti dell'attività politica di Aristotele fu l'educazione di Alessandro Magno. Dalle rovine del Grande Impero sorsero stati ellenistici e nuovi filosofi.
Se i precedenti insegnamenti etici vedevano nella sua inclusione nell'insieme sociale il principale mezzo di miglioramento morale dell'individuo, ora, al contrario, i filosofi considerano la liberazione di una persona dal potere del mondo esterno, e soprattutto dal potere politico- sfera sociale, come condizione per una vita virtuosa e felice. Questo è, in larga misura, l'atteggiamento della scuola stoica. Questa scuola, fondata da Zenone alla fine del IV sec. aC, esisteva durante l'Impero Romano. La filosofia per gli stoici non è solo scienza, ma, soprattutto, via della vita, saggezza della vita. Solo la filosofia è in grado di insegnare a una persona a mantenere l'autocontrollo e la dignità nella difficile situazione sorta in epoca ellenistica, soprattutto nel tardo impero romano, dove il decadimento della morale raggiunse il suo culmine nei primi secoli della nuova era . Gli stoici considerano la libertà dal potere del mondo esterno su una persona la virtù principale di un saggio; La sua forza sta nel fatto che non è schiavo delle proprie passioni. Un vero saggio, secondo gli stoici, non ha paura nemmeno della morte; È dagli stoici che viene la comprensione della filosofia come scienza della morte. L'idea principale dello stoicismo è la sottomissione al destino e alla fatalità di tutte le cose. Zenone ha detto questo dello stoico: "Vivi coerentemente, cioè secondo un'unica e armoniosa regola di vita, perché coloro che vivono incoerentemente sono infelici". Per uno stoico, la natura è destino o destino: fare pace con il destino, non resistergli: questo è uno dei comandamenti di Seneca.
Un completo rifiuto dell'attivismo sociale in etica si trova nel famoso materialista Epicuro (341-270 aC). Il più famoso degli epicurei romani fu Lucrezio Caro (99-55 d.C. circa). L’individuo, e non l’insieme sociale, è il punto di partenza dell’etica epicurea. Epicuro rivede così la definizione di uomo data da Aristotele. L'individuo è primario; tutte le connessioni sociali, tutte le relazioni umane dipendono dagli individui, dai loro desideri soggettivi e dalle considerazioni razionali di beneficio e piacere. L'unione sociale, secondo Epicuro, non è il fine supremo, ma solo un mezzo per il benessere personale degli individui; a questo punto Epicuro risulta essere vicino ai sofisti. Nel 306 a.C. ad Atene fondò una scuola. A differenza dell’etica stoica, l’etica epicurea è edonistica: Epicuro considerava la felicità, intesa come piacere, lo scopo della vita umana. Tuttavia, Epicuro non vedeva affatto il vero piacere nell'indulgere in rozzi piaceri sensuali senza alcuna misura. Come la maggior parte dei saggi greci, era devoto all'ideale della moderazione. Il piacere più alto, come gli stoici, era considerato l'equanimità dello spirito (atarassia), la pace della mente e la serenità, e tale stato può essere raggiunto solo se una persona impara a moderare le proprie passioni e desideri carnali, subordinandoli alla ragione. Gli epicurei prestano particolare attenzione alla lotta contro le superstizioni, inclusa la religione tradizionale greca.
Un appello al misticismo. La filosofia del tardo ellenismo, liberandosi dal libero pensiero del primo ellenismo, seguì la via del sacro, cioè del sacro. comprensione religiosa del mondo. CARATTERISTICHE DELLA FILOSOFIA ANTICA 1. Genesi della filosofia: il passaggio dal mito al logos Il passaggio da una società tribale socialmente omogenea a una società socialmente differenziata ha portato a un cambiamento nel modo di pensare. ...
In decomposizione è l'elemento materiale dell'esistenza. E questa è una brillante ascesa del pensiero a un livello fondamentalmente nuovo di comprensione filosofica dell'esistenza. Capitolo 3. L'emergere e le caratteristiche del sofismo 3.1 Sofismo e filosofia dei sofisti Nel V secolo. AVANTI CRISTO e. in molte città della Grecia, il potere politico dell'antica aristocrazia e tirannia fu sostituito dal potere della democrazia proprietaria di schiavi. Sviluppo del suo creato...
Gli antichi greci sorsero nel VI-VII secolo. AVANTI CRISTO. Ha contribuito con un ruolo eccezionale allo sviluppo della civiltà mondiale. Grazie alla filosofia antica, alla cultura e alla civiltà europea, sorsero la filosofia occidentale e le sue scuole successive. Fino ad ora, la scienza, la cultura e la filosofia europee stanno ritornando alla filosofia antica come fonte primaria e modo di pensare.
Il termine stesso "filosofo" è nato in contrasto con "sophos" - un saggio profeta che possiede la saggezza divina. Il “filosofo” è una persona che non possiede la verità divina, completa e completa. Un filosofo è una persona che ama la verità e si impegna per la saggezza:
L'obiettivo del filosofo è comprendere qual è la causa principale di tutto ciò che esiste, la causa principale dell'essere; comprendere il mondo utilizzando la ragione, l'argomentazione, la logica, l'esperienza. È necessario spiegare il mondo nel suo insieme, evitando i miti e la fede nelle fantasie, come fanno l'arte e la religione.
I greci credevano che l'inizio della filosofia risiedesse nella sorpresa dell'uomo di fronte al mondo e a se stesso. Filosofare è caratteristico dell'umanità; non è solo un processo di ricerca della verità, ma anche uno stile di vita insito in un individuo libero.
La filosofia antica si sviluppò per fasi e si possono distinguere i seguenti periodi:
I primi classici (naturalisti, presocratici) spiegavano i fenomeni naturali, l'essenza del cosmo, il mondo circostante e la ricerca dell'origine di tutte le cose.
Filosofia antica proporre una serie di idee e problemi, che sono attuali ancora oggi.
Problemi di esistenza e non esistenza, la materia e le sue forme: l'idea dell'opposizione di forma e materia, degli elementi principali, dell'identità e dell'opposizione di essere e non essere, della struttura dell'essere e della sua incoerenza; come è nato il Cosmo e qual è la sua struttura. (Talete, Anassimandro, Anassimene, Zenone, Democrito).
Il problema di una persona, la sua conoscenza, i suoi rapporti con altre persone: qual è l'essenza della moralità, il rapporto tra l'uomo e lo Stato, esiste la verità assoluta ed è realizzabile dalla mente umana (Socrate, Antifonte, Epicuro).
Il problema della volontà umana e della libertà: Con questi concetti si identificava l'idea dell'insignificanza dell'uomo davanti alle forze della natura e della sua forza di spirito nel desiderio di libertà, di conoscenza, di felicità di una persona libera. (Seneca, Epitteto).
Il problema del rapporto tra l'uomo e Dio, la volontà divina, la struttura del Cosmo. Le idee del Cosmo e dell'essere, la struttura della materia, dell'anima, della società furono proposte come compenetranti l'una con l'altra (Plotino, Filone d'Alessandria, ecc.)
Il problema del sensuale e del soprasensibile- l'idea di problemi filosofici di base sintetici. Il problema di trovare un metodo razionale di conoscenza (Platone, Aristotele e studenti).
La filosofia antica ha le seguenti caratteristiche: la base materiale per il fiorire della filosofia era la fioritura economica delle città-stato greche. I pensatori erano indipendenti dalla produzione, liberati dal lavoro fisico e affermavano di essere la guida spirituale della società.
L'idea principale della filosofia antica era il cosmocentrismo, che nelle fasi successive fu mescolato con l'antropocentrismo. Era consentita l'esistenza di dei vicini all'uomo. L'uomo è stato riconosciuto come parte della natura.
Nella filosofia antica furono stabilite due direzioni filosofiche: idealistica (gli insegnamenti di Platone) e materialistica - (la linea di Democrito) .