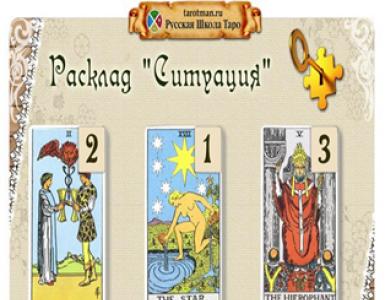Malattie mentali nei bambini di 4 anni. Come non perdere un disturbo mentale in un bambino e cosa fare in questi casi. Trattamento dei problemi mentali nei bambini
Tempo di lettura: 3 minuti
I disturbi mentali nei bambini sorgono a causa di fattori speciali che provocano disturbi dello sviluppo della psiche del bambino. La salute mentale dei bambini è così vulnerabile che le manifestazioni cliniche e la loro reversibilità dipendono dall'età del bambino e dalla durata dell'esposizione a fattori speciali.
La decisione di consultare un bambino con uno psicoterapeuta di solito non è facile per i genitori. Nella comprensione dei genitori, ciò significa riconoscere il sospetto che il bambino abbia disturbi neuropsichiatrici. Molti adulti hanno paura di iscrivere i propri figli, così come le forme limitate di istruzione ad essa associate e la scelta limitata della professione futura. Per questo motivo, i genitori spesso cercano di non notare le caratteristiche comportamentali, lo sviluppo e le stranezze, che di solito sono manifestazioni di disturbi mentali nei bambini.
Se i genitori sono inclini a credere che il bambino debba essere curato, prima, di regola, vengono fatti tentativi per trattare i disturbi neuropsichiatrici utilizzando rimedi casalinghi o consigli di guaritori familiari. Dopo tentativi indipendenti infruttuosi di migliorare le condizioni della prole, i genitori decidono di cercare un aiuto qualificato. Quando si rivolgono per la prima volta a uno psichiatra o uno psicoterapeuta, i genitori spesso cercano di farlo in modo anonimo e non ufficiale.
Gli adulti responsabili non dovrebbero nascondersi dai problemi e, quando riconoscono i primi segni di disturbi neuropsichiatrici nei bambini, consultare immediatamente un medico e seguire le sue raccomandazioni. Ogni genitore dovrebbe avere le conoscenze necessarie nel campo dei disturbi nevrotici per prevenire deviazioni nello sviluppo del proprio figlio e, se necessario, cercare aiuto ai primi segni di un disturbo, poiché anche le questioni legate alla salute mentale dei bambini sono serio. È inaccettabile sperimentare il trattamento da soli, quindi è necessario contattare tempestivamente gli specialisti per un consiglio.
Spesso i genitori attribuiscono i disturbi mentali nei bambini all'età, il che implica che il bambino è ancora piccolo e non capisce cosa gli sta succedendo. Questa condizione è spesso percepita come una manifestazione comune di capricci, ma gli esperti moderni sostengono che i disturbi mentali sono molto evidenti ad occhio nudo. Spesso queste deviazioni hanno un impatto negativo sulle capacità sociali e sullo sviluppo del bambino. Se si cerca aiuto tempestivamente, alcuni disturbi possono essere completamente curati. Se vengono rilevati sintomi sospetti in un bambino nelle fasi iniziali, è possibile prevenire gravi conseguenze.
I disturbi mentali nei bambini sono divisi in 4 classi:
- ritardi nello sviluppo;
- prima infanzia;
- disturbo dell'attenzione.
Cause di disturbi mentali nei bambini
La comparsa di disturbi mentali può essere causata da vari motivi. I medici affermano che il loro sviluppo può essere influenzato da vari fattori: psicologici, biologici, sociopsicologici.
I fattori provocatori sono: predisposizione genetica alla malattia mentale, incompatibilità nel tipo di temperamento di genitore e figlio, intelligenza limitata, danno cerebrale, problemi familiari, conflitti, eventi traumatici. L’educazione familiare non è la meno importante.
I disturbi mentali nei bambini in età scolare spesso insorgono a causa del divorzio dei genitori. Il rischio di disturbi mentali spesso aumenta nei bambini provenienti da famiglie monoparentali o se uno dei genitori ha una storia di malattia mentale. Per determinare quale tipo di aiuto deve essere fornito al tuo bambino, devi determinare con precisione la causa del problema.
Sintomi di disturbi mentali nei bambini
Questi disturbi in un bambino vengono diagnosticati sulla base dei seguenti sintomi:
- tic, sindrome ossessiva;
- ignorare le regole stabilite;
- senza motivo apparente, cambia spesso umore;
- diminuzione dell'interesse per i giochi attivi;
- movimenti del corpo lenti e insoliti;
- deviazioni associate al pensiero compromesso;
I periodi di maggiore suscettibilità ai disturbi mentali e nervosi si verificano durante le crisi legate all'età, che coprono i seguenti periodi di età: 3-4 anni, 5-7 anni, 12-18 anni. Da ciò è ovvio che l'adolescenza e l'infanzia sono il momento giusto per lo sviluppo della psicogenicità.
I disturbi mentali nei bambini di età inferiore a un anno sono causati dall'esistenza di una gamma limitata di bisogni (segnali) negativi e positivi che i bambini devono soddisfare: dolore, fame, sonno, necessità di far fronte ai bisogni naturali.
Tutti questi bisogni sono di vitale importanza e non possono essere insoddisfatti, quindi, quanto più pedanti i genitori osservano il regime, tanto più velocemente si sviluppa uno stereotipo positivo. Il mancato soddisfacimento di uno dei bisogni può portare a una causa psicogena, e quanto più si notano violazioni, tanto più grave è la privazione. In altre parole, la reazione di un bambino di età inferiore a un anno è determinata dai motivi di soddisfazione degli istinti e, ovviamente, prima di tutto, questo è l'istinto di autoconservazione.
I disturbi mentali nei bambini di 2 anni si osservano se la madre mantiene un legame eccessivo con il bambino, favorendo così l'infantilizzazione e l'inibizione del suo sviluppo. Tali tentativi da parte del genitore, creando ostacoli all'autoaffermazione del bambino, possono portare alla frustrazione, nonché a reazioni psicogene elementari. Mentre persiste il sentimento di eccessiva dipendenza dalla madre, si sviluppa la passività del bambino. Con ulteriore stress, tale comportamento può assumere un carattere patologico, cosa che spesso accade nei bambini insicuri e paurosi.
I disturbi mentali nei bambini di 3 anni si manifestano con capricciosità, disobbedienza, vulnerabilità, aumento dell'affaticamento e irritabilità. È necessario fare attenzione quando si reprime l'attività crescente di un bambino all'età di 3 anni, poiché ciò può contribuire alla mancanza di comunicazione e alla mancanza di contatto emotivo. La mancanza di contatto emotivo può portare a (ritiro) disturbi del linguaggio (ritardo nello sviluppo del linguaggio, rifiuto di comunicare o di contatto verbale).
I disturbi mentali nei bambini di 4 anni si manifestano con testardaggine, protesta contro l'autorità degli adulti e crolli psicogeni. Si notano anche tensione interna, disagio e sensibilità alla privazione (restrizione), che causa.
Le prime manifestazioni nevrotiche nei bambini di 4 anni si riscontrano nelle reazioni comportamentali di rifiuto e protesta. Sono sufficienti piccoli influssi negativi per sconvolgere l’equilibrio mentale del bambino. Il bambino è in grado di reagire a situazioni patologiche ed eventi negativi.
I disturbi mentali nei bambini di 5 anni si rivelano superiori rispetto allo sviluppo mentale dei loro coetanei, soprattutto se gli interessi del bambino diventano unilaterali. Il motivo per chiedere aiuto a uno psichiatra dovrebbe essere la perdita delle capacità precedentemente acquisite da parte del bambino, ad esempio: guida le macchine senza meta, il suo vocabolario si impoverisce, diventa disordinato, smette di giocare a giochi di ruolo e comunica poco.
I disturbi mentali nei bambini di 7 anni sono associati alla preparazione e all'ingresso a scuola. Instabilità dell'equilibrio mentale, fragilità del sistema nervoso, predisposizione ai disturbi psicogeni possono essere presenti nei bambini di 7 anni. Alla base di queste manifestazioni c'è la tendenza all'astenia psicosomatica (disturbi dell'appetito, disturbi del sonno, affaticamento, vertigini, diminuzione delle prestazioni, tendenza alla paura) e al superlavoro.
Le lezioni a scuola diventano poi causa di nevrosi quando le esigenze poste al bambino non corrispondono alle sue capacità e lui resta indietro nelle materie scolastiche.
I disturbi mentali nei bambini di età compresa tra 12 e 18 anni si manifestano nelle seguenti caratteristiche:
Tendenza a sbalzi d'umore improvvisi, irrequietezza, malinconia, ansia, negativismo, impulsività, conflittualità, aggressività, incoerenza dei sentimenti;
Sensibilità alla valutazione degli altri della propria forza, aspetto, capacità, capacità, eccessiva fiducia in se stessi, eccessiva criticità, disprezzo per i giudizi degli adulti;
Una combinazione di sensibilità con insensibilità, irritabilità con timidezza dolorosa, desiderio di riconoscimento con indipendenza;
Rifiuto delle regole generalmente accettate e divinizzazione di idoli casuali, nonché fantasia sensuale con filosofare secco;
Schizoide e cicloide;
Il desiderio di generalizzazioni filosofiche, una tendenza a posizioni estreme, contraddizioni interne nella psiche, egocentrismo del pensiero giovanile, incertezza nel livello delle aspirazioni, tendenza a teorizzare, massimalismo nelle valutazioni, una varietà di esperienze associate al risveglio del desiderio sessuale;
Intolleranza alle cure, sbalzi d'umore immotivati.
Spesso la protesta degli adolescenti si trasforma in un'assurda opposizione e insensata testardaggine a qualsiasi consiglio ragionevole. Si sviluppano fiducia in se stessi e arroganza.
Segni di disturbo mentale nei bambini
La probabilità di sviluppare disturbi mentali nei bambini varia a seconda dell'età. Considerando che lo sviluppo mentale nei bambini non è uniforme, in certi periodi diventa disarmonico: alcune funzioni si formano più velocemente di altre.
Segni di disturbo mentale nei bambini possono manifestarsi nelle seguenti manifestazioni:
Sentimenti di ritiro e profonda tristezza che durano più di 2-3 settimane;
Tentativi di uccidere o farsi del male;
Paura divorante senza motivo, accompagnata da respiro rapido e battito cardiaco forte;
Partecipazione a numerosi combattimenti, uso di armi con il desiderio di ferire qualcuno;
Comportamento incontrollabile e violento che causa danni a sé stessi e agli altri;
Non mangiare, usare lassativi o buttare via il cibo per perdere peso;
Grave ansia che interferisce con le normali attività;
Difficoltà di concentrazione, nonché incapacità di stare fermi, che rappresenta un pericolo fisico;
Uso di alcol o droghe;
Gravi sbalzi d’umore che portano a problemi relazionali;
Cambiamenti nel comportamento.
È difficile stabilire una diagnosi accurata basandosi solo su questi segni, quindi i genitori dovrebbero contattare uno psicoterapeuta se scoprono le manifestazioni di cui sopra. Questi segni non devono necessariamente comparire nei bambini con disturbi mentali.
Trattamento dei problemi mentali nei bambini
Per aiuto nella scelta di un metodo di trattamento, dovresti contattare uno psichiatra infantile o uno psicoterapeuta. La maggior parte dei disturbi richiede un trattamento a lungo termine. Per il trattamento dei pazienti giovani vengono utilizzati gli stessi farmaci degli adulti, ma in dosi più piccole.
Come trattare i disturbi mentali nei bambini? Nel trattamento sono efficaci antipsicotici, farmaci ansiolitici, antidepressivi, vari stimolanti e stabilizzatori dell'umore. Di grande importanza: l'attenzione e l'amore dei genitori. I genitori non dovrebbero ignorare i primi segni di disturbi che si sviluppano in un bambino.
Se nel comportamento di un bambino compaiono sintomi incomprensibili, puoi ottenere consigli su questioni preoccupanti dagli psicologi infantili.
Dottore del Centro medico e psicologico "PsychoMed"
Le informazioni presentate in questo articolo sono intese solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza professionale e l'assistenza medica qualificata. Al minimo sospetto di un disturbo mentale in un bambino, assicurati di consultare un medico!
Il concetto di disturbo mentale nei bambini può essere piuttosto difficile da spiegare, per non parlare di definirlo, soprattutto da soli. La conoscenza dei genitori di solito non è sufficiente per questo. Di conseguenza, molti bambini che potrebbero trarre beneficio dalle cure non ricevono l’aiuto di cui hanno bisogno. Questo articolo aiuterà i genitori a imparare a identificare i segnali di allarme della malattia mentale nei bambini e ad evidenziare alcune opzioni di aiuto.
Perché è difficile per i genitori determinare lo stato d'animo del proprio figlio?
Sfortunatamente, molti adulti non sono consapevoli dei segni e dei sintomi della malattia mentale nei bambini. Anche se i genitori conoscono i principi di base per riconoscere i disturbi mentali gravi, spesso hanno difficoltà a riconoscere lievi segni di comportamento anomalo nei loro figli. E il bambino a volte non ha abbastanza vocabolario o bagaglio intellettuale per spiegare verbalmente i suoi problemi.
Le preoccupazioni circa gli stereotipi associati alla malattia mentale, il costo dell'uso di determinati farmaci e la complessità logistica del possibile trattamento spesso ritardano il trattamento o costringono i genitori ad attribuire la condizione del proprio bambino a qualche fenomeno semplice e temporaneo. Tuttavia, un disturbo psicopatologico che sta iniziando a svilupparsi non può essere frenato se non da un trattamento adeguato e, soprattutto, tempestivo.
Il concetto di disturbo mentale, la sua manifestazione nei bambini
I bambini possono soffrire delle stesse malattie mentali degli adulti, ma le manifestano in modi diversi. Ad esempio, i bambini depressi mostrano spesso più segni di irritabilità rispetto agli adulti, che tendono ad essere più tristi.
I bambini soffrono molto spesso di una serie di malattie, inclusi disturbi mentali acuti o cronici:
I bambini che soffrono di disturbi d'ansia come il disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo da stress post-traumatico, la fobia sociale e il disturbo d'ansia generalizzato mostrano forti segni di ansia, che è un problema persistente che interferisce con le loro attività quotidiane.
A volte l'ansia è una parte tradizionale dell'esperienza di ogni bambino, spesso passando da uno stadio di sviluppo a quello successivo. Tuttavia, quando lo stress assume un ruolo attivo, diventa difficile per il bambino. È in questi casi che è indicato il trattamento sintomatico.
- Disturbo da deficit di attenzione o iperattività.
Questo disturbo comprende tipicamente tre categorie di sintomi: difficoltà di concentrazione, iperattività e comportamento impulsivo. Alcuni bambini affetti da questa condizione presentano sintomi di tutte le categorie, mentre altri possono presentare un solo segno.
Questa patologia è un grave disturbo dello sviluppo che si manifesta nella prima infanzia, di solito prima dei 3 anni. Sebbene i sintomi e la loro gravità siano soggetti a cambiamenti, il disturbo influisce sempre sulla capacità del bambino di comunicare e interagire con gli altri.
- Problemi alimentari.
I disturbi alimentari, come l'anoressia e la gola, sono malattie piuttosto gravi che minacciano la vita di un bambino. I bambini possono diventare così preoccupati per il cibo e per il loro peso da impedire loro di concentrarsi su qualsiasi altra cosa.
- Disturbi dell'umore.
Disturbi affettivi come depressione e depressione possono portare a sentimenti persistenti di tristezza o sbalzi d'umore molto più gravi della solita variabilità comune a molte persone.
- Schizofrenia.
Questa malattia mentale cronica fa sì che il bambino perda il contatto con la realtà. La schizofrenia compare più spesso nella tarda adolescenza, a partire dai 20 anni circa.
A seconda delle condizioni del bambino, le malattie possono essere classificate come disturbi mentali temporanei o permanenti.
Principali segni di malattia mentale nei bambini

Alcuni indicatori che indicano che un bambino potrebbe avere problemi di salute mentale sono:
Cambiamenti di umore. Cerca segni dominanti di tristezza o malinconia che durino per almeno due settimane, o gravi sbalzi d'umore che causano problemi nelle relazioni a casa o a scuola.
Emozioni troppo forti. Emozioni acute di paura travolgente senza motivo, a volte combinate con tachicardia o respiro accelerato, sono un motivo serio per prestare attenzione a tuo figlio.
Comportamento insolito. Ciò può includere cambiamenti improvvisi nel comportamento o nell’immagine di sé, nonché azioni pericolose o fuori controllo. Anche i frequenti litigi con l'uso di oggetti di terze parti, un forte desiderio di fare del male agli altri sono segnali di allarme.
Difficoltà di concentrazione. La manifestazione caratteristica di tali segni è molto chiaramente visibile al momento della preparazione dei compiti. Vale anche la pena prestare attenzione alle lamentele degli insegnanti e al rendimento scolastico attuale.
Perdita di peso inspiegabile. La perdita improvvisa di appetito, il vomito frequente o l'uso di lassativi possono indicare un disturbo alimentare;
Sintomi fisici. Rispetto agli adulti, i bambini con problemi di salute mentale possono spesso lamentare mal di testa e dolori di stomaco piuttosto che tristezza o ansia.
Danno fisico. A volte le condizioni di salute mentale portano all’autolesionismo, chiamato anche autolesionismo. I bambini spesso scelgono metodi disumani per questi scopi: spesso si tagliano o si danno fuoco. Questi bambini spesso sviluppano anche pensieri suicidi e tentano di suicidarsi effettivamente.
Abuso di sostanze. Alcuni bambini usano droghe o alcol per cercare di affrontare i propri sentimenti.
Azioni dei genitori se si sospetta che un bambino abbia disturbi mentali
Se i genitori sono veramente preoccupati per la salute mentale dei propri figli, dovrebbero contattare un professionista il prima possibile.
Il medico dovrebbe descrivere il comportamento attuale in dettaglio, concentrandosi sulle discrepanze più evidenti con il periodo precedente. Per ulteriori informazioni, prima di visitare un medico, si consiglia di parlare con gli insegnanti della scuola, l'insegnante di classe, gli amici intimi o altre persone che trascorrono molto tempo con il bambino. Di norma, questo approccio è molto utile per prendere una decisione e scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa che un bambino non mostrerebbe mai a casa. Dobbiamo ricordare che non dovrebbero esserci segreti per il medico. Eppure, non esiste una panacea sotto forma di compresse.
Azioni generali degli specialisti

Le condizioni di salute mentale nei bambini vengono diagnosticate e trattate sulla base di segni e sintomi, tenendo conto dell'impatto dei problemi di salute psicologica o mentale sulla vita quotidiana del bambino. Questo approccio ci consente anche di determinare i tipi di disturbi mentali del bambino. Non esistono test positivi semplici, unici o garantiti al 100%. Per fare una diagnosi, il medico può raccomandare la presenza di professionisti correlati, come uno psichiatra, uno psicologo, un assistente sociale, un infermiere psichiatrico, un educatore della salute mentale o un terapista comportamentale.
Il medico o altri professionisti lavoreranno con il bambino, solitamente su base individuale, per determinare innanzitutto se il bambino è veramente anormale in base a criteri diagnostici o meno. Per fare un confronto, vengono utilizzati database speciali di sintomi psicologici e mentali infantili, utilizzati da specialisti di tutto il mondo.
Inoltre, il medico o altro operatore di salute mentale cercherà altre possibili ragioni per spiegare il comportamento del bambino, come una storia di malattie o traumi precedenti, inclusa la storia familiare.
Vale la pena notare che diagnosticare i disturbi mentali infantili può essere piuttosto difficile, poiché esprimere correttamente le proprie emozioni e sentimenti può essere una sfida seria per i bambini. Inoltre, questa qualità varia sempre da bambino a bambino: non esistono bambini identici a questo riguardo. Nonostante queste sfide, una diagnosi accurata è parte integrante di un trattamento adeguato ed efficace.
Approcci terapeutici generali
Le opzioni di trattamento comuni per i bambini che hanno problemi di salute mentale includono:
- Psicoterapia.
La psicoterapia, nota anche come “terapia della parola” o terapia comportamentale, è un modo per trattare molti problemi di salute mentale. Parlando con uno psicologo, mostrando emozioni e sentimenti, il bambino ti permette di guardare nel profondo delle sue esperienze. Durante la psicoterapia, i bambini stessi imparano molto sulla loro condizione, umore, sentimenti, pensieri e comportamenti. La psicoterapia può aiutare un bambino a imparare a rispondere a situazioni difficili affrontando in modo sano le barriere problematiche.
- Terapia farmacologica.
- Combinazione di approcci.
Nel processo di ricerca dei problemi e delle relative soluzioni, gli stessi specialisti offriranno l'opzione terapeutica necessaria e più efficace. In alcuni casi, le sessioni di psicoterapia saranno sufficienti, in altri sarà impossibile fare a meno dei farmaci.
Vale la pena notare che i disturbi mentali acuti sono sempre più facili da trattare rispetto a quelli cronici.
Aiuto dei genitori
In questi momenti, il bambino ha più che mai bisogno del sostegno dei suoi genitori. I bambini con diagnosi di salute mentale, proprio come i loro genitori, in genere provano sentimenti di impotenza, rabbia e frustrazione. Chiedi consiglio al medico di tuo figlio su come cambiare il modo in cui interagisci con tuo figlio o tua figlia e su come affrontare comportamenti difficili.
Cerca modi per rilassarti e divertirti con tuo figlio. Complimenta i suoi punti di forza e le sue capacità. Esplora nuove tecniche che possono aiutarti a capire come rispondere con calma alle situazioni stressanti.

La consulenza familiare o i gruppi di sostegno possono essere di grande aiuto nel trattamento dei disturbi mentali infantili. Questo approccio è molto importante per genitori e figli. Questo ti aiuterà a comprendere la malattia di tuo figlio, i suoi sentimenti e cosa potete fare insieme per fornire il massimo aiuto e supporto.
Per aiutare tuo figlio ad avere successo a scuola, mantieni gli insegnanti e i funzionari scolastici informati sulla salute mentale di tuo figlio. Sfortunatamente, in alcuni casi, potresti dover cambiare il tuo istituto scolastico in una scuola il cui curriculum è progettato per bambini con problemi mentali.
Se sei preoccupato per la salute mentale di tuo figlio, chiedi una consulenza professionale. Nessuno può prendere una decisione per te. Non evitare l'aiuto perché ti vergogni o hai paura. Con il giusto supporto, puoi scoprire la verità sulla disabilità di tuo figlio ed esplorare le opzioni terapeutiche, garantendo così che tuo figlio continui ad avere una qualità di vita dignitosa.
Dipartimento della Salute della Regione di Tyumen
Istituzione medica e preventiva statale della regione di Tyumen
"Ospedale psichiatrico clinico regionale di Tyumen"
Istituzione educativa statale di istruzione professionale superiore "Tyumen Medical Academy"
Manifestazioni precoci di malattia mentale
nei bambini e negli adolescenti
psicologi medici
Tjumen' - 2010
Manifestazioni precoci di malattia mentale nei bambini e negli adolescenti: raccomandazioni metodologiche. Tjumen'. 2010.
Rodyashin E.V. Medico capo del GLPU TO TOKPB
Raeva TV Testa Dipartimento di Psichiatria, Dottore in Medicina. Scienze dell'istituto scolastico statale di istruzione professionale superiore "Tyumen Medical Academy"
Fomuskina M.G. Capo psichiatra infantile freelance del dipartimento sanitario della regione di Tyumen
Le raccomandazioni metodologiche forniscono una breve descrizione delle manifestazioni precoci dei principali disturbi mentali e dei disturbi dello sviluppo mentale nell'infanzia e nell'adolescenza. Il manuale può essere utilizzato da pediatri, neurologi, psicologi clinici e altri specialisti in “medicina infantile” per stabilire diagnosi preliminari di disturbi mentali, poiché stabilire una diagnosi definitiva è responsabilità di uno psichiatra.
introduzione
Neuropatia
Disturbi ipercinetici
Azioni abituali patologiche
Paure infantili
Fantasia patologica
Nevrosi d'organo: balbuzie, tic, enuresi, encopresi
Disturbi del sonno nevrotico
Disturbi dell’appetito nevrotico (anoressia)
Sottosviluppo mentale
Infantilismo mentale
Abilità scolastiche compromesse
Umore ridotto (depressione)
Partire e vagare
Atteggiamento doloroso verso un difetto fisico immaginario
Anoressia nervosa
Sindrome dell'autismo della prima infanzia
Conclusione
Bibliografia
Applicazione
Schema di esame patopsicologico di un bambino
Diagnosi delle paure nei bambini
introduzione
La salute mentale dei bambini e degli adolescenti è importante per garantire e sostenere lo sviluppo sostenibile di qualsiasi società. Allo stato attuale, l'efficacia della fornitura di assistenza psichiatrica alla popolazione infantile è determinata dall'individuazione tempestiva dei disturbi mentali. Quanto prima i bambini con disturbi mentali vengono identificati e ricevono un'adeguata assistenza medica, psicologica e pedagogica, tanto maggiore è la probabilità di un buon adattamento scolastico e minore è il rischio di comportamenti disadattivi.
Un'analisi dell'incidenza dei disturbi mentali nei bambini e negli adolescenti che vivono nella regione di Tyumen (senza distretti autonomi) negli ultimi cinque anni ha dimostrato che la diagnosi precoce di questa patologia non è ben organizzata. Inoltre, nella nostra società permane il timore sia del contatto diretto con un servizio psichiatrico sia della possibile condanna degli altri, portando i genitori a evitare attivamente la consultazione di uno psichiatra per il proprio figlio, anche quando è innegabilmente necessaria. La diagnosi tardiva dei disturbi mentali nella popolazione infantile e l'inizio prematuro del trattamento portano alla rapida progressione della malattia mentale e alla disabilità precoce dei pazienti. È necessario aumentare il livello di conoscenza di pediatri, neurologi e psicologi medici nel campo delle principali manifestazioni cliniche delle malattie mentali nei bambini e negli adolescenti, poiché se compaiono anomalie nella salute (somatica o mentale) di un bambino, i suoi rappresentanti legali si rivolgono innanzitutto a questi specialisti per chiedere aiuto.
Un compito importante del servizio psichiatrico è la prevenzione attiva dei disturbi neuropsichiatrici nei bambini. Dovrebbe iniziare dal periodo perinatale. L'identificazione dei fattori di rischio durante la raccolta dell'anamnesi di una donna incinta e dei suoi parenti è molto importante per determinare la probabilità di disturbi neuropsichiatrici nei neonati (onere ereditario delle malattie somatiche e neuropsichiatriche nelle famiglie, età dell'uomo e della donna al momento del concepimento , la presenza di cattive abitudini, caratteristiche del corso della gravidanza, ecc.). Le infezioni trasmesse in utero dal feto si manifestano nel periodo postnatale come encefalopatia perinatale di origine ipossico-ischemica con vari gradi di danno al sistema nervoso centrale. Come risultato di questo processo, possono verificarsi disturbi da deficit di attenzione e iperattività.
Nel corso della vita di un bambino ci sono i cosiddetti “periodi critici di vulnerabilità legata all’età”, durante i quali l’equilibrio strutturale, fisiologico e mentale del corpo viene interrotto. È durante tali periodi, se esposti a qualsiasi agente negativo, che aumenta il rischio di disturbi mentali nei bambini, così come, in presenza di una malattia mentale, il suo decorso più grave. Il primo periodo critico sono le prime settimane di vita intrauterina, il secondo periodo critico sono i primi 6 mesi dopo la nascita, poi da 2 a 4 anni, da 7 a 8 anni, da 12 a 15 anni. Le tossine e altri pericoli che colpiscono il feto nel primo periodo critico spesso causano gravi anomalie congenite dello sviluppo, inclusa una grave displasia cerebrale. Le malattie mentali, come la schizofrenia e l'epilessia, che si manifestano tra i 2 ei 4 anni, sono caratterizzate da un decorso maligno con rapido collasso della psiche. Esiste una preferenza per lo sviluppo di condizioni psicopatologiche specifiche legate all'età ad una certa età del bambino.
Manifestazioni precoci della malattia mentale nei bambini e negli adolescenti
Neuropatia
La neuropatia è una sindrome di “nervosismo” congenito infantile che si manifesta prima dei tre anni. Le prime manifestazioni di questa sindrome possono essere diagnosticate già nell'infanzia sotto forma di disturbi somatovegetativi: inversione del sonno (sonnolenza diurna e frequenti risvegli e irrequietezza notturna), frequenti rigurgiti, sbalzi termici fino al subfebbrile, iperidrosi. Pianti frequenti e prolungati, aumento del malumore e del pianto si notano con qualsiasi cambiamento nella situazione, cambiamento nel regime, condizioni di cura o collocamento del bambino in un istituto per bambini. Un sintomo abbastanza comune è il cosiddetto “arrotolarsi”, quando ad uno stimolo psicogeno si verifica una reazione di insoddisfazione, associata a risentimento e accompagnata da un pianto, che porta ad un attacco affettivo-respiratorio: al culmine dell'espirazione, il tonico si verifica la tensione dei muscoli della laringe, la respirazione si ferma, il viso diventa pallido, quindi appare l'acrocianosi. La durata di questo stato è di diverse decine di secondi e termina con un respiro profondo.
I bambini affetti da neuropatia hanno spesso una maggiore tendenza a reazioni allergiche, infezioni e raffreddori. Se le manifestazioni neuropatiche persistono in età prescolare sotto l'influenza di influenze situazionali sfavorevoli, infezioni, lesioni, ecc. Insorgono facilmente vari disturbi nevrotici monosintomatici e simili alla nevrosi: enuresi notturna, encopresi, tic, balbuzie, terrori notturni, disturbi dell'appetito nevrotico (anoressia), azioni patologiche abituali. La sindrome da neuropatia è relativamente spesso inclusa nella struttura dei disturbi neuropsichici organici residui che insorgono a seguito di lesioni cerebrali organiche intrauterine e perinatali, accompagnate da sintomi neurologici, aumento della pressione intracranica e, spesso, ritardo dello sviluppo psicomotorio e del linguaggio.
Disturbi ipercinetici.
I disturbi ipercinetici (sindrome iperdinamica) o sindrome da disinibizione psicomotoria si manifestano principalmente tra i 3 e i 7 anni e si manifestano con mobilità eccessiva, irrequietezza, pignoleria, mancanza di concentrazione, che portano a disturbi dell'adattamento, instabilità dell'attenzione e distraibilità. Questa sindrome si verifica molte volte più spesso nei ragazzi che nelle ragazze.
I primi segni della sindrome compaiono in età prescolare, ma prima dell'ingresso a scuola sono talvolta difficili da riconoscere a causa delle diverse varianti della norma. In questo caso, il comportamento dei bambini è caratterizzato dal desiderio di movimenti costanti, corrono, saltano, a volte si siedono per un breve periodo, poi saltano in piedi, toccano e afferrano oggetti che cadono nel loro campo visivo, chiedono molto domande, spesso senza ascoltare le risposte. A causa della maggiore attività fisica e dell'eccitabilità generale, i bambini entrano facilmente in conflitto con i coetanei, spesso violano il regime delle istituzioni per l'infanzia e padroneggiano male il curriculum scolastico. La sindrome iperdinamica si verifica fino al 90% nelle conseguenze di danni cerebrali organici precoci (patologia dello sviluppo intrauterino, traumi alla nascita, asfissia alla nascita, prematurità, meningoencefalite nei primi anni di vita), accompagnati da sintomi neurologici diffusi e, in alcuni casi, un ritardo nello sviluppo intellettuale.
Azioni abituali patologiche.
I comportamenti patologici abituali più comuni nei bambini sono succhiarsi il pollice, mangiarsi le unghie, masturbarsi, strapparsi o strappare i capelli e dondolare ritmicamente la testa e il corpo. Caratteristiche comuni delle abitudini patologiche sono la loro volontarietà, la capacità di interromperle temporaneamente attraverso uno sforzo di volontà, la comprensione da parte del bambino (a partire dalla fine dell'età prescolare) come abitudini negative e addirittura dannose in assenza, nella maggior parte dei casi, di il desiderio di superarli e persino la resistenza attiva ai tentativi degli adulti di eliminarli.
Il succhiamento del pollice o della lingua come abitudine patologica si verifica principalmente nei bambini in età precoce e prescolare. Il sintomo più comune è succhiarsi il pollice. La presenza a lungo termine di questa abitudine patologica può portare a malocclusione.
L'yactation è un'oscillazione stereotipata ritmica arbitraria del corpo o della testa, osservata principalmente prima di addormentarsi o al risveglio nei bambini piccoli. Di norma, il dondolio è accompagnato da una sensazione di piacere e i tentativi di altri di interferire con esso provocano insoddisfazione e pianto.
Mangiarsi le unghie (onicofagia) è più comune durante la pubertà. Spesso vengono morse non solo le parti sporgenti delle unghie, ma anche le aree parzialmente adiacenti della pelle, il che porta ad infiammazioni locali.
La masturbazione (masturbazione) comporta l'irritazione dei genitali con le mani, la compressione delle gambe e lo sfregamento contro vari oggetti. Nei bambini piccoli, questa abitudine è il risultato della fissazione sulla manipolazione giocosa delle parti del corpo e spesso non è accompagnata dall'eccitazione sessuale. Con la neuropatia, la masturbazione avviene a causa dell'aumentata eccitabilità generale. A partire dall'età di 8-9 anni, l'irritazione degli organi genitali può essere accompagnata da eccitazione sessuale con una pronunciata reazione vegetativa sotto forma di iperemia facciale, aumento della sudorazione e tachicardia. Infine, durante la pubertà, la masturbazione comincia ad essere accompagnata da idee di natura erotica. L'eccitazione sessuale e l'orgasmo aiutano a rafforzare l'abitudine patologica.
La tricotillomania è il desiderio di strapparsi i peli del cuoio capelluto e delle sopracciglia, spesso accompagnato da una sensazione di piacere. Si osserva principalmente nelle ragazze in età scolare. Lo strappamento dei capelli a volte porta alla calvizie localizzata.
Paure infantili.
La relativa facilità con cui si manifestano le paure è una caratteristica dell'infanzia. Le paure sotto l’influenza di vari fattori esterni e situazionali insorgono più facilmente quanto più giovane è l’età del bambino. Nei bambini piccoli, la paura può essere causata da qualsiasi oggetto nuovo che appare all'improvviso. A questo proposito, un compito importante, anche se non sempre facile, è quello di distinguere le paure psicologiche “normali” dalle paure di natura patologica. Segni di paure patologiche sono considerati la loro infondatezza o una chiara discrepanza tra la gravità delle paure e l'intensità dell'impatto che le ha causate, la durata dell'esistenza delle paure, una violazione delle condizioni generali del bambino (sonno, appetito, attività fisica benessere) e il comportamento del bambino sotto l'influenza delle paure.
Tutte le paure possono essere divise in tre gruppi principali: paure ossessive; paure dal contenuto sopravvalutato; paure deliranti. Le paure ossessive nei bambini si distinguono per la specificità del loro contenuto, una connessione più o meno chiara con il contenuto della situazione traumatica. Molto spesso si tratta di paure di infezioni, inquinamento, oggetti appuntiti (aghi), spazi chiusi, trasporti, paura della morte, paura delle risposte orali a scuola, paura della parola nelle persone che balbettano, ecc. Le paure ossessive vengono riconosciute dai bambini come “superflue”, aliene, e le combattono.
I bambini non trattano le paure relative a contenuti estremamente preziosi come estranee o dolorose, sono convinti della loro esistenza e non cercano di superarle. Tra queste paure nei bambini in età prescolare e primaria prevalgono la paura dell'oscurità, della solitudine, degli animali (cani), la paura della scuola, la paura del fallimento, la punizione per violazione della disciplina, la paura di un insegnante severo. La paura della scuola può essere la causa del persistente rifiuto di frequentare la scuola e del fenomeno del disadattamento scolastico.
Le paure deliranti sono caratterizzate dall'esperienza di una minaccia nascosta sia da parte di persone che animali, e da oggetti e fenomeni inanimati, e sono accompagnate da costante ansia, diffidenza, timidezza e sospetto verso gli altri. I bambini piccoli hanno paura della solitudine, delle ombre, del rumore, dell'acqua, dei vari oggetti di uso quotidiano (rubinetti dell'acqua, lampade elettriche), degli estranei, dei personaggi dei libri per bambini e delle fiabe. Il bambino tratta tutti questi oggetti e fenomeni come ostili, minacciando il suo benessere. I bambini si nascondono da oggetti reali o immaginari. Le paure deliranti sorgono al di fuori di una situazione traumatica.
Fantasia patologica.
L'emergere di fantasie patologiche nei bambini e negli adolescenti è associata alla presenza di un'immaginazione creativa dolorosamente alterata (fantasticare). In contrasto con le fantasie dinamiche e in rapida evoluzione di un bambino sano, strettamente legate alla realtà, le fantasie patologiche sono persistenti, spesso separate dalla realtà, bizzarre nel contenuto, spesso accompagnate da disturbi comportamentali, adattamento e si manifestano in varie forme. La prima forma di fantasia patologica è l'imitazione giocosa. Un bambino temporaneamente, a volte per molto tempo (da diverse ore a diversi giorni), si reincarna in un animale (lupo, lepre, cavallo, cane), un personaggio di una fiaba, una creatura fantastica immaginaria, un oggetto inanimato. Il comportamento del bambino imita l'aspetto e le azioni di questo oggetto.
Un'altra forma di attività ludica patologica è rappresentata dalle manipolazioni monotone e stereotipate con oggetti che non hanno alcun significato ludico: bottiglie, pentole, noci, corde, ecc. Tali "giochi" sono accompagnati dall'eccitazione, dalla difficoltà di cambiare, dall'insoddisfazione e dall'irritazione del bambino quando cerca di strapparlo da questa attività.
Nei bambini in età prescolare e primaria, la fantasia patologica di solito assume la forma di fantasia figurativa. I bambini immaginano vividamente animali, piccole persone, bambini con cui giocano mentalmente, danno loro nomi o soprannomi, viaggiano con loro, finendo in paesi sconosciuti, bellissime città e altri pianeti. Le fantasie dei ragazzi sono spesso associate a temi militari: si immaginano scene di battaglia e truppe. Guerrieri in abiti colorati degli antichi romani, nell'armatura dei cavalieri medievali. A volte (soprattutto in età prepuberale e puberale) le fantasie hanno un contenuto sadico: vengono immaginati disastri naturali, incendi, scene di violenza, esecuzioni, torture, omicidi, ecc.
Le fantasie patologiche negli adolescenti possono assumere la forma di autoincriminazione e calunnia. Più spesso si tratta di autoincriminazioni investigative di ragazzi adolescenti che parlano di partecipazione immaginaria a rapine, attacchi armati, furti d'auto e appartenenza a organizzazioni di spionaggio. Per dimostrare la verità di tutte queste storie, gli adolescenti scrivono con grafia alterata e lasciano biglietti ai loro cari e conoscenti, presumibilmente di leader di bande, che contengono tutti i tipi di richieste, minacce ed espressioni oscene. La calunnia per stupro è comune tra le adolescenti. Sia con l'autoincriminazione che con la calunnia, gli adolescenti a volte quasi credono nella realtà delle loro fantasie. Questa circostanza, così come la vivacità e l'emotività dei resoconti su eventi fittizi, spesso convincono gli altri della loro veridicità, e quindi iniziano le indagini, le chiamate alla polizia, ecc. La fantasia patologica si osserva in varie malattie mentali.
Neurosi degli organi(nevrosi sistemiche). Le nevrosi d'organo comprendono balbuzie nevrotica, tic nevrotici, enuresi nevrotica ed encopresi.
Balbuzie nevrotica. La balbuzie è una violazione del ritmo, del tempo e della fluidità della parola associata a spasmi dei muscoli coinvolti nell'atto linguistico. Le cause della balbuzie nevrotica possono essere traumi mentali sia acuti che subacuti (spavento, eccitazione improvvisa, separazione dai genitori, cambiamento nel modello di vita abituale, ad esempio, collocare un bambino in un istituto di assistenza all'infanzia in età prescolare) e situazioni psicotraumatiche a lungo termine (rapporti conflittuali in famiglia, educazione errata). I fattori interni che contribuiscono sono una storia familiare di patologie del linguaggio, principalmente balbuzie. Nell'origine della balbuzie sono importanti anche una serie di fattori esterni, in particolare un "clima vocale" sfavorevole sotto forma di sovraccarico di informazioni, tentativi di accelerare il ritmo dello sviluppo del linguaggio del bambino, un brusco cambiamento nei requisiti per la sua attività linguistica , bilinguismo in famiglia e richieste eccessive dei genitori sul linguaggio del bambino. Di norma, la balbuzie si intensifica in condizioni di stress emotivo, ansia, maggiore responsabilità e, se necessario, quando entri in contatto con estranei. Allo stesso tempo, in un ambiente domestico familiare, quando si parla con gli amici, la balbuzie può diventare meno evidente. La balbuzie nevrotica è quasi sempre abbinata ad altri disturbi nevrotici: paure, sbalzi d'umore, disturbi del sonno, tic, enuresi, che spesso precedono l'insorgenza della balbuzie.
Tic nevrotici. I tic nevrotici sono una varietà di movimenti elementari automatici e abituali: sbattere le palpebre, corrugare la fronte, leccarsi le labbra, contrarre la testa e le spalle, tossire, "grugnire", ecc.). Nell'eziologia dei tic nevrotici, il ruolo dei fattori causali è svolto da situazioni psicotraumatiche a lungo termine, traumi mentali acuti accompagnati da paura, irritazione locale (congiuntiva, vie respiratorie, pelle, ecc.), Che causano una reazione motoria riflessa protettiva, come così come l'imitazione dei tic in qualcuno che ti circonda. I tic di solito si presentano sotto forma di reazione nevrotica immediata o leggermente ritardata nel tempo a causa dell'azione di un fattore traumatico. Più spesso, tale reazione è fissa, appare una tendenza alla comparsa di tic di diversa localizzazione e si aggiungono altre manifestazioni nevrotiche: instabilità dell'umore, pianto, irritabilità, paure episodiche, disturbi del sonno, sintomi astenici.
Enuresi nevrotica. Con il termine “enuresi” si indica lo stato di perdita inconscia di urina, soprattutto durante il sonno notturno. L'enuresi nevrotica comprende quei casi in cui il ruolo causale appartiene a fattori psicogeni. Si parla di enuresi come condizione patologica in caso di incontinenza urinaria nei bambini a partire dai 4 anni di età, poiché in età precoce può essere fisiologica, associata all'immaturità legata all'età dei meccanismi di regolazione della minzione e della mancanza di un'abilità rafforzata per trattenere l'urina.
A seconda del momento in cui si verifica l'enuresi, questa si divide in “primaria” e “secondaria”. Con l'enuresi primaria, l'incontinenza urinaria si osserva fin dalla prima infanzia senza intervalli del periodo di abilità di pulizia formata, caratterizzata dalla capacità di non trattenere l'urina non solo durante la veglia, ma anche durante il sonno. L'enuresi primaria (disontogenetica), nella cui genesi gioca un ruolo il ritardo nella maturazione dei sistemi di regolazione urinaria, ha spesso un carattere familiare-ereditario. L'enuresi secondaria avviene dopo un periodo più o meno lungo di almeno 1 anno in cui si acquisisce la capacità di pulirsi. L'enuresi nevrotica è sempre secondaria. La clinica dell'enuresi nevrotica si distingue per la sua pronunciata dipendenza dalla situazione e dall'ambiente in cui si trova il bambino, da varie influenze sulla sua sfera emotiva. L'incontinenza urinaria, di regola, aumenta bruscamente durante l'esacerbazione di una situazione traumatica, ad esempio in caso di separazione dei genitori, dopo un altro scandalo, in connessione con la punizione fisica, ecc. D'altra parte, l'allontanamento temporaneo di un bambino da una situazione traumatica è spesso accompagnato da una notevole riduzione o cessazione dell'enuresi. A causa del fatto che l'emergere dell'enuresi nevrotica è facilitato da tratti caratteriali come l'inibizione, la timidezza, l'ansia, la paura, l'impressionabilità, l'insicurezza, la bassa autostima, i bambini con enuresi nevrotica relativamente presto, già in età prescolare e di scuola primaria , iniziano a provare dolore per la loro carenza, ne sono imbarazzati, sviluppano un senso di inferiorità, nonché un'ansiosa attesa di un'altra perdita di urina. Quest'ultimo porta spesso a difficoltà ad addormentarsi e ad un sonno notturno agitato, che però non garantisce il risveglio tempestivo del bambino quando si manifesta la voglia di urinare durante il sonno. L'enuresi nevrotica non è mai l'unico disturbo nevrotico; è sempre combinato con altre manifestazioni nevrotiche, come labilità emotiva, irritabilità, pianto, sbalzi d'umore, tic, paure, disturbi del sonno, ecc.
È necessario distinguere l'enuresi nevrotica dall'enuresi simile alla nevrosi. L'enuresi simile alla nevrosi si verifica in connessione con precedenti malattie cerebrali organiche o somatiche generali, è caratterizzata da una maggiore monotonia del decorso, dall'assenza di una chiara dipendenza dai cambiamenti della situazione con una pronunciata dipendenza dalle malattie somatiche, una frequente combinazione con manifestazioni cerebrasteniche, psicoorganiche, disturbi neurologici focali e diencefalico-vegetativi, presenza di alterazioni organiche dell'EEG e segni di idrocefalo alla radiografia del cranio. Nell'enuresi simile alla nevrosi, la reazione della personalità all'incontinenza urinaria è spesso assente fino alla pubertà. I bambini non prestano attenzione al loro difetto per molto tempo e non se ne vergognano, nonostante il naturale disagio.
L'enuresi nevrotica dovrebbe anche essere distinta dall'incontinenza urinaria come una delle forme di reazioni di protesta passiva nei bambini in età prescolare. In quest'ultimo caso, l'incontinenza urinaria si osserva solo durante il giorno e si verifica principalmente in una situazione psicologicamente traumatica, ad esempio in un asilo nido o in una scuola materna in caso di riluttanza a frequentarli, in presenza di una persona indesiderata, ecc. Inoltre, ci sono manifestazioni di comportamento di protesta, insoddisfazione per la situazione e reazioni di negatività.
Encopresi nevrotica. L'encopresi è il passaggio involontario delle feci che avviene in assenza di anomalie e malattie dell'intestino inferiore o dello sfintere anale. La malattia si verifica circa 10 volte meno frequentemente dell'enuresi. La causa dell'encopresi nella maggior parte dei casi sono le situazioni traumatiche croniche in famiglia, le richieste eccessivamente rigide dei genitori nei confronti del bambino. I fattori che contribuiscono al “suolo” possono essere condizioni neuropatiche e insufficienza cerebrale organica residua.
La clinica dell'encopresi nevrotica è caratterizzata dal fatto che un bambino che in precedenza aveva abilità di pulizia, sperimenta periodicamente durante il giorno una piccola quantità di movimenti intestinali sulla sua biancheria; Più spesso, i genitori si lamentano che il bambino "si sporca solo leggermente i pantaloni", in rari casi vengono rilevati movimenti intestinali più abbondanti. Di norma, il bambino non sente il bisogno di defecare, all'inizio non si accorge della presenza di movimenti intestinali e solo dopo un po 'sente un odore sgradevole. Nella maggior parte dei casi, i bambini sono dolorosamente consapevoli dei loro difetti, se ne vergognano e cercano di nascondere la biancheria sporca ai genitori. Una peculiare reazione della personalità all'encopresi può essere l'eccessivo desiderio del bambino di pulizia e ordine. Nella maggior parte dei casi, l’encopresi è associata a umore depresso, irritabilità e tendenza al pianto.
Disturbi del sonno nevrotico.
La durata del sonno fisiologicamente necessaria cambia significativamente con l'età, dalle 16-18 ore al giorno in un bambino del primo anno di vita alle 10-11 ore all'età di 7-10 anni e alle 8-9 ore negli adolescenti di 14-16 anni. Anni. Inoltre, con l'età, il sonno si sposta prevalentemente verso la notte, e quindi la maggior parte dei bambini sopra i 7 anni non avverte il desiderio di dormire durante il giorno.
Per stabilire la presenza di un disturbo del sonno, ciò che conta non è tanto la sua durata quanto la sua profondità, determinata dalla velocità del risveglio sotto l'influenza di stimoli esterni, nonché la durata del periodo di addormentamento. Nei bambini piccoli, la causa immediata dei disturbi del sonno sono spesso diversi fattori psico-traumatici che agiscono sul bambino nelle ore serali, poco prima di andare a dormire: litigi tra i genitori a quest'ora, messaggi vari da parte degli adulti che spaventano il bambino su eventuali incidenti e incidenti, visione di film in televisione, ecc.
Il quadro clinico dei disturbi del sonno nevrotico è caratterizzato da difficoltà ad addormentarsi, disturbi del sonno profondo con risvegli notturni, terrori notturni, nonché sonnambulismo e chiacchiere nel sonno. I disturbi del sonno si esprimono in una lenta transizione dalla veglia al sonno. L'addormentarsi può durare fino a 1-2 ore ed è spesso combinato con varie paure e preoccupazioni (paura del buio, paura di soffocare nel sonno, ecc.), azioni patologiche abituali (succhiarsi il pollice, arricciarsi i capelli, masturbazione), azioni ossessive come i rituali elementari (augurare ripetutamente la buonanotte, mettere a letto certi giocattoli e certe azioni con essi, ecc.). Manifestazioni frequenti di disturbi del sonno nevrotico sono il sonnambulismo e il parlare nel sonno. Di norma, in questo caso sono legati al contenuto dei sogni e riflettono le esperienze traumatiche individuali.
I risvegli notturni di origine nevrotica, a differenza di quelli epilettici, mancano della repentinità del loro inizio e della loro cessazione, sono molto più lunghi e non sono accompagnati da un chiaro cambiamento di coscienza.
Disturbi dell'appetito nevrotico (anoressia).
Questo gruppo di disturbi nevrotici è molto diffuso e comprende vari disturbi del “comportamento alimentare” nei bambini associati a una diminuzione primaria dell'appetito. Vari momenti psicotraumatici giocano un ruolo nell'eziologia dell'anoressia: separazione del bambino dalla madre, collocamento in un istituto per l'infanzia, approccio educativo disomogeneo, punizione fisica, attenzione insufficiente al bambino. La causa immediata dell'anoressia nevrotica primaria è spesso il tentativo della madre di allattare forzatamente il bambino quando questi rifiuta di mangiare, la sovralimentazione o la coincidenza accidentale dell'alimentazione con qualche esperienza spiacevole (un grido acuto, paura, litigio tra adulti, ecc.) . Il fattore interno che contribuisce più importante è una condizione neuropatica (congenita o acquisita), caratterizzata da un forte aumento dell'eccitabilità autonomica e dell'instabilità della regolazione autonomica. Inoltre, la debolezza somatica gioca un certo ruolo. Tra i fattori esterni, l'eccessiva ansia dei genitori riguardo allo stato nutrizionale del bambino e al processo di alimentazione, l'uso della persuasione, le storie e altri fattori che distraggono dal cibo, nonché un'educazione impropria con la soddisfazione di tutti i capricci e i capricci del bambino. bambino, che lo portano a viziarsi eccessivamente, sono importanti.
Le manifestazioni cliniche dell'anoressia sono abbastanza simili. Il bambino non ha alcun desiderio di mangiare alcun cibo oppure è molto selettivo nel cibo, rifiutando molti cibi comuni. Di regola, è riluttante a sedersi a tavola, mangia molto lentamente e "fa rotolare" il cibo in bocca per molto tempo. A causa dell'aumento del riflesso del vomito, spesso si verifica vomito durante il pasto. Mangiare provoca malumore, malumore e pianto nel bambino. Il decorso della reazione nevrotica può essere di breve durata, non superiore a 2-3 settimane. Allo stesso tempo, nei bambini con condizioni neuropatiche, così come in quelli viziati in condizioni di educazione impropria, l'anoressia nevrotica può acquisire un decorso prolungato con un persistente rifiuto di mangiare a lungo termine. In questi casi è possibile la perdita di peso.
Sottosviluppo mentale.
Segni di ritardo mentale compaiono già all'età di 2-3 anni, il linguaggio frasale è assente per molto tempo e la pulizia e le capacità di cura di sé si sviluppano lentamente. I bambini sono poco curiosi, hanno poco interesse per gli oggetti circostanti, i giochi sono monotoni e non c'è vivacità nel gioco.
In età prescolare, si attira l'attenzione sullo scarso sviluppo delle capacità di self-service; il discorso frasale è caratterizzato da un vocabolario scarso, dalla mancanza di frasi dettagliate, dall'impossibilità di una descrizione coerente delle immagini della trama e da un'offerta insufficiente di informazioni quotidiane. Il contatto con i coetanei è accompagnato da una mancanza di comprensione dei loro interessi, del significato e delle regole dei giochi, da uno scarso sviluppo e dalla mancanza di differenziazione delle emozioni superiori (simpatia, pietà, ecc.).
Nell'età della scuola primaria si riscontra l'incapacità di comprendere e padroneggiare il programma scolastico primario di una scuola di massa, la mancanza di conoscenze quotidiane di base (indirizzo di casa, professione dei genitori, stagioni, giorni della settimana, ecc.) e l'incapacità comprendere il significato figurato dei proverbi. Gli insegnanti della scuola materna e gli insegnanti della scuola possono aiutare a diagnosticare questo disturbo mentale.
Infantilismo mentale.
L'infantilismo mentale è uno sviluppo ritardato delle funzioni mentali del bambino con un ritardo predominante nella sfera emotivo-volitiva (immaturità personale). L'immaturità emotivo-volitiva si esprime nella mancanza di indipendenza, maggiore suggestionabilità, desiderio di piacere come motivazione principale del comportamento, predominanza degli interessi di gioco in età scolare, disattenzione, senso immaturo del dovere e responsabilità, debole capacità di subordinare i propri comportamento alle esigenze della squadra, della scuola e incapacità di frenare le manifestazioni immediate dei sentimenti. , incapacità di esercitare la volontà, di superare le difficoltà.
È anche caratteristica l'immaturità psicomotoria, che si manifesta nella mancanza di movimenti fini delle mani, nella difficoltà di sviluppare le capacità motorie scolastiche (disegno, scrittura) e le abilità lavorative. La base dei disturbi psicomotori elencati è la relativa predominanza dell'attività del sistema extrapiramidale rispetto al sistema piramidale a causa della sua immaturità. Si nota una deficienza intellettuale: la predominanza di un tipo di pensiero concreto-figurativo, un maggiore esaurimento dell'attenzione e una certa perdita di memoria.
Le conseguenze sociali e pedagogiche dell’infantilismo mentale sono l’insufficiente “maturità scolastica”, la mancanza di interesse per l’apprendimento e lo scarso rendimento scolastico.
Disturbi delle abilità scolastiche.
Le violazioni delle abilità scolastiche sono tipiche dei bambini in età scolare (6-8 anni). I disturbi dello sviluppo della capacità di lettura (dislessia) si manifestano nel mancato riconoscimento delle lettere, nella difficoltà o impossibilità di mettere in relazione le immagini delle lettere con i suoni corrispondenti e nella sostituzione di alcuni suoni con altri durante la lettura. Inoltre, si verifica un ritmo di lettura lento o accelerato, riorganizzazione delle lettere, deglutizione delle sillabe e posizionamento errato dello stress durante la lettura.
Un disturbo nella formazione delle capacità di scrittura (disgrafia) si esprime in violazioni della correlazione dei suoni del discorso orale con la loro scrittura, gravi disturbi della scrittura indipendente sotto dettatura e durante la presentazione: c'è una sostituzione di lettere corrispondenti a suoni simili nella pronuncia , omissioni di lettere e sillabe, loro riarrangiamento, smembramento di parole e scrittura fusa di due o più parole, sostituzione di lettere graficamente simili, scrittura speculare di lettere, ortografia poco chiara di lettere, scivolamento fuori linea.
Lo sviluppo compromesso delle capacità di conteggio (discalculia) si manifesta in particolari difficoltà nella formazione del concetto di numero e nella comprensione della struttura dei numeri. Particolari difficoltà sono causate dalle operazioni digitali associate al passaggio al dieci. È difficile scrivere numeri a più cifre. Spesso viene notata l'ortografia speculare dei numeri e delle combinazioni di numeri (21 invece di 12). Spesso si verificano disturbi nella comprensione delle relazioni spaziali (i bambini confondono il lato destro e sinistro), nella posizione relativa degli oggetti (davanti, dietro, sopra, sotto, ecc.).
Sfondo dell'umore ridotto - depressione.
Nei bambini in età prescolare e prescolare, gli stati depressivi si manifestano sotto forma di disturbi somatovegetativi e motori. Le manifestazioni più atipiche degli stati depressivi nei bambini piccoli (fino a 3 anni) si verificano durante una prolungata separazione del bambino dalla madre e si esprimono con letargia generale, attacchi di pianto, irrequietezza motoria, rifiuto di attività ludiche, disturbi del cervello il ritmo del sonno e della veglia, perdita di appetito, perdita di peso, predisposizione a raffreddori e malattie infettive.
In età prescolare, oltre ai disturbi del sonno e dell'appetito, si osservano enuresi, encopresi e disturbi psicomotori depressivi: i bambini hanno un'espressione sofferente sul viso, camminano a testa bassa, trascinando i piedi, senza muovere le braccia, parlano in modo voce calma e potrebbe avvertire disagio o dolore in diverse parti del corpo. Nei bambini in età scolare, i cambiamenti comportamentali vengono alla ribalta in caso di depressione: passività, letargia, isolamento, indifferenza, perdita di interesse per i giocattoli, difficoltà di apprendimento dovute a ridotta attenzione, lenta assimilazione del materiale educativo. In alcuni bambini, soprattutto maschi, predominano irritabilità, permalosità, tendenza all'aggressività e ritiro dalla scuola e dalla casa. In alcuni casi si può verificare una ripresa di abitudini patologiche caratteristiche dei più giovani: succhiarsi le dita, mangiarsi le unghie, strapparsi i capelli, masturbarsi.
In età prepuberale, un affetto depressivo più pronunciato si manifesta sotto forma di umore depresso e malinconico, un peculiare sentimento di scarso valore, idee di autoumiliazione e auto-colpa. I bambini dicono: “Sono incapace. Sono il più debole tra i ragazzi della classe”. Per la prima volta sorgono pensieri suicidi ("Perché dovrei vivere così?", "Chi ha bisogno di me così?"). Durante la pubertà, la depressione si manifesta con la sua caratteristica triade di sintomi: umore depresso, ritardo intellettivo e motorio. Le manifestazioni somatovegetative occupano un posto importante: disturbi del sonno, perdita di appetito. stitichezza, lamentele di mal di testa, dolore in varie parti del corpo.
I bambini temono per la loro salute e la loro vita, diventano ansiosi, si fissano sui disturbi somatici, chiedono con timore ai genitori se il loro cuore potrebbe fermarsi, se soffocheranno nel sonno, ecc. A causa dei disturbi somatici persistenti (depressione somatizzata, “mascherata”), i bambini vengono sottoposti a numerosi esami funzionali e di laboratorio, esami da parte di specialisti specializzati per identificare eventuali malattie somatiche. I risultati degli esami sono negativi. A questa età, sullo sfondo di un umore basso, gli adolescenti sviluppano un interesse per l'alcol e le droghe, si uniscono alla compagnia di adolescenti delinquenti e sono inclini a tentativi di suicidio e autolesionismo. La depressione nei bambini si sviluppa in situazioni psicotraumatiche gravi, come la schizofrenia.
Partire e vagare.
L'assenteismo e il vagabondaggio si esprimono in ripetute partenze da casa o da scuola, collegio o altri istituti per bambini, seguite da vagabondaggio, spesso per molti giorni. Per lo più osservato nei ragazzi. Nei bambini e negli adolescenti, il ritiro può essere associato a sentimenti di risentimento, a un danno all'autostima, a una reazione di protesta passiva, o alla paura della punizione o all'ansia per qualche offesa. Nell'infantilismo mentale si osservano abbandoni scolastici e assenteismo principalmente per paura di difficoltà legate agli studi. Le fughe negli adolescenti con tratti caratteriali isterici sono associate al desiderio di attirare l'attenzione dei parenti, di suscitare pietà e simpatia (fughe dimostrative). Un altro tipo di motivazione per i prelievi iniziali è il “craving sensoriale”, cioè il bisogno di esperienze nuove e in continua evoluzione, così come il desiderio di divertimento.
Le partenze possono essere “immotivate”, impulsive, con un irresistibile desiderio di fuga. Si chiamano dromomania. I bambini e gli adolescenti fuggono da soli o in piccoli gruppi; possono andare in altre città, passare la notte nei corridoi, nelle soffitte e nelle cantine; di norma non tornano a casa da soli. Vengono portati da agenti di polizia, parenti e sconosciuti. I bambini non avvertono stanchezza, fame o sete per molto tempo, il che indica che hanno una patologia pulsionale. L'abbandono e il vagabondaggio interrompono l'adattamento sociale dei bambini, riducono il rendimento scolastico e portano a varie forme di comportamento antisociale (teppismo, furto, alcolismo, abuso di sostanze, tossicodipendenza, rapporti sessuali precoci).
Atteggiamento doloroso verso una disabilità fisica immaginaria (dismorfofobia).
L'idea dolorosa di un difetto fisico immaginario o irragionevolmente esagerato si manifesta nell'80% dei casi durante la pubertà, e più spesso nelle ragazze adolescenti. Le idee stesse di disabilità fisica possono essere espresse sotto forma di pensieri sui difetti facciali (naso lungo e brutto, bocca grande, labbra spesse, orecchie sporgenti), fisico (grassezza o magrezza eccessiva, spalle strette e bassa statura nei ragazzi), insufficienza sviluppo sessuale (pene piccolo, “curvo”) o sviluppo sessuale eccessivo (ghiandole mammarie grandi nelle ragazze).
Un tipo particolare di esperienza dismorfofobica è l'insufficienza di alcune funzioni: paura di non riuscire a trattenere i gas intestinali in presenza di estranei, paura dell'alito cattivo o dell'odore del sudore, ecc. Le esperienze sopra descritte influenzano il comportamento degli adolescenti che iniziano a evitare luoghi affollati, amici e conoscenti, cercano di camminare solo dopo il tramonto, cambiano vestiti e acconciatura. Gli adolescenti più stenici cercano di sviluppare e utilizzare a lungo termine varie tecniche di automedicazione, esercizi fisici speciali, si rivolgono con insistenza a cosmetologi, chirurghi e altri specialisti che richiedono chirurgia plastica, trattamenti speciali, ad esempio ormoni della crescita, soppressori dell'appetito. Gli adolescenti spesso si guardano allo specchio (“sintomo dello specchio”) e rifiutano anche di farsi fotografare. Esperienze dismorfofobiche episodiche e transitorie, associate ad un atteggiamento pregiudiziale verso vere e proprie disabilità fisiche minori, si verificano normalmente durante la pubertà. Ma se hanno un carattere pretenzioso pronunciato, persistente, spesso assurdo, determinano il comportamento, interrompono l'adattamento sociale di un adolescente e si basano su uno sfondo di umore depresso, allora queste sono già esperienze dolorose che richiedono l'aiuto di uno psicoterapeuta o psichiatra .
Anoressia nervosa.
L’anoressia nervosa è caratterizzata da un desiderio deliberato ed estremamente persistente di rifiuto qualitativo e/o quantitativo del cibo e di perdita di peso. È molto più comune nelle ragazze adolescenti e nelle giovani donne, molto meno comune nei ragazzi e nei bambini. Il sintomo principale è la convinzione di essere sovrappeso e il desiderio di correggere questo “svantaggio” fisico. Nelle prime fasi della condizione, l'appetito persiste a lungo e l'astinenza dal cibo viene occasionalmente interrotta da attacchi di eccesso di cibo (bulimia nervosa). Quindi il modello abituale stabilito di eccesso di cibo si alterna al vomito, portando a complicazioni somatiche. Gli adolescenti tendono a mangiare il cibo da soli, cercano di sbarazzarsene silenziosamente e studiano attentamente il contenuto calorico degli alimenti.
La perdita di peso avviene in vari altri modi: esercizio fisico estenuante; prendere lassativi, clisteri; regolare induzione artificiale del vomito. Una sensazione di fame costante può portare a forme di comportamento ipercompensatorie: alimentazione di fratelli e sorelle più giovani, maggiore interesse nella preparazione di vari cibi, nonché comparsa di irritabilità, maggiore eccitabilità e diminuzione dell'umore. I segni dei disturbi somatoendocrini compaiono e aumentano gradualmente: scomparsa del grasso sottocutaneo, oligo-, poi amenorrea, cambiamenti distrofici negli organi interni, perdita di capelli, cambiamenti nei parametri biochimici del sangue.
Sindrome dell'autismo della prima infanzia.
La sindrome dell'autismo della prima infanzia è un gruppo di sindromi di diversa origine (danno cerebrale organico intrauterino e perinatale - infettivo, traumatico, tossico, misto; ereditario-costituzionale), osservato nei bambini in età precoce, prescolare e primaria all'interno di diverse forme nosologiche. La sindrome dell'autismo della prima infanzia si manifesta più chiaramente dai 2 ai 5 anni, sebbene alcuni segni siano notati in età precoce. Così, già nei neonati manca il “complesso di rivitalizzazione” caratteristico dei bambini sani quando sono a contatto con la madre, non sorridono quando vedono i genitori, e talvolta manca una reazione indicativa agli stimoli esterni, che può essere considerato un difetto degli organi di senso. I bambini sperimentano disturbi del sonno (sonno intermittente, difficoltà ad addormentarsi), persistenti disturbi dell'appetito con diminuzione e particolare selettività e mancanza di fame. C'è il timore della novità. Qualsiasi cambiamento nell'ambiente abituale, ad esempio, dovuto alla riorganizzazione dei mobili, all'apparizione di una cosa nuova, di un nuovo giocattolo, spesso provoca malcontento o addirittura una violenta protesta con il pianto. Una reazione simile si verifica quando si cambia l'ordine o l'orario di alimentazione, camminata, lavaggio e altri aspetti della routine quotidiana.
Il comportamento dei bambini con questa sindrome è monotono. Possono passare ore a compiere le stesse azioni che ricordano vagamente un gioco: versare l'acqua dentro e fuori dai piatti, smistare pezzi di carta, scatole di fiammiferi, lattine, spaghi, disporli in un certo ordine, senza permettere a nessuno di rimuoverli. Queste manipolazioni, così come un crescente interesse per certi oggetti che di solito non hanno uno scopo ludico, sono espressione di un'ossessione speciale, all'origine della quale è evidente il ruolo della patologia pulsionale. I bambini con autismo cercano attivamente la solitudine, sentendosi meglio quando lasciati soli. Tipici sono i disturbi psicomotori, che si manifestano con insufficienza motoria generale, andatura goffa, stereotipie nei movimenti, tremori, rotazione delle mani, salti, rotazione attorno al proprio asse, camminata e corsa in punta di piedi. Di norma, c'è un ritardo significativo nella formazione delle abilità di base per la cura di sé (mangiare in modo indipendente, lavarsi, vestirsi, ecc.).
Le espressioni facciali del bambino sono povere, inespressive, caratterizzate da uno "sguardo vuoto e inespressivo", nonché da uno sguardo come se oltrepassasse o "attraverso" l'interlocutore. Il discorso contiene ecolalia (ripetizione di una parola ascoltata), parole pretenziose, neologismi, intonazione prolungata e l'uso di pronomi e verbi in 2a e 3a persona in relazione a se stessi. Alcuni bambini sperimentano un completo rifiuto di comunicare. Il livello di sviluppo dell'intelligenza varia: normale, sopra la media e può esserci un ritardo mentale. Le sindromi autistiche della prima infanzia hanno nosologie diverse. Alcuni scienziati li attribuiscono alla manifestazione del processo schizofrenico, altri alle conseguenze di danni cerebrali organici precoci, forme atipiche di ritardo mentale.
Conclusione
La diagnosi clinica in psichiatria infantile si basa non solo sulle denunce dei genitori, dei tutori e dei bambini stessi, sulla raccolta dell'anamnesi della vita del paziente, ma anche sull'osservazione del comportamento del bambino e sull'analisi del suo aspetto. Quando si parla con i genitori (altri rappresentanti legali) del bambino, è necessario prestare attenzione all'espressione facciale del paziente, alle espressioni facciali, alla sua reazione all'esame, al desiderio di comunicare, alla produttività del contatto, alla capacità di comprendere ciò che ha sentito, seguire istruzioni impartite, volume del vocabolario, purezza della pronuncia dei suoni, sviluppo delle capacità motorie fini, eccessiva mobilità o inibizione, lentezza, goffaggine nei movimenti, reazione alla madre, ai giocattoli, ai bambini presenti, desiderio di comunicare con loro, capacità di vestirsi, mangiare , sviluppo delle capacità di pulizia, ecc. Se vengono rilevati segni di un disturbo mentale in un bambino o un adolescente, si dovrebbe consigliare ai genitori o ai tutori di chiedere consiglio a uno psicoterapeuta infantile, a uno psichiatra infantile o a psichiatri negli ospedali regionali nelle aree rurali.
Gli psicoterapeuti infantili e gli psichiatri infantili che prestano servizio alla popolazione infantile e adolescenziale di Tyumen lavorano nel reparto ambulatoriale dell'Ospedale Psichiatrico Clinico Regionale di Tyumen, Tyumen, st. Herzen, 74 anni. Registrazione telefonica degli psicoterapeuti infantili: 50-66-17; numero di telefono dell'albo degli psichiatri infantili: 50-66-35; Linea di assistenza: 50-66-43.
Bibliografia
- Bukhanovsky A.O., Kutyavin Yu.A., Litvan M.E. Psicopatologia generale. – Casa editrice “Phoenix”, 1998.
- Kovalev V.V. Psichiatria infantile. – M.: Medicina, 1979.
- Kovalev V.V. Semiotica e diagnosi della malattia mentale nel bambino e nell'adolescente. – M.: Medicina, 1985.
- Levchenko I.Yu. Patopsicologia: teoria e pratica: libro di testo. - M.: Accademia, 2000.
- Problemi di diagnosi, terapia e ricerca strumentale in psichiatria infantile / Materiali scientifici della conferenza tutta russa. -Volgograd, 2007.
- Eidemiller E.G. Psichiatria infantile. San Pietroburgo: Pietro, 2005.
APPLICAZIONE
- Schema di esame patopsicologico di un bambino secondo
Contatto (discorso, gesto, espressione facciale):
- non entra in contatto;
- mostra negativismo verbale;
— il contatto è formale (puramente esterno);
- non prende contatto subito, con grande difficoltà;
— non mostra interesse al contatto;
— contatto selettivo;
— stabilisce facilmente e rapidamente un contatto, mostra interesse e obbedisce volentieri.
Sfera emotivo-volitiva:
attivo passivo;
attivo/inerte;
allegro/letargico;
disinibizione motoria;
aggressività;
viziato;
sbalzi d'umore;
conflitto;
Condizione dell'udito(normale, perdita dell'udito, sordità).
Stato di visione(normale, miopia, ipermetropia, strabismo, atrofia del nervo ottico, ipovisione, cecità).
Capacità motorie:
1) mano principale (destra, sinistra);
2) sviluppo della funzione manipolativa delle mani:
- nessuna presa;
- gravemente limitato (non può manipolare, ma ha capacità di presa);
- limitato;
- capacità motorie fini insufficienti;
- sicuro;
3) coordinazione delle azioni delle mani:
- assente;
— norma (N);
4) tremore. Ipercinesi. Coordinazione compromessa dei movimenti
Attenzione (durata della concentrazione, resistenza, commutazione):
- il bambino ha difficoltà a concentrarsi, ha difficoltà a mantenere l'attenzione su un oggetto (bassa concentrazione e instabilità dell'attenzione);
- l'attenzione non è sufficientemente stabile, superficiale;
- si esaurisce rapidamente e richiede il passaggio ad un altro tipo di attività;
- scarso cambio di attenzione;
- l'attenzione è abbastanza stabile. La durata della concentrazione e dello spostamento dell'attenzione è soddisfacente.
Reazione all'approvazione:
- adeguato (si rallegra dell'approvazione, l'aspetta);
- inadeguato (non risponde all'approvazione, ne è indifferente). Reazione al commento:
— adeguato (corregge il comportamento in conformità con il commento);
Adeguato (offeso);
- nessuna reazione all'osservazione;
- reazione negativa (lo fa per ripicca).
Atteggiamento verso il fallimento:
- valuta il fallimento (nota l'inesattezza delle sue azioni, corregge gli errori);
— non vi è alcuna valutazione del fallimento;
- una reazione emotiva negativa al fallimento o al proprio errore.
Prestazione:
- estremamente basso;
- ridotto;
- sufficiente.
Natura dell'attività:
— mancanza di motivazione per l'attività;
- funziona formalmente;
- l'attività è instabile;
- l'attività è sostenibile, lavora con interesse.
Capacità di apprendimento, utilizzo di ausili (durante l'esame):
- non esiste capacità di apprendimento. L'aiuto non usa;
- non vi è alcun trasferimento del metodo d'azione mostrato a compiti simili;
- La capacità di apprendimento è bassa. L'aiuto è sottoutilizzato. Il trasferimento della conoscenza è difficile;
- insegniamo al bambino. Utilizza l'aiuto di un adulto (passa da un metodo inferiore di completamento delle attività a uno superiore). Trasferisce il metodo di azione ricevuto a un'attività simile (N).
Livello di sviluppo dell'attività:
1) mostrare interesse per i giocattoli, selettività degli interessi:
- persistenza dell'interesse per il gioco (si impegna a lungo con un giocattolo o si sposta da uno all'altro): non mostra interesse per i giocattoli (non lavora in alcun modo con i giocattoli. Non partecipa al gioco congiunto con gli adulti. Lo fa non organizzare giochi indipendenti);
- mostra un interesse superficiale e poco persistente per i giocattoli;
- mostra persistente interesse selettivo per i giocattoli;
- compie azioni inappropriate con oggetti (assurde, non dettate dalla logica del gioco o dalla qualità del soggetto dell'azione);
— utilizza i giocattoli in modo adeguato (utilizza l'oggetto in conformità al suo scopo);
3) la natura delle azioni con oggetti giocattolo:
- manipolazioni non specifiche (agisce allo stesso modo con tutti gli oggetti, stereotipicamente: picchietta, tira in bocca, succhia, lancia);
- manipolazioni specifiche - tiene conto solo delle proprietà fisiche degli oggetti;
- azioni degli oggetti: utilizza gli oggetti in conformità con il loro scopo funzionale;
— atti procedurali;
- catena di azioni di gioco;
- un gioco con elementi di trama;
- gioco di ruolo.
Stock di idee generali:
- basso, limitato;
- leggermente ridotto;
— corrisponde all'età (N).
Conoscenza delle parti del corpo e del viso (orientamento visivo).
Percezione visiva:
percezione del colore:
- nessuna idea del colore;
- confronta i colori;
- distingue i colori (evidenzia per parola);
- riconosce e nomina i colori primari (N – a 3 anni);
percezione della dimensione:
- nessuna idea delle dimensioni;
- correla gli oggetti per dimensione; - differenzia gli oggetti per dimensione (evidenziazione per parola);
- nomina la taglia (N - a 3 anni);
percezione della forma:
- nessuna idea della forma;
- correla gli oggetti per forma;
- distingue le forme geometriche (evidenzia per parola); nomi (planari e volumetrici) forme geometriche (N – a 3 anni).
Piegare una bambola matrioska (in tre parti– da 3 a 4 anni; quattro parti– dai 4 ai 5 anni; in sei parti– dai 5 anni):
— modi per completare l'attività:
- azione con la forza;
— enumerazione delle opzioni;
— test mirati (N – fino a 5 anni);
- provando;
Inclusione in una serie (matrioska in sei parti– dai 5 anni):
— le azioni sono inadeguate/adeguate;
— modi per completare l'attività:
- taglia esclusa;
— test mirati (N – fino a 6 anni);
- correlazione visiva (richiesto dai 6 anni).
Piegare una piramide (fino a 4 anni – 4 anelli; da 4 anni – 5-6 anelli):
— le azioni sono inadeguate/adeguate;
- esclusa la misura dell'anello;
- tenendo conto della dimensione degli anelli:
- provando;
— correlazione visiva (N – dai 6 anni obbligatoria).
Inserisci i cubi(prove, enumerazione delle opzioni, prova, correlazione visiva).
Cassetta postale (dai 3 anni):
- azione con la forza (ammessa in N fino a 3,5 anni);
— enumerazione delle opzioni;
- provando;
— correlazione visiva (N dai 6 anni è obbligatoria).
Immagini accoppiate (dai 2 anni; scelta su un campione di due, quattro, sei immagini).
Costruzione:
1) progettazione da materiale da costruzione (per imitazione, per modello, per rappresentazione);
2) piegare figure da bastoncini (per imitazione, per modello, per idea).
Percezione delle relazioni spaziali:
1) orientamento nei lati del proprio corpo e immagine speculare;
2) differenziazione dei concetti spaziali (sopra - sotto, più lontano - più vicino, destra - sinistra, davanti - dietro, al centro);
3) un'immagine olistica di un oggetto (piegando le immagini ritagliate da 2-3-4-5-6 parti; tagliate verticalmente, orizzontalmente, diagonalmente, con una linea spezzata);
4) comprensione e utilizzo delle strutture logico-grammaticali (N dai 6 anni).
Rappresentanze temporanee:
- momenti della giornata (N da 3 anni);
- stagioni (N dai 4 anni);
- giorni della settimana (N da 5 anni);
— comprensione e uso delle strutture logico-grammaticali (N da 6 anni).
Rappresentazioni quantitative:
— conteggio ordinale (orale e conteggio di oggetti);
— determinazione del numero di articoli;
- selezionando dal set la quantità richiesta;
- correlazione degli articoli per quantità;
- i concetti di “molti” - “pochi”, “più” - “meno”, “ugualmente”;
- operazioni di conteggio.
Memoria:
1) memoria meccanica (entro N, ridotta);
2) memoria indiretta (logico-verbale) (N, ridotta). Pensiero:
— livello di sviluppo del pensiero:
- visivamente efficace;
- visivamente figurativo;
- elementi di pensiero logico astratto.
- Diagnosi delle paure nei bambini.
Per diagnosticare la presenza di paure, si tiene una conversazione con il bambino per discutere le seguenti domande: Dimmi, per favore, hai paura o non hai paura:
- Quando sei solo?
- Ammalarsi?
- Morire?
- Alcuni bambini?
- Uno degli insegnanti?
- Che ti puniranno?
- Babu Yaga, Kashchei l'Immortale, Barmaley, Snake Gorynych?
- Sogni spaventosi?
- Buio?
- Lupo, orso, cani, ragni, serpenti?
- Auto, treni, aerei?
- Tempeste, temporali, uragani, inondazioni?
- Quando è molto alto?
- In una piccola stanza angusta, bagno?
- Acqua?
- Fuoco fuoco?
- Guerre?
- Medici (tranne i dentisti)?
- Sangue?
- Iniezioni?
- Dolore?
- Suoni acuti inaspettati (quando qualcosa cade o colpisce improvvisamente)?
Elaborazione della metodologia “Diagnostica della presenza di paure nei bambini”
Sulla base delle risposte ricevute alle domande di cui sopra, si conclude sulla presenza di paure nei bambini. La presenza di un gran numero di paure diverse in un bambino è un indicatore importante di uno stato pre-nevrotico. Tali bambini dovrebbero essere classificati come gruppo "a rischio" e con loro dovrebbe essere svolto un lavoro speciale (correttivo) (si consiglia di consultarli con uno psicoterapeuta o uno psichiatra).
Le paure nei bambini possono essere suddivise in diversi gruppi: medico(dolore, iniezioni, medici, malattie); associato a causare danni fisici(suoni inaspettati, trasporti, fuoco, fuoco, elementi, guerra); di morte(il suo); animali e personaggi delle fiabe; incubi e oscurità; socialmente mediato(persone, bambini, punizioni, ritardi, solitudine); "paure spaziali"(altezze, acqua, spazi confinati). Per trarre una conclusione inequivocabile sulle caratteristiche emotive di un bambino, è necessario tenere conto delle caratteristiche dell'intera attività della vita del bambino nel suo insieme.
In alcuni casi, è consigliabile utilizzare un test che consenta di diagnosticare l'ansia di un bambino di età compresa tra i quattro ei sette anni in relazione ad una serie di situazioni di vita tipiche di comunicazione con altre persone. Gli autori del test considerano l'ansia come un tipo di stato emotivo, il cui scopo è garantire la sicurezza del soggetto a livello personale. Un aumento del livello di ansia può indicare un insufficiente adattamento emotivo del bambino a determinate situazioni sociali.
Nell'infanzia possono manifestarsi varie malattie: nevrosi, schizofrenia, epilessia, danno cerebrale esogeno. Sebbene i segni principali di queste malattie importanti per la diagnosi si manifestino a qualsiasi età, i sintomi nei bambini sono leggermente diversi da quelli osservati negli adulti. Tuttavia, esistono numerosi disturbi specifici dell’infanzia, sebbene alcuni di essi possano persistere per tutta la vita di una persona. Questi disturbi riflettono disturbi nel corso naturale dello sviluppo del corpo; sono relativamente stabili; di solito non si osservano fluttuazioni significative nelle condizioni del bambino (remissioni), così come un forte aumento dei sintomi. Man mano che si sviluppano, alcune anomalie possono essere compensate o scomparire del tutto. La maggior parte dei disturbi descritti di seguito si verificano più spesso nei ragazzi.
Autismo infantile
Autismo infantile (Sindrome di Kanner) si verifica con una frequenza dello 0,02-0,05%. Si verifica 3-5 volte più spesso nei ragazzi che nelle ragazze. Sebbene le anomalie dello sviluppo possano essere identificate nell’infanzia, la malattia viene solitamente diagnosticata tra i 2 e i 5 anni, quando si stanno sviluppando le capacità di comunicazione sociale. La descrizione classica di questo disturbo [Kanner L., 1943] comprende estremo isolamento, desiderio di solitudine, difficoltà nella comunicazione emotiva con gli altri, uso inadeguato dei gesti, dell'intonazione e delle espressioni facciali nell'esprimere emozioni, deviazioni nello sviluppo del linguaggio con un tendenza alla ripetizione, ecolalia, uso scorretto dei pronomi (“tu” invece di “io”), ripetizione monotona di rumori e parole, diminuzione dell'attività spontanea, stereotipie, manierismi. A questi disturbi si uniscono un'ottima memoria meccanica e un desiderio ossessivo di mantenere tutto immutato, la paura del cambiamento, il desiderio di raggiungere la completezza in ogni azione e una preferenza per la comunicazione con gli oggetti rispetto a quella con le persone. Il pericolo è rappresentato dalla tendenza di questi pazienti ad autolesionismo (mordersi, strapparsi i capelli, colpire la testa). In età scolare si verificano spesso attacchi epilettici. Un concomitante ritardo mentale è stato osservato in 2/3 dei pazienti. Va notato che il disturbo si verifica spesso dopo un'infezione intrauterina (rosolia). Questi fatti supportano la natura organica della malattia. Una sindrome simile, ma senza deficit cognitivo, fu descritta da H. Asperger (1944), che la considerò una malattia ereditaria (concordanza nei gemelli identici fino al 35%). Di Questo disturbo deve essere differenziato dall'oligofrenia e dalla schizofrenia infantile. La prognosi dipende dalla gravità del difetto organico. La maggior parte dei pazienti mostra qualche miglioramento nel comportamento con l’età. Per il trattamento vengono utilizzati metodi di allenamento speciali, psicoterapia e piccole dosi di aloperidolo.
Disturbo ipercinetico infantile
Disturbo del comportamento ipercinetico (sindrome iperdinamica) è un disturbo dello sviluppo relativamente comune (dal 3 all'8% di tutti i bambini). Il rapporto tra ragazzi e ragazze è 5:1. Caratterizzato da attività estrema, mobilità e attenzione ridotta, che impedisce lezioni regolari e l'assimilazione del materiale scolastico. Il lavoro iniziato, di regola, non è completato; con buone capacità mentali, i bambini cessano rapidamente di interessarsi al compito, perdono e dimenticano le cose, litigano, non riescono a sedersi davanti allo schermo televisivo, infastidiscono costantemente gli altri con domande, spingono, pizzicano e tirano genitori e coetanei. Si presume che il disturbo sia basato su una disfunzione cerebrale minima, ma non si osservano quasi mai chiari segni di una sindrome psicoorganica. Nella maggior parte dei casi, il comportamento si normalizza tra i 12 e i 20 anni, ma per prevenire la formazione di tratti antisociali psicopatici persistenti, il trattamento dovrebbe iniziare il prima possibile. La terapia si basa su un'educazione persistente e strutturata (controllo rigoroso da parte di genitori ed educatori, esercizio fisico regolare). Oltre alla psicoterapia vengono utilizzati anche farmaci psicotropi. I farmaci nootropici sono ampiamente utilizzati: piracetam, pantogam, fenibut, encephabol. La maggior parte dei pazienti sperimenta un paradossale miglioramento del comportamento con l'uso di psicostimolanti (sydnocarb, caffeina, derivati della fenamina, antidepressivi stimolanti - imipramina e sydnophen). Quando si utilizzano derivati della fenamina, si osservano occasionalmente un temporaneo ritardo della crescita e una perdita di peso corporeo e può formarsi dipendenza.
Ritardi isolati nello sviluppo delle competenze
I bambini spesso sperimentano un ritardo isolato nello sviluppo di qualsiasi abilità: parlare, leggere, scrivere o contare, funzioni motorie. A differenza dell'oligofrenia, che è caratterizzata da un ritardo uniforme nello sviluppo di tutte le funzioni mentali, con i disturbi sopra elencati, di solito, con l'avanzare dell'età, si osserva un miglioramento significativo della condizione e un appianamento del ritardo esistente, sebbene alcuni disturbi possono rimanere negli adulti. Per la correzione vengono utilizzati metodi pedagogici.
L'ICD-10 comprende diverse sindromi rare, presumibilmente di natura organica, che si verificano durante l'infanzia e sono accompagnate da un disturbo isolato di determinate abilità.
Sindrome di Landau-Kleffner si manifesta come una compromissione catastrofica della pronuncia e della comprensione del parlato all'età di 3-7 anni dopo un periodo di sviluppo normale. La maggior parte dei pazienti presenta crisi epilettiformi e quasi tutti presentano anomalie EEG con epiattività temporale patologica mono o bilaterale. Il recupero si osserva in 1/3 dei casi.
Sindrome di Rett si verifica solo nelle ragazze. Si manifesta con perdita delle capacità manuali e della parola, combinata con ritardo della crescita della testa, enuresi, encopresi e attacchi di mancanza di respiro, talvolta con attacchi epilettici. La malattia si verifica all'età di 7-24 mesi sullo sfondo di uno sviluppo relativamente favorevole. In età più avanzata si manifestano atassia, scoliosi e cifoscoliosi. La malattia porta a una grave disabilità.
Disturbi di alcune funzioni fisiologiche nei bambini
Enuresi, encopresi, alimentazione non commestibile (pica), balbuzie possono manifestarsi come disturbi indipendenti o (più spesso) come sintomi di nevrosi infantili e lesioni cerebrali organiche. Spesso molti di questi disturbi o la loro combinazione con i tic possono essere osservati nello stesso bambino in età diverse.
Balbuzie Si verifica abbastanza spesso nei bambini. È indicato che la balbuzie transitoria si verifica nel 4% e la balbuzie persistente si verifica nell'1% dei bambini, più spesso nei ragazzi (in vari studi il rapporto tra i sessi è stimato da 2:1 a 10:1). Di solito, la balbuzie si verifica all'età di 4-5 anni in un contesto di normale sviluppo mentale. Il 17% dei pazienti ha una storia ereditaria di balbuzie. Esistono varianti nevrotiche della balbuzie con esordio psicogeno (dopo lo spavento, sullo sfondo di gravi conflitti intrafamiliari) e varianti di origine organica (disontogenetiche). La prognosi per la balbuzie nevrotica è molto più favorevole; dopo la pubertà si osserva la scomparsa dei sintomi o il livellamento nel 90% dei pazienti. La balbuzie nevrotica è strettamente correlata agli eventi traumatici e alle caratteristiche personali dei pazienti (predominano i tratti ansiosi e sospettosi). Caratterizzato da un aumento dei sintomi in situazioni di grande responsabilità e difficile esperienza della propria malattia. Molto spesso, questo tipo di balbuzie è accompagnato da altri sintomi di nevrosi (logoneurosi): disturbi del sonno, pianto, irritabilità, stanchezza, paura di parlare in pubblico (logofobia). L'esistenza a lungo termine dei sintomi può portare allo sviluppo patologico della personalità con un aumento dei tratti astenici e pseudoschizoidi. La variante organicamente condizionata (disontogenetica) della balbuzie si sviluppa gradualmente indipendentemente dalle situazioni traumatiche; le esperienze psicologiche relative al difetto del linguaggio esistente sono meno pronunciate. Si osservano spesso altri segni di patologia organica (sintomi neurologici diffusi, alterazioni dell'EEG). La balbuzie stessa ha un carattere più stereotipato e monotono, che ricorda l'ipercinesia simile al tic. L'aumento dei sintomi è associato più a ulteriori pericoli esogeni (lesioni, infezioni, intossicazioni) che allo stress psico-emotivo. Il trattamento della balbuzie dovrebbe essere effettuato in collaborazione con un logopedista. Nella versione nevrotica, le sedute di logopedia dovrebbero essere precedute dalla psicoterapia di rilassamento (“modalità del silenzio”, psicoterapia familiare, ipnosi, auto-allenamento e altri suggerimenti, psicoterapia di gruppo). Nel trattamento delle opzioni organiche, grande importanza è attribuita alla somministrazione di nootropi e miorilassanti (mydocalm).
Enuresi a vari stadi di sviluppo si osserva nel 12% dei ragazzi e nel 7% delle ragazze. La diagnosi di enuresi viene posta nei bambini di età superiore ai 4 anni; negli adulti questo disturbo si osserva raramente (fino ai 18 anni l'enuresi persiste solo nell'1% dei ragazzi e non si osserva nelle ragazze). Alcuni ricercatori notano la partecipazione di fattori ereditari al verificarsi di questa patologia. Si propone di distinguere tra enuresi primaria (disontogenetica), che si manifesta nel fatto che un ritmo normale di minzione non viene stabilito fin dall'infanzia, e enuresi secondaria (nevrotica), che si verifica nei bambini sullo sfondo di traumi psicologici dopo diversi anni della normale regolazione della minzione. Quest'ultima variante dell'enuresi procede in modo più favorevole e nella maggior parte dei casi scompare entro la fine della pubertà. L'enuresi nevrotica (secondaria), di regola, è accompagnata da altri sintomi di nevrosi: paure, timidezza. Questi pazienti spesso reagiscono emotivamente in modo acuto al disturbo esistente; ulteriori traumi mentali provocano un aumento dei sintomi. L'enuresi primaria (dizontogenetica) è spesso combinata con lievi sintomi neurologici e segni di disontogenesi (spina bifida, prognazia, epicanto, ecc.) E si osserva spesso infantilismo mentale parziale. C'è un atteggiamento più calmo nei confronti del loro difetto, una frequenza rigorosa, non correlata alla situazione psicologica immediata. La minzione durante gli attacchi notturni di epilessia dovrebbe essere distinta dall'enuresi inorganica. Per la diagnosi differenziale, viene esaminato un EEG. Alcuni autori considerano l'enuresi primaria come un segno predisponente all'insorgenza dell'epilessia [Shprecher B.L., 1975]. Per trattare l'enuresi nevrotica (secondaria), vengono utilizzate la psicoterapia calmante, l'ipnosi e l'autoallenamento. Si consiglia ai pazienti con enuresi di ridurre l'assunzione di liquidi prima di coricarsi e di mangiare cibi che promuovono la ritenzione idrica nel corpo (cibi salati e dolci).
Gli antidepressivi triciclici (imipramina, amitriptilina) per l'enuresi nei bambini hanno un buon effetto nella maggior parte dei casi. L'enuresi spesso scompare senza un trattamento speciale.
Tiki
Tiki si verificano nel 4,5% dei ragazzi e nel 2,6% delle ragazze, di solito all'età di 7 anni e oltre, di solito non progrediscono e in alcuni pazienti scompaiono completamente una volta raggiunta la maturità. L'ansia, la paura, l'attenzione degli altri e l'uso di psicostimolanti intensificano i tic e possono provocarli in un adulto che si è ripreso dai tic. Spesso si trova una connessione tra tic e disturbo ossessivo-compulsivo nei bambini. Bisogna sempre differenziare attentamente i tic dagli altri disturbi del movimento (ipercinesia), che spesso sono sintomo di gravi malattie nervose progressive (parkinsonismo, corea di Huntingdon, morbo di Wilson, sindrome di Lesch-Nychen, corea minore, ecc.). A differenza dell’ipercinesi, i tic possono essere soppressi con la forza di volontà. I bambini stessi li trattano come una cattiva abitudine. Per il trattamento dei tic nevrotici vengono utilizzati la psicoterapia familiare, l'ipnosuggestione e il training autogeno. Si consiglia di coinvolgere il bambino in attività fisiche che gli interessano (ad esempio, fare sport). Se la psicoterapia non ha successo, vengono prescritti antipsicotici lievi (Sonapax, Etaparazina, Halotteridolo a piccole dosi).
Una malattia grave manifestata da tic cronici èSindrome di Gilles de la Tourette La malattia inizia durante l'infanzia (di solito tra i 2 ei 10 anni); nei ragazzi 3-4 volte più spesso che nelle ragazze. Inizialmente, i tic compaiono sotto forma di sbattimento delle palpebre, spasmi della testa e smorfie. Dopo alcuni anni nell'adolescenza compaiono tic motori vocali e complessi, che spesso cambiano localizzazione, a volte con una componente aggressiva o sessuale. La coprolalia (parolecce) si osserva in 1/3 dei casi. I pazienti sono caratterizzati da una combinazione di impulsività e ossessioni e da una ridotta capacità di concentrazione. La malattia è di natura ereditaria. C'è un accumulo tra i parenti di pazienti malati con tic cronici e nevrosi ossessiva. Esiste un'elevata concordanza nei gemelli identici (50-90%) e circa il 10% nei gemelli fraterni. Il trattamento si basa sull'uso di antipsicotici (aloperidolo, pimozide) e clonidina in dosi minime. La presenza di ossessioni eccessive richiede anche la prescrizione di antidepressivi (fluoxetina, clomipramina). La farmacoterapia aiuta a controllare le condizioni dei pazienti, ma non cura la malattia. A volte l’efficacia del trattamento farmacologico diminuisce nel tempo.
Peculiarità di manifestazione delle principali malattie mentali nei bambini
Schizofrenia con esordio nell'infanzia, si differenzia dalle varianti tipiche della malattia per un decorso più maligno, una significativa predominanza dei sintomi negativi sui disturbi produttivi. L'esordio precoce della malattia è più comune nei ragazzi (il rapporto tra i sessi è 3,5:1). Nei bambini è molto raro vedere manifestazioni tipiche della schizofrenia come deliri di influenza e pseudoallucinazioni. Predominano i disturbi della sfera motoria e del comportamento: sintomi catatonici ed ebefrenici, disinibizione delle pulsioni o, al contrario, passività e indifferenza. Tutti i sintomi sono caratterizzati da semplicità e stereotipi. Degno di nota è la natura monotona dei giochi, i loro stereotipi e schematismi. Spesso i bambini selezionano oggetti speciali per i giochi (fili, forchette, scarpe) e trascurano i giocattoli. A volte c'è una sorprendente unilateralità di interessi (vedere un esempio clinico che illustra la sindrome da dismorfomania corporea nella sezione 5.3).
Sebbene in quasi tutti i pazienti si possano osservare segni tipici di un difetto schizofrenico (mancanza di iniziativa, autismo, atteggiamento indifferente o ostile nei confronti dei genitori), questi sono spesso combinati con una sorta di ritardo mentale, che ricorda il ritardo mentale. E. Kraepelin (1913) lo identificò come forma indipendentepfropfschizofrenia, combina caratteristiche di oligofrenia e schizofrenia con una predominanza di sintomi ebefrenici. Occasionalmente si osservano forme della malattia in cui lo sviluppo mentale che precede la manifestazione della schizofrenia avviene, al contrario, a un ritmo accelerato: i bambini iniziano a leggere e contare presto e sono interessati a libri che non corrispondono alla loro età. In particolare, è stato notato che la forma paranoide della schizofrenia è spesso preceduta da uno sviluppo intellettivo prematuro.
Alla pubertà, segni frequenti dell'esordio della schizofrenia sono la sindrome dismorfomanica e i sintomi di depersonalizzazione. La lenta progressione dei sintomi e l'assenza di allucinazioni e deliri evidenti possono assomigliare alla nevrosi. Tuttavia, a differenza delle nevrosi, tali sintomi non dipendono in alcun modo dalle situazioni stressanti esistenti e si sviluppano in modo autoctono. Ai sintomi tipici delle nevrosi (paure, ossessioni) si aggiungono presto rituali e senestopatie.
Follia affettiva non si verifica nella prima infanzia. Attacchi affettivi distinti possono essere osservati nei bambini di almeno 12-14 anni. Molto raramente i bambini possono lamentarsi di sentirsi tristi. Più spesso, la depressione si manifesta con disturbi somatovegetativi, disturbi del sonno e dell'appetito e stitichezza. La depressione può essere indicata da letargia persistente, lentezza, sensazioni spiacevoli nel corpo, malumore, pianto, rifiuto di giocare e comunicare con i coetanei e un senso di inutilità. Gli stati ipomaniacali sono più evidenti agli altri. Si manifestano come attività inaspettata, loquacità, irrequietezza, disobbedienza, diminuzione dell'attenzione e incapacità di bilanciare le azioni con le proprie forze e capacità. Negli adolescenti, più spesso che nei pazienti adulti, si osserva un decorso continuo della malattia con un costante cambiamento nelle fasi affettive.
I bambini piccoli raramente mostrano schemi chiari nevrosi. Più spesso si osservano reazioni nevrotiche a breve termine dovute alla paura, uno spiacevole divieto da parte dei genitori per il bambino. La probabilità di tali reazioni è maggiore nei bambini con sintomi di insufficienza organica residua. Non è sempre possibile identificare chiaramente le varianti delle nevrosi caratteristiche degli adulti (nevrastenia, isteria, nevrosi ossessivo-fobica) nei bambini. Degni di nota sono l'incompletezza e la natura rudimentale dei sintomi e la predominanza di disturbi somatovegetativi e motori (enuresi, balbuzie, tic). G.E. Sukhareva (1955) sottolineò che più il bambino è piccolo, più i sintomi della nevrosi sono monotoni.
Una manifestazione abbastanza comune delle nevrosi infantili è una varietà di paure. Nella prima infanzia, questa è la paura degli animali, dei personaggi delle fiabe, degli eroi del cinema; in età prescolare e della scuola primaria - paura dell'oscurità, della solitudine, della separazione dai genitori, della morte dei genitori, ansiosa anticipazione del prossimo lavoro scolastico; negli adolescenti - pensieri ipocondriaci e dismorfofobici, a volte paura della morte. Le fobie si verificano più spesso nei bambini con un carattere ansioso e sospettoso e con maggiore impressionabilità, suggestionabilità e timidezza. L'emergere delle paure è facilitato dall'iperprotezione da parte dei genitori, che consiste in costanti paure ansiose per il bambino. A differenza delle ossessioni degli adulti, le fobie dei bambini non sono accompagnate dalla consapevolezza dell'alienazione e del dolore. Di norma, non esiste un desiderio intenzionale di sbarazzarsi delle paure. Pensieri, ricordi e conteggi ossessivi non sono tipici dei bambini. Abbondanti ossessioni ideative e non cariche emotivamente, accompagnate da rituali e isolamento, richiedono una diagnosi differenziale con la schizofrenia.
Anche le immagini dettagliate della nevrosi isterica nei bambini non vengono osservate. Più spesso si possono osservare attacchi respiratori affettivi con forte pianto, al culmine dei quali si sviluppano arresto respiratorio e cianosi. Talvolta si osserva mutismo selettivo psicogeno. La ragione di tali reazioni potrebbe essere un divieto dei genitori. A differenza dell'isteria negli adulti, le reazioni psicogene isteriche dei bambini si verificano nei ragazzi e nelle ragazze con la stessa frequenza.
I principi di base del trattamento dei disturbi mentali nell'infanzia non differiscono in modo significativo dai metodi utilizzati negli adulti. La psicofarmacoterapia è leader nel trattamento delle malattie endogene. Nel trattamento delle nevrosi, i farmaci psicotropi vengono combinati con la psicoterapia.
BIBLIOGRAFIA
- Bashina V.M. Schizofrenia della prima infanzia (statica e dinamica). - 2a ed. - M.: Medicina, 1989. - 256 p.
- Guryeva V.A., Semke V.Ya., Gindikin V.Ya. Psicopatologia dell'adolescenza. - Tomsk, 1994. - 310 p.
- Zakharov A.I. Neurosi nei bambini e negli adolescenti: anamnesi, eziologia e patogenesi. - JL: Medicina, 1988.
- Kagan V.E. Autismo nei bambini. - M.: Medicina, 1981. - 206 p.
- Kaplan GI, Sadok B.J. Psichiatria clinica: trad. dall'inglese - T. 2. - M.: Medicina, 1994. - 528 p.
- Kovalev V.V. Psichiatria infantile: una guida per i medici. - M.: Medicina, 1979. - 607 p.
- Kovalev V.V. Semiotica e diagnosi della malattia mentale nel bambino e nell'adolescente. - M.: Medicina, 1985. - 288 p.
- Oudtshoorn D.N. Psichiatria infantile e dell'adolescenza: trad. dai Paesi Bassi. /Ed. E IO. Gurovich. - M., 1993. - 319 pag.
- Psichiatria: trad. dall'inglese /Ed. R.Shader. - M.: Praktika, 1998. - 485 p.
- Simeone T.P. Schizofrenia nella prima infanzia. - M.: Medgiz, 1948. - 134 p.
- Sukhareva G.E. Lezioni di psichiatria infantile. - M.: Medicina, 1974. - 320 p.
- Ushakov T.K. Psichiatria infantile. - M.: Medicina, 1973. - 392 p.
Disturbi del linguaggio nei bambini
06.04.2015Snezhana Ivanova
Gli esperti dicono che i disturbi del linguaggio possono essere identificati fin dai primi giorni di vita di un bambino...
La nascita è l'inizio di una nuova vita. Come sarà dipende in gran parte da come si svilupperà l'omino. Pertanto, i genitori devono essere particolarmente responsabili del suo futuro, sia prima che dopo la nascita del bambino. Per fare questo devono interessarsi alla letteratura specializzata che descriva chiaramente le fasi dello sviluppo dei bambini, soprattutto nel primo periodo.
Quindi, il bambino è nato. La prima cosa che facciamo quando lo vediamo è sorridergli e dirgli qualcosa. Avviene la prima comunicazione. In cambio, ci aspettiamo delle risposte. Non ce ne sono ancora. Ma credimi, appariranno presto e ci renderanno incredibilmente felici. Dopotutto, la comunicazione è di grande importanza per un bambino.
Ma cosa fare se il bambino non mostra la stessa attività comunicativa delle mamme che conosci? Non è necessario suonare subito l’allarme. Tutti i bambini sono diversi. Analizza cosa può già fare tuo figlio, confrontalo con cosa dovrebbe essere in grado di fare alla sua età e solo allora contatta uno specialista. Non dimenticare che i bambini devono svilupparsi fin dai primi giorni di vita, richiedono non solo alimentazione e pannolini asciutti, ma anche comunicazione. Ce ne deve essere molto. Forse è questo il problema? In caso contrario, vai avanti.
Cosa indica i disturbi del linguaggio nei bambini?
Gli esperti dicono che i disturbi del linguaggio possono essere identificati fin dai primi giorni di vita di un bambino. Prima di tutto, questo è indicato dal monotono e debole pianto del bambino.
Quali altri segni indicano possibili problemi con la parola?
| Età del bambino, mesi | Cosa non è in grado di fare il bambino? |
| Entro la fine di 1 mese | Non esprime il suo disappunto con un grido quando vuole mangiare o ha altri disagi. |
| Entro la fine di 4 mesi | Non sorride quando le persone gli parlano. |
| Entro la fine del 5 | Non pronuncia singoli suoni o sillabe, non cerca di cercare quegli oggetti indicati dagli adulti ("Dov'è la luce?"). |
| Entro la fine del 7 | Non cerca di attirare l'attenzione emettendo determinati suoni. |
| Entro la fine del 9 | Le parole composte da sillabe identiche (“ma-ma”, “pa-pa”, “give-give”, ecc.) non apparivano. |
| Entro la fine del 10 | Il bambino non pronuncia otto sillabe o combinazioni di suoni, non agita la testa in modo negativo e non risponde con i movimenti delle mani quando dice addio. |
| Entro la fine del 12 | Non dice una sola parola in modo significativo, non ascolta la musica, non soddisfa le richieste semplici ("Dammi un orso!", ecc.). |
| Entro la fine del 15 | Non usa in modo significativo le parole “mamma” e “papà”. |
| Entro la fine del 19 | Non dice parole significative, non mostra le parti del corpo che gli adulti nominano. |
| Entro la fine del 29 | Non capisce il significato delle parole "grande - piccolo". |
Se un bambino ha questi problemi, potrebbe avere disturbi dello sviluppo del linguaggio. Per scoprire la causa del loro aspetto e stabilire una diagnosi accurata, è necessario consultare i seguenti specialisti:
- otorinolaringoiatra (controllerà l'udito del bambino);
- neurologo (per determinare se il bambino ha un danno organico al sistema nervoso centrale, compresi i centri del linguaggio della corteccia cerebrale);
- uno psicologo infantile, logopedista o psichiatra (per determinare lo stato dell'intelligenza non verbale);
- insegnante di logopedista (per la diagnosi finale).
Cause di disturbi del linguaggio
Molte persone sono interessate alle cause dei disturbi del linguaggio nei bambini. Ci sono molti fattori. Possono essere sia esterni che interni. A volte sono combinati tra loro. I principali sono i seguenti:
- Patologie intrauterine.
- Eredità.
- Patologie congenite.
- Malattie dei primi anni di vita di un bambino.
- Condizioni sociali e di vita sfavorevoli.
Patologie intrauterine
Il primo trimestre di gravidanza è molto importante poiché il feto sviluppa il sistema nervoso centrale, comprese le aree del linguaggio della corteccia cerebrale. I fattori più negativi durante questo periodo sono:
- ipossia intrauterina;
- malattie infettive della madre durante la gravidanza (herpes, rosolia, sifilide, toxoplasmosi, influenza, scarlattina, poliomielite, infezione da HIV, morbillo);
- lesioni alla madre durante il trasporto del bambino;
- incompatibilità del sangue tra la madre e il nascituro, che porta alla produzione di anticorpi nel corpo materno e, di conseguenza, il feto rilascia una sostanza tossica che danneggia aree del cervello, che si riflette successivamente nel suo linguaggio e nel suo linguaggio. udito;
- prematurità e postmaturità del feto;
- fumo materno e uso di droghe;
- uso incontrollato di farmaci da parte della madre;
- tentativo di interrompere la gravidanza;
- esposizione della madre a lavori pericolosi, soprattutto nei primi mesi di gravidanza;
- fatica.
Eredità
Se uno dei genitori inizia a parlare tardi, è molto probabile che il bambino abbia gli stessi problemi. Le anomalie genetiche includono anche una struttura non standard dell'apparato articolatorio (numero errato di denti, loro allineamento, problemi con il morso, difetti nella struttura del palato), balbuzie e problemi nello sviluppo delle zone del linguaggio nella corteccia cerebrale.
Patologie congenite
Il parto non è sempre favorevole per il bambino. I più pericolosi per lui sono l'asfissia (disturbi respiratori, che porta alla carenza di ossigeno nel cervello), lesioni alla nascita (bacino stretto nella madre, uso del forcipe per la nascita di un bambino).
Anche un bambino nato con un peso corporeo inferiore a 1500 ge che è stato sottoposto a una serie di misure di rianimazione, inclusa la ventilazione, richiederà un'attenzione speciale durante lo sviluppo.
Tutti i fattori di cui sopra possono causare disturbi del linguaggio in un bambino.
Malattie dei primi anni di vita
I primi anni sono molto significativi nella vita e nello sviluppo di un bambino. Pertanto è necessario diffidare di:
- malattie infettive, in particolare meningite, meningoencefalite, infiammazione dell'orecchio medio e interno (porta alla diminuzione e alla perdita dell'udito, il che significa che la parola soffre);
- lesioni cerebrali;
- danni al cielo.
Condizioni sociali e di vita sfavorevoli
I disturbi del linguaggio sono molto spesso osservati in quei bambini che mancano di comunicazione emotiva e verbale con i propri cari. Ciò non accade necessariamente nelle famiglie in cui i genitori bevono o conducono uno stile di vita immorale. In una famiglia apparentemente prospera, i bambini possono anche essere privati dell’attenzione dei genitori. Una comunicazione insufficiente, soprattutto con la madre, può essere il fattore principale del disturbo del linguaggio di un bambino.
È molto difficile per un bambino sostituire la connessione emotiva con la madre con qualcos'altro. Attenzione, genitori! Nessun giocattolo può sostituirti!
Possiamo quindi riassumere il primo risultato per capire cosa è necessario per prevenire i disturbi del linguaggio nei bambini. La cosa più importante è sapere che la parola è un processo mentale complesso. Un bambino inizia a parlare quando il cervello, l'udito e l'apparato articolatorio raggiungono un certo livello di sviluppo. Molto spesso dipende dall'ambiente. Se un bambino non riceve impressioni vivide, non vengono create per lui le condizioni per il movimento e la comunicazione, presto sperimenterà ritardi sia nello sviluppo fisico che mentale.
Ricorda che il bambino ha davvero bisogno di cure e amore. Se è privato della piena comunicazione con gli adulti o limitato solo a situazioni quotidiane monotone, è probabile che presto il bambino manifesterà disturbi del linguaggio.
Tipi di disturbi del linguaggio nei bambini
Nella moderna logopedia esistono due classificazioni principali dei disturbi del linguaggio: clinico-pedagogico e psicologico-pedagogico. Non si escludono in alcun modo a vicenda, ma aiutano solo a comprendere più a fondo la causa della deviazione e cercare di eliminarla il più possibile (se possibile) o di proteggerla da deviazioni secondarie conseguenti al difetto principale.
Classificazione clinica e pedagogica
La prima classificazione è amichevole per la medicina. Secondo esso si distinguono i disturbi del linguaggio scritto e orale.
Disturbi del linguaggio orale
Nei disturbi del linguaggio orale sono possibili disturbi del linguaggio durante la pronuncia diretta di un'affermazione (disegno fonatore) e deviazioni sistemiche (polimorfiche) (disegno strutturale-semantico).
Violazioni nella progettazione della fonazione
Come risultato di violazioni della registrazione della fonazione durante la pronuncia delle dichiarazioni, nel bambino si osservano le seguenti caratteristiche del linguaggio:
- formazione della voce;
- pronunce sonore;
- ritmi del tempo;
- intonazione.
Il bambino capisce correttamente il parlato, ma non può riprodurlo correttamente a causa di un difetto. In questo contesto, si distinguono le seguenti malattie:
Disfonia caratterizzato da un disturbo o completa assenza di fonazione a causa di patologia dell'apparato vocale (violazione della voce, del suo timbro o intonazione).
Bradilalia caratterizzato da una velocità di parola lenta a causa della patologia.
Tahilalia caratterizzato da un'accelerazione del ritmo della parola.
Balbuzie- Si tratta di disturbi nel tempo e nel ritmo della parola a causa di spasmi muscolari dell'apparato vocale.
Dislalia– Si tratta di difetti del linguaggio con udito normale e apparato articolatorio intatto.
Rinolalia caratterizzato da una violazione del timbro della voce e, di conseguenza, della pronuncia del suono, dovuta alle caratteristiche dell'apparato articolatorio.
Disartria- disturbo del linguaggio a causa di insufficiente innervazione dell'apparato articolatorio.
Violazioni nella progettazione strutturale e semantica
Le deviazioni più gravi sono strutturali e semantiche. A causa del danno alla corteccia cerebrale, un bambino sperimenta una perdita totale o parziale della capacità non solo di riprodurre le affermazioni, ma anche di comprendere. Vengono diagnosticate le seguenti malattie: alalia e afasia.
Alalia– assenza di parola o suo sottosviluppo a causa di danni organici alla corteccia cerebrale nell’area delle zone del linguaggio durante il periodo di sviluppo intrauterino del bambino o in tenera età.
Afasia- perdita della parola, completa o parziale, a causa di un danno cerebrale locale (di norma, la diagnosi viene posta dopo 3 anni).
Disturbi della scrittura
Si possono osservare disturbi della lingua scritta nella lettura o nell'ortografia. Di conseguenza, si notano due diagnosi: dislessia e disgrafia.
Dislessia– una parziale violazione del processo di lettura, che si manifesta nella difficoltà nel riconoscere le lettere e nella loro fusione in sillabe e parole. Ciò porta a una lettura errata delle parole.
Disgrafia si manifesta con disturbi della scrittura. Durante questo difetto, le lettere vengono mescolate e saltate.

Classificazione psicologica e pedagogica
La classificazione psicologica e pedagogica è apparsa con lo scopo di determinare il grado di possibile influenza sulla correzione dei disturbi del linguaggio del bambino durante il processo pedagogico (lezioni con un logopedista).

Sottosviluppo fonetico-fonetico il discorso è caratterizzato da una violazione dei processi di pronuncia, che è associata a difetti nella percezione e nella pronuncia di alcuni fonemi. Ciò vale solo per le comunicazioni nella lingua madre del bambino.
Sottosviluppo del discorso generale osservato nei bambini in cui tutti i componenti del sistema vocale sono compromessi. Il bambino è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche:
- sviluppo del linguaggio successivo;
- il vocabolario è povero;
- difetti sia nella pronuncia che nella formazione dei fonemi.
Balbuzie – questa è una violazione solo nella funzione comunicativa. Allo stesso tempo, tutti gli altri mezzi di comunicazione sono formati correttamente.
Non dovremmo dimenticare che le deviazioni del linguaggio possono essere combinate, ad esempio, con la balbuzie e il sottosviluppo generale del linguaggio.
Distribuzione dei bambini in gruppi in base ai disturbi del linguaggio
Rispettivamente disturbi del linguaggio nei bambini divisi in tre gruppi:
Gruppo 1 – bambini con disturbi del linguaggio fonetico. Di regola, non pronunciano i suoni individuali. Non si osservano altre deviazioni.
Gruppo 2 – bambini con disturbi fonetico-fonemici. In questo caso, il bambino non solo non pronuncia i suoni, ma li distingue anche male e non comprende le differenze articolatorie e acustiche. Questi bambini non sono in grado di analizzare i suoni, hanno difficoltà a imparare a leggere e scrivere, nel discorso orale riorganizzano le sillabe e "ingoiano" le terminazioni delle parole.
Gruppo 3 – questi sono bambini con sottosviluppo generale del linguaggio. Un bambino del genere non distingue i suoni, non li unisce in sillabe, ha un vocabolario scarso e non ha un discorso coerente. Se al bambino non viene fornita un'assistenza speciale logopedica in modo tempestivo, in futuro sono possibili seri problemi nella sfera della comunicazione.
Secondo i disturbi del linguaggio nei bambini, si distinguono tre livelli di sottosviluppo generale del linguaggio (secondo R.E. Levina), se l'udito fisico è preservato:
Primo livello: un bambino di età compresa tra 5-6 anni non parla, emette solo suoni incomprensibili accompagnati da gesti.
Secondo livello: il bambino usa solo parole comuni, alcune forme grammaticali, ma le capacità linguistiche sono significativamente indietro rispetto alla norma.
Terzo livello: il discorso frasale del bambino è sviluppato, ma sono presenti alcuni difetti fonetico-fonemici e lessico-grammaticali. Entra in comunicazione solo in presenza di adulti.
I disturbi del linguaggio influenzano significativamente altre funzioni mentali del bambino. Di norma, questi bambini hanno un'attenzione instabile, difficile da distribuire. Anche il pensiero è diverso, soprattutto verbale-logico. L'analisi e la sintesi, il confronto e la generalizzazione sono difficili per loro. Questi bambini possono avere scarse funzioni locomotorie: coordinazione compromessa, velocità e destrezza ridotte. È molto difficile per loro percepire le istruzioni verbali. Le capacità motorie fini delle mani richiedono un'attenzione speciale.
Un bambino con disturbi del linguaggio, soprattutto gravi, è caratterizzato da forte negativismo, aggressività, suscettibilità, riluttanza a comunicare e stabilire contatti e mancanza di fiducia in se stessi. Questo bambino ha bisogno di aiuto.
Abbiamo capito che i disturbi del linguaggio sono diversi e possono manifestarsi in qualsiasi bambino in qualsiasi fase del suo sviluppo.
Parliamo di cosa si può e si deve fare, a partire dai primi giorni di vita, per prevenire i disturbi del linguaggio in un bambino.
- Comunica costantemente con il bambino, dando alla conversazione quante più emozioni diverse possibili (sorriso, cipiglio, sorpresa, paura, gioia, ammirazione, ecc.). In questo caso, le parole devono essere pronunciate chiaramente.
- Obbligatorio per il bambino ginnastica con le dita. Come non ricordare la famosa poesia "La gazza: il porridge cotto dal corvo". Gli scienziati hanno da tempo dimostrato che sulla punta delle dita ci sono centri nervosi strettamente collegati alle aree del linguaggio della corteccia cerebrale. Pertanto, i massaggi con le dita sono molto utili per il bambino. Devono essere eseguiti sotto forma di gioco. Per fare questo vengono utilizzate poesie in cui viene chiesto al bambino di ripetere determinati movimenti con le dita. In questo caso non si sviluppa solo la parola, ma anche la memoria, vengono create alcune immagini, alle quali vengono poi assegnati concetti specifici.
Quando il bambino cresce, giocare con i mosaici e i set da costruzione, così come disegnare, modellare, allacciare, avvitare tappi, ecc. dovrebbero diventare attività indispensabili.
Tutto ciò contribuirà ad evitare molti disturbi del linguaggio nei bambini.
Molti genitori hanno questa domanda:
Il bambino ha 2,5 anni, ma non pronuncia tutti i suoni. Ha bisogno di aiuto dalla logopedia?
Se consideriamo questa domanda da un punto di vista fisiologico, molto probabilmente l'apparato articolatorio del bambino non è ancora pronto. Non ha abbastanza controllo sulla lingua, sulle labbra o sulle guance. Questa è la norma a questa età. Pertanto, non è necessario rivolgersi a un logopedista, ma è necessario prestare particolare attenzione ai giochi correttivi. La ginnastica per le dita e la lingua dovrebbe diventare obbligatoria. Inoltre, non dimenticare la respirazione. Tutti insieme miglioreranno significativamente la pronuncia dei suoni.
Abbiamo parlato sopra della ginnastica con le dita. Ora proviamo a rendere la lingua “obbediente”.
Esercizi per la lingua
Sottolineiamo subito: prima di iniziare a fare gli esercizi, prova a farli prima da solo, poi con tuo figlio, e poi insegnagli a farlo da solo. Tutti gli esercizi vengono eseguiti davanti a uno specchio. Dovrebbero essere eseguiti senza intoppi, passando dal semplice al complesso.
In modo che il bambino si pronunci bene suoni sibilanti, è bene eseguire l'esercizio “Recinzione”: i denti sono chiusi, le labbra sono tirate in avanti. Mantieni questa posizione per circa 10 secondi.
Per la pronuncia suoni sibilanti Utile l’esercizio “Slide”: apri un po’ la bocca; appoggiare i bordi laterali della lingua contro i molari superiori; la punta della lingua è nella parte anteriore inferiore. Devi tenerlo premuto per 10-15 secondi.
Il logopedista può offrirti molti altri complessi per suoni diversi. La cosa principale è impegnarsi costantemente con il bambino. Solo in questo caso è possibile un risultato positivo nel prossimo futuro.
Esercizi di respirazione
Una corretta respirazione è un aspetto importante quando si pronunciano i suoni. È necessario sviluppare la capacità di parlare in modo fluido e corretto. Per fare ciò esistono esercizi che consentono di aumentare il tempo di espirazione orale da 2 s a 8 s. Inoltre, bisogna insegnare al bambino a respirare sia attraverso la bocca che attraverso il naso; espira con il suono, il magazzino, ecc.
Per fare ciò, puoi eseguire l'esercizio "Tempesta". Saranno necessari un bicchiere d'acqua e una cannuccia da cocktail. Passiamo ora all'esercizio: la bocca è leggermente aperta, la lingua appoggia sui denti inferiori, portiamo il tubo in bocca e lo abbassiamo nel bicchiere. Soffia in modo che l'acqua gorgogli. In questo caso, le guance non dovrebbero gonfiarsi e le labbra dovrebbero rimanere immobili. Il flusso d'aria dopo tali esercizi sarà più mirato e più duraturo.
Sarà utile anche gonfiare palloncini e bolle di sapone, giocare con fischietti e strumenti musicali per bambini: armonica, pipa, ecc.
Molto spesso, i bambini inventano le parole dei loro figli con i suoni che sono convenienti per loro da pronunciare. Chiamiamo “balbettio” la ripetizione di tale vocabolario da parte degli adulti. Quindi, dovrebbe essere evitato. Se gli adulti iniziano a usare tali parole nel loro discorso, rimarranno fissate nella memoria del bambino per un lungo periodo, il che può creare problemi nell'ulteriore sviluppo del suo discorso. Tutte le parole devono essere corrette dopo un errore di pronuncia. In questo caso, il tuo viso dovrebbe essere all’altezza degli occhi del bambino in modo che possa vedere come pronunci tutti i suoni.
Il discorso di un bambino si forma più intensamente durante il periodo prescolare. Questo è un periodo da 3 a 6 anni. In questo caso, i modelli di comportamento del bambino sono i suoi genitori.
Pertanto, dovrebbero parlare al bambino:
- correttamente, senza “balbettare”:
- leggibile, chiaro, con corretta collocazione degli accenti;
- semplice (le frasi consistono di 2-4 parole);
- con parole ripetute per un certo periodo di tempo (il bambino deve ricordarle e imparare a operare con esse nel suo discorso);
- vario nell'intonazione, nel timbro della voce, nel tempo;
- “vivere”, perché emozioni e gesti devono diventare parte della comunicazione.
Se tuo figlio ha 4 anni e osservi problemi persistenti nella sua pronuncia, dovresti assolutamente contattare un logopedista. Dopotutto, quando inizia la scuola, un bambino dovrebbe:
- pronunciare correttamente tutti i suoni della tua lingua madre;
- essere in grado di effettuare analisi parziali del suono;
- avere un vocabolario ricco, composto da parole che appartengono a diverse parti del discorso;
- concordare le parole in genere, caso e numero;
- comporre strutture sintattiche complesse sotto forma di dialogo o monologo.
Se a tuo figlio è stato diagnosticato un disturbo del linguaggio, le sedute con un logopedista sono obbligatorie. Se non inizi a correggere completamente le sue patologie del linguaggio, col tempo inizieranno ad apparire difetti secondari, che porteranno a deviazioni significative nello sviluppo del bambino.
Se il tuo bambino ha disartria, dislalia o alalia motoria
Con queste malattie, la pronuncia del bambino ne risente. Di questo sono “colpevoli” gli organi articolatori, che non ha imparato a controllare. Dopotutto, una persona può produrre suoni solo dopo diversi anni di duro lavoro sullo sviluppo della parola. Ciò include i sistemi cerebrali e la periferia, che sono controllati dal sistema nervoso centrale. Affinché un bambino inizi a pronunciare correttamente i suoni, è necessario combinare questi processi in un unico insieme, e solo in questo caso la lingua, insieme al resto degli organi linguistici, con una corretta respirazione e un funzionamento coordinato del cervello sotto il controllo del sistema nervoso centrale, inizierà a dire ciò che è necessario.
La correzione dei difetti di pronuncia del suono avviene, di regola, in 4 fasi. Ogni fase ha il proprio scopo, obiettivi e direzione del lavoro:
- Preparatorio. Lo scopo di questa fase è preparare la produzione del suono e la sua automazione. Per fare ciò, è necessario sviluppare la percezione uditiva e l'attenzione nel bambino. Ciò può essere ottenuto attraverso lo sviluppo dell'attenzione uditiva, della percezione del linguaggio e della formazione di interesse per la conversazione. In questa fase è importante insegnare al bambino a respirare correttamente e a sviluppare la voce. Sono importanti anche gli esercizi per le labbra, la lingua e tutto il viso. Un posto speciale appartiene alle capacità motorie fini.
- Produzione del suono. La seconda fase ha lo scopo di imparare a pronunciare correttamente un suono in un suono isolato. Per fare ciò, vengono eseguiti esercizi di articolazione per sviluppare i muscoli necessari.
- La sua automazione. La terza fase consiste nello sviluppare la pronuncia corretta del suono in modo automatico. Viene introdotto in una sillaba, parole, ecc.
- Differenziazione. Nell'ultima fase, il bambino impara a differenziare i suoni mediante la percezione uditiva; rafforza la capacità di pronunciarlo correttamente.