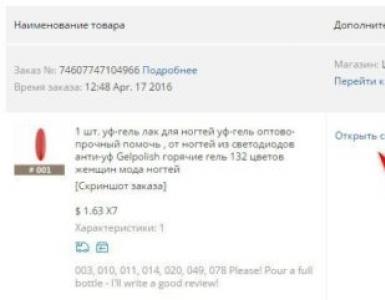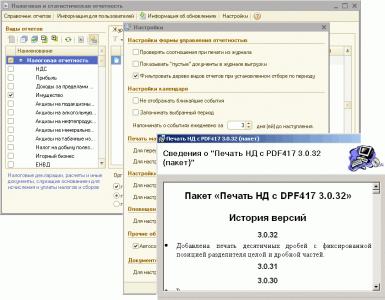Disturbi nei sistemi fisiologici del corpo. Sistemi fisiologici degli organi del corpo umano. Sistema respiratorio
Il corpo umano è costituito da organi. Cuore, polmoni, reni, mano, occhio: tutto questo organi, cioè parti del corpo che svolgono determinate funzioni.
Organo ha la sua forma e posizione unica nel corpo. La forma della mano è diversa dalla forma della gamba, il cuore non è come i polmoni o lo stomaco. A seconda delle funzioni svolte, la struttura dell'organo varia. Di solito un organo è costituito da più tessuti, spesso 4 principali. Uno di questi ha un ruolo primario. Pertanto, il tessuto osseo predominante è l'osso, il tessuto principale della ghiandola è epiteliale, il tessuto principale del muscolo è muscolare. Allo stesso tempo, ogni organo ha tessuto connettivo nervoso ed epiteliale (vasi sanguigni).
Organo fa parte dell'intero organismo e quindi non può funzionare al di fuori del corpo. Allo stesso tempo, il corpo può fare a meno di alcuni organi. Ciò è evidenziato dalla rimozione chirurgica di un arto, di un occhio e di denti. Ogni organo è parte integrante di un sistema di organi fisiologici più complesso. La vita di un organismo è assicurata dall'interazione di un gran numero di organi diversi. Gli organi uniti da una specifica funzione fisiologica costituiscono un sistema fisiologico. Si distinguono i seguenti sistemi fisiologici: tegumentario, di sostegno e di movimento, digestivo, circolatorio, respiratorio, escretore, riproduttivo, endocrino, nervoso.
Principali sistemi di organi
Sistema tegumentario
Struttura: pelle e mucose. Funzioni – proteggono dagli influssi esterni quali disidratazione, sbalzi di temperatura, danni, penetrazione di vari agenti patogeni e sostanze tossiche nel corpo.
Sistema di sostegno e movimento
Struttura – rappresentata da un gran numero di ossa e muscoli; le ossa, collegandosi tra loro, formano lo scheletro delle parti corrispondenti del corpo.
Funzioni – funzione di supporto; lo scheletro svolge anche una funzione protettiva, limitando le cavità occupate dagli organi interni. Lo scheletro e i muscoli forniscono il movimento del corpo.
Struttura - comprende gli organi della cavità orale (lingua, denti, ghiandole salivari, faringe, esofago, stomaco, intestino, fegato, pancreas).
Funzioni: negli organi digestivi il cibo viene frantumato, inumidito con la saliva e viene influenzato dai succhi gastrici e da altri succhi digestivi. Di conseguenza, si formano i nutrienti necessari per il corpo. Vengono assorbiti nell'intestino e trasportati dal sangue a tutti i tessuti e le cellule del corpo.
Sistema circolatorio
Struttura: è costituita dal cuore e dai vasi sanguigni.
Funzioni - il cuore con le sue contrazioni spinge il sangue attraverso i vasi verso gli organi e i tessuti dove avviene il metabolismo continuo. Grazie a questo scambio le cellule ricevono ossigeno e altre sostanze necessarie e vengono liberate da sostanze non necessarie come anidride carbonica e prodotti di scarto.
Sistema respiratorio
Struttura: cavità nasale, rinofaringe, trachea, polmoni.
Funzioni: contribuisce a fornire ossigeno al corpo e a liberarlo dall'anidride carbonica.
Struttura: gli organi principali di questo sistema sono i reni, gli ureteri e la vescica.
Funzioni – svolge la funzione di rimuovere i prodotti metabolici liquidi.
Sistema riproduttivo
Struttura: organi riproduttivi maschili (testicoli), ghiandole riproduttive femminili (ovaie). Lo sviluppo avviene nell'utero.
Funzioni: svolge una funzione, qui si formano le cellule germinali.
Sistema endocrino
Struttura: varie ghiandole. Ad esempio, tiroide, pancreas.
Funzioni: ciascuna ghiandola produce e rilascia sostanze chimiche speciali nel sangue. Queste sostanze sono coinvolte nella regolazione delle funzioni di tutte le cellule e i tessuti del corpo.
Sistema nervoso
Struttura: recettori, nervi, cervello e midollo spinale.
Funzioni – unisce tutti gli altri sistemi, regola e coordina le loro attività. Grazie al sistema nervoso vengono svolte l'attività mentale e il comportamento umano.
Schema di costruzione di un organismo
Molecole - organelli cellulari - cellule - tessuti - organi - sistemi di organi- organismo
Fisiologia– la scienza dei meccanismi di funzionamento e regolazione dell’attività di cellule, organi, sistemi del corpo nel suo insieme e la sua interazione con l’ambiente.
Organismoè un sistema macromolecolare aperto che si autoregola, si autoripara e si ripropone con l'aiuto del metabolismo e dell'energia continui, capace di sentire, muoversi attivamente e intenzionalmente e adattarsi nell'ambiente.
Tessileè un sistema di cellule e strutture non cellulari unite da un'origine, struttura e funzione comune. Esistono 4 tipi di tessuto: muscolare, nervoso, epiteliale e connettivo.
Organo- questa è una parte del corpo, isolata sotto forma di un complesso di tessuti che svolgono funzioni specifiche. Un organo è costituito da unità strutturali e funzionali, che sono una cellula o un insieme di cellule in grado di svolgere la funzione principale dell'organo su piccola scala.
Sistema fisiologicoè un insieme ereditariamente fisso di organi e tessuti che svolgono una funzione comune.
Sistema funzionaleè un insieme dinamico di singoli organi e sistemi fisiologici che si forma per ottenere un risultato adattivo benefico per il corpo.
Funzione- è l'attività specifica di cellule, organi e apparati per assicurare le funzioni vitali dell'intero organismo.
Fattori di affidabilità dei sistemi fisiologici– processi che aiutano a mantenere la vita del sistema in condizioni ambientali difficili. I fattori di affidabilità dei sistemi fisiologici includono
· Duplicazione in sistemi fisiologici;
· Riserva degli elementi strutturali dell'organo e loro mobilità funzionale;
· Rigenerazione di una parte danneggiata di un organo o tessuto e sintesi di nuovi elementi strutturali;
· Adattamento;
· Migliorare la struttura degli organi nella filo- e ontogenesi;
· Funzionamento economico;
· Plasticità del sistema nervoso centrale;
· Fornire ossigeno al corpo.
Fisiologia cellulareCellulaè un'unità strutturale e funzionale di un organo (tessuto) in grado di esistere in modo indipendente, svolgendo una funzione specifica in un piccolo volume, crescendo, moltiplicandosi e rispondendo attivamente all'irritazione.
Membrana cellulare- membrana cellulare, che forma uno spazio chiuso contenente protoplasma.
Protoplasma– la totalità di tutti gli elementi intracellulari (ialoplasma, organelli e inclusioni).
Citoplasma- Questo è protoplasma, ad eccezione del nucleo.
Ialoplasma (citosol)– un ambiente interno omogeneo della cellula, contenente sostanze nutritive (glucosio, aminoacidi, proteine, fosfolipidi, deposito di glicogeno) e che garantisce l’interazione di tutti gli organelli cellulari.
Funzioni delle cellule:
1. Funzioni generali garantire l’attività vitale della cellula stessa. Sono divisi in
a) sintesi di strutture e composti tissutali e cellulari necessari alla vita;
b) produzione di energia (si verifica a seguito del catabolismo - il processo di decomposizione);
c) trasferimento transmembrana di sostanze;
d) riproduzione cellulare;
e) disintossicazione dai prodotti metabolici, che si realizza attraverso i seguenti meccanismi: disintossicazione dell'ammoniaca attraverso la formazione di glutammina e urea; trasferimento di sostanze tossiche formate nella cellula in sostanze idrosolubili a bassa tossicità; neutralizzazione dei radicali attivi dell'ossigeno mediante il sistema antiossidante;
e) funzione del recettore.
2. Funzioni cellulari specifiche: contrattile; percezione, trasmissione del segnale, assimilazione e memorizzazione delle informazioni; lo scambio di gas; supporto; protettivo.
Funzioni degli organelli cellulariLa cellula contiene due tipi di organelli: membrana (nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, mitocondri, lisosomi) e senza membrana (ribosomi, microtubuli, microfilamenti, filamenti intermedi).
Funzioni degli organelli di membrana:
· Nucleo – trasporta informazioni genetiche e fornisce la regolazione della sintesi proteica nella cellula.
· Reticolo endoplasmatico - è un serbatoio di ioni, assicura la sintesi e il trasporto di varie sostanze e garantisce la disintossicazione delle sostanze tossiche.
· Apparato del Golgi – prevede la fase di formazione e maturazione degli enzimi lisosomiali, proteine, glicoproteine di membrana.
· Lisosomi – digestione delle sostanze organiche che entrano nella cellula (acidi nucleici, granuli di glicogeno, componenti della cellula stessa, batteri fagocitati).
· Perossisomi – con i loro enzimi catalizzano la formazione e la decomposizione del perossido di idrogeno.
· Mitocondri – rilasciano la maggior parte dell'energia dai nutrienti che entrano nel corpo e partecipano alla sintesi dei fosfolipidi e degli acidi grassi.
Funzioni degli organelli privi di membrana:
· Ribosomi – sintetizzano le proteine.
· Microtubuli – negli assoni e nei dendriti dei neuroni, sono coinvolti nel trasporto di sostanze.
· Microfilamenti, filamenti intermedi formano il citoscheletro cellulare, che garantisce il mantenimento della forma cellulare, il movimento intracellulare degli organelli di membrana, il movimento della membrana cellulare e delle cellule stesse, l'organizzazione dei fusi mitotici, la formazione di pseudopodi.
Caratteristiche strutturali e funzionali della membrana cellulareLa membrana cellulare è una sottile piastra lipoproteica, il cui contenuto lipidico è del 40%, proteine - 60%. Sulla superficie esterna della membrana è presente una piccola quantità di carboidrati associati a proteine (glicoproteine) o lipidi (glicolipidi). Questi carboidrati sono coinvolti nella ricezione di sostanze biologicamente attive e reazioni immunitarie.
La base strutturale della membrana cellulare - matrice– costituisce uno strato biomolecolare di fosfolipidi, che costituisce una barriera verso particelle cariche e molecole di sostanze idrosolubili. I lipidi forniscono un'elevata resistenza elettrica della membrana cellulare. Le molecole di fosfolipidi di membrana sono costituite da due parti: una porta una carica ed è idrofila, l'altra non porta carica ed è idrofoba. Nella membrana cellulare, le regioni idrofile di alcune molecole sono dirette all'interno della cellula e altre verso l'esterno. Nello spessore della membrana, le molecole di fosfolipidi interagiscono con le regioni idrofobiche. Questo forma una forte struttura lipidica a doppio strato. Lo strato lipidico contiene molto colesterolo.
La membrana cellulare contiene un gran numero di proteine, che sono suddivise nelle seguenti classi: integrali, strutturali, enzimi, trasportatori, proteine che formano canali, pompe ioniche, recettori specifici. La stessa proteina può essere un enzima, un recettore e una pompa. Molte molecole proteiche hanno parti idrofobe e idrofile. Le parti idrofobe delle proteine sono immerse in uno strato lipidico che non trasporta alcuna carica. Le regioni idrofile delle proteine interagiscono con le regioni idrofile dei lipidi, garantendo la resistenza della membrana. Le molecole proteiche incorporate nella matrice sono chiamate integrali. La maggior parte di queste proteine sono glicoproteine. Formano canali ionici. Le proteine attaccate all'esterno della membrana sono chiamate proteine di superficie. Di solito si tratta di proteine enzimatiche.
La membrana cellulare ha permeabilità selettiva. Quindi, qualsiasi membrana consente alle sostanze liposolubili di passare bene. Alcune membrane consentono un buon passaggio dell'acqua. La membrana non consente il passaggio degli anioni degli acidi organici. La membrana è dotata di canali che consentono il passaggio selettivo degli ioni sodio, potassio, cloro e calcio. La maggior parte delle membrane ha una carica superficiale negativa, fornita dalla parte carboidratica di fosfolipidi, glicolipidi e glicoproteine che sporgono dalla membrana. La membrana ha fluidità, quindi le sue singole parti possono muoversi.
Funzioni della membrana cellulare:
· il recettore - svolto dalle glicoproteine e dai glicolipidi delle membrane - svolge il riconoscimento cellulare, lo sviluppo dell'immunità;
· barriera o protettiva - svolta dalle membrane cellulari di tutti i tessuti del corpo;
· trasporto - collabora con la funzione barriera - costituisce la composizione dell'ambiente intracellulare, il più favorevole per il decorso ottimale delle reazioni metaboliche. Fornisce: a) pressione osmotica e pH; b) l'ingresso attraverso il tratto gastrointestinale nel sangue e nella linfa delle sostanze necessarie per la sintesi delle strutture cellulari e la produzione di energia; c) la creazione di cariche elettriche, il verificarsi e la propagazione dell'eccitazione; d) attività contrattile dei muscoli; e) rilascio di prodotti metabolici nell'ambiente; f) rilascio di ormoni ed enzimi;
· creazione di una carica elettrica e comparsa di un potenziale d'azione nei tessuti eccitabili;
· produzione di sostanze biologicamente attive - trombossani, leucotrieni, protoglandine.
Trasporto primario delle sostanzeIl trasporto primario avviene contro la concentrazione e i gradienti elettrici utilizzando speciali pompe ioniche e un meccanismo microvescicolare dentro o fuori la cellula. Assicura il trasferimento della stragrande maggioranza delle sostanze e dell'acqua nel corpo, l'attività vitale di tutte le cellule e dell'organismo nel suo insieme.
1. Trasporto tramite pompe. Le pompe sono localizzate sulle membrane cellulari o sulle membrane degli organelli cellulari e sono proteine integrali con proprietà di trasportatore e attività ATPasi. Le principali caratteristiche delle pompe sono le seguenti:
a) le pompe funzionano costantemente e assicurano il mantenimento dei gradienti di concentrazione degli ioni, questo assicura la creazione di una carica elettrica della cella e favorisce il movimento dell'acqua e delle particelle scariche secondo le leggi della diffusione e dell'osmosi, creando una carica elettrica della cella . Quasi tutte le cellule sono caricate internamente negativamente rispetto all'ambiente esterno.
b) il principio di funzionamento delle pompe è lo stesso: la pompa Na/K (Na/K-ATPasi) è elettrogenica, poiché in un ciclo vengono rimossi 3 ioni Na+ dalla cellula e 2 ioni K+ vengono restituiti alla cellula cellula. Per ogni ciclo di funzionamento della pompa Na/K viene consumata una molecola di ATP e questa energia viene spesa solo per il trasporto dello ione Na+.
c) la pompa sodio-potassio è una proteina integrale composta da quattro polipeptidi e dotata di centri di legame per sodio e potassio. Esiste in due conformazioni: E 1 ed E 2. La conformazione E 1 è rivolta verso l'interno della cellula e ha affinità per lo ione sodio. Ad esso vengono aggiunti 3 ioni sodio. Di conseguenza, viene attivata l'ATPasi, che garantisce l'idrolisi dell'ATP e il rilascio di energia. L'energia cambia la conformazione E 1 nella conformazione E 2, con il sodio 3 che finisce all'esterno della cellula. Ora la conformazione E 2 perde la sua affinità per il sodio e acquista affinità per il potassio. 2 potassio si attaccano alla proteina pompa e la conformazione cambia immediatamente. Il potassio finisce all'interno della cellula e viene interrotto. Questo è un ciclo di funzionamento della pompa. Quindi il ciclo si ripete. Questo tipo di trasporto è chiamato antiporto. I principali attivatori di tale pompa sono l'aldosterone e la tiroxina, e gli inibitori sono le strofantine e la carenza di ossigeno.
d) le pompe del calcio (Ca-ATPasi) funzionano allo stesso modo, solo che il calcio viene trasferito solo in una direzione (dallo ialoplasma al reticolo sarco-o endoplasmatico, e anche all'esterno della cellula). Qui il magnesio è necessario per rilasciare energia.
e) la pompa protonica (H-ATPasi) è localizzata nei tubuli renali, nella membrana delle cellule parietali dello stomaco. Funziona costantemente in tutti i mitocondri.
f) le pompe sono specifiche: ciò si manifesta nel fatto che solitamente trasportano uno o due ioni specifici.
2. Trasporto microvescicolare. Utilizzando questo tipo di trasporto, vengono trasferite proteine molecolari di grandi dimensioni, polisaccaridi e acidi nucleici. Esistono tre tipi di questo trasporto: a) endocitosi - trasferimento di una sostanza nella cellula; b) l'esocitosi è il trasporto di una sostanza dalla cellula; c) transcitosi – una combinazione di endocitosi ed esocitosi.
3. Filtrazione – trasporto primario, in cui il passaggio di una soluzione attraverso una membrana semipermeabile viene effettuato sotto l'influenza di un gradiente di pressione idrostatica tra liquidi su entrambi i lati di questa membrana.
Trasporto secondario di sostanzeIl trasporto secondario è la transizione di varie particelle e molecole d'acqua dovuta all'energia (potenziale) precedentemente immagazzinata, che viene creata sotto forma di gradienti elettrici, di concentrazione e idrostatici. Trasporta gli ioni attraverso i canali ionici e include i seguenti meccanismi.
1. Diffusione: le particelle si spostano da un'area ad alta concentrazione a un'area a bassa concentrazione. Se le particelle sono cariche, la direzione della diffusione è determinata dall'interazione tra concentrazione (chimica) e gradienti elettrici (la loro combinazione è chiamata gradiente elettrochimico). Se le particelle non sono cariche, la direzione della loro diffusione è determinata solo dal gradiente di concentrazione. Le molecole polari si diffondono più velocemente di quelle non polari. Gli ioni si diffondono solo attraverso i canali ionici. L'acqua si diffonde attraverso canali formati da acquaporioni. L'anidride carbonica, l'ossigeno, le molecole di acidi grassi non dissociati, gli ormoni - molecole non polari - si diffondono lentamente.
2. La diffusione semplice avviene attraverso i canali o direttamente attraverso lo strato lipidico. Ormoni steroidei, tiroxina, urea, etanolo, ossigeno, anidride carbonica, farmaci, veleni possono entrare nella cellula per semplice diffusione.
3. La diffusione facilitata è caratteristica delle particelle non elettrolitiche in grado di formare complessi con molecole trasportatrici. Ad esempio, l’insulina trasporta il glucosio. Il trasferimento avviene senza consumo diretto di energia.
4. Il trasporto dipendente dal sodio è un tipo di diffusione che viene effettuata utilizzando un gradiente di concentrazione di ioni sodio, la cui creazione richiede energia. Esistono due opzioni per questo meccanismo di trasporto di sostanze dentro o fuori la cellula. La prima opzione è simportazione, la direzione di movimento della sostanza trasportata coincide con la direzione di movimento del sodio secondo il suo gradiente elettrochimico. Avviene senza consumo diretto di energia. Ad esempio, il trasferimento del glucosio dai tubuli prossimali del nefrone alle cellule tubulari dell'urina primaria. Seconda opzione - antiporto. Questo movimento delle particelle trasportate è diretto nella direzione opposta al movimento del sodio. Ad esempio, questo è il modo in cui si muove il calcio, uno ione idrogeno. Se il trasporto di due particelle è accoppiato tra loro, viene chiamato tale trasporto controsport.
5. L'osmosi è un caso speciale di diffusione: il movimento dell'acqua attraverso una membrana semipermeabile in un'area con una maggiore concentrazione di particelle, cioè con una maggiore pressione osmotica. In questo tipo di trasporto non si spreca energia.
Canali ioniciIl numero di canali ionici sulla membrana cellulare è enorme: ci sono circa 50 canali del sodio per 1 µm2, in media si trovano a una distanza di 140 nm l'uno dall'altro.
Caratteristiche strutturali e funzionali canali ionici. I canali hanno un'uscita e un filtro selettivo, mentre i canali controllati hanno anche un meccanismo di gate. I canali sono pieni di liquido. La selettività dei canali ionici è determinata dalla loro dimensione e dalla presenza di particelle cariche nel canale. Queste particelle hanno una carica opposta alla carica dello ione che attraggono. Anche le particelle scariche possono passare attraverso i canali. Gli ioni che passano attraverso il canale devono liberarsi dal guscio di idratazione, altrimenti le loro dimensioni saranno maggiori del diametro del canale. Uno ione troppo piccolo, passando attraverso il filtro selettivo, non può rinunciare al suo involucro di idratazione, quindi non può passare attraverso il canale.
Classificazione dei canali. Esistono i seguenti tipi di canali:
· Controllato e non controllato – determinato dalla presenza di un meccanismo di cancello.
· Canali controllati elettro, chemio e meccanicamente.
· Veloce e lento – a seconda della velocità di chiusura e apertura.
· Ione-selettivo: consente il passaggio di uno ione e canali che non hanno selettività.
La caratteristica principale dei canali è che possono essere bloccati da determinate sostanze e farmaci. Ad esempio, novocaina, atropina, tetrodotossina. Per lo stesso tipo di ione possono esistere diversi tipi di canali.
Proprietà del tessuto biologico. IrritantiDi base proprietà del tessuto biologico il seguente:
1. L'irritabilità è la capacità della materia vivente di cambiare attivamente la natura della sua attività vitale sotto l'influenza di uno stimolo.
2. L'eccitabilità è la capacità di una cellula di generare un potenziale d'azione quando stimolata. I tessuti connettivi ed epiteliali non sono eccitabili.
3. La conduttività è la capacità dei tessuti e delle cellule di trasmettere l'eccitazione.
4. La contrattilità è la capacità del tessuto di modificare la propria lunghezza e/o tensione sotto l'azione di uno stimolo.
Stimoloè un cambiamento nell'ambiente esterno o interno del corpo, percepito dalle cellule e che provoca una risposta. Uno stimolo adeguato è quello verso il quale la cellula, nel processo di evoluzione, ha acquisito la massima sensibilità grazie allo sviluppo di strutture speciali che percepiscono questo stimolo.
Caratteristiche della regolazione delle funzioni corporeeRegolazione delle funzioni– questo è un cambiamento diretto nell’intensità del lavoro di organi, tessuti, cellule per ottenere un risultato utile in base alle esigenze del corpo in varie condizioni della sua vita. Il regolamento è classificato in due direzioni: 1. Secondo il meccanismo della sua attuazione (tre meccanismi: nervoso, umorale e miogenico); 2. dal momento della sua attivazione relativa al momento della variazione del valore dell'indicatore regolamentato dell'organismo (due tipologie di regolazione: per deviazione e anticipo). In ogni caso si distinguono i livelli di regolazione cellulare, organico, sistemico e organismico.
Meccanismo di regolazione neurale
Questo tipo di regolazione delle funzioni è il principale e il più veloce. Inoltre ha un effetto preciso e locale su un singolo organo o anche su un gruppo separato di cellule di un organo. Uno dei principali meccanismi di regolazione nervosa è l'influenza unidirezionale dei sistemi simpatico e parasimpatico. Si distinguono i seguenti tipi di influenze del sistema nervoso autonomo:
· Influenza scatenante– provoca l’attività di un organo che è a riposo. Ad esempio, innescando la contrazione di un muscolo a riposo quando gli impulsi arrivano dai motoneuroni del midollo spinale o del tronco lungo le fibre nervose efferenti. L'effetto scatenante si realizza attraverso processi elettrofisiologici.
· Influenza modulante (correttiva).– provoca un cambiamento nell’intensità dell’attività degli organi. Si manifesta in due varianti: a) effetto modulante su un organo già funzionante; eb) un effetto modulante sugli organi funzionanti in modalità automatica. Attraverso l'azione trofica, elettrofisiologica e vasomotoria del sistema nervoso si realizza un effetto modulante.
Pertanto, il sistema nervoso autonomo e quello somatico hanno un effetto sia di attivazione che di modulazione sull'attività degli organi. Il sistema nervoso autonomo ha solo un effetto modulante sui muscoli scheletrici e cardiaci.
Il prossimo punto importante è questo la regolazione nervosa viene effettuata secondo il principio del riflesso. Riflesso- Questa è la risposta del corpo all'irritazione dei recettori sensoriali, effettuata utilizzando il sistema nervoso. Ogni riflesso viene effettuato attraverso un arco riflesso. Un arco riflesso è un insieme di strutture con l'aiuto delle quali viene eseguito un riflesso. L'arco riflesso di qualsiasi riflesso è costituito da cinque collegamenti:
1. Collegamento percettivo– recettore – fornisce la percezione dei cambiamenti nell’ambiente esterno ed interno del corpo. La raccolta di recettori si chiama zona riflessogena.
2. Collegamento afferente. Per il sistema nervoso somatico è un neurone afferente con i suoi processi; il suo corpo è situato nei gangli spinali o nei gangli dei nervi cranici. Il ruolo di questo collegamento è trasmettere il segnale al sistema nervoso centrale al terzo collegamento dell'arco riflesso.
3. Collegamento di gestione– un insieme di neuroni centrali (per il SNA e periferici) che formano la risposta del corpo.
4. Collegamento efferente– questo è l’assone di un neurone effettore (per il sistema nervoso somatico – un motoneurone).
5. Effettore- corpo funzionante. Il neurone effettore del sistema nervoso somatico è il motoneurone.
Tutti i riflessi sono divisi in gruppi:
· Congenito (incondizionato) e acquisito (condizionato);
· Somatico e vegetativo;
· Riflesso omeostatico, protettivo, sessuale, di orientamento;
· Mono- e polisinaptico;
· esterocettivo, interocettivo e propriocettivo;
· Centrale e periferica;
· Proprio e associato.
Regolazione umorale
Il collegamento ormonale nella regolazione delle funzioni corporee viene attivato con l'aiuto del sistema nervoso autonomo, cioè il sistema endocrino è subordinato al sistema nervoso. La regolazione umorale avviene lentamente e, a differenza del sistema nervoso, ha un effetto generalizzato. Inoltre, il meccanismo di regolazione umorale ha spesso effetti opposti delle sostanze biologicamente attive sullo stesso organo. Gli ormoni sono sostanze biologicamente attive prodotte da ghiandole endocrine o cellule specializzate. Gli ormoni vengono prodotti anche dalle cellule nervose: in questo caso vengono chiamati neuroormoni. Tutti gli ormoni entrano nel sangue e agiscono sulle cellule bersaglio in varie parti del corpo. Esistono anche ormoni prodotti da cellule non specializzate: si tratta di ormoni tissutali o paracrini. L'influenza ormonale su organi, tessuti e sistemi del corpo è divisa in
· funzionale, che a sua volta si divide in innescante, modulante e permissiva;
· morfogenetico.
Oltre alla regolazione endocrina, esiste anche la regolazione con l'aiuto dei metaboliti, prodotti formati nel corpo durante il processo metabolico. I metaboliti agiscono principalmente come regolatori locali. Ma ci sono effetti dei metaboliti sui centri nervosi.
Meccanismo di regolazione miogenico
L'essenza del meccanismo di regolazione miogenico è che lo stiramento moderato preliminare del muscolo scheletrico o cardiaco aumenta la forza delle loro contrazioni. Il meccanismo miogenico svolge un ruolo importante nella regolazione della pressione idrostatica negli organi e nei vasi cavi.
Unità dei meccanismi regolatori e principio sistemico di regolazione
L'unità dei meccanismi regolatori risiede nella loro interazione. Pertanto, quando l'aria fredda agisce sui termorecettori cutanei, aumenta il flusso di impulsi afferenti nel sistema nervoso centrale; questo porta al rilascio di ormoni che aumentano il tasso metabolico e aumentano la produzione di calore. Il principio sistemico di regolazione è che vari indicatori del corpo vengono mantenuti a un livello ottimale con l'aiuto di molti organi e sistemi. Pertanto, la pressione parziale di ossigeno e anidride carbonica è fornita dall'attività dei sistemi: cardiovascolare, respiratorio, neuromuscolare, sanguigno.
Funzioni della barriera ematoencefalica
La funzione regolatrice della BBB è quella di formare uno speciale ambiente interno del cervello, garantendo una modalità ottimale di attività delle cellule nervose e consentendo selettivamente il passaggio di molte sostanze umorali. La funzione barriera è svolta da una struttura speciale delle pareti dei capillari cerebrali: il loro endotelio, così come la membrana basale che circonda il capillare dall'esterno. Oltre al BBB, svolge una funzione protettiva: impedisce l'ingresso di microbi, sostanze estranee o tossiche. La BBB non consente il passaggio di molti farmaci.
Affidabilità dei sistemi regolatori
L’affidabilità dei sistemi normativi è assicurata dai seguenti fattori:
1. Interazione e complementazione di tre meccanismi regolatori (nervoso, umorale e miogenico).
2. L'azione dei meccanismi nervoso e umorale può essere multidirezionale.
3. L'interazione delle divisioni simpatica e parasimpatica del sistema nervoso autonomo è sinergica.
4. Le divisioni simpatica e parasimpatica del SNA possono causare un duplice effetto (sia attivazione che inibizione).
5. Esistono diversi meccanismi per regolare il livello degli ormoni nel sangue, il che aumenta l'affidabilità della regolazione umorale.
6. Esistono diversi modi di regolazione sistemica delle funzioni.
L'intero corpo di una persona sana o malata, i suoi singoli organi e sistemi, in particolare gli organi circolatori, reagiscono costantemente alle varie irritazioni provenienti dal mondo circostante e interno. In questo caso si formano reazioni adattative che a un certo momento sono utili per i singoli organi e per l'organismo nel suo insieme, e quindi possono trasformarsi in patologiche e richiedere una correzione.
Sistemi funzionali del corpo, secondo P.K. Anokhin, si formano a livello molecolare, omeostatico e comportamentale, come l'interazione di elementi nel raggiungimento di risultati benefici comuni per sistemi e organi. In ogni singolo elemento del sistema funzionale si manifestano le proprietà e gli stati del risultato adattivo finale, utile per l'organismo.
Numerosi flussi di segnali nervosi e speciali molecole informative (oligopeptidi, complessi proteici immunitari, acidi grassi, prostaglandine, ecc.) informano costantemente il cervello sullo stato dei vari tessuti e sui cambiamenti metabolici che si verificano in essi. Diffondendosi dal cervello, i segnali nervosi e le molecole di informazione hanno, a loro volta, effetti regolatori sui processi tissutali. Le informazioni circolano quindi continuamente nell'organizzazione dinamica di vari sistemi funzionali, dal bisogno alla sua soddisfazione.
A causa dell'interazione dei sistemi funzionali del corpo, qualsiasi malattia è sempre accompagnata da cambiamenti in altri organi e strutture somatiche.
I cambiamenti patologici in un organo contribuiscono alla comparsa di cambiamenti negli organi e nei tessuti funzionalmente correlati, prevalentemente innervati dagli stessi segmenti del midollo spinale. Nella zona di innervazione del segmento vengono identificate aree di iperalgesia cutanea, tensione muscolare, dolore del periostio e movimento compromesso nel segmento corrispondente della colonna vertebrale. Tuttavia, l'effetto riflesso non è limitato a un singolo segmento. Cambiamenti patologici possono comparire nelle strutture somatiche e viscerali innervate da altri segmenti del midollo spinale.
A livello del segmento del midollo spinale può verificarsi un'elaborazione intrasegmentale del segnale nocicettivo. Come risultato dell'attivazione delle cellule multimodali, i segnali del dolore possono fluire nei neuroni per vari scopi: motorio, autonomo, ecc. Di conseguenza, vengono stabilite connessioni funzionali: viscero-motoria, dermato-motoria, dermato-viscerale, viscero -viscerale, motorio-viscerale - spesso di natura patologica. Inoltre, i segnali afferenti che entrano nel sistema nervoso centrale dalla lesione possono causare reazioni più generalizzate dovute all'interruzione della regolazione neuroumorale.
Le relazioni viscero-somatiche, tenendo conto delle interrelazioni di vari sistemi funzionali del corpo, possono essere rappresentate da meccanismi di interazione non riflessa e riflessa.
Conseguenza della non riflessività interazione viscero-somatica- destabilizzazione dei meccanismi di elaborazione dei segnali sensoriali all'ingresso dell'apparato segmentale, irritazione dei gruppi neurogeni del corno posteriore del midollo spinale ed eccitazione dei canali sensoriali della pelle, legamenti, muscoli, fascia. Di conseguenza, si formano zone di iperalgesia (zone di Zakharyin-Ged) nel corrispondente dermatomo, miotomo e sclerotomo. Il dolore di solito non è intenso, si basa sulla corrispondenza metamerica dell'organo interessato e di altre strutture, è localizzato nell'area di un metamero e non è accompagnato da ipertonicità locale delle strutture miofasciali. Esiste per un breve periodo di tempo, dopo di che scompare o si trasforma in dolore, che ha un meccanismo riflesso, che a sua volta è la base per la formazione dei punti trigger miofasciali.
I meccanismi riflessi dell'interazione viscero-somatica comprendono le interazioni viscero-motoria, viscero-sclerotomica, viscero-dermatomerica e motore-viscerale.
Le interazioni viscero-motorie nelle malattie acute degli organi interni sono accompagnate dalla formazione di un intenso flusso afferente nocicettivo e dalla difesa muscolare.
La patologia cronica degli organi interni è caratterizzata da un minimo flusso afferente nocicettivo e dalla formazione di ipertono miofasciale, in cui vi è dolore localizzato di varia intensità, contrazione muscolare locale (specialmente nei muscoli paravertebrali tonici).
Nell'interazione viscero-sclerotomale, i meccanismi di attivazione sclerotomale si formano come risultato di un processo riflesso nella fascia, nei legamenti e nel periostio. Questi cambiamenti avvengono più lentamente che nei muscoli.
L'interazione motore-viscerale avviene a causa del flusso di informazioni dal sistema muscolo-scheletrico all'organo interno. In questo caso l'interazione propriocettiva si forma all'interno del segmento (attraverso i sistemi umorale, endocrino e nervoso), poi nella formazione reticolare del tronco cerebrale, nel sistema limbico, nell'ipotalamo, ecc. Poiché gli input afferenti sono strettamente segmentati , e l'output è “sparso” (animazione delle afferenze), quindi la disfunzione dei centri vegetativi trofici colpisce una vasta area.
I rapporti anatomici dei segmenti del midollo spinale, dei dermatomi, dei muscoli e degli organi interni fanno supporre che alcune aree della superficie corporea (pelle, tessuto sottocutaneo, muscoli, tessuto connettivo), attraverso il sistema nervoso, siano collegate con determinati organi interni. Pertanto, in qualsiasi processo patologico sulla superficie del corpo è incluso anche il corrispondente organo interno. E viceversa: con qualsiasi danno all'organo interno, prendono parte al processo anche i tessuti tegumentari corrispondenti a un determinato segmento, l'eliminazione dei cambiamenti patologici in cui è necessario aumentare l'efficacia del trattamento.
Il sistema muscolare è altamente reattivo e risponde a qualsiasi stimolo esterno ed interno principalmente con tensione, seguita da cambiamenti nel tono dell'apparato legamentoso, della fascia e della pelle. La correzione di questi cambiamenti patologici viene effettuata con l'aiuto di esercizi fisici e massaggi. La scelta della tecnica di massaggio, dei tipi di esercizio fisico e dell'intensità dell'esercizio dipende dallo stato funzionale del paziente, dai cambiamenti patologici morfologici e fisiologici caratteristici di una determinata malattia, nonché dai processi biochimici nel corpo che si verificano durante l'allenamento fisico.
Sistemi fisiologici del corpo - scheletrico (scheletro umano), muscolare, circolatorio, respiratorio, digestivo, nervoso, sistema sanguigno, ghiandole endocrine, analizzatori, ecc. Il sangue è un tessuto liquido che circola nel sistema circolatorio e garantisce l'attività vitale delle cellule e tessuti del corpo come organo e sistema fisiologico. È costituito da plasma (55tAF60%) e da elementi formati in esso sospesi: globuli rossi, leucociti, piastrine ed altre sostanze (40tAF45%) ed ha una reazione leggermente alcalina (pH 7,36). La quantità totale di sangue è pari al 7tAF8% del peso corporeo di una persona. A riposo, il 40tAF50% del sangue è escluso dalla circolazione e si trova nei “depositi ematici”: fegato, milza, vasi cutanei, muscoli, polmoni. Se necessario (ad esempio durante il lavoro muscolare), il volume di riserva del sangue viene incluso nella circolazione sanguigna e diretto riflessivamente all'organo funzionante. Il rilascio del sangue dal “deposito” e la sua ridistribuzione in tutto il corpo è regolata dal sistema nervoso centrale (SNC). La perdita di più di 1/3 della quantità di sangue da parte di una persona è pericolosa per la vita. Allo stesso tempo, ridurre la quantità di sangue di 200tAF400 ml (donazione) è innocuo per le persone sane e stimola addirittura i processi ematopoietici. Esistono quattro gruppi sanguigni (I, II, III, IV). Quando si salva la vita di persone che hanno perso molto sangue, o per alcune malattie, le trasfusioni di sangue vengono effettuate tenendo conto del gruppo. Ogni persona dovrebbe conoscere il proprio gruppo sanguigno.
1. Sistemi fisiologici del corpo
Il sistema cardiovascolare. Il cuore è l'organo principale del sistema circolatorio.Il cuore è un organo muscolare cavo che esegue contrazioni ritmiche, grazie alle quali avviene il processo di circolazione sanguigna nel corpo. Il cuore TAF è un dispositivo autonomo e automatico. Tuttavia, il suo lavoro è regolato da numerose connessioni dirette e di feedback provenienti da vari organi e sistemi del corpo. Il cuore è collegato al sistema nervoso centrale, che ha un effetto regolatore sul suo funzionamento. Il sistema cardiovascolare è costituito dalla circolazione sistemica e polmonare. La metà sinistra del cuore serve alla circolazione sistemica, la metà destra serve al piccolo circolo. La pulsazione è un'onda di oscillazioni propagata lungo le pareti elastiche delle arterie in seguito allo shock idrodinamico di una porzione di sangue espulsa nell'aorta sotto pressione durante la contrazione del ventricolo sinistro. La frequenza del polso corrisponde alla frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca a riposo (al mattino, sdraiati, a stomaco vuoto) è inferiore a causa dell'aumento della potenza di ogni contrazione. Una diminuzione della frequenza cardiaca aumenta il tempo di pausa assoluto necessario al riposo del cuore e ai processi di recupero nel muscolo cardiaco. A riposo, la frequenza cardiaca di una persona sana è di 60 AF70 battiti/min. La pressione sanguigna è creata dalla forza di contrazione dei ventricoli del cuore e dall'elasticità delle pareti dei vasi sanguigni. Si misura nell'arteria brachiale. Esistono una pressione massima (sistolica), che si crea durante la contrazione del ventricolo sinistro (sistole), e una pressione minima (diastolica), che si osserva durante il rilassamento del ventricolo sinistro (diastole). Normalmente una persona sana di età compresa tra 18 e 40 anni a riposo ha una pressione arteriosa di 120/70 mmHg. (pressione sistolica 120 mm, diastolica 70 mm). La pressione sanguigna più alta si osserva nell'aorta. Man mano che ti allontani dal cuore, la pressione sanguigna diminuisce sempre di più. La pressione più bassa si osserva nelle vene quando fluiscono nell'atrio destro. Una differenza di pressione costante garantisce un flusso sanguigno continuo attraverso i vasi sanguigni (nella direzione della bassa pressione).
Sistema respiratorio. L'apparato respiratorio comprende la cavità nasale, la laringe, la trachea, i bronchi e i polmoni. Nel processo di respirazione, l'ossigeno entra costantemente nel corpo dall'aria atmosferica attraverso gli alveoli dei polmoni e l'anidride carbonica viene rilasciata dal corpo. Il processo di respirazione del tAU è un intero complesso di processi fisiologici e biochimici, nella cui attuazione è coinvolto non solo l'apparato respiratorio, ma anche il sistema circolatorio. L'anidride carbonica entra nel sangue dalle cellule dei tessuti, dal sangue nei polmoni e dai polmoni nell'aria atmosferica.
Apparato digerente ed escretore. L'apparato digerente è costituito dalla cavità orale, dalle ghiandole salivari, dalla faringe, dall'esofago, dallo stomaco, dall'intestino tenue e crasso, dal fegato e dal pancreas. In questi organi, il cibo viene lavorato meccanicamente e chimicamente, le sostanze alimentari che entrano nel corpo vengono digerite e i prodotti digestivi vengono assorbiti. Il sistema escretore è formato da reni, ureteri e vescica, che assicurano l'escrezione di prodotti metabolici dannosi dal corpo con l'urina (fino al 75%). Inoltre, alcuni prodotti metabolici vengono escreti attraverso la pelle, i polmoni (con l'aria espirata) e attraverso il tratto gastrointestinale. Con l'aiuto dei reni, il corpo mantiene l'equilibrio acido-base (PH), il volume richiesto di acqua e sali e una pressione osmotica stabile.
Sistema nervoso. Il sistema nervoso è costituito da una sezione centrale (cervello e midollo spinale) e da una sezione periferica (nervi che si estendono dal cervello e dal midollo spinale e si trovano alla periferia dei gangli nervosi). Il sistema nervoso centrale coordina le attività di vari organi e sistemi del corpo e regola questa attività in un ambiente esterno mutevole utilizzando il meccanismo riflesso. I processi che si verificano nel sistema nervoso centrale sono alla base di tutta l'attività mentale umana. Il cervello è una raccolta di un numero enorme di cellule nervose. La struttura del cervello è incomparabilmente più complessa della struttura di qualsiasi organo del corpo umano. Il midollo spinale si trova nel canale spinale formato dagli archi vertebrali. La prima vertebra cervicale è il confine superiore del midollo spinale, mentre il confine inferiore è la seconda vertebra lombare. Il midollo spinale è diviso in cinque sezioni con un certo numero di segmenti: cervicale, toracico, lombare, sacrale e coccigeo. Al centro del midollo spinale c'è un canale pieno di liquido cerebrospinale.
Il sistema nervoso autonomo è un dipartimento specializzato del sistema nervoso, regolato dalla corteccia cerebrale. Si divide in sistema simpatico e parasimpatico. L'attività del cuore, dei vasi sanguigni, degli organi digestivi, dell'escrezione, della regolazione del metabolismo, della formazione di calore, della partecipazione alla formazione delle reazioni emotive: tutto questo è sotto la giurisdizione del sistema nervoso simpatico e parasimpatico e sotto il controllo del dipartimento superiore del sistema nervoso centrale.
2. Sistema muscoloscheletrico (parti attive e passive)
I processi motori nel corpo umano sono forniti dal sistema muscolo-scheletrico, costituito da una parte passiva (ossa, legamenti, articolazioni e fascia) e da muscoli attivi, costituiti principalmente da tessuto muscolare. Entrambe queste parti sono interconnesse a livello di sviluppo, anatomico e funzionale. Ci sono tessuti muscolari lisci e striati. Il tessuto muscolare liscio forma le membrane muscolari delle pareti degli organi interni, dei vasi sanguigni e linfatici, nonché dei muscoli della pelle. La contrazione della muscolatura liscia non è soggetta alla volontà, per questo è detta involontaria. Il suo elemento strutturale è una cellula a forma di fuso lunga circa 100 micron, costituita da citoplasma (sarcoplasma), in cui si trovano il nucleo e i filamenti contrattili delle miofibrille lisce. I muscoli striati sono formati da tessuto che è attaccato principalmente a varie parti dello scheletro, motivo per cui sono chiamati anche muscoli scheletrici. Il tessuto muscolare striato è un muscolo volontario, perché le sue contrazioni sono suscettibili di volontà. L'unità strutturale del muscolo scheletrico è una fibra muscolare striata; queste fibre si trovano parallele tra loro e sono interconnesse da tessuto connettivo lasso in fasci. La superficie esterna del muscolo è circondata da un perimisio (membrana del tessuto connettivo). La parte centrale e ispessita del muscolo è chiamata ventre, alle estremità passa nelle parti del tendine. Con l'aiuto dei tendini, il muscolo è attaccato alle ossa dello scheletro. I muscoli hanno forme diverse: lunghi, corti e larghi. Ve ne sono a due teste, a tre teste, a quattro teste, quadrate, triangolari, piramidali, rotonde, frastagliate, a forma di soleo. In base alla direzione delle fibre muscolari si distinguono i muscoli retto, obliquo e orbicolare. In base alla loro funzione i muscoli si dividono in flessori, estensori, adduttori, abduttori e rotatori. I muscoli hanno un apparato ausiliario, che comprende: fascia, canali fibro-ossei, guaine sinoviali e borse. I muscoli sono abbondantemente forniti di sangue grazie alla presenza di un gran numero di vasi sanguigni e hanno vasi linfatici ben sviluppati. Ogni muscolo ha fibre nervose motorie e sensoriali che comunicano con il sistema nervoso centrale. I muscoli che eseguono lo stesso movimento sono detti sinergici, mentre i movimenti opposti sono detti antagonisti. L'azione di ciascun muscolo può avvenire solo con il contemporaneo rilassamento del muscolo antagonista; tale coordinazione è detta coordinazione muscolare. I movimenti complessi (ad esempio camminare) coinvolgono molti gruppi muscolari. I muscoli striati si dividono in muscoli del tronco, della testa e del collo, degli arti superiori e inferiori. I muscoli del tronco sono rappresentati dai muscoli della schiena, del torace e dell'addome. I muscoli della schiena si dividono in superficiali e profondi. I muscoli superficiali includono il trapezio e il latissimus dorsi; l'elevatore della scapola, i muscoli romboidali maggiori e minori; muscoli posteriori dentati superiore e inferiore. I muscoli della schiena sollevano, portano e adducono la scapola, raddrizzano il collo, tirano la spalla e il braccio indietro e verso l'interno e partecipano all'atto della respirazione. I muscoli profondi della schiena raddrizzano la colonna vertebrale. I muscoli del torace sono divisi nei propri muscoli intercostali esterni ed interni e nei muscoli associati al cingolo scapolare e all'arto superiore: pettorale maggiore e minore, succlavia e dentato anteriore. I muscoli intercostali esterni si sollevano e i muscoli intercostali interni abbassano le costole durante l'inspirazione e l'espirazione. I restanti muscoli del torace si sollevano, adducono il braccio e ruotano verso l'interno, tirano la scapola in avanti e verso il basso e abbassano la clavicola. Il torace e la cavità addominale sono separati dal muscolo a cupola e dal diaframma. I muscoli addominali sono rappresentati dagli obliqui esterni ed interni, dal trasverso e dal retto dell'addome, nonché dal muscolo quadrato dei lombi. Il muscolo retto è racchiuso in una robusta guaina formata dai tendini dei muscoli addominali esterni, obliqui interni e trasversali. I muscoli retti dell'addome sono coinvolti nella flessione del busto in avanti, mentre i muscoli obliqui forniscono la flessione laterale. Questi muscoli formano la pressa addominale, la cui funzione principale è mantenere gli organi addominali in una posizione funzionalmente vantaggiosa. Inoltre, la contrazione dei muscoli addominali assicura gli atti della minzione, dei movimenti intestinali e del parto; questi muscoli sono coinvolti nella respirazione, nei movimenti di conati di vomito, ecc. I muscoli addominali sono ricoperti da una fascia esterna. Lungo la linea mediana della parete addominale anteriore si trova una corda muscolare tendinea chiamata linea alba, nella parte centrale della quale si trova un anello ombelicale. Nelle parti laterali inferiori dell'addome si trova il canale inguinale, in cui negli uomini si trova il cordone spermatico, nelle donne si trova il legamento rotondo dell'utero. Tutti i muscoli del viso e della testa sono divisi in due gruppi: facciali e masticatori. I muscoli facciali sono fasci muscolari sottili privi di fascia; Ad un'estremità questi muscoli sono intrecciati nella colonna e, quando contratti, partecipano alle espressioni facciali. I muscoli facciali si trovano in gruppi intorno agli occhi, al naso e alla bocca. I muscoli masticatori sono due superficiali (temporale e massetere) e due profondi (pterigoideo interno ed esterno). Questi muscoli svolgono l'atto della masticazione e forniscono il movimento della mascella inferiore. I muscoli del collo comprendono: i muscoli sottocutaneo e sternocleidomastoideo, i muscoli digastrico, stiloioideo, miloioideo, genioioideo, sternoioideo, omoioideo, sternotiroideo e tiroioideo, scaleni laterali e muscoli prevertebrali. I muscoli dell'arto superiore sono divisi nei muscoli del cingolo scapolare e dell'arto superiore libero. I muscoli del cingolo scapolare (deltoide, sopraspinato, sottospinato, piccolo e grande rotondo e sottoscapolare) circondano l'articolazione della spalla, fornendo al suo interno vari movimenti. I muscoli dell'arto superiore libero - il braccio - si dividono nei muscoli della spalla (bicipite, coracobrachiale, brachiale e tricipite), nei muscoli dell'avambraccio, situati sulle superfici anteriore, posteriore e laterale, e nei muscoli dell'avambraccio mano, adagiato principalmente sulla superficie palmare. Grazie a questi muscoli sono possibili i movimenti del gomito, delle articolazioni del polso e delle articolazioni della mano e delle dita. I muscoli dell'arto inferiore - la gamba - si dividono in muscoli della regione dell'anca e muscoli dell'arto inferiore libero. Il movimento nell'articolazione dell'anca è prodotto da numerosi muscoli, tra cui ci sono quelli interni (ileopsoas, piriforme, otturatore interno) ed esterni (gluteo massimo, medio gluteo, minimo, otturatore esterno, quadrato e tensore della fascia lata). I muscoli dell'arto inferiore libero sono costituiti dai muscoli della coscia, formando 3 gruppi: anteriore, posteriore e interno; stinchi, che formano i gruppi anteriore, posteriore ed esterno, e piedi. I muscoli delle gambe eseguono movimenti nelle articolazioni del ginocchio, della caviglia e del piede. La proprietà principale di tutti i tipi di muscoli è la loro capacità di contrarsi, mentre svolgono una certa quantità di lavoro. La capacità dei muscoli di ridurre attivamente la propria lunghezza durante il lavoro dipende dalla loro capacità di modificare il grado di elasticità sotto l'influenza degli impulsi nervosi. La forza muscolare dipende dal numero di miofibrille nelle fibre muscolari: nei muscoli ben sviluppati ce ne sono di più, nei muscoli poco sviluppati ce ne sono meno. L'allenamento sistematico e il lavoro fisico, durante i quali si verifica un aumento delle miofibrille nelle fibre muscolari, portano ad un aumento della forza muscolare. I muscoli scheletrici, con poche eccezioni, muovono le ossa nelle articolazioni secondo le leggi della leva finanziaria. L'origine del muscolo (punto fisso di attacco) è su un osso e il punto del suo attacco (estremità periferica) è sull'altro. Il punto fisso, o luogo di origine del muscolo, e il suo punto mobile, o luogo di attacco, possono cambiare reciprocamente, a seconda di quale parte del corpo è più mobile in un dato caso. In ogni movimento prendono parte non solo il muscolo che produce questo movimento, ma anche una serie di altri muscoli, in particolare quelli che eseguono il movimento opposto, il che garantisce movimenti fluidi e calmi. Per sfruttare appieno tutta la forza di un dato muscolo, quasi tutti i muscoli del corpo devono essere coinvolti e tesi in un modo o nell'altro durante qualsiasi lavoro. Ecco perché, per svolgere con successo il lavoro muscolare, tutti i muscoli del corpo devono essere sviluppati armoniosamente per evitare l'insorgere di un affaticamento precoce. Nell'uomo i muscoli scheletrici sono 327 pari e 2 spaiati (tabella colori, art. 656, ad Art. Uomo). Tutti i movimenti volontari sono interconnessi e regolati dal sistema nervoso centrale. Il meccanismo della contrazione muscolare viene attivato da un impulso nervoso che raggiunge il muscolo lungo il nervo motore. Le fibre nervose terminano sulle singole fibre muscolari con placche terminali, che di solito si trovano nella parte centrale delle fibre muscolari, che consentono all'intera fibra muscolare essere attivato più rapidamente Le contrazioni della muscolatura liscia delle pareti degli organi interni si verificano lentamente e a forma di verme - la cosiddetta onda peristaltica, grazie alla quale il loro contenuto si muove, in particolare il contenuto dello stomaco e dell'intestino. la muscolatura liscia avviene automaticamente, sotto l'influenza dei riflessi interni. Pertanto, i movimenti peristaltici causati dalla muscolatura liscia dello stomaco e dell'intestino si verificano nel momento in cui il cibo entra in essi. Tuttavia, la peristalsi è influenzata anche dai centri nervosi superiori. Il muscolo cardiaco differisce nella struttura e nella funzione dei muscoli striati e lisci. Ha una proprietà che è assente in altri muscoli, cioè la contrazione automatica, che ha un certo ritmo e forza. Il muscolo cardiaco non interrompe il suo lavoro ritmico per tutta la vita. Il sistema nervoso regola la frequenza, la forza e il ritmo delle contrazioni cardiache (vedi Sistema cardiovascolare). Malattie del sistema muscolare. Tra le malformazioni dello sviluppo muscolare rientrano i disturbi dello sviluppo del diaframma con conseguente formazione di ernie diaframmatiche (vedi Ernia).La necrosi muscolare può verificarsi a seguito di disturbi metabolici, processi infiammatori, esposizione a un tumore vicino, traumi, così come il blocco delle grandi arterie. Nel tessuto muscolare possono verificarsi processi distrofici di varia origine, inclusa la lipomatosi (deposizione eccessiva di grasso), osservati, in particolare, con l'obesità generale. La deposizione di calcare nei muscoli si osserva come manifestazione di un disturbo generale o locale del metabolismo del calcare. L'atrofia muscolare si esprime nel fatto che le fibre muscolari diventano gradualmente più sottili. Le cause dell’atrofia muscolare sono varie. Come fenomeno fisiologico, l'atrofia muscolare può verificarsi negli anziani. A volte l'atrofia si sviluppa a causa di malattie del sistema nervoso, malattie con esaurimento generale, a causa di funzionalità muscolare compromessa o per inattività. L'ipertrofia muscolare è principalmente di natura fisiologica e lavorativa. Può anche essere compensatorio, quando l'atrofia e la morte di parte del tessuto muscolare sono accompagnate dall'ipertrofia delle restanti fibre. L'ipertrofia muscolare si osserva anche in alcune malattie ereditarie. I tumori sono relativamente rari nei muscoli. Alle malattie comuni di M. s. si riferisce al cosiddetto infiammazione asettica dei muscoli e miosite. Le lesioni muscolari associate al processo infiammatorio si verificano in numerose malattie sistemiche (vedi Malattie del collagene, Reumatismi) e infettive (vedi Miocardite). Lo sviluppo dell'infiammazione purulenta dell'ascesso è una forma grave di danno muscolare che richiede un trattamento chirurgico. Il danno ai muscoli si presenta sotto forma di contusioni o rotture; entrambi si manifestano come gonfiore doloroso e indurimento a causa dell'emorragia. Aiuta con i lividi - vedi Lividi. In caso di rotture muscolari complete, è necessaria un'operazione: cucire insieme i segmenti strappati; in caso di rotture muscolari incomplete, la fusione muscolare avviene quando viene prescritto il riposo a lungo termine (immobilizzazione). Dopo che i muscoli si sono fusi, vengono prescritte procedure fisioterapeutiche, nonché massaggi ed esercizi terapeutici per ripristinare la loro funzione. Un grave danno muscolare può portare a cambiamenti cicatriziali e contratture, alla deposizione di calcare in essi e alla loro ossificazione. Le contratture sono causate non solo da vari tipi di lesioni e ustioni, ma anche dall'immobilità dei muscoli, ad esempio degli arti, associata a malattie croniche dei nervi, delle articolazioni, ecc., motivo per cui la terapia fisica è così importante per tali malattie. Nel ripristinare le funzioni muscolari compromesse, di particolare importanza sono il massaggio e uno speciale complesso di terapia fisica, eseguiti da medici e istruttori di fisioterapia o su loro raccomandazione. Anche alcuni farmaci prescritti dal medico hanno lo stesso scopo.
È consuetudine distinguere i seguenti sistemi fisiologici del corpo: scheletrico (scheletro umano), muscolare, circolatorio, respiratorio, digestivo, nervoso, sistema sanguigno, ghiandole endocrine, analizzatori, ecc.
Il sangue come fisiologicoSangue - tessuto fluido circolante sistema, tessuto liquido sistema circolatorio e garantire l'attività vitale delle cellule e dei tessuti del corpo come organo e sistema fisiologico. Consiste in plasma(55-60%) e pesato in esso elementi sagomati: eritrociti, leucociti, piastrine e altre sostanze (40-45%) (Fig. 2.8); ha una reazione leggermente alcalina (7,36 pH).
Globuli rossi - i globuli rossi, a forma di piastra rotonda concava con un diametro di 8 e uno spessore di 2-3 micron, sono riempiti con una proteina speciale: l'emoglobina, che è in grado di formare un composto con l'ossigeno (ossiemoglobina) e trasportarlo dai polmoni ai tessuti, e dai tessuti trasferiscono l'anidride carbonica ai polmoni, svolgendo così la funzione respiratoria. La durata della vita di un eritrocita nel corpo è di 100-120 giorni. Il midollo osseo rosso produce fino a 300 miliardi di globuli rossi giovani, immettendoli nel sangue ogni giorno. 1 ml di sangue umano contiene normalmente 4,5-5 milioni di globuli rossi. Per le persone attivamente coinvolte nell’attività fisica, questo numero può aumentare in modo significativo (6 milioni o più). Leucociti - i globuli bianchi svolgono una funzione protettiva distruggendo corpi estranei e agenti patogeni (fagocitosi). 1 ml di sangue contiene 6-8 mila leucociti. Piastrine(e in 1 ml sono contenuti da 100 a 300mila) svolgono un ruolo importante nel complesso processo di coagulazione del sangue. Il plasma sanguigno dissolve ormoni, sali minerali, sostanze nutritive e altre sostanze con cui fornisce i tessuti e contiene anche prodotti di decomposizione rimossi dai tessuti.
Riso. 2.8. Composizione del sangue umano
Costanti fondamentali del sangue umano
Quantità di sangue.............................. 7% del peso corporeo
Acqua............................ 90-91%
Densità............................ 1.056-1.060 g/cm 3
Viscosità.............. 4-5 arb. unità (relativo all'acqua)
pH.................................... ...7,35-7,45
Proteine totali (albumina, globuline, fibrinogeno). . . 65-85 g/l
Na*................................ 1,8-2,2 g/l"
A*.................................... 1,5-2,2 g/l
Ca*............................ 0,04-0,08 g/l
Pressione osmotica........ 7,6-8,1 atm (768,2-818,7 kPa)
Pressione oncotica..... 25-30 mm Hg. Arte. (3,325-3,99 kPa)
Indice di depressione................. -0,56 "C
Il plasma sanguigno contiene anche anticorpi che creano l'immunità (immunità) del corpo contro sostanze tossiche di origine infettiva o di altra origine, microrganismi e virus. Il plasma sanguigno partecipa al trasporto dell'anidride carbonica ai polmoni.
La costanza della composizione del sangue è mantenuta sia dai meccanismi chimici del sangue stesso che da speciali meccanismi regolatori del sistema nervoso.
Quando il sangue si muove attraverso i capillari che penetrano in tutti i tessuti, parte del plasma sanguigno fuoriesce costantemente attraverso le loro pareti nello spazio interstiziale, che si forma fluido interstiziale, che circonda tutte le cellule del corpo. Da questo fluido, le cellule assorbono nutrienti e ossigeno e rilasciano anidride carbonica e altri prodotti di degradazione formati durante il processo metabolico. Pertanto, il sangue rilascia continuamente le sostanze nutritive utilizzate dalle cellule nel liquido interstiziale e assorbe le sostanze da esse secrete. Qui si trovano anche i vasi linfatici più piccoli. Alcune sostanze del liquido interstiziale penetrano in essi e si formano linfa, che svolge le seguenti funzioni: restituisce le proteine dallo spazio interstiziale al sangue, partecipa alla ridistribuzione dei liquidi nel corpo, fornisce i grassi alle cellule dei tessuti, mantiene il normale corso dei processi metabolici nei tessuti, distrugge e rimuove gli agenti patogeni dal corpo. La linfa ritorna attraverso i vasi linfatici al sangue, alla parte venosa del sistema vascolare.
La quantità totale di sangue rappresenta il 7-8% del peso corporeo di una persona. A riposo, il 40-50% del sangue è escluso dalla circolazione e si trova nei “depositi sanguigni”: fegato, milza, vasi sanguigni della pelle, muscoli e polmoni. Se necessario (ad esempio durante il lavoro muscolare), il volume di riserva del sangue viene incluso nella circolazione sanguigna e diretto riflessivamente all'organo funzionante. Il rilascio del sangue dal “deposito” e la sua ridistribuzione in tutto il corpo è regolata dal sistema nervoso centrale.
La perdita di più di 1/3 della quantità di sangue da parte di una persona è pericolosa per la vita. Allo stesso tempo, ridurre la quantità di sangue di 200-400 ml (donazione) è innocuo per le persone sane e stimola addirittura i processi ematopoietici. Esistono quattro gruppi sanguigni (I, II, III, IV) Per salvare la vita di persone che hanno perso molto sangue o per alcune malattie, le trasfusioni di sangue vengono effettuate tenendo conto del gruppo. Ogni persona dovrebbe conoscere il proprio gruppo sanguigno.
Il sistema cardiovascolare. Il sistema circolatorio è costituito dal cuore e dai vasi sanguigni. Cuore - l'organo principale del sistema circolatorio - è un organo muscolare cavo che esegue contrazioni ritmiche, grazie alle quali avviene il processo di circolazione sanguigna nel corpo. Il cuore è un dispositivo autonomo e automatico. Tuttavia, il suo lavoro è regolato da numerose connessioni dirette e di feedback provenienti da vari organi e sistemi del corpo. Il cuore è collegato al sistema nervoso centrale, che ha un effetto regolatore sul suo funzionamento.
Il sistema cardiovascolare è costituito da circolazione sistemica e polmonare(Fig. 2.9). La metà sinistra del cuore serve un grande cerchio
circolazione sanguigna, giusto - piccola. La circolazione sistemica inizia dal ventricolo sinistro del cuore, attraversa i tessuti di tutti gli organi e ritorna all'atrio destro. Dall'atrio destro il sangue passa nel ventricolo destro, da dove inizia la circolazione polmonare, che passa attraverso i polmoni, dove il sangue venoso, cedendo anidride carbonica ed essendo saturo di ossigeno, si trasforma in sangue arterioso e viene inviato a sinistra atrio. Dall'atrio sinistro il sangue fluisce nel ventricolo sinistro e da lì nuovamente nella circolazione sistemica.
L'attività del cuore consiste in un cambiamento ritmico dei cicli cardiaci, costituito da tre fasi: contrazione degli atri, contrazione dei ventricoli e rilassamento generale del cuore.
Impulso - un'onda di vibrazioni si propagava lungo le pareti elastiche delle arterie a seguito dello shock idrodinamico di una porzione di sangue espulsa nell'aorta ad alta pressione durante la contrazione del ventricolo sinistro. La frequenza del polso corrisponde alla frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca a riposo (al mattino, sdraiati, a stomaco vuoto) è inferiore a causa dell'aumento della potenza di ogni contrazione. Una diminuzione della frequenza cardiaca aumenta il tempo di pausa assoluto necessario al riposo del cuore e ai processi di recupero nel muscolo cardiaco. A riposo, il polso di una persona sana è di 60-70 battiti/min.
Pressione sanguignaè creato dalla forza di contrazione dei ventricoli del cuore e dall'elasticità delle pareti dei vasi sanguigni. Si misura nell'arteria brachiale. Viene fatta una distinzione tra la pressione massima (o sistolica), che si crea durante la contrazione del ventricolo sinistro (sistole), e la pressione minima (o diastolica), che si osserva durante il rilassamento del ventricolo sinistro (diastole). La pressione viene mantenuta grazie all'elasticità delle pareti dell'aorta distesa e di altre grandi arterie. Normalmente una persona sana di età compresa tra 18 e 40 anni ha una pressione arteriosa a riposo di 120/70 mmHg. Arte. (pressione sistolica 120 mm, diastolica 70 mm). La pressione sanguigna più alta si osserva nell'aorta.
Man mano che ti allontani dal cuore, la pressione sanguigna diminuisce sempre di più. La pressione più bassa si osserva nelle vene quando fluiscono nell'atrio destro. Una differenza di pressione costante garantisce un flusso sanguigno continuo attraverso i vasi sanguigni (nella direzione della bassa pressione).
Sistema respiratorio Sistema respiratorio include cavità nasale, laringe, trachea, bronchi E polmoni. Nel processo di respirazione, l'ossigeno entra costantemente nel corpo dall'aria atmosferica attraverso gli alveoli dei polmoni e l'anidride carbonica viene rilasciata dal corpo (Fig. 2.10 e 2.11).
La trachea nella sua parte inferiore è divisa in due bronchi, ciascuno dei quali, entrando nei polmoni, si ramifica come un albero. Gli ultimi rami più piccoli dei bronchi (bronchioli) passano in anni alveolari chiusi, nelle cui pareti è presente un gran numero di formazioni sferiche - vescicole polmonari (alveoli). Ogni alveolo è circondato da una fitta rete di capillari. La superficie totale di tutte le vescicole polmonari è molto grande, è 50 volte più grande della superficie della pelle umana e ammonta a più di 100 m2.
I polmoni si trovano in una cavità toracica ermeticamente chiusa. Sono ricoperti da una membrana sottile e liscia - la pleura; la stessa membrana riveste l'interno della cavità toracica. Lo spazio formato tra questi fogli di pleura è chiamato cavità pleurica. Durante l'espirazione la pressione nella cavità pleurica è sempre 3-4 mmHg inferiore a quella atmosferica. Art., durante l'inalazione - entro 7-9.
Il processo di respirazione è un intero complesso di processi fisiologici e biochimici, nella cui attuazione è coinvolto non solo l'apparato respiratorio, ma anche il sistema circolatorio.
Meccanismo di respirazione ha una natura riflessiva (automatica). A riposo, lo scambio d'aria nei polmoni avviene a seguito dei movimenti respiratori ritmici del torace. Quando la pressione nella cavità toracica diminuisce, una parte dell'aria viene aspirata sufficientemente passivamente nei polmoni a causa della differenza di pressione: si verifica l'inalazione. Quindi la cavità toracica diminuisce e l'aria viene espulsa dai polmoni: avviene l'espirazione. L'espansione della cavità toracica avviene a seguito dell'attività dei muscoli respiratori. A riposo, durante l'inspirazione, la cavità toracica viene espansa da uno speciale muscolo respiratorio: il diaframma, così come i muscoli intercostali esterni; Durante il lavoro fisico intenso vengono attivati anche altri muscoli (scheletrici). L'espirazione a riposo avviene passivamente; quando i muscoli che inspirano sono rilassati, il torace si riduce sotto l'influenza della gravità e della pressione atmosferica. Durante il lavoro fisico intenso, l'espirazione coinvolge i muscoli addominali, i muscoli intercostali interni e altri muscoli scheletrici. L'esercizio sistematico e lo sport rafforzano i muscoli respiratori e aiutano ad aumentare il volume e la mobilità (escursione) del torace.
Lo stadio della respirazione in cui l'ossigeno dell'aria atmosferica passa nel sangue e l'anidride carbonica dal sangue nell'aria atmosferica è chiamato respirazione esterna; il trasferimento dei gas attraverso il sangue è la fase successiva e definitiva tessuto Respirazione (o interna) - il consumo di ossigeno da parte delle cellule e il rilascio di anidride carbonica da parte loro a seguito di reazioni biochimiche associate alla formazione di energia per garantire i processi vitali del corpo.
Esterno La respirazione (polmonare) avviene negli alveoli dei polmoni. Qui, attraverso le pareti semipermeabili degli alveoli e dei capillari, l'ossigeno passa dall'aria alveolare riempiendo le cavità degli alveoli. Le molecole di ossigeno e anidride carbonica effettuano questa transizione in centesimi di secondo. Dopo che l’ossigeno è stato trasferito dal sangue ai tessuti, tessuto respirazione (intracellulare). L'ossigeno passa dal sangue al liquido interstiziale e da lì alle cellule dei tessuti, dove viene utilizzato per garantire i processi metabolici. L'anidride carbonica, prodotta intensamente nelle cellule, passa nel liquido interstiziale e poi nel sangue. Con l'aiuto del sangue viene trasportato ai polmoni e poi eliminato dal corpo. La transizione dell'ossigeno e dell'anidride carbonica attraverso le pareti semipermeabili degli alveoli, dei capillari e delle membrane dei globuli rossi mediante diffusione (transizione) è dovuta alla differenza nella pressione parziale di ciascuno di questi gas. Quindi, ad esempio, ad una pressione atmosferica di 760 mm Hg. Arte. la pressione parziale dell'ossigeno (p0a) al suo interno è 159 mm Hg. Art., e nel sangue alveolare - 102, nel sangue arterioso - 100, nel sangue venoso - 40 mm Hg. Arte. Nel tessuto muscolare in attività, p0a può diminuire fino a zero. A causa della differenza nella pressione parziale dell'ossigeno, la sua transizione graduale avviene nei polmoni, quindi attraverso le pareti dei capillari nel sangue e dal sangue nelle cellule dei tessuti.
L'anidride carbonica dalle cellule dei tessuti entra nel sangue, dal sangue nei polmoni, dai polmoni nell'aria atmosferica, poiché il gradiente di pressione parziale dell'anidride carbonica (CO 2) è diretto nella direzione opposta rispetto a p0a (nelle cellule CO 2 - 50-60, nel sangue - 47, nell'aria alveolare - 40, nell'aria atmosferica - 0,2 mm Hg).
Apparato digerente e scarico. Apparato digerente comprende cavità orale, ghiandole salivari, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue e crasso, fegato E pancreas. In questi organi, il cibo viene lavorato meccanicamente e chimicamente, le sostanze alimentari che entrano nel corpo vengono digerite e i prodotti digestivi vengono assorbiti.
Apparato escretore modulo reni, ureteri E vescia, che garantiscono l'escrezione di prodotti metabolici dannosi dal corpo nelle urine (fino al 75%). Inoltre, alcuni prodotti metabolici vengono escreti attraverso la pelle (con le secrezioni delle ghiandole sudoripare e sebacee), i polmoni (con l'aria espirata) e attraverso il tratto gastrointestinale. Con l'aiuto dei reni, il corpo mantiene l'equilibrio acido-base (pH), il volume richiesto di acqua e sali e una pressione osmotica stabile (cioè l'omeostasi).
Sistema nervosoSistema nervoso comprende centrale(cervello e midollo spinale) w. periferica dipartimenti (nervi provenienti dal cervello e dal midollo spinale e situati su
periferia dei gangli nervosi). Il sistema nervoso centrale coordina le attività di vari organi e sistemi del corpo e regola questa attività in un ambiente esterno mutevole utilizzando il meccanismo riflesso. I processi che si verificano nel sistema nervoso centrale sono alla base di tutta l'attività mentale umana.
Sulla struttura del sistema nervoso centrale. Midollo spinale si trova nel canale spinale formato dagli archi vertebrali. La prima vertebra cervicale è il confine superiore del midollo spinale, mentre il confine inferiore è la seconda vertebra lombare. Il midollo spinale è diviso in cinque sezioni con un certo numero di segmenti: cervicale, toracico, lombare, sacrale e coccigeo. Al centro del midollo spinale c'è un canale pieno di liquido cerebrospinale. In una sezione trasversale di un campione di laboratorio, si distinguono facilmente la materia grigia e quella bianca del cervello. materia grigia Il cervello è formato da un accumulo di corpi di cellule nervose (neuroni), i cui processi periferici, come parte dei nervi spinali, raggiungono vari recettori della pelle, dei muscoli, dei tendini e delle mucose. materia bianca grigio circostante, costituito da processi che collegano le cellule nervose del midollo spinale; sensoriale ascendente (afferente), che collega tutti gli organi e i tessuti (eccetto la testa) con il cervello; Vie motorie discendenti (efferenti) che vanno dal cervello alle cellule motorie del midollo spinale. Quindi, il midollo spinale svolge una funzione riflessa e di conduttore per gli impulsi nervosi. In varie parti del midollo spinale ci sono motoneuroni (cellule nervose motorie) che innervano i muscoli degli arti superiori, della schiena, del torace, dell'addome e degli arti inferiori. I centri per la defecazione, la minzione e l'attività sessuale si trovano nella regione sacrale. Una funzione importante dei motoneuroni è quella di fornire costantemente il tono muscolare necessario, grazie al quale tutti gli atti motori riflessi vengono eseguiti dolcemente e senza intoppi. Il tono dei centri del midollo spinale è regolato dalle parti superiori del sistema nervoso centrale. Le lesioni del midollo spinale comportano vari disturbi associati al fallimento della funzione di conduzione. Tutti i tipi di lesioni e malattie del midollo spinale possono portare a disturbi del dolore e della sensibilità alla temperatura, all'interruzione della struttura dei movimenti volontari complessi e al tono muscolare.
Cervelloè un accumulo di un numero enorme di cellule nervose. È costituito da sezioni anteriore, intermedia, media e posteriore. La struttura del cervello è incomparabilmente più complessa della struttura di qualsiasi organo del corpo umano.
Corteccia cerebrale cervello - la parte più giovane del cervello in termini filogenetici (la filogenesi è il processo di sviluppo di organismi vegetali e animali durante l'esistenza della vita sulla Terra). Nel processo di evoluzione, la corteccia cerebrale è diventata la divisione più alta del sistema nervoso centrale, modellando l'attività dell'organismo nel suo insieme nella sua relazione con l'ambiente. Il cervello è attivo non solo durante la veglia, ma anche durante il sonno. Il tessuto cerebrale consuma 5 volte più ossigeno del cuore e 20 volte più dei muscoli. Costituendo solo circa il 2% del peso corporeo umano, il cervello assorbe il 18-25% dell'ossigeno consumato dall'intero corpo. Il cervello è significativamente superiore agli altri organi nel consumo di glucosio. Utilizza il 60-70% del glucosio prodotto dal fegato, nonostante il cervello contenga meno sangue rispetto ad altri organi. Il deterioramento dell’afflusso di sangue al cervello può essere associato all’inattività fisica. In questo caso, si verificano mal di testa di varia localizzazione, intensità e durata, vertigini, debolezza, diminuzione delle prestazioni mentali, deterioramento della memoria e irritabilità. Per caratterizzare i cambiamenti nelle prestazioni mentali, viene utilizzata una serie di tecniche che valutano le sue varie componenti (attenzione, memoria e percezione, pensiero logico).
Sistema nervoso autonomo - una parte specializzata del sistema nervoso regolata dalla corteccia cerebrale. A differenza di somatico sistema nervoso, che innerva i muscoli volontari (scheletrici) e fornisce la sensibilità generale del corpo e di altri organi di senso, il sistema nervoso autonomo regola l'attività degli organi interni: respirazione, circolazione sanguigna, escrezione, riproduzione, ghiandole endocrine. Il sistema nervoso autonomo è suddiviso in comprensivo E parasimpatico sistemi (Fig. 2.12).

Riso. 2.12. Schema della struttura del sistema nervoso autonomo:
/ - mesencefalo, II- midollo, III- midollo spinale cervicale, IV - midollo spinale toracico, V-midollo spinale lombare, VI- midollo spinale sacrale, 1 - occhio, 2 - ghiandola lacrimale 3 - ghiandole salivari, 4 - cuore, 5 - polmoni, 6 - stomaco, 7 - intestini, 8 - vescia, 9 - nervo vago, 10 - nervo pelvico, 11 - tronco simpatico con gangli vertebrali, 12 - Plesso Solare, 13 - nervo oculomotore 14 - nervo lacrimale, 15 - corda timpanica, 16 - nervo linguale
L'attività del cuore, dei vasi sanguigni, degli organi digestivi, dell'escrezione, degli organi riproduttivi e di altri organi, la regolazione del metabolismo, la termoformazione, la partecipazione alla formazione di reazioni emotive (paura, rabbia, gioia) - tutto questo è sotto la giurisdizione del simpatico e sistema nervoso parasimpatico e sotto il controllo della parte superiore del sistema nervoso centrale.
Recettori e analizzatori La capacità dell'organismo di adattarsi rapidamente ai cambiamenti ambientali si realizza grazie all'educazione speciale - recettori il quale, avendo
con rigorosa specificità, trasformano gli stimoli esterni (suono, temperatura, luce, pressione) in impulsi nervosi che viaggiano lungo le fibre nervose fino al sistema nervoso centrale. I recettori umani si dividono in due gruppi principali: estero-(esterno) e intero- recettori (intrinseci). Ciascuno di questi recettori è parte integrante di un sistema di analisi chiamato analizzatore. Analizzatoreè costituito da tre sezioni: il recettore, la parte conduttiva e la formazione centrale nel cervello.
La sezione più alta dell'analizzatore è la sezione corticale. Elenchiamo i nomi degli analizzatori il cui ruolo nella vita umana è noto a molti. Questo è un analizzatore della pelle (sensibilità tattile, del dolore, del calore, del freddo); motore (i recettori nei muscoli, nelle articolazioni, nei tendini e nei legamenti vengono eccitati sotto l'influenza della pressione e dello stiramento); vestibolare (si trova nell'orecchio interno e percepisce la posizione del corpo nello spazio); visivo (luce e colore); uditivo (suono); olfattivo (odore); gustativo (gusto); viscerale (condizione di un certo numero di organi interni).
Sistema endocrinoGhiandole endocrine, o ghiandole endocrine (Fig. 2.13), producono sostanze biologiche speciali - ormoni. Il termine "ormone" deriva dal greco "hormo" - incoraggio, eccito. Gli ormoni forniscono la regolazione umorale (attraverso il sangue, la linfa, il liquido interstiziale) dei processi fisiologici nel corpo, raggiungendo tutti gli organi e tessuti. Alcuni ormoni vengono prodotti solo durante determinati periodi, mentre la maggior parte viene prodotta durante tutta la vita di una persona. Possono inibire o accelerare la crescita del corpo, la pubertà, lo sviluppo fisico e mentale, regolare il metabolismo, l'energia e l'attività degli organi interni. Le ghiandole endocrine includono: tiroide, paratiroidi, gozzo, ghiandole surrenali, pancreas, ipofisi, gonadi e molti altri.
Alcune di queste ghiandole producono, oltre agli ormoni, sostanze secretorie(ad esempio, il pancreas è coinvolto nel processo di digestione, secernendo secrezioni nel duodeno
intestino; il prodotto della secrezione esterna delle gonadi maschili - i testicoli - è lo sperma, ecc.). Tali ghiandole sono chiamate ghiandole a secrezione mista.
Gli ormoni, in quanto sostanze ad elevata attività biologica, nonostante le concentrazioni estremamente basse nel sangue, sono in grado di provocare cambiamenti significativi nello stato del corpo, in particolare nell'implementazione del metabolismo e dell'energia. Hanno un effetto remoto e sono caratterizzati da specificità, che si esprime in due forme: alcuni ormoni (ad esempio gli ormoni sessuali) influenzano solo la funzione di determinati organi e tessuti, altri controllano solo alcuni cambiamenti nella catena dei processi metabolici e nella l’attività degli enzimi che regolano questi processi. Gli ormoni vengono distrutti in tempi relativamente brevi e per mantenerne una certa quantità nel sangue è necessario che siano secreti instancabilmente dalla ghiandola corrispondente. Quasi tutti i disturbi dell'attività delle ghiandole endocrine causano una diminuzione delle prestazioni complessive di una persona. La funzione delle ghiandole endocrine è regolata dal sistema nervoso centrale; gli effetti nervosi e umorali su vari organi, tessuti e le loro funzioni sono una manifestazione di un sistema unificato di regolazione neuroumorale delle funzioni corporee.
2.4. Ambiente esterno e suo impatto
corpo umano e attività
Ambiente esterno. Una persona è influenzata da vari fattori ambientali. Quando si studiano i diversi tipi delle sue attività, non lo è
fare senza tener conto dell'influenza fattori naturali(pressione barometrica, composizione del gas e umidità dell'aria, temperatura ambiente, radiazione solare - il cosiddetto ambiente fisico), fattori biologici ambiente vegetale e animale, nonché fattori dell’ambiente sociale con risultati delle attività quotidiane, economiche, industriali e creative di una persona.
Dall'ambiente esterno, il corpo riceve le sostanze necessarie per la sua vita e il suo sviluppo, nonché sostanze irritanti (utili e dannose) che interrompono la costanza dell'ambiente interno. Il corpo, attraverso l'interazione dei sistemi funzionali, si sforza in ogni modo di mantenere la necessaria costanza del suo ambiente interno.
L'attività di tutti gli organi e dei loro sistemi nell'intero organismo è caratterizzata da determinati indicatori che presentano determinati intervalli di fluttuazione. Alcune costanti sono stabili e piuttosto rigide (ad esempio, il pH del sangue è 7,36-7,40, la temperatura corporea è compresa tra 35 e 42°C), altre normalmente presentano fluttuazioni significative (ad esempio, la gittata sistolica del cuore - la quantità di sangue espulso per ogni contrazione - 50-200 cm*). I vertebrati inferiori, in cui la regolazione degli indicatori che caratterizzano lo stato dell'ambiente interno è imperfetta, si trovano in balia dei fattori ambientali. Ad esempio, una rana, non avendo un meccanismo per regolare la costanza della temperatura corporea, duplica così tanto la temperatura dell'ambiente esterno che in inverno tutti i suoi processi vitali sono inibiti, e in estate, essendo lontana dall'acqua, si secca e muore. Nel processo di sviluppo filogenetico, gli animali superiori, compreso l'uomo, sembravano collocarsi in una serra, creando il proprio ambiente interno stabile e garantendo così una relativa indipendenza dall'ambiente esterno.
Fattori socio-ecologici naturali e loro impatto sul corpo. I fattori naturali e socio-biologici che influenzano il corpo umano sono indissolubilmente legati alle questioni ambientali. Ecologia(Greco oikos - casa, abitazione, patria + logos - concetto, insegnamento) è sia un campo di conoscenza, sia una parte della biologia, una disciplina accademica e una scienza complessa. L’ecologia esamina le relazioni degli organismi tra loro e con le componenti inanimate della natura della Terra (la sua biosfera). L'ecologia umana studia i modelli di interazione umana con la natura, i problemi di conservazione e promozione della salute. L'uomo dipende dalle condizioni del suo ambiente così come la natura dipende dall'uomo. Nel frattempo, l'impatto delle attività industriali sull'ambiente (inquinamento dell'atmosfera, del suolo, dei corpi idrici con rifiuti industriali, deforestazione, aumento delle radiazioni a seguito di incidenti e violazioni tecnologiche) minaccia l'esistenza dell'uomo stesso. Nelle grandi città, ad esempio, l’habitat naturale si sta notevolmente deteriorando, il ritmo della vita, la situazione psico-emotiva del lavoro, della vita e del tempo libero vengono sconvolti e il clima sta cambiando. Nelle città l'intensità della radiazione solare è inferiore del 15-20% rispetto all'area circostante, ma la temperatura media annuale è di 1-2 "C più alta, le fluttuazioni giornaliere e stagionali sono meno significative, la pressione atmosferica è inferiore, l'aria inquinata è inferiore Tutti questi cambiamenti hanno un effetto estremamente negativo sulla salute fisica e mentale di una persona. Circa l'80% delle malattie dell'uomo moderno sono il risultato del deterioramento della situazione ambientale sul pianeta. I problemi ambientali sono direttamente correlati al processo di organizzazione e la conduzione di esercizi e sport sistematici, nonché alle condizioni in cui si svolgono.
2.5. Attività funzionale umana e
rapporto tra attività fisica e mentale
Attività funzionale umana. L'attività funzionale umana è caratterizzata da vari atti motori: contrazione del muscolo cardiaco, movimento del corpo nello spazio, movimento dei bulbi oculari, deglutizione, respirazione, nonché la componente motoria della parola e delle espressioni facciali.
Lo sviluppo delle funzioni muscolari è fortemente influenzato dalle forze di gravità e d'inerzia, che il muscolo è costantemente costretto a superare. Il tempo durante il quale si svolge la contrazione muscolare e lo spazio in cui avviene svolgono un ruolo importante.
Si presume e dimostrato da numerosi lavori scientifici che il lavoro ha creato l'uomo. Il concetto di “lavoro” comprende le sue varie tipologie. Nel frattempo, esistono due tipi principali di attività lavorativa umana: il lavoro fisico e mentale e le loro combinazioni intermedie.
Lavoro fisico- questo è un tipo di attività umana, le cui caratteristiche sono determinate da un complesso di fattori che distinguono un tipo di attività da un altro, associati alla presenza di fattori climatici, industriali, fisici, informativi e simili. L'esecuzione del lavoro fisico è sempre associata ad una certa gravità del travaglio, che è determinata dal grado di coinvolgimento dei muscoli scheletrici nel lavoro e riflette il costo fisiologico dell'attività principalmente fisica. A seconda del grado di gravità, il lavoro viene classificato in lavoro fisicamente leggero, moderato, duro e molto duro. I criteri per valutare la gravità del lavoro sono indicatori ergometrici (quantità di lavoro esterno, carichi spostati, ecc.) e fisiologici (livelli di consumo energetico, frequenza cardiaca, altri cambiamenti funzionali).
Lavoro mentale - Questa è l'attività di una persona per trasformare il modello concettuale della realtà formato nella sua mente creando nuovi concetti, giudizi, conclusioni e, sulla base di essi, ipotesi e teorie. Il risultato del lavoro mentale sono valori o soluzioni scientifiche e spirituali che, attraverso azioni di controllo sugli strumenti, vengono utilizzati per soddisfare bisogni sociali o personali. Il lavoro mentale appare in varie forme, a seconda del tipo di modello concettuale e degli obiettivi che una persona si trova ad affrontare (queste condizioni determinano le specificità del lavoro mentale). Le caratteristiche non specifiche del lavoro mentale includono la ricezione e l'elaborazione delle informazioni, il confronto delle informazioni ricevute con quelle archiviate nella memoria umana, la sua trasformazione, la determinazione della situazione problematica, i modi per risolvere il problema e la formazione dell'obiettivo del lavoro mentale , a seconda del tipo e dei metodi di conversione delle informazioni e di sviluppo di soluzioni; distinguere tra tipi di lavoro mentale riproduttivo e produttivo (creativo). Nei tipi di lavoro riproduttivo vengono utilizzate trasformazioni precedentemente note con algoritmi ad azione fissa (ad esempio operazioni di conteggio); nel lavoro creativo, gli algoritmi sono completamente sconosciuti o forniti in una forma poco chiara. La valutazione di se stessa da parte di una persona come soggetto di lavoro mentale, i motivi dell'attività, il significato dell'obiettivo e il processo lavorativo stesso costituiscono la componente emotiva del lavoro mentale. La sua efficacia è determinata dal livello di conoscenza e dalla capacità di implementarla, dalle capacità di una persona e dalle sue caratteristiche volitive. Con un'elevata intensità di lavoro mentale, soprattutto se associata a una mancanza di tempo, possono verificarsi fenomeni di blocco mentale (inibizione temporanea del processo di lavoro mentale), che proteggono i sistemi funzionali del sistema nervoso centrale dalla dissociazione.
La relazione tra l'attività fisica e mentale di una persona. Una delle caratteristiche più importanti della personalità è intelligenza. La condizione per l'attività intellettuale e le sue caratteristiche sono le capacità mentali che si formano e si sviluppano nel corso della vita. L'intelligenza si manifesta nell'attività cognitiva e creativa, compreso il processo di acquisizione della conoscenza, dell'esperienza e della capacità di usarla nella pratica.
Un altro lato non meno importante della personalità è la sfera emotivo-volitiva, il temperamento e il carattere. La capacità di regolare la formazione della personalità si ottiene attraverso la formazione, l'esercizio e l'educazione. E l'esercizio fisico sistematico, e ancor più le sessioni educative e di allenamento nello sport, hanno un effetto positivo sulle funzioni mentali, formando resistenza mentale ed emotiva alle attività faticose fin dall'infanzia. Numerosi studi sullo studio dei parametri del pensiero, della memoria, della stabilità dell'attenzione, della dinamica delle prestazioni mentali nel processo di attività produttiva in persone adattate (allenate) all'attività fisica sistematica e in individui non adattati (non allenati) indicano che i parametri delle prestazioni mentali dipendono direttamente dal livello di forma fisica generale e speciale. L'attività mentale sarà meno suscettibile all'influenza di fattori sfavorevoli se si utilizzano intenzionalmente i mezzi e i metodi della cultura fisica (ad esempio pause di allenamento fisico, riposo attivo, ecc.).
La giornata scolastica per gli studenti è piena di notevole stress mentale ed emotivo. Una postura di lavoro forzata, quando i muscoli che mantengono il corpo in un certo stato sono tesi per lungo tempo, frequenti violazioni del regime di lavoro e di riposo, un'attività fisica inadeguata: tutto ciò può causare affaticamento, che si accumula e si trasforma in superlavoro. Per evitare che ciò accada è necessario sostituire un tipo di attività con un altro. La forma di riposo più efficace durante il lavoro mentale è il riposo attivo sotto forma di lavoro fisico moderato o esercizio fisico.
Nella teoria e nella metodologia dell'educazione fisica vengono sviluppati metodi di influenza mirata sui singoli gruppi muscolari e su interi sistemi del corpo. Il problema viene posto attraverso la cultura fisica, che influenzerebbe direttamente la conservazione dell'attività attiva del cervello umano durante un intenso lavoro mentale.
L’esercizio fisico influenza significativamente i cambiamenti nelle prestazioni mentali e nelle capacità sensomotorie negli studenti del primo anno e, in misura minore, negli studenti del secondo e terzo anno. Gli studenti del primo anno sono più stanchi nel processo di studio in condizioni di adattamento all'istruzione universitaria. Pertanto, per loro, le lezioni di educazione fisica sono uno dei mezzi più importanti per adattarsi alle condizioni di vita e di studio all'università. Le lezioni di educazione fisica aumentano le prestazioni mentali degli studenti di quelle facoltà in cui predominano le lezioni teoriche e meno di quelle nel cui curriculum si alternano lezioni pratiche e teoriche.
Anche l’esercizio indipendente degli studenti nella routine quotidiana è di grande importanza preventiva. Gli esercizi mattutini quotidiani, una passeggiata o una corsa all'aria aperta hanno un effetto benefico sul corpo, aumentano il tono muscolare, migliorano la circolazione sanguigna e lo scambio di gas e questo ha un effetto positivo sull'aumento delle prestazioni mentali degli studenti. La ricreazione attiva durante le vacanze è importante: gli studenti, dopo essersi rilassati in un campo sportivo e ricreativo, iniziano l'anno scolastico con una maggiore capacità di rendimento.
2.6. Affaticamento durante il lavoro fisico e mentale.
Recupero
Qualsiasi attività muscolare, esercizio fisico o sport aumenta l’attività dei processi metabolici, allena e mantiene ad alto livello i meccanismi che svolgono il metabolismo e l’energia nel corpo, il che ha un effetto positivo sulle prestazioni mentali e fisiche di una persona. Tuttavia, con l'aumento dello stress fisico o mentale, della quantità di informazioni e dell'intensificazione di molti tipi di attività, nel corpo si sviluppa una condizione speciale chiamata affaticamento.
Fatica - Questo è uno stato funzionale che si verifica temporaneamente sotto l'influenza di un lavoro prolungato e intenso e porta ad una diminuzione della sua efficacia. L'affaticamento si manifesta nel fatto che la forza muscolare e la resistenza diminuiscono, la coordinazione dei movimenti peggiora, i costi energetici aumentano quando si eseguono lavori della stessa natura, la velocità di elaborazione delle informazioni rallenta, la memoria si deteriora e il processo di concentrazione e spostamento dell'attenzione e della padronanza il materiale teorico diventa più difficile. La fatica è associata alla sensazione fatica, e allo stesso tempo funge da segnale naturale di possibile esaurimento del corpo e da meccanismo biologico protettivo che lo protegge dallo sforzo eccessivo. Anche l'affaticamento che si verifica durante l'esercizio è uno stimolante, mobilitando sia le riserve del corpo, i suoi organi e sistemi, sia i processi di recupero.
L'affaticamento si verifica durante l'attività fisica e mentale. Può essere affilato, quelli. apparire in un breve periodo di tempo, e cronico, quelli. essere di natura a lungo termine (fino a diversi mesi); generale, quelli. caratterizzare i cambiamenti nelle funzioni del corpo nel suo complesso, e Locale, che colpisce qualsiasi gruppo muscolare, organo, analizzatore limitato. Esistono due fasi di fatica: compensato(quando non vi è alcuna evidente diminuzione delle prestazioni a causa del fatto che le capacità di riserva del corpo sono attivate) e non compensato(quando la capacità di riserva del corpo è esaurita e le prestazioni diminuiscono chiaramente). L'esecuzione sistematica del lavoro in un contesto di recupero insufficiente, un'organizzazione del lavoro mal concepita, un eccessivo stress fisico e mentale possono portare a superlavoro, e quindi a sovratensione sistema nervoso, esacerbazioni di malattie cardiovascolari, ipertensione e ulcera peptica, diminuzione delle proprietà protettive del corpo. La base fisiologica di tutti questi fenomeni è uno squilibrio dei processi nervosi eccitatori-inibitori. L'affaticamento mentale è particolarmente pericoloso per la salute mentale di una persona; è associato alla capacità del sistema nervoso centrale di lavorare a lungo sotto sovraccarico e questo può alla fine portare allo sviluppo di un'inibizione estrema e all'interruzione della coerenza dell'interazione delle funzioni autonome.
È possibile eliminare la fatica aumentando il livello di allenamento generale e specializzato del corpo, ottimizzandone l'attività fisica, mentale ed emotiva.
La prevenzione e l'eliminazione dell'affaticamento mentale sono facilitate dalla mobilitazione di quegli aspetti dell'attività mentale e dell'attività motoria che non sono associati a quelli che hanno portato all'affaticamento. È necessario riposare attivamente, passare ad altre attività e utilizzare un arsenale di strumenti di recupero.
Recupero - un processo che si verifica nel corpo dopo la cessazione del lavoro e consiste in una transizione graduale delle funzioni fisiologiche e biochimiche allo stato originale. Viene chiamato il tempo durante il quale viene ripristinato lo stato fisiologico dopo aver eseguito un determinato lavoro periodo di recupero. Va ricordato che nel corpo, sia durante il lavoro che nel riposo pre-lavoro e post-lavoro, a tutti i livelli della sua attività vitale, si verificano continuamente processi interconnessi di consumo e ripristino delle riserve funzionali, strutturali e regolatorie. Durante il lavoro i processi di dissimilazione prevalgono sull'assimilazione, e tanto più quanto maggiore è l'intensità del lavoro e minore è la prontezza del corpo a svolgerlo.
Durante il periodo di recupero predominano i processi di assimilazione e il ripristino delle risorse energetiche avviene in eccesso rispetto al livello iniziale (super recupero, o supercompensazione). Ciò è di grande importanza per aumentare la forma fisica del corpo e dei suoi sistemi fisiologici, garantendo un aumento delle prestazioni.
Schematicamente il processo di recupero può essere rappresentato sotto forma di tre anelli complementari: 1) eliminazione delle modifiche e delle violazioni. soluzioni nei sistemi di regolazione neuroumorale; 2) rimozione dei prodotti di decadimento formati nei tessuti e nelle cellule dell'organo funzionante dai luoghi di origine; 3) eliminazione dei prodotti di decomposizione dall'ambiente interno del corpo.
Nel corso della vita, lo stato funzionale del corpo cambia periodicamente. Tali cambiamenti periodici possono verificarsi a brevi intervalli o su lunghi periodi. Il recupero periodico è associato ai bioritmi, che sono determinati dalla periodicità quotidiana, dal periodo dell'anno, dai cambiamenti legati all'età, dalle caratteristiche di genere, dall'influenza delle condizioni naturali e dell'ambiente. Pertanto, i cambiamenti nel fuso orario, nelle condizioni di temperatura e nelle tempeste geomagnetiche possono ridurre l’attività di recupero e limitare le prestazioni mentali e fisiche.
Distinguere Presto E tardi fase di recupero. La fase iniziale termina pochi minuti dopo il lavoro leggero, dopo il lavoro duro - dopo poche ore; le fasi tardive di recupero possono durare fino a diversi giorni.
La fatica è accompagnata da una fase di riduzione delle prestazioni e dopo un po' di tempo può essere sostituita da una fase di aumento delle prestazioni. La durata di queste fasi dipende dal grado di allenamento del corpo, oltre che dal lavoro svolto.
Le funzioni dei vari sistemi corporei non vengono ripristinate contemporaneamente. Ad esempio, dopo una lunga corsa, la funzione respiratoria esterna (frequenza e profondità) è la prima a ritornare ai parametri originari; dopo alcune ore la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna si stabilizzano; gli indicatori delle reazioni sensomotorie ritornano al livello originale dopo un giorno o più; Nei maratoneti il metabolismo basale viene ripristinato tre giorni dopo la gara.
Una combinazione razionale di stress e riposo è necessaria per mantenere e sviluppare l'attività dei processi di recupero. Strumenti di ripristino aggiuntivi Possono esserci fattori di igiene, alimentazione, massaggio, sostanze biologicamente attive (vitamine). Il criterio principale per la dinamica positiva dei processi di recupero è la prontezza per l'attività ripetuta e l'indicatore più oggettivo del ripristino delle prestazioni è il volume massimo di lavoro ripetuto. È necessario prestare particolare attenzione alle sfumature dei processi di recupero quando si organizzano esercizi fisici e si pianificano i carichi di allenamento. Si consiglia di eseguire carichi ripetuti in fase di aumento delle prestazioni. Intervalli di riposo troppo lunghi riducono l'efficacia del processo di allenamento. Pertanto, dopo una corsa veloce di 60-80 m, il debito di ossigeno viene eliminato entro 5-8 minuti. Durante questo periodo l'eccitabilità del sistema nervoso centrale rimane ad un livello elevato. Pertanto, un intervallo di 5-8 minuti sarà ottimale per ripetere il lavoro veloce.
Per accelerare il processo di recupero, nella pratica sportiva viene utilizzato il riposo attivo, ad es. passaggio ad un altro tipo di attività. L'importanza del riposo attivo per il ripristino delle prestazioni fu stabilita per la prima volta dal fisiologo russo I.M. Sechenov (1829-1905). Ha dimostrato, ad esempio, che un arto stanco si riprende rapidamente non con il riposo passivo, ma con il lavoro con un altro arto.
2.7. Ritmi biologici e prestazioni
Ritmi biologici - ripetizione regolare e periodica nel tempo della natura e dell'intensità dei processi vitali, degli stati o degli eventi individuali. In un modo o nell'altro, i bioritmi sono inerenti a tutti gli organismi viventi. Sono caratterizzati da periodo, ampiezza, fase, livello medio, profilo e sono suddivisi in esogeno(causato da influenze ambientali) e endogeno(determinato dai processi nel sistema vivente stesso). Esistono bioritmi di cellule, organi, organismi, comunità. Secondo la funzione svolta, i ritmi biologici sono suddivisi in fisiologico - cicli di lavoro associati all'attività dei singoli sistemi (respirazione, battito cardiaco) e ambientale, O adattivo, serve per adattare il corpo alla periodicità dell'ambiente (ad esempio, inverno - estate). Il periodo (frequenza) del ritmo fisiologico può variare ampiamente a seconda del grado di carico funzionale (da 60 battiti/min del cuore a riposo a 180-200 battiti/min durante l'esecuzione del lavoro); il periodo dei ritmi ambientali è relativamente costante, fissato geneticamente (cioè associato all'ereditarietà), in condizioni naturali catturate dai cicli ambientali, e svolge la funzione di un “orologio biologico”.
Esempi ben noti dell'azione degli orologi biologici sono i “gufi” e le “allodole”. Si è notato che le prestazioni cambiano durante il giorno, ma la natura ci ha fornito la notte per riposarci. È stato stabilito che il periodo di attività in cui il livello delle funzioni fisiologiche è elevato è il tempo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 ore. Entro le 14:00 e la sera le prestazioni diminuiscono. Nel frattempo, non tutte le persone obbediscono a questo schema: alcuni affrontano con maggior successo il lavoro al mattino e nella prima metà della giornata (si chiamano allodole), altri - la sera e anche di notte (si chiamano gufi).
Nelle condizioni moderne sono diventati importanti ritmi sociali, nella cui prigionia siamo costantemente: l'inizio e la fine della giornata lavorativa, il riposo e il sonno abbreviati, i pasti prematuri, le veglie notturne. I ritmi sociali esercitano una pressione crescente sui ritmi biologici, rendendoli dipendenti, indipendentemente dai bisogni naturali del corpo. Gli studenti sono più attivi socialmente e hanno un tono emotivo elevato e, a quanto pare, non è un caso che abbiano maggiori probabilità di soffrire di ipertensione rispetto ai loro coetanei di altri gruppi sociali.
Quindi, i ritmi della vita sono determinati da processi fisiologici nel corpo, fattori naturali e sociali: il cambiamento delle stagioni, dei giorni, lo stato dell'attività solare e della radiazione cosmica, la rotazione della Luna attorno alla Terra (e la posizione e l'influenza dei pianeti l'uno sull'altro), il cambiamento del sonno e della veglia, i processi lavorativi e il riposo, l'attività fisica e il riposo passivo. Tutti gli organi e i sistemi funzionali del corpo hanno i propri ritmi, misurati in secondi, ore, settimane, mesi e anni. Interagendo tra loro, i bioritmi dei singoli organi e sistemi formano un sistema ordinato di processi ritmici, che organizza l'attività dell'intero organismo nel tempo.
La conoscenza e l'uso razionale dei ritmi biologici possono aiutare in modo significativo nel processo di preparazione e nelle esibizioni alle competizioni. Se presti attenzione al calendario delle gare, vedrai che la parte più intensa del programma si svolge nelle ore mattutine (dalle 10 alle 12) e serali (dalle 15 alle 19), cioè nell'ora del giorno che più si avvicina ai naturali incrementi prestazionali. Molti ricercatori ritengono che gli atleti dovrebbero ricevere il carico principale nel pomeriggio. Tenendo conto dei bioritmi, è possibile ottenere risultati migliori ad un costo fisiologico inferiore. Gli atleti professionisti si allenano più volte al giorno, soprattutto nel periodo pre-gara, e molti si comportano bene perché sono preparati per ogni momento della competizione.
La scienza dei ritmi biologici è di grande importanza pratica per la medicina. Sono comparsi nuovi concetti: cronomedicina, cronodiagnosi, cronoterapia, cronoprofilassi, cronopatologia, cronofarmacologia, ecc. Questi concetti sono associati all'uso del fattore tempo, "bioritmi nella pratica del trattamento dei pazienti. Dopotutto, indicatori fisiologici della stessa persona ottenuti al mattino, a mezzogiorno o a tarda notte, differiscono notevolmente, possono essere interpretati da diverse posizioni. I dentisti, ad esempio, sanno che la sensibilità dei denti agli stimoli dolorosi è massima alle 18 e minima poco dopo mezzanotte, quindi si sforzano di eseguire tutte le procedure più dolorose al mattino.
È consigliabile utilizzare il fattore tempo in molte aree dell'attività umana. Se la routine della giornata lavorativa, delle sessioni di studio, dell'alimentazione, del riposo e dell'esercizio fisico è progettata senza tenere conto dei ritmi biologici, ciò può portare non solo a una diminuzione delle prestazioni mentali o fisiche, ma anche allo sviluppo di qualsiasi malattia .
2.8. Ipocinesia e inattività fisica
Ipocinesia(Greco ipo - diminuzione, diminuzione, insufficienza; kinesis - movimento) - uno stato speciale del corpo causato dalla mancanza di attività motoria. In alcuni casi, questa condizione porta all’inattività fisica. Inattività fisica(Greco ipo - diminuzione; dynamis - forza) - un insieme di cambiamenti morfo-funzionali negativi nel corpo dovuti a una prolungata ipocinesia. Si tratta di cambiamenti atrofici nei muscoli, deallenamento fisico generale, deallenamento del sistema cardiovascolare, diminuzione della stabilità ortostatica, cambiamenti nell'equilibrio salino, del sistema sanguigno, demineralizzazione delle ossa, ecc. Alla fine, l'attività funzionale degli organi e dei sistemi diminuisce, l'attività dei meccanismi regolatori che assicurano la loro interconnessione viene interrotta e la resistenza a vari fattori sfavorevoli si deteriora; l'intensità e il volume delle informazioni afferenti associate alle contrazioni muscolari diminuiscono, la coordinazione dei movimenti è compromessa, il tono muscolare (turgore) diminuisce, gli indicatori di resistenza e forza diminuiscono. I più resistenti allo sviluppo di segni ipodinamici sono i muscoli di natura antigravitazionale (collo, schiena). I muscoli addominali si atrofizzano in tempi relativamente brevi, il che influisce negativamente sulla funzione degli organi circolatori, respiratori e digestivi. In condizioni di inattività fisica, la forza delle contrazioni cardiache diminuisce a causa della diminuzione del ritorno venoso agli atri, il volume minuto, la massa del cuore e il suo potenziale energetico si riducono, il muscolo cardiaco si indebolisce e la quantità di sangue circolante diminuisce. il sangue diminuisce a causa del suo ristagno nel deposito e nei capillari. Il tono dei vasi arteriosi e venosi si indebolisce, la pressione sanguigna diminuisce, l'apporto di ossigeno ai tessuti (ipossia) e l'intensità dei processi metabolici (squilibri nell'equilibrio di proteine, grassi, carboidrati, acqua e sali) si deteriorano. La capacità vitale dei polmoni e della ventilazione polmonare, così come l'intensità dello scambio di gas, diminuiscono. Tutto ciò si accompagna ad un indebolimento del rapporto tra funzioni motorie e autonomiche e ad un'inadeguatezza della tensione neuromuscolare. Pertanto, con l'inattività fisica, nel corpo si crea una situazione irta di conseguenze di “emergenza” per le sue funzioni vitali. Se aggiungiamo che la mancanza del necessario esercizio fisico sistematico è associata a cambiamenti negativi nell'attività delle parti superiori del cervello, delle sue strutture e formazioni sottocorticali, allora diventa chiaro perché le difese generali del corpo diminuiscono e si verifica un aumento dell'affaticamento , il sonno è disturbato e diminuisce la capacità di mantenere elevate le prestazioni mentali o fisiche.
2.9. Strutture di educazione fisica che forniscono
resistenza mentale e fisica
prestazione
Nozioni di base significa cultura fisica - esercizio fisico. Esiste una classificazione fisiologica degli esercizi, in cui tutte le diverse attività muscolari sono combinate in gruppi separati di esercizi in base alle caratteristiche fisiologiche.
La resistenza del corpo ai fattori avversi dipende dalle proprietà congenite e acquisite. È molto mobile e può essere allenato sia attraverso l'esercizio muscolare che con diversi influssi esterni (sbalzi di temperatura, mancanza o eccesso di ossigeno, anidride carbonica). Si è notato, ad esempio, che l'allenamento fisico migliorando i meccanismi fisiologici aumenta la resistenza al surriscaldamento, all'ipotermia, all'ipossia e agli effetti di alcune sostanze tossiche, riduce la morbilità e aumenta le prestazioni. Gli sciatori allenati, quando il loro corpo viene raffreddato a 35°C, mantengono prestazioni elevate. Se le persone non addestrate non sono in grado di svolgere il lavoro quando la loro temperatura sale a 37-38°C, le persone addestrate riescono a far fronte con successo al carico anche quando la loro temperatura corporea raggiunge i 39°C o più.
Le persone che si impegnano sistematicamente e attivamente nell'esercizio fisico aumentano la stabilità mentale, mentale ed emotiva quando svolgono attività mentali o fisiche faticose.
Tra i principali qualità fisiche (o motorie), fornire un elevato livello di prestazione fisica umana include forza, velocità E resistenza, che si manifestano in determinate proporzioni a seconda delle condizioni per svolgere una particolare attività motoria, della sua natura, specificità, durata, potenza e intensità. Alle qualità fisiche menzionate vanno aggiunte flessibilità E agilità, che determinano in gran parte il successo di alcuni tipi di esercizio fisico. La diversità e la specificità degli effetti dell'esercizio sul corpo umano possono essere comprese familiarizzando con classificazione fisiologica degli esercizi fisici(dal punto di vista dei fisiologi dello sport). Si basa su alcune caratteristiche di classificazione fisiologiche inerenti a tutti i tipi di attività muscolare inclusi in un gruppo specifico. Pertanto, a seconda della natura delle contrazioni muscolari, il lavoro muscolare può essere statico O dinamico carattere. L'attività dei muscoli in condizioni di mantenimento di una posizione stazionaria del corpo o di sue parti, così come l'esercizio dei muscoli mentre si sostiene qualsiasi carico senza spostarlo, è caratterizzata come funzionamento statico(forza statica). Gli sforzi statici sono caratterizzati dal mantenimento di varie posture del corpo e dagli sforzi muscolari durante lavoro dinamico associati ai movimenti del corpo o di sue parti nello spazio.
D Un gruppo significativo di esercizi fisici viene eseguito rigorosamente permanente (standard) condizioni sia in allenamento che in competizione; gli atti motori vengono eseguiti in una determinata sequenza. Nell'ambito di una certa standardizzazione dei movimenti e delle condizioni per la loro attuazione, l'esecuzione di movimenti specifici viene migliorata con la manifestazione di forza, velocità, resistenza ed elevata coordinazione durante l'esecuzione.
Esiste anche un folto gruppo di esercizi fisici, la cui particolarità è non standard, l'incostanza delle condizioni per la loro attuazione, in una situazione mutevole che richiede una reazione motoria istantanea (arti marziali, giochi sportivi). Due grandi gruppi di esercizi fisici associati a movimenti standard o non standard, a loro volta, sono suddivisi in esercizi (movimenti) ciclico carattere (camminare, correre, nuotare, remare, pattinare, sciare, andare in bicicletta, ecc.) ed esercizio fisico aciclico carattere (esercizi senza la ripetizione continua obbligatoria di determinati cicli che hanno un inizio e una fine del movimento chiaramente definiti: salti, lanci, elementi ginnici e acrobatici, sollevamento pesi. Ciò che hanno in comune i movimenti di natura ciclica è che rappresentano tutti lavoro costante E potenza variabile con durate diverse. La diversa natura dei movimenti non sempre consente di determinare con precisione la potenza del lavoro svolto (cioè la quantità di lavoro per unità di tempo associata alla forza delle contrazioni muscolari, alla loro frequenza e ampiezza); in questi casi, viene utilizzato il termine “intensità”. La durata massima del lavoro dipende dalla sua potenza, intensità e volume e la natura del lavoro è associata al processo di affaticamento nel corpo. Se la potenza del lavoro è elevata, la sua durata è breve a causa della rapida insorgenza della fatica e viceversa. Quando lavorano ciclicamente, i fisiologi dello sport distinguono zona di massima potenza(la durata del lavoro non supera i 20-30 s, e l'affaticamento e il calo delle prestazioni si verificano per lo più entro 10-15 s); submassimale(da 20-30 a 3-5 s); grande(da 3-5 a 30-50 minuti) e moderare(durata 50 minuti o più).
Le caratteristiche dei cambiamenti funzionali nel corpo durante l'esecuzione di vari tipi di lavoro ciclico in diverse zone di potenza determinano il risultato sportivo. Ad esempio, la caratteristica principale del lavoro nella zona di massima potenza è che l'attività muscolare avviene in condizioni prive di ossigeno (anaerobiche). La potenza del lavoro è così grande che il corpo non è in grado di garantirne il completamento attraverso i processi di ossigeno (aerobici). Se tale potenza fosse ottenuta attraverso le reazioni dell'ossigeno, gli organi circolatori e respiratori dovrebbero garantire l'erogazione di oltre 40 litri di ossigeno al minuto ai muscoli. Ma anche in un atleta altamente qualificato, con il pieno rafforzamento della funzione respiratoria e circolatoria, il consumo di ossigeno può avvicinarsi solo alla cifra indicata. Durante i primi 10-20 secondi di lavoro, il consumo di ossigeno per 1 minuto raggiunge solo 1-2 litri. Pertanto, il lavoro di massima potenza viene svolto “a debito”, che viene eliminato dopo la fine dell'attività muscolare. I processi di respirazione e circolazione sanguigna durante il lavoro alla massima potenza non hanno il tempo di intensificarsi a un livello tale da fornire la quantità necessaria di ossigeno per dare energia ai muscoli che lavorano. Durante lo sprint, vengono fatti solo pochi respiri superficiali e talvolta tale corsa viene eseguita trattenendo completamente il respiro. Allo stesso tempo, le parti afferenti ed efferenti del sistema nervoso funzionano con la massima tensione, provocando un affaticamento abbastanza rapido delle cellule del sistema nervoso centrale. Il motivo dell'affaticamento dei muscoli stessi è associato ad un significativo accumulo di prodotti metabolici anaerobici e all'esaurimento delle sostanze energetiche in essi contenuti. La massa principale di energia rilasciata durante il funzionamento alla massima potenza si forma a causa dell'energia di decomposizione di ATP e CP. Il debito di ossigeno, eliminato durante il periodo di recupero dopo il lavoro svolto, viene utilizzato per la risintesi ossidativa (riduzione) di tali sostanze.
La diminuzione della potenza e l'aumento della durata del lavoro sono dovuti al fatto che oltre alle reazioni anaerobiche di apporto energetico all'attività muscolare, si svolgono anche i processi di formazione dell'energia aerobica. Ciò aumenta (fino alla completa soddisfazione del bisogno) l'apporto di ossigeno ai muscoli che lavorano. Pertanto, quando si esegue un lavoro in una zona di potenza relativamente moderata (corsa su lunghe e ultra lunghe distanze), il livello di consumo di ossigeno può raggiungere circa l'85% del massimo possibile. In questo caso, parte dell'ossigeno consumato viene utilizzato per la risintesi ossidativa di ATP, CP e carboidrati. Con un lavoro prolungato (a volte molte ore) di potenza moderata, le riserve di carboidrati del corpo (glicogeno) vengono significativamente ridotte, il che porta ad una diminuzione del glucosio nel sangue, influenzando negativamente l'attività dei centri nervosi, dei muscoli e di altri organi funzionanti. Per ricostituire le riserve di carboidrati del corpo durante le lunghe corse e le nuotate, viene fornita un'alimentazione speciale con soluzioni di zucchero, glucosio e succhi.
I movimenti aciclici non hanno una ripetibilità continua dei cicli e sono stereotipicamente le fasi successive dei movimenti con un chiaro completamento. Per eseguirli, è necessario mostrare forza, velocità e un'elevata coordinazione dei movimenti (movimenti di potenza e velocità-potenza). Il successo nell'esecuzione di questi esercizi è associato alla manifestazione della forza massima, o della velocità, o di una combinazione di entrambi, e dipende dal livello richiesto di prontezza funzionale dei sistemi corporei nel loro insieme.
A significa la cultura fisica comprende non solo l'esercizio fisico, ma anche poteri curativi della natura(sole, aria e acqua), fattori di igiene(orario di lavoro, sonno, alimentazione, condizioni igienico-sanitarie). L'utilizzo delle forze curative della natura aiuta a rafforzare e attivare le difese dell'organismo, stimola il metabolismo e l'attività dei sistemi fisiologici e dei singoli organi. Per aumentare il livello delle prestazioni fisiche e mentali, è necessario stare all'aria aperta, abbandonare le cattive abitudini, esercitare attività fisica e fare indurimento. Esercizi fisici sistematici in condizioni di intensa attività educativa alleviano lo stress neuropsichico e l'attività muscolare sistematica aumenta la stabilità mentale, mentale ed emotiva del corpo durante un intenso lavoro educativo.
Domande di controllo
1. Il concetto dei fondamenti socio-biologici della cultura fisica.
2. Fondamenti scientifici naturali della cultura fisica e dello sport.
3. Il principio dell'integrità dell'organismo e la sua unità con l'ambiente.
4. Autoregolazione e automiglioramento del corpo.
5. Idea generale della struttura del corpo umano.
6. Elencare i tipi di tessuti corporei e le loro proprietà generali e specifiche.
7. Tre cavità principali del corpo umano. Nomina quali organi si trovano in essi.
8. Il concetto di organo e sistema di organi.
9. Forma e funzioni delle ossa dello scheletro umano.
10. In cosa consiste lo scheletro umano?
11. Colonna vertebrale. I suoi dipartimenti e funzioni.
12. Il concetto di cassapanca e le sue funzioni.
13. Idea generale della struttura del cranio e delle sue funzioni.
14. Il concetto di articolazioni, legamenti e tendini.
15. Idea del sistema muscolo-scheletrico.
16. Idea del sistema muscolare (funzioni dei muscoli striati e lisci).
17. Un'idea della struttura del tessuto muscolare,
18. Il ruolo dei muscoli del tronco, della testa, del collo, degli arti superiori e inferiori.
19. Idea generale dell'approvvigionamento energetico della contrazione muscolare.
20. Idea dell'apparato respiratorio.
21. Idea dell'apparato digerente.
22. Idea del sistema escretore.
23. Sistema nervoso centrale, suoi dipartimenti e funzioni.
24. Struttura e funzioni del midollo spinale.
25. Cervello (struttura e funzioni).
26. Sistema nervoso autonomo e sistema nervoso somatico.
27. Sistema nervoso simpatico e parasimpatico.
28.. Concetto di recettori.
29. Analizzatori.
30. Ghiandole endocrine.
31. Ambiente esterno, suoi fattori naturali, biologici e sociali.
32. Omeostasi.
33. Fattori ambientali e loro influenza sul corpo.
34. Il concetto di attività funzionale umana.
35. Caratteristiche del lavoro mentale.
36. Caratteristiche del lavoro fisico.
37. Modalità motoria, combinazione di lavoro e riposo. Tipi di ricreazione.
38. Il rapporto tra l'attività fisica e mentale di una persona.
39. Il concetto di fatica durante l'attività fisica e mentale.
40. Processo di recupero.
41. Idea dei ritmi biologici umani.
42. Ipocinesia e inattività fisica.
43. Mezzi di cultura fisica.
44. Classificazione fisiologica degli esercizi fisici.
Seconda parte
2.10. Meccanismi e modelli fisiologici
miglioramento dei sistemi corporei individuali sotto
l’influenza di un allenamento fisico mirato