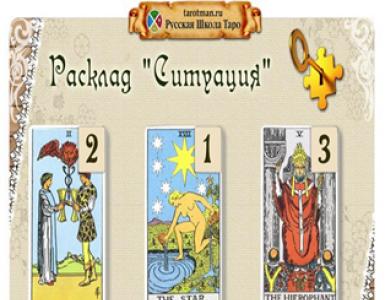Riassunto La fonetica come branca della linguistica. Caratteristiche dei suoni, processi fonetici, divisione fonetica del discorso. La fonologia come disciplina scientifica. Il concetto di fonema. La morfologia come branca della grammatica. Classificazione genealogica delle lingue. La fonetica è giusta
La maggior parte degli esperti considera la fonologia (lo studio del lato funzionale dei suoni del parlato) come una sezione (parte) della fonetica (lo studio dei suoni del parlato); alcuni vedono le due discipline come rami della linguistica non sovrapposti.
La differenza tra fonologia e fonetica è che l'argomento della fonetica non si riduce all'aspetto funzionale dei suoni del parlato, ma copre anche il suo aspetto sostanziale, vale a dire: aspetti fisici e biologici (fisiologici): articolazione, proprietà acustiche dei suoni, la loro percezione mediante l'ascoltatore (fonetica percettiva).
Fonetica- una branca della linguistica in cui viene studiata la struttura sonora della lingua, ad es. suoni del parlato, accento delle sillabe, intonazione. I suoni del parlato hanno tre lati e corrispondono a tre sezioni della fonetica:
- 1. Acustica del parlato. Studia i segni fisici della parola.
- 2. Antropofonica o fisiologia del linguaggio. Studia i segni biologici del linguaggio, cioè il lavoro svolto da una persona durante la pronuncia (articolazione) o la percezione dei suoni del linguaggio.
L'argomento della fonetica comprende la stretta connessione tra discorso orale, interno e scritto. A differenza di altre discipline linguistiche, la fonetica studia non solo la funzione linguistica, ma anche il lato materiale del suo oggetto: il lavoro dell'apparato di pronuncia, nonché le caratteristiche acustiche dei fenomeni sonori e la loro percezione da parte dei madrelingua. A differenza delle discipline non linguistiche, la fonetica considera i fenomeni sonori come elementi del sistema linguistico che servono a tradurre parole e frasi in forma sonora materiale, senza la quale la comunicazione è impossibile. Conformemente al fatto che il lato sonoro di una lingua può essere considerato negli aspetti acustico-articolatorio e linguistico-funzionale, in fonetica si distingue tra fonetica propriamente detta e fonologia. La fonetica suona i morfemi del linguaggio
Tra le scienze linguistiche fonetica occupa un posto speciale. Fonetica si occupa del lato materiale del linguaggio, con mezzi sonori privi di significato indipendente.
Esistono fonetiche generali e particolari, ovvero fonetiche delle singole lingue. La fonetica generale studia le condizioni generali della formazione del suono, in base alle capacità dell'apparato di pronuncia umano (ad esempio, si distinguono le consonanti labiali, frontelinguali e retrolinguali, se intendiamo l'organo di pronuncia che determina le caratteristiche principali della consonante , o occlusive, fricative, se si intende il metodo di formare un ostacolo per far passare dai polmoni un flusso d'aria necessario a formare una consonante), e analizza anche le caratteristiche acustiche delle unità sonore, ad esempio la presenza o l'assenza di una voce quando si pronunciano diversi tipi di consonanti. Vengono costruite classificazioni universali dei suoni (vocali e consonanti), che si basano in parte su caratteristiche articolatorie e in parte su caratteristiche acustiche. La Fonetica Generale studia anche gli schemi di combinazione dei suoni, l'influenza delle caratteristiche di uno dei suoni vicini sugli altri (vari tipi di accomodamento o assimilazione), la coarticolazione; la natura della sillaba, le leggi della combinazione dei suoni in sillabe e i fattori che determinano la divisione delle sillabe; organizzazione fonetica della parola, in particolare l'accento. Studia i mezzi utilizzati per l'intonazione; tono della voce, forza (intensità), durata delle singole parti della frase, pause.
Fonologia-- una branca della linguistica che studia la struttura della struttura sonora di una lingua e il funzionamento dei suoni nel sistema linguistico. L'unità principale della fonologia è il fonema, l'oggetto principale di studio è l'opposizione ( opposizione) fonemi che insieme formano il sistema fonologico di una lingua.
Fonema-- l'unità minima della struttura sonora di una lingua. Il fonema non ha un significato lessicale o grammaticale autonomo, ma serve a distinguere e identificare unità significative del linguaggio (morfemi e parole).
Fonologia studia il lato sociale e funzionale dei suoni del linguaggio. I suoni sono considerati non come un fenomeno fisico (acustica), non come un fenomeno biologico (articolazione), ma come mezzo di comunicazione e come elemento del sistema linguistico.
La fonologia viene spesso distinta come disciplina separata dalla fonetica. In questi casi, le prime due sezioni della fonetica (in senso lato) - l'acustica del linguaggio e la fisiologia del linguaggio - vengono combinate nella fonetica (in senso stretto), che si oppone alla fonologia.
La fonetica è una branca della linguistica che studia il lato sonoro della lingua. Il suono è l'unità più breve e indivisibile della lingua. I suoni nella lingua servono a distinguere i gusci sonori di varie parole: tom, lì, diga, regalo, calore, palla, ecc.
I suoni sono pronunciati dagli organi vocali, la cui totalità è chiamata apparato vocale. L'apparato vocale è costituito dalle corde vocali, dalla cavità orale, che contiene la lingua, le labbra, i denti, il palato, gli alveoli e le cavità nasali. Gli organi vocali sono attivi (mobili) e passivi (immobili). Quelli attivi includono le corde vocali, la lingua, le labbra e la parte posteriore del palato. Passivo: tutti gli altri.
Di tutti gli organi della parola, solo le corde vocali sono create dalla natura appositamente per la pronuncia dei suoni. Tutti gli altri organi della parola avevano originariamente uno scopo diverso (che, tra l'altro, mantengono fino ad oggi). Pertanto, la funzione iniziale e principale dei denti è masticare il cibo, la funzione della lingua è di spingere ulteriormente il cibo masticato lungo il tratto digestivo, la funzione della cavità nasale è quella di fungere da canale respiratorio, ecc. E solo più tardi tutti questi organi furono adattati per produrre suoni.
Le corde vocali, a differenza degli altri organi vocali, producono vibrazioni ritmiche del flusso sonoro, chiamate tono. I restanti organi della parola producono vibrazioni non ritmiche del flusso sonoro, chiamate rumore.
Il lavoro degli organi vocali necessario per produrre un suono particolare è chiamato articolazione. L'articolazione di qualsiasi suono è composta da tre fasi: escursione, resistenza e ricorsione. L'escursione è il portare gli organi della parola nello stato necessario per la produzione di un dato suono, la resistenza è la permanenza degli organi della parola in questo stato e la ricorsione è il passaggio all'articolazione del suono successivo.
I suoni sono vocali e consonanti. Le vocali sono suoni che si formano facendo tremare le corde vocali e sono costituiti da un solo tono senza alcuna mescolanza di rumore. Le consonanti sono suoni formati dal rumore.
A seconda del rapporto tra rumore e voce, tutte le consonanti sono distribuite in tre gruppi: sonorante (sonanti), consonanti sonore e consonanti sorde. I suoni sonori sono suoni costituiti da tono e rumore, in cui predomina il tono. In russo le sonori sono “m”, “n”, “r”, “l”, così come le loro varianti morbide. Come le vocali, le sonorità possono essere estese, persino cantate. In alcune lingue, le sonore, insieme alle vocali, svolgono un ruolo sillabico. Un esempio di ciò è la parola ceca vlk (lupo), dove il sonante gioca un ruolo nella formazione delle sillabe. La capacità di formare una sillaba avvicina i sonanti ai suoni vocalici.
Le consonanti sonore sono suoni costituiti da tono e rumore con predominanza di rumore. Le consonanti sorde sono suoni costituiti solo da rumore.
I suoni vocalici sono classificati in base al luogo della loro formazione e alle caratteristiche dell'articolazione. Di particolare importanza per la classificazione dei suoni vocalici è la posizione che assume la lingua nel momento in cui il suono viene pronunciato. Le vocali in cui la punta della lingua è vicina alla fila inferiore dei denti sono chiamate vocali anteriori. In russo, la prima fila include [e] e [i]. In altre lingue il numero delle vocali anteriori è maggiore. Quindi, ad esempio, in tedesco i suoni [ä], [ö], [ü] appartengono anche alla prima fila.
Le vocali in cui la punta della lingua è spostata al massimo verso la laringe sono chiamate vocali posteriori. In russo, l'ultima fila include [o], [u].
Le vocali centrali occupano una posizione intermedia tra le vocali di questi gruppi. In russo è [s], [a].
Un'altra caratteristica importante delle vocali è il livello di elevazione della lingua quando vengono pronunciate. Le vocali alte nella lingua russa includono [i], [ы], [у]. Durante l'articolazione di questi suoni, la punta della lingua si trova proprio nel palato. L'aumento medio include i suoni [e] e [o], mentre l'aumento inferiore include la vocale [a].
Le vocali possono essere arrotondate (labializzate) e non arrotondate (non labializzate). Quelli arrotondati in lingua russa includono [o], [u] e quelli non arrotondati includono tutti gli altri. In altre lingue, la gamma delle vocali arrotondate è leggermente più ampia. Ad esempio, in tedesco questi includono anche i suoni [ü] e [ö].
Alcune lingue distinguono tra vocali nasali e non nasali. I suoni nasali sono suoni in cui parte del flusso sonoro passa attraverso la cavità nasale. Le vocali nasali si trovano in polacco, kashubiano, lituano, portoghese, francese, occitano, bretone e in numerose altre lingue del mondo.
Per molte lingue è importante distinguere i suoni vocalici in base alla lunghezza/brevezza. Sostituire una vocale breve con una lunga e viceversa può cambiare completamente il significato della parola. Ad esempio, in ceco la parola pas (con vocale lunga) significa “cintura”, e la parola pas (con vocale breve) significa “passaporto”.
I suoni consonanti sono classificati in base al rapporto tra tono e rumore (questo è già stato menzionato sopra), dal luogo di formazione e dal metodo di formazione.
Secondo il luogo di formazione, le consonanti possono essere retrolinguali: [g], [k], [x]; frontelinguistico: [zh], [sh], [h], [r]; dentale: [d], [t], [z], [s], [l], [n], [ts]; labiale: [b], [p], [v], [f], [m]. C'è anche un suono della lingua media in lingua russa - [th].
Secondo il metodo di formazione, tutte le consonanti sono divise in esplosive (istantanee), fricative (lunghe, fricative) e vibranti. Le consonanti esplosive sono quelle la cui formazione è dovuta al fatto che un flusso d'aria proveniente dalla laringe rompe l'ostacolo creato dall'uno o dall'altro organo della parola. Le esplosive nella lingua russa includono [b], [k], [g], [t], ecc. Le consonanti di attrito sono consonanti che si formano a causa dell'attrito di un flusso d'aria sulle pareti di uno spazio formato da alcuni organi di discorso. Nella lingua russa, le fricative includono [ш], [з], [ф], ecc. I vibranti sono suoni formati a causa del tremore della punta della lingua o della parte posteriore del palato. In russo c'è solo una vibrante - [r].
Le affricate sono incluse in un gruppo speciale. Le affricate sono consonanti costituite da due componenti: una esplosiva e una fricativa. Ci sono due affricate senza voce nella lingua russa: [ch], [ts]. In inglese incontriamo l'affricata sonora [j] - nelle parole joke, job, large, juge, ecc., in polacco - con la coppia sonora k [ts] - [dz] nelle parole: dzwon - "campana" , dzban - "brocca", chodzą - "camminare" e molti altri. eccetera.
In russo e in altre lingue slave, le consonanti hanno spesso un segno aggiuntivo di durezza/morbidezza: vez - carrello, mal - accartocciato, tavolo - così.
In alcune lingue, le consonanti differiscono in lunghezza/brevezza. Quindi, ad esempio, in estone kas è una particella interrogativa e kass è "gatto".
Non tutte le categorie di suoni sopra elencate sono presenti in tutte le lingue del mondo. Ad esempio, la lingua Mangarai (una delle lingue indigene dell'Australia) è completamente priva di consonanti sorde e le lingue polinesiane non hanno affricate.
A.Yu. Spazzatura. Fondamenti della scienza del linguaggio - Novosibirsk, 2004.
Testare il lavoro in linguistica sull'argomento:
La fonetica come branca della linguistica
1. La fonetica come scienza (oggetto di studio e aspetti della fonetica)
7. Riferimenti
1. La fonetica come scienza
Fonetica- una branca della linguistica che studia i suoni della parola e la struttura sonora del linguaggio (sillabe, combinazioni di suoni, modelli di combinazione dei suoni in una catena vocale).
L'argomento della fonetica è la stretta connessione tra discorso orale, interno e scritto. La fonetica studia non solo la funzione linguistica, ma anche il lato materiale del suo oggetto: il lavoro dell'apparato di pronuncia, nonché le caratteristiche acustiche dei fenomeni sonori e la loro percezione da parte dei madrelingua. La fonetica considera i fenomeni sonori come elementi del sistema linguistico che servono a tradurre parole e frasi in forma sonora materiale, senza la quale la comunicazione è impossibile.
Tre aspetti della fonetica:
1) anatomico e fisiologico (articolatorio). Esplora il suono della parola dal punto di vista della sua creazione: quali organi vocali sono coinvolti nella sua pronuncia; Corde vocali attive o passive. Le labbra sono protese in avanti, ecc.
2) acustico (fisico). Considera il suono come una vibrazione dell'aria e ne registra le caratteristiche fisiche: frequenza (altezza), forza (ampiezza), durata.
3) aspetto funzionale (fonologico). Studia le funzioni dei suoni nel linguaggio, opera con i fonemi.
Unità fonetiche di base e mezzi:
Tutte le unità fonetiche sono divise in segmentali e supersegmentali.
Le unità segmentali sono unità che possono essere distinte nel flusso del discorso: suoni, sillabe, parole fonetiche (strutture ritmiche, battiti), frasi fonetiche (sintagmi).
Una frase fonetica è un segmento del discorso che rappresenta un'unità intonazione-semantica, evidenziata su entrambi i lati da pause.
Syntagma (battito del parlato) è un segmento di una frase fonetica caratterizzata da un'intonazione speciale e un accento del battito. Le pause tra le battute sono facoltative (o brevi) e l'accento sulla battuta non è molto intenso.
Una parola fonetica (struttura ritmica) fa parte di una frase unita da un accento verbale.
Una sillaba è l'unità più piccola di una catena vocale.
Il suono è l'unità fonetica minima.
Le unità supersegmentali (mezzi di intonazione) sono unità che si sovrappongono a quelle segmentali: unità melodiche (tono), dinamiche (accento) e temporali (tempo o durata).
Lo stress è la selezione nel parlato di una certa unità in una serie di unità omogenee utilizzando l'intensità (energia) del suono.
Il tono è uno schema ritmico e melodico del discorso, determinato da un cambiamento nella frequenza del segnale sonoro.
Il tempo è la velocità del discorso, che è determinata dal numero di unità segmentali parlate per unità di tempo.
Durata: la durata di un segmento vocale.
Sezioni di fonetica
La fonetica si divide in generale, comparativa, storica e descrittiva.
La fonetica generale esamina i modelli caratteristici della struttura del suono di tutte le lingue del mondo. La fonetica generale studia la struttura dell'apparato vocale umano e il suo utilizzo in diverse lingue nella formazione dei suoni del linguaggio, esamina i modelli di cambiamento dei suoni nel flusso vocale, stabilisce la classificazione dei suoni, la relazione tra suoni e fonetica astratta unità - fonemi, stabilisce i principi generali per dividere il flusso sonoro in suoni, sillabe e unità più grandi.
La fonetica comparativa confronta la struttura sonora di una lingua con altre lingue. Il confronto tra lingue straniere e native è necessario principalmente per vedere e assimilare le caratteristiche di una lingua straniera. Ma un simile confronto fa luce sui modelli della lingua madre. A volte il confronto tra lingue affini aiuta a penetrare più a fondo nella loro storia.
La fonetica storica traccia lo sviluppo di una lingua per un periodo di tempo abbastanza lungo (a volte dall'apparizione di una lingua specifica - la sua separazione dalla lingua madre).
La fonetica descrittiva esamina la struttura sonora di una particolare lingua in una determinata fase (molto spesso la struttura fonetica di una lingua moderna).
2. Classificazione dei suoni del parlato in base alle loro caratteristiche acustiche
La classificazione articolatoria dei suoni del linguaggio è necessaria per tutti coloro che studiano la pronuncia; la pratica pedagogica non può farne a meno. Tuttavia, è piuttosto ingombrante. Si è scoperto che è possibile creare una classificazione dei suoni più armoniosa ed economica in base alla loro natura acustica. Ciò è stato fatto quando nei laboratori fonetici sono comparsi dispositivi per analizzare le caratteristiche acustiche dei suoni, cioè i loro spettri, chiamati spettrometri.
La classificazione acustica si basa sulla forma dello spettro sonoro. Esegue costantemente un'opposizione binaria (binaria, dicotomica) dei suoni del parlato per ciascun attributo: suoni bassi - alti, diesis - diesis, ecc.
Cos'è lo spettro sonoro?
Tutti i suoni sono divisi in toni e rumori. I suoni con vibrazioni periodiche e armoniche sono toni. I suoni risultanti da una serie di vibrazioni non periodiche sono chiamati rumore. Nel discorso, i suoni tonali si formano con la partecipazione delle corde vocali. I rumori si formano quando si verificano ostruzioni nella cavità orale. Le vocali sono suoni tonali, le consonanti sorde sono suoni rumorosi. Le consonanti sonore sono consonanti tonali con una leggera mescolanza di rumore, le consonanti rumorose sonore sono rumore con la partecipazione del tono.
Ogni suono tonale della parola è costituito da molte vibrazioni semplici, cioè vibrazioni di una certa frequenza (sono chiamate armoniche). Se tracciamo le frequenze di queste armoniche in hertz sull'asse orizzontale e i valori di intensità in decibel sull'asse verticale, otteniamo lo spettro di questo suono.
Con diverse posizioni degli organi vocali, la cavità orale è come un sistema di risonatori acustici: è "sintonizzata" su più armoniche contemporaneamente. La figura mostra uno schema del funzionamento di un tale sistema: si può vedere che i risonatori sono sintonizzati su frequenze di 500 Hz e 1000 Hz.
Quando un suono complesso entra in un sistema di risonatori con una tale risposta in frequenza, si trasforma: le frequenze che coincidono con quelle risonanti vengono amplificate e le altre frequenze vengono smorzate. Lo spettro sonoro assomiglia a questo
3. Classificazione dei suoni vocalici in base alle loro caratteristiche articolatorie
Le vocali sono classificate in base alle seguenti principali caratteristiche articolatorie:
1. Riga, ad es. a seconda di quale parte della lingua viene sollevata durante la pronuncia. Quando la parte anteriore della lingua si alza, si formano le vocali anteriori (i, uh), le vocali medio-medie (s) e le vocali posteriori-posteriori (o, y).
2. Sollevamento, ad es. a seconda di quanto si solleva la parte posteriore della lingua, si formano cavità risonatrici di volume variabile. Ci sono vocali aperte o, in altre parole, larghe (a) e chiuse, cioè strette (i, u).
3. Labializzazione, ad es. a seconda che l'articolazione dei suoni sia accompagnata o meno dall'arrotondamento delle labbra protese in avanti.
Ci sono vocali arrotondate (labiali, labializzate), ad esempio [⊃], [υ] e vocali non arrotondate, ad esempio [i], [ε].
4. Nasalizzazione, ad es. a seconda che il velo sia abbassato, consentendo o meno il passaggio simultaneo di un flusso d'aria attraverso la bocca e il naso. Le vocali nasali (nasalizzate), ad esempio [õ], [ã], sono pronunciate con uno speciale timbro “nasale”.
5. Longitudine. In un certo numero di lingue (inglese, tedesco, latino, greco antico, ceco, ungherese, finlandese), con la stessa o simile articolazione, le vocali formano coppie, i cui membri sono contrastanti nella durata della pronuncia, ad es. differiscono, ad esempio, per le vocali brevi: [a], [i], [⊃], [υ] e per le vocali lunghe: [a:], [i:], [⊃:], .
6. Dittongazione
In molte lingue le vocali si dividono in monottonghi e dittonghi. Un monottongo è una vocale articolatoria e acusticamente uniforme.
Un dittongo è un suono vocale complesso costituito da due suoni pronunciati in una sillaba. Questo è un suono vocale speciale in cui l'articolazione inizia in modo diverso da come finisce. Un elemento del dittongo è sempre più forte dell'altro elemento. Esistono due tipi di dittonghi: discendente e ascendente.
In un dittongo discendente il primo elemento è forte e il secondo più debole. Tali dittonghi sono caratteristici dell'inglese. e tedesco linguaggio: tempo, Zeit. In un dittongo ascendente il primo elemento è più debole del secondo. Tali dittonghi sono tipici del francese, dello spagnolo e dell'italiano: pied, bueno, chiaro. In russo lingua Non ci sono dittonghi.
4. Classificazione dei suoni consonantici secondo il metodo di articolazione
La classificazione delle consonanti si basa sul contrasto di alcune caratteristiche con altre. Nel russo moderno, i suoni delle consonanti sono divisi secondo diversi criteri di classificazione (acustici e articolatori):
2) per luogo di istruzione;
3) per metodo di educazione;
4) dalla presenza o assenza di palatalizzazione (“ammorbidimento”, dal latino palatum - cielo).
Secondo le caratteristiche articolatorie, quelli iniziali sono il metodo di formazione e il luogo di formazione.
1. In base al luogo di formazione del rumore, in base al quale gli organi della parola prendono parte alla pronuncia, i suoni sono divisi in labiali e linguali. a) Consonanti labiali, in cui si forma un ostacolo con l'aiuto delle labbra o del labbro inferiore e denti dell'arcata superiore. In russo, i labiali sono divisi in labiolabiali ([b], [p], [m], [b"], [p"], [m"]) e labiodentali ([v], [v"] , [f ], [F"]).
Quando si producono suoni labiali, l'organo attivo è il labbro inferiore e l'organo passivo è il labbro superiore (suoni labiali) o i denti superiori (suoni labiali).
b) A seconda di quale parte della lingua crea un'ostruzione, le consonanti linguali si dividono in anteriore-linguali, medio-linguali e posteriori-linguali.
In russo, i suoni della lingua frontale includono [d], [t], [n], [z], [s], [l] e i corrispondenti suoni deboli [d"], [t"], [n"] , [ z"], [s"], [l"], così come [ts], [h"], [sh], [sh̅"], [zh"].
Quelli frontelinguistici includono:
1) dentale: [t], [t"], [d], [d"], [s], [s"], [z], [z"], [ts], [n], [n "], [LL"];
2) palatodentale: [w], [sh̅"], [zh], [zh̅"], [p], [p"], [h"].
I suoni linguali costituiscono la maggior parte di tutti i suoni consonantici: i suoni linguali anteriori si formano con la partecipazione della parte anteriore della parte posteriore della lingua; mediolinguale - con la partecipazione della parte centrale della parte posteriore della lingua; linguale posteriore - con la partecipazione della parte posteriore della lingua.
Solo [j] appartiene al suono della lingua media.
I suoni linguali posteriori sono [g], [k], [x], [g"], [k"], [x"].
2. Secondo il metodo di formazione del rumore, le consonanti sono divise in:
A) Esplosivo (chiuso), quando pronunciato si ha la completa chiusura degli organi fonatori, con la forza vinta da un flusso d'aria. Si tratta di [b], [p], [d], [t], [g], [k] e le corrispondenti varianti soft [b"], [p"], [d"], [t"], [g"], [k"].
B) Frizionale (fricative), durante la pronuncia dei quali gli organi della parola non si chiudono completamente, determinando la formazione di uno spazio attraverso il quale passa l'aria. Le consonanti di attrito sono altrimenti chiamate spiranti (dal latino spiro - respiro). In russo è [v], [v"], [f], [f"], [z], [z"], [s], [s"], [zh], [zh̅"], [ w], [sh̅"], [x].
C) Affrica, quando si pronunciano queste consonanti, gli organi della parola si chiudono, formando una barriera, che viene poi lacerata dall'aria, risultando in uno spazio vuoto. In questo caso la chiusura e la rottura sono istantanee. Questi sono i suoni [ch"] e [ts].
D) Consonanti tremanti o vibranti, durante la cui formazione vibrano gli organi attivi della parola. In russo questi sono i suoni [р] e [р"].
D) Consonanti passive vicine, durante la pronuncia delle quali gli organi vocali sono completamente chiusi, ma non vengono interrotti dall'aria, poiché l'aria passa attraverso il naso o la bocca. Questi sono i suoni [l], [l"], [m], [m"], [n], [n"].
3. La maggior parte dei suoni consonantici della lingua russa si oppongono tra loro sulla base della durezza e della morbidezza: [b] - [b"], [p] - [p"], ecc.
5. Classificazione dei suoni consonantici per luogo di formazione e organo attivo
Il luogo di formazione dei suoni consonantici è determinato dal punto in cui nel tratto articolatorio durante la produzione di questo suono si forma un ostacolo
percorsi del flusso d'aria. Per formare un ostacolo in diversi punti dell'apparato articolatorio, vengono utilizzate le capacità dei suoi organi mobili: la lingua e le labbra. Si chiamano organi attivi. Questo è il labbro inferiore o qualsiasi parte della lingua (posteriore, centrale, anteriore). Secondo l'organo attivo della parola, tutti i suoni consonantici sono divisi in labiali e linguali.
Un organo che rimane immobile mentre produce il suono si dice passivo. Questo è il labbro superiore, o i denti superiori, o qualche parte del palato (posteriore, centrale, anteriore). Secondo l'organo passivo della parola, tutti i suoni consonantici sono divisi in dentale, palatale-dentale, mediopalatale e palatale posteriore. Pertanto, quando si determina la posizione della formazione di un ostacolo, al suono viene assegnata non una, ma due caratteristiche: secondo l'organo attivo e quello passivo, ad esempio, [p] - labiale (organo attivo - labbro inferiore) labiale (organo passivo - labbro superiore).
Quindi, a seconda dell'organo attivo coinvolto nella formazione del suono, i suoni consonantici russi sono divisi in labiali [p], [p"], [b], [b"], [m], [m"], [ f], [f"], [v], [v"] e linguale [t], [t"], [s], [s"], [z], [z"], [ts], [ l], [l"], [n], [n"], [w], [w":] [g], [zh":], [p], [p"], [j], [ k], [k"], [g], [g"], [x], [x"]. Queste differenze sono utilizzate attivamente nella lingua russa per differenziare i significati.
I suoni linguali sono divisi in altri tre gruppi a seconda di quale parte della lingua (organo massiccio e mobile) è più attivamente coinvolta nella produzione del suono: linguale, linguale anteriore - [t], [t"], [s], [ s"], [z], [z"], [ts], [l], [l"], [n], [n"], linguale, linguale medio - [j] e linguale, linguale posteriore - [ k], [k" ], [g], [g"], [x], [x"]. Queste differenze sono utilizzate attivamente nella lingua russa per differenziare i significati.
Alla caratteristica del suono di un organo attivo si aggiunge la sua caratteristica di un organo passivo, che, come già accennato, comprende il labbro superiore, i denti e il palato. Quindi si distinguono i seguenti gruppi di suoni:
suoni labiali [p], [p"], [b], [b"], [m], [m"];
suoni labiodentali [f], [f"], [v], [v"];
suoni linguali, linguali anteriori, dentali [t], [t"], [s], [s"], [z], [z"], [ts], [l], [l"], [n] , [N"];
suoni linguali, linguali anteriori, palatodentali [w], [sh":] [zh], [zh":], [r], [r"], [h"];
suono linguale, lingua media, palato medio [j];
suoni linguali, linguali posteriori, palatali posteriori [k], [k"], [g], [g"], [x], [x"].
La classificazione dei suoni consonantici russi in base al luogo di formazione può essere presentata graficamente come segue.
La differenza nel luogo di formazione può svolgere un ruolo decisivo di differenziazione semantica quando tutte le altre caratteristiche dei suoni coincidono. Ad esempio, i suoni [s] e [x] sono duri, sordi, fricativi, ma il primo è linguale, linguale anteriore, dentale, e il secondo è linguale, linguale posteriore, palatale posteriore. Oppure i suoni [s] e [w] sono duri, sordi, fricativi, ma il primo è linguale, linguale anteriore, dentale, e il secondo è linguale, linguale anteriore, palatodentale. A causa del fatto che durante la loro produzione l'aria supera gli ostacoli formati da diversi organi di articolazione in diversi punti del tratto articolatorio, sentiamo facilmente la differenza nel loro suono e non possiamo percepire, ad esempio, le parole boor e lui stesso come la stessa cosa.
6. Il ruolo degli organi vocali nella produzione del suono
L'apparato vocale è costituito da due sezioni: centrale e periferica. La sezione centrale comprende il cervello con la sua corteccia, i nodi sottocorticali, le vie e i nuclei dei nervi corrispondenti. Alla parte periferica dell'apparato vocale; si riferisce all'intero insieme degli organi esecutivi della parola, costituito da ossa, cartilagine, muscoli e legamenti, nonché nervi sensoriali e motori periferici, con l'aiuto dei quali viene controllato il lavoro di questi organi.
L'apparato vocale periferico è costituito da tre sezioni principali che agiscono insieme.
La 1a sezione è l'apparato che forma la respirazione, che comprende il torace con i polmoni, i bronchi e la trachea.
La terza sezione è l'apparato di produzione del suono, o articolatorio, che consiste nella faringe, nel rinofaringe, nelle cavità orale e nasale.
La prima sezione dell'apparato vocale periferico serve a fornire un flusso d'aria, la seconda a formare la voce, la terza è un risuonatore, conferendo al suono forza e colore e formando così i suoni caratteristici del nostro discorso, che si presentano come un risultato dell'attività delle singole parti attive dell'apparato articolatorio. Questi ultimi includono la mascella inferiore, la lingua, le labbra e il palato molle.
La mascella inferiore si muove verso il basso e verso l'alto; il palato molle si alza e si abbassa, chiudendo e aprendo così il passaggio nella cavità nasale; la lingua e le labbra possono assumere un'ampia varietà di posizioni. Un cambiamento nella posizione degli organi vocali comporta la formazione di porte e costrizioni in varie parti dell'apparato articolatorio, a causa delle quali viene determinato l'uno o l'altro carattere del suono.
Le parti più importanti dell'apparato articolatorio che formano il discorso articolato sono la faringe, la lingua, il velo e la mascella inferiore: gli organi sono mobili, cioè cambiano posizione durante la parola. La faringe si trova sopra la laringe e passa dall'alto nel rinofaringe (la cavità che si trova sopra il velo palatino). Nella lingua si distinguono le seguenti parti: il bordo anteriore (la parte anteriore), il dorso (la parte centrale), i bordi (su entrambi i lati) e la radice (la parte posteriore a contatto con l'epiglottide).
La lingua è ricca di muscoli che la rendono molto mobile: può allungarsi e accorciarsi, diventare stretta e larga, piatta e curva.
Il palato molle, o velo, che termina con una piccola ugola, si trova nella parte superiore della cavità orale ed è una continuazione del palato duro, che inizia con gli alveoli ai denti superiori. Il velo palatino ha la capacità di muoversi verso l'alto e verso il basso e quindi separare la faringe dal rinofaringe. Quando si pronunciano tutti i suoni tranne la m e la n, il velo palatino viene sollevato. Se per qualche motivo il velo è inattivo e non è sollevato, allora il suono è nasale (nasale), poiché quando il velo è abbassato, le onde sonore passano principalmente attraverso la cavità nasale.
La mascella inferiore, per la sua mobilità, è un organo molto importante dell'apparato articolatorio (pronuncia del suono), poiché contribuisce al pieno sviluppo delle vocali accentate
suoni (a, o, u, e, i, s).
Lo stato doloroso delle singole parti dell'apparato articolare si riflette nella corretta risonanza e chiarezza dei suoni pronunciati. Pertanto, per sviluppare l'articolazione necessaria, tutti gli organi coinvolti nella formazione dei suoni del parlato devono funzionare correttamente e di concerto.
7. Riferimenti
1. Buraya E.A., Galochkina, I.E., Shevchenko T.I. Fonetica della lingua russa moderna
2. Bogomazov G.M. Lingua letteraria russa moderna: fonetica
3. Cheshko Lev Antonovich Lingua russa: fonetica. Vocabolario. Arti grafiche
Tutoraggio
Hai bisogno di aiuto per studiare un argomento?
I nostri specialisti ti consiglieranno o forniranno servizi di tutoraggio su argomenti che ti interessano.
Invia la tua candidatura indicando subito l'argomento per conoscere la possibilità di ottenere una consulenza.
Il nome “fonetica”, derivato dalla parola greca “suono”, è utilizzato da molti scienziati in diversi paesi. Negli studi letterari tedeschi più antichi, il nome Lautlehre è molto più comune. Questa è la scienza di
Non c'è consenso sulla questione se la fonetica sia una disciplina puramente linguistica o al confine tra linguistica e scienze naturali. In Sievers troviamo che la fonetica “forma una zona di confine tra fisica, fisiologia e linguistica”. Baudouin de Courtenay vedeva la fonetica come una disciplina linguistica, ma sottolineava anche la necessità di studiare l'acustica. Shcherba ha sostenuto questo punto di vista; cita un ampio elenco di lavori su acustica e fisiologia.
La fonetica si divide in privata (singole lingue) e generale. Quando studia e descrive la struttura del suono di una determinata lingua, il ricercatore inizia identificando le unità sonore funzionalmente significative di questa lingua (fonemi), basandosi su alcune delle loro caratteristiche fonetiche, e quindi, avendo ricevuto un oggetto da descrivere sotto forma di queste unità, ne analizza le caratteristiche articolatorio-acustiche in tutte le posizioni possibili in una data lingua.
L'argomento della fonetica comprende la stretta connessione tra discorso orale, interno e scritto. A differenza di altre discipline linguistiche, la fonetica studia non solo la funzione linguistica, ma anche il lato materiale del suo oggetto: il lavoro dell'apparato di pronuncia, nonché le caratteristiche acustiche dei fenomeni sonori e la loro percezione da parte dei madrelingua. A differenza delle discipline non linguistiche, la fonetica considera i fenomeni sonori come elementi del sistema linguistico che servono a tradurre parole e frasi in forma sonora materiale, senza la quale la comunicazione è impossibile. Conformemente al fatto che il lato sonoro di una lingua può essere considerato negli aspetti acustico-articolatorio e linguistico-funzionale, in fonetica si distingue tra fonetica propriamente detta e fonologia.
Una fonetica particolare è associata alla lessicologia, alla morfologia e alla sintassi. Nel vocabolario, questo si rivela in alcuni modelli di distribuzione del suono, chiamati fonotattica, limitando il sound design delle parole. La fonotattica si riferisce alle regole per l'utilizzo di determinati fonemi e alle loro combinazioni in diverse parti di una parola. La consonante /s/ nelle parole native tedesche non ricorre in Anlaut. Una caratteristica distintiva del tedesco è che i vincoli fonotattici operano sul morfema piuttosto che sulla parola. Pertanto, in russo l'uso di parole rumorose sonore è escluso solo alla fine della parola, e in tedesco - alla fine della radice e alla fine dei morfemi derivazionali. /fra G lich/, /fra G it/. Il fonema /z/ non è possibile alla fine di un morfema, nemmeno prima della vocale au S atmen.
Il ramo della fonetica che si occupa dell'accento delle parole è anche associato alla lessicologia. Spostare l'accento rende la parola irriconoscibile. La connessione tra fonetica e lessicologia si rivela anche nel fatto che, grazie all'alternanza, un madrelingua è in grado di identificare un morfema e riconoscere la relazione etimologica tra parole che contengono questo morfema.
La connessione tra fonetica e morfologia è più profonda che con la lessicologia, poiché influenza molti aspetti essenziali della struttura grammaticale di una lingua. Molti germanisti introducono la fonetica come sezione dei libri di grammatica (Grimm, Paul, Sütterlin). Morfonologia- una disciplina relativamente nuova (Trubetskoy), si occupa di alternanze di fonemi che non violano l'identità del morfema corrispondente. All'intersezione tra morfologia (morfemica) e fonologia. a//ä Apfel//Äpfel la categoria grammaticale del numero si esprime solo tramite dieresi.
La connessione tra fonetica e sintassi si manifesta attraverso l'intonazione. Senza una durata adeguata nel tempo, senza l'una o l'altra forza del suono e senza movimento nella frequenza del tono fondamentale della voce, nemmeno l'espressione più breve può essere pronunciata. Intonologia(Peshkovsky, Febi).
In molti casi l'intonazione è l'unico mezzo per esprimere il significato di una frase, in particolare il suo tipo comunicativo.
Dividere il flusso vocale in sintagmi.
Collegamento di frasi nel flusso del discorso.
Il tema è la divisione rematica di una frase.
Connotazione emotiva (modale-emotiva).
Discorso poetico.
Aspetti della fonetica: articolatoria, acustica, percettiva, linguistica (sociale).
Sezioni di fonetica, fonetica segmentale e soprasegmentale.
Il concetto di fonema.
Un madrelingua isola facilmente un fonema separato da una parola, cioè un intero fonema, e non solo una parte di esso (inizio, metà, fine). Questo è il suo minimalismo fonologico. Stiamo parlando di isolamento fonologico (cioè legato al significato), e non acustico. La sillaba funge da unità di pronuncia nel parlato normale. Pronunciare una singola sillaba non richiede uno sforzo particolare e viene percepito in modo naturale. Dividere una sillaba nei suoi suoni costituenti suona innaturale e non avviene mai nel discorso spontaneo. I bambini in età prescolare, come dimostrato da studi specifici, non sanno come scomporre le parole in fonemi individuali e non sono consapevoli dei singoli suoni.
Poiché il fonema stesso non significa nulla come parte di una parola, il bambino non ha motivo di prenderne coscienza nell'atto della parola. Un motivo del genere appare solo quando si insegna a un bambino a leggere e scrivere, cosa che inizia, naturalmente, con l'apprendimento dei significati sonori delle lettere. Sfortunatamente, la separazione delle lettere porta a un malinteso sulla separazione dei suoni.
Pilch: “Un suono separato esiste, tuttavia, solo come suono separato di una determinata lingua, e non come elemento distinto del flusso vocale indipendente da questa lingua. Ogni segmentazione è adatta solo per una determinata lingua e all'interno della struttura di quella lingua. I segmenti fonemici (come il segmento tedesco /s/ in heißen, /ts/ in heizen) sono unità astratte, non concrete."
Una sillaba è giustamente considerata l'unità minima di pronuncia. Un fonema è l'unità sonora minima della lingua, e la sua indivisibilità è determinata non in modo articolatorio o acustico, ma dal fatto che nel suo insieme, e non nelle sue singole parti, svolge una certa funzione linguistica (semantica).
La differenza fondamentale tra un fonema e un morfema - la più piccola unità significativa della lingua - è che un fonema non può essere un portatore diretto di significato. Anche in caso di cedimento e, abbassarsi T, dove i fonemi sembrano servire come designazione del numero e della persona del verbo, infatti, la funzione morfologica è svolta dalle desinenze dei morfemi, mentre i fonemi agiscono solo come piano per l'espressione di questi morfemi. La connessione tra un fonema e un significato si rivela indirettamente, vale a dire nel fatto che la sua presenza nella forma sonora di un morfema o di una parola è obbligatoria: senza fonemi e E T i significati grammaticali corrispondenti non possono essere realizzati.
Funzioni del fonema. Principi per determinare la composizione dei fonemi di una lingua.
Funzioni svolte dai fonemi
1)Costitutivo o tettonico. In questa funzione, i fonemi fungono da materiale da costruzione da cui viene creato l'involucro sonoro delle unità linguistiche dotate di significato (morfemi, parole e le loro forme).
2) Distintivo, o distintivo. I fonemi possono, ad esempio, agire come una funzione discriminatoria delle parole. Ton – Tod, o nella forma che distingue la forma, ad es. Tag - Tag.
In alcuni casi, il fonema svolge sia le sue funzioni costitutive che quelle distintive da solo - in parole unifonemiche (congiunzioni a, e; interiezioni, nomi di lettere - in tedesco) e morfemi (suffissi, desinenze). Un caso più tipico è quando un fonema espleta la sua funzione costitutiva partecipando insieme ad un altro fonema o ad altri fonemi alla formazione dell'esponente di una parola o di un morfema. Se gli esponenti di tali parole o morfemi differiscono tra loro per un fonema, la funzione distintiva del fonema è, per così dire, concentrata in un punto e quindi appare particolarmente chiara.
La composizione dei fonemi è stabilita secondo il dizionario più completo della lingua moderna, comprese le forme delle parole non incluse nel dizionario. Il vocabolario tedesco, come altre lingue moderne, contiene un numero enorme di prestiti.
Gli internazionalismi, cioè le parole formate dalle radici greche o latine nei tempi moderni - sociologia, dovrebbero essere distinti dai prestiti. Non si può parlare qui di alcuna influenza della pronuncia greca o latina. L'influenza sulla pronuncia è possibile solo quando entrano in contatto parlanti di lingue diverse.
È necessaria un'analisi attenta dell'aspetto sonoro dei prestiti per valutarlo correttamente e decidere se debba essere considerato un fenomeno della struttura sonora della lingua presa in prestito. Sarebbe errato includere il tedesco /nasale a/ nei fonemi vocalici in quanto la parola Chance, presa in prestito dal francese, si pronuncia con questo suono, come qui pronuncia delle citazioni.
Se la pronuncia di una parola presa in prestito non è dettata dal suo aspetto sonoro originale, è necessario tenerne conto quando si identifica la composizione dei fonemi di questa lingua. Il nome del classico della letteratura francese Hugo in francese non ha una consonante all'inizio. In russo la /g/ veniva provocata dalla scrittura. Il contrasto tra Hugo e lip mostra che /g/ e /g’/ da allofoni di un fonema si sono trasformati in due fonemi indipendenti.
Nello stabilire un inventario fonemico non deve tralasciare una sola parola del vocabolario principale, comprese quelle rare. Questi ultimi sono di particolare interesse, poiché riflettono più chiaramente la dinamica del sistema audio.
Quando si stabilisce la composizione dei fonemi di una lingua, si dovrebbe fare affidamento sul tipo completo di pronuncia. Le unità semantiche (morfemi, parole) sono rappresentate nel sistema linguistico e immagazzinate nella memoria di chi lo parla sotto forma di una catena di fonemi, che riflette l'intero tipo di pronuncia.
Fonema e allofoni. Tipi di allofoni.
Allofono, allofonema– un fonema in una determinata posizione fonetica, cioè un rappresentante completo del fonema nel discorso. Per comprendere l'essenza dell'allofono, è necessario tenere conto del fatto che il suono che lo rappresenta in specifiche condizioni di comunicazione vocale sarà diverso. Ogni persona ha caratteristiche diverse dell'apparato vocale. L'analisi acustica mostra che ogni persona pronuncia ogni volta lo stesso allofono in modo leggermente diverso. Allo stesso tempo, ogni suono pronunciato in questo momento non è un allofono speciale, ma una delle sue possibili implementazioni nel parlato. Di conseguenza, un allofono, come un fonema, è una sorta di invariante, cioè un'unità astratta. Fa da sottofondo una sola, unica “istanza” di suono (Maslov) emesso in un dato momento, avente caratteristiche fonetiche ben definite.
Il fonema in una determinata posizione è rappresentato da un allofono e in una determinata pronuncia dallo sfondo, che è oggetto di analisi fonetica sperimentale. Fonema e allofono sono unità di struttura linguistica; lo sfondo è essenzialmente extralinguistico, riflette la natura biologica dell'uomo.
|
Tipi (tipi) di allofoni: |
||||
|
obbligatorio |
opzionale |
|||
|
di base |
specifico (posizionale in senso lato) |
|||
|
che si presentano in condizioni di coarticolazione, cioè in combinazione con altri fonemi - combinatorio. Combinazione con vocali labializzate – Katze - Kohle |
a seconda della posizione occupata dal fonema in un'unità significativa - all'inizio di una parola o morfema, alla fine, o in una posizione intervocalica all'interno di queste unità, o quando sono combinati nel flusso del discorso, - posizionale. Occlusiva glottale (Knacklaut) all'inizio della radice per le vocali Abend, Erbe, beachten, Ausatmung. Le consonanti occlusive sorde della lingua tedesca all'inizio di una parola o radice prima delle vocali compaiono negli allofoni posizionali aspirati, in altre posizioni non aspirate Puder, verkürzen, Pate, Lupe. |
a seconda della posizione del fonema rispetto al luogo dell’accento – accento. È particolarmente comune in russo, dove si distinguono fino a due gradi di riduzione nelle sillabe non accentate. In tedesco, queste sono vocali lunghe in una sillaba accentata e vocali semilunghe in una sillaba non accentata. |
Tedesca r, russa g sociolinguistico, sistemico-linguistico |
|
|
t, d, l pronuncia isolata, riconosciuta come elemento del discorso |
||||
Gli allofoni sono in rapporti di distribuzione complementare, cioè non si trovano nella stessa posizione, e quindi sono la realizzazione di un fonema. Se nella stessa parola o morfema il fonema rappresentato da questo allofono è in una posizione diversa, allora sarà rappresentato da un altro allofono. Le Con ale Con ov
Tuttavia, per considerare due suoni usati in modo complementare come allofoni di un fonema, è necessario che siano collegati tra loro attraverso unità semantiche del linguaggio - bra T oh, applique T tu. La distribuzione aggiuntiva è solo una condizione esterna per l'unificazione degli allofoni. Per rappresentare un fonema, sebbene non in tutti i casi, ma in alcune parti del sistema linguistico, devono necessariamente alternarsi in un'unità semantica.
Il caso delle consonanti tedesche /h/ e /ng/ illustra bene il fatto che la sola distribuzione complementare non può costituire un criterio. Queste consonanti si trovano in posizioni mutuamente esclusive: /h/ solo all'inizio di una sillaba, /ng/ solo alla fine. Allo stesso tempo, rappresentano fonemi diversi, poiché non sono affatto collegati tra loro dall'alternanza, cosa esclusa per gli allofoni.
Quattro regole derivate da NS Trubetskoy per distinguere i fonemi dalle varianti dei fonemi:
1) Se in una lingua particolare due suoni si trovano nella stessa posizione e possono sostituirsi a vicenda senza cambiare il significato della parola, allora tali suoni sono varianti opzionali di un fonema.
Allo stesso tempo, le opzioni opzionali sono generalmente significative e individuali, oltre che stilisticamente significative e stilisticamente insignificanti.
2) Se due suoni si trovano nella stessa posizione e non possono sostituirsi a vicenda senza cambiare il significato della parola o distorcerlo al di là del riconoscimento, allora questi suoni sono realizzazioni fonetiche di due fonemi diversi.
3) Se due suoni acusticamente (o articolatoriamente) correlati non si presentano mai nella stessa posizione, allora sono varianti combinatorie dello stesso fonema.
4) Due suoni che soddisfano a tutti gli effetti le condizioni della terza regola non possono tuttavia essere considerati varianti di uno stesso fonema se in una data lingua possono susseguirsi come membri di una combinazione sonora, inoltre, in una posizione in cui uno uno di questi suoni può verificarsi non accompagnato da un altro.
Trascrizione fonemica e allofonica.
Il grado di dettaglio della registrazione della trascrizione del discorso dipende da ciò che deve registrare: tutte le caratteristiche del suono, inclusa la generazione del discorso individuale e dipendente dalla situazione (emotiva), o le caratteristiche sistema fonetico lingua.
L'analisi fonemica è "la selezione di un suono sullo sfondo di una parola, il confronto delle parole secondo i suoni selezionati, la determinazione della composizione sonora quantitativa e coerente di una parola". Cioè, durante l'analisi fonemica, non solo riconosciamo e distinguiamo le parole in base alla percezione delle differenze nella loro composizione fonemica, ma rivolgiamo anche la nostra coscienza analitica alla composizione sonora della parola. Pertanto, il processo di analisi fonemica è una funzione più complessa.
Sulla base della percezione e dell'analisi fonemica, si formano idee fonemiche sulla composizione sonora della lingua. e) l'uso corretto dei suoni per distinguere le parole /, nello sviluppo del quale anche la memoria e l'attenzione giocano un ruolo significativo.
Nella trascrizione fonemica ogni fonema, indipendentemente dalla sua implementazione sonora, è sempre trasmesso dallo stesso segno di trascrizione. Ciò che è scritto nella trascrizione fonemica è racchiuso tra parentesi oblique / /.
Nella fonetica (allofonemica) vengono utilizzati segni diversi per trasmettere diverse varianti dello stesso fonema. Ciò che è scritto nella trascrizione fonetica è racchiuso tra parentesi quadre.
Errori fonemici e fonetici.
È chiaro che gli errori fonologici non possono che essere fonetici e continua la ricerca per la più accurata differenziazione degli errori di pronuncia in base al loro significato per il processo di comunicazione.
Ad esempio, nell'articolazione dei suoni labiali si rileva quanto segue:
· errori fonemici – indistinzione e confusione p-f, b-b, p-b, f-v, p-p e così via.;
· errori fonetici - pronuncia dei suoni V E F come labiolabiali.
Quando si pronunciano le sonanti, si verificano spesso errori fonemici: lr; l-n, l-l", rr" e così via.; errori fonetici: R- un colpo, l- bilabiale, ecc.
Categorie di difetti come la miscelazione e la sostituzione dei suoni costituiscono un gruppo speciale, perché Queste deviazioni dalla pronuncia standard rivelano l'instabilità dell'intero sistema fonetico della lingua. I bambini possono mescolare i suoni in alcune posizioni di una parola e pronunciarli correttamente in altre. Un suono può avere diversi sostituti. Le sostituzioni sonore possono essere costanti, ma spesso sono variabili nelle diverse forme di discorso. In questi gruppi di difetti, di natura fonologica, si manifesta una violazione delle opposizioni sonore, che colpisce parte o tutto il sistema uditivo, a seconda del numero di suoni mescolati.
Ci sono due aspetti della norma di pronuncia: ortoepia e ortofonia. L'ortoepia è le regole che determinano la scelta del fonema appropriato, del luogo dell'accento e dell'intonazione richiesta quando si pronuncia una determinata unità linguistica significativa. Ad esempio, in russo la regola è scegliere il fonema /sh/ o /ch/ prima di /n/ e /t/ (buloshnaya, ma barocco; shto, ma lettore), in tedesco - /sch/ o /s/ prima /p/ ( Schpiritus - alcool, Spiritus - espirazione).
L'ortofonia è la regola per scegliere l'allofono necessario in una determinata posizione e pronunciarlo correttamente. Quindi le consonanti russe /sh/ e /ts/ devono essere sempre dure, indipendentemente dalla vocale che le segue (sei, prezzo). La consonante tedesca /soft ch/ in tutte le posizioni dovrebbe essere pronunciata come mediolinguale e non come palatalizzata anteriore-linguale, la vocale allofona /k/ alla fine di una parola dopo le vocali anteriori dovrebbe essere pronunciata debolmente palatalizzata - Blick, zurück, Sieg. Gli errori di ortografia vengono comunemente definiti accenti.
Gli errori ortoepici possono essere classificati come errori fonologici e errori ortofonici - come fonetici nel senso stretto del termine. Reformatsky ha scritto sull'importanza di questa distinzione per i metodi di insegnamento. Gli errori fonologici, cioè la sostituzione dei fonemi, sono spesso il risultato del non sapere quale fonema pronunciare, piuttosto che come pronunciarlo. Se un russo dice /spät/ invece di /schpät/ è perché non sa che questa parola inizia con /sch/. Tuttavia sostituisce il fonema /ng/ con /nk/, ad esempio nella parola /sang/, proprio perché non sa come pronunciarlo. In entrambi i casi, il riconoscimento delle parole diventa impossibile.
Sistema fonetico. Il concetto di opposizione.
La descrizione del sistema di fonemi di una lingua si basa sui contrasti (opposizioni) dei fonemi secondo caratteristiche distintive (vocato-vocato, duro-morbido, ecc.). Possiamo dire che un fonema è costituito solo da queste caratteristiche. Un sistema fonologico è impossibile senza opposizioni: se una lingua (ad esempio il francese) non ha il concetto di fonemi consonantici morbidi, allora non ci sono fonemi consonantici duri, sebbene i suoni del parlato pronunciati possano essere considerati da parlanti di un'altra lingua (ad esempio , russo) come duro o morbido.
Molto spesso, tuttavia, i tratti distintivi che non influiscono sul significato non vengono riconosciuti dai madrelingua. Queste sono, ad esempio, le vocali chiuse aperte in lingua russa: in parole suocero([test']) - test([test]) suoni vocalici diversi, ma distinguiamo le parole suocero E test non dalla chiusura-apertura del suono [e], ma dalla durezza-morbidezza delle consonanti. In russo, le vocali aperte e chiuse non si trovano mai nella stessa posizione (le vocali chiuse sono sempre solo prima delle consonanti morbide); Non esiste una sola coppia di parole che differisca solo nella vocale chiusa-aperta; la vocale chiusa-aperta è solo un segno accompagnatorio della morbidezza-durezza della consonante. In tedesco, ad esempio, le parole Ähre – [’ὲ:rÖ] ( orecchio) e Ehre – [’é:rÖ] ( onore) differiscono solo nell'apertura-chiusura del suono della prima vocale (cioè questa caratteristica è significativa), quindi i madrelingua tedeschi percepiscono chiaramente le differenze nell'apertura-chiusa dei suoni vocalici.
La teoria delle opposizioni di Trubetskoy ha costituito la base del metodo dell'opposizione. Non tutte le differenze sono un'opposizione. L'opposizione è possibile solo quando non ci sono solo differenze tra i suoi membri, ma anche le sue caratteristiche, che sono la base per il confronto, e la caratteristica distintiva è chiamata caratteristica differenziale.
L'opposizione può essere definita come una differenza semanticamente rilevante quando gli altri sono simili in un attributo.
La base dell'opposizione è invariante, ma esistono anche segni reali = varianti.
La conclusione è che questa teoria è associata alla comprensione di un fonema come un certo insieme di caratteristiche differenziali. Fonema = insieme di caratteristiche differenziali. I singoli fonemi si distinguono per diverse caratteristiche differenziali. t/d – secondo sonorità-senza voce, t/z – secondo voce/voce e chiusura (frizionale). I suoni devono differire secondo una caratteristica differenziale.
Multidimensionale: si estende ad altri membri dello stesso sistema.
Unidimensionale: la base per il confronto è inerente solo a una coppia di membri.
Proporzionale
Isolato
Un'opposizione si dice proporzionale se i rapporti tra i suoi membri sono identici ai rapporti di un'altra opposizione.
Esempio. In tedesco: p-b, t-d, k-g sono proporzionali; p-š è isolato (b-[zh] non è in tedesco).
Privato: un membro (contrassegnato) è caratterizzato dalla presenza e l'altro (non contrassegnato) dall'assenza dell'attributo.
Graduale: diversi gradi (gradazioni) di una caratteristica. Esempi: u-o (labializzazione), ü-ö, i-e.
Equipolante: entrambi i termini sono logicamente uguali. Esempi: p-t, f-k.
Secondo il volume del potere semanticamente distintivo delle opposizioni in diverse posizioni:
costanti - hanno la stessa forza che distingue il significato in tutte le posizioni (/r/-/l/ in russo);
neutralizzato - i cui membri, in determinate condizioni, non possono svolgere la funzione di discriminazione del significato. Si distinguono posizioni di rilevanza (possono) e di neutralizzazione (non possono).
Un tipico esempio di neutralizzazione: assordamento delle consonanti sonore alla fine di una parola, caratteristico delle lingue russa o tedesca. La posizione in cui viene rimossa l'opposizione è chiamata posizione di neutralizzazione, o posizione debole. Per ogni opposizione può esserci la propria posizione di neutralizzazione: ad esempio, per l'opposizione tra sordo e sonoro rumoroso in lingua russa, la posizione prima della vocale è forte, e la posizione prima della consonante rumorosa (eccetto [v]) è debole, e per l'opposizione di consonanti dure e morbide, solo la posizione debole davanti ad un'altra rumorosa (alla fine della parola sono possibili sia dure che morbide, cfr. talpa - talpa.
Caratteristiche integrali e differenziali dei fonemi.
Trubetskoy divide tutte le caratteristiche di un fonema in rilevanti e irrilevanti. Egli considera rilevanti solo le opposizioni privative: la presenza di un segno (marcatezza), l'assenza di segno (non marcatezza).
Se un fonema è opposto a tutti gli altri fonemi, allora, secondo Shcherba, “ogni fonema è determinato principalmente da ciò che lo distingue dagli altri fonemi della stessa lingua. Grazie a ciò, tutti i fonemi di una data lingua formano un unico sistema di opposti, dove ogni membro è determinato da una serie di opposizioni diverse, sia i fonemi individuali che i loro gruppi”.
La teoria dei segni di Trubetskoy è stata criticata da Bernstein, poiché contraddice i fatti osservati nella pratica della comunicazione. Pertanto, la non nasalità di /g/ (una caratteristica irrilevante, secondo Trubetskoy) è importante per la percezione della parola “anno”.
Distinguere le caratteristiche rilevanti come significative e irrilevanti ( integrante) in quanto insignificante è inaccettabile quando si insegna la pronuncia straniera. Se dici a uno studente russo che il segno di sordità per il fonema tedesco /sch/ non è significativo, allora potrebbe considerare ammissibile la sua pronuncia sonora. Il che non è accettabile dal punto di vista della norma di pronuncia tedesca.
La teoria delle caratteristiche rilevanti è stata ulteriormente sviluppata nei lavori di Jacobson e Halle. Chiamavano questi segni differenziale, poiché la loro funzione è quella di distinguere unità linguistiche significative. Procedono dal fatto che queste caratteristiche sono primarie rispetto al fonema, poiché sono loro che consentono al fonema di essere un'unità distintiva, e quindi il fonema stesso è un insieme di caratteristiche differenziali.
Kuznetsov: Solo determinando i fonemi di una data lingua (sulla base del loro contrasto nella composizione di varie unità significative in condizioni fonetiche identiche), il loro comportamento fonetico in varie condizioni fonetiche e condizioni di vari fonemi contrastanti e non contrastanti, possiamo sarà in grado di selezionare dall'intera massa di caratteristiche stabilite sperimentalmente quelle che per una data lingua sono differenziali.
Principali scuole fonologiche: scuola fonologica di Praga, scuola fonologica di Shcherba, scuola fonologica di Mosca, fonologia descrittiva e generativa.
La base della teoria MPS è una dottrina speciale del fonema. Il punto più importante di questa dottrina è la necessità di un'applicazione coerente del criterio morfemico nel determinare la composizione fonemica della lingua. In conformità a ciò, vengono introdotti i concetti di funzione del fonema (percettiva e significativa), posizione fonetica, alternanza posizionale, distribuzione (distribuzione), caratteristiche differenziali e integrali del fonema, alternanze, iperfonema.
Un fonema è una serie di suoni posizionalmente alternati che possono non avere caratteristiche fonetiche comuni; sono uniti solo dalle loro caratteristiche posizionali. I fonemi, a loro volta, possono anche essere combinati in gruppi in base al loro comportamento posizionale e non in base alla somiglianza acustica. I fonemi possono essere neutralizzati. Ciò accade se in qualche posizione i fonemi sono espressi dallo stesso suono. I fonemi neutralizzati formano un iperfonema. I principi base proposti nell'analisi della struttura fonologica di una lingua vengono applicati dall'IFS anche quando si considerano i fenomeni supersegmentali: accento, toni, intonazione, ecc.
Le idee della scuola hanno trovato applicazione nella teoria della scrittura - grafica e ortografia, nella creazione di alfabeti, nella trascrizione e traslitterazione pratica, nella fonetica storica, nella dialettologia e nella geografia linguistica e nell'insegnamento di una lingua non nativa.
La posizione principale dell'IFS - le unità posizionalmente alternate sono modifiche della stessa unità di livello linguistico superiore - si è rivelata piuttosto produttiva nel descrivere i fenomeni di formazione delle parole, morfologia, sintassi, vocabolario, poetica, ecc.
Scuola fonologica di Leningrado- una delle direzioni nello studio del livello sonoro del linguaggio. Il fondatore della scuola fu l'eccezionale linguista L. V. Shcherba. Secondo la sua definizione, un fonema è considerato un'unità capace di differenziare le parole e le loro forme. Shcherba associava anche la funzione linguistica del fonema alla sua capacità di partecipare alla formazione dell'aspetto sonoro di un'unità linguistica significativa: un morfema, una parola. I seguaci di Shcherba (L. R. Zinder, S. I. Bernshtein, M. I. Matusevich) svilupparono le sue idee secondo cui il sistema di fonemi di una lingua non è solo il risultato di costruzioni logiche del ricercatore, ma una vera organizzazione di unità sonore che fornisce a chiunque un madrelingua abbia la capacità generare e percepire qualsiasi messaggio vocale.
Il concetto di fonema in LFS differisce da come viene interpretato da altri insegnamenti fonologici e fonetici, principalmente perché fornisce la possibilità e l'obbligo di utilizzare le caratteristiche di specifici fenomeni materiali (acustici, articolatori) per formare unità significative del linguaggio. Questo è ciò che garantisce l'interesse fondamentale dei seguaci di questa scuola per le proprietà materiali delle unità sonore, per la ricerca nel campo della fonetica sperimentale, nella ricerca di nuovi metodi di analisi e sintesi del discorso, nello sviluppo di raccomandazioni per vari metodi di trasmissione del parlato sonoro su lunghe distanze. Negli ultimi anni, la scienza russa ha ottenuto straordinari successi in questi settori.
Scuola Linguistica di Praga- la direzione principale del ramo europeo della linguistica strutturale. Il centro dell'attività del PLS era il Circolo Linguistico di Praga (creato nel 1926, sciolto a livello organizzativo all'inizio degli anni '50). Il circolo è nato come associazione di diversi scienziati cechi (V. Mathesius, B. Trnka, ecc.) e russi (R. O. Jacobson, N. S. Trubetskoy, S. O. Kartsevskij).
PLS si basava sulle idee di F. De Saussure. La sua formazione e il suo sviluppo furono fortemente influenzati dalla tradizione linguistica russa: le idee di F. F. Fortunatov, L. V. Shcherba e soprattutto I. A. Baudouin de Courtenay. PLS ha sviluppato il concetto di organizzazione sistemica della lingua, inclusa l'idea di un approccio sistemico all'evoluzione linguistica (lingua nell'aspetto diacronico) e un concetto dinamico di lingua considerata nell'aspetto sincronico.
Il concetto strutturale-funzionale del PLS è stato incarnato in modo più completo e coerente negli studi sul lato sonoro del linguaggio. I fondamentali "Fondamenti di fonologia" di N. S. Trubetskoy hanno praticamente creato una nuova branca della linguistica: la fonologia. Sono stati introdotti concetti di base come: fonema, opposizione, classificazione delle opposizioni, marcato-non marcato, correlazione, caratteristica differenziale, neutralizzazione dei fonemi, ecc.
Il contributo più significativo di PLS alla sintassi è stata la dottrina di W. Mathesius (1882-1945) sulla divisione effettiva di una frase come rivelatrice della sua prospettiva funzionale evidenziando il tema e la rema dell'enunciato. La sintassi funzionale implica lo studio dei mezzi e dei metodi per combinare le parole in una frase all'interno di una determinata situazione di comunicazione linguistica (situazione comunicativa). La divisione effettiva di una frase determina il modo in cui questa viene inclusa nel contesto soggettivo in base al quale è nata.
Nell'ambito di LLS è nata la teoria delle funzioni linguistiche e degli stili funzionali e sono state gettate le basi dell'attività linguistica normalizzante civilizzata. Il termine "funzione" è associato all'idea dello scopo del linguaggio come sistema speciale. L'analisi degli scopi a cui serve la lingua ci consente di identificare le seguenti funzioni linguistiche: sociale (fornendo la comunicazione con altre persone) ed espressiva (la lingua agisce come mezzo per esprimere pensieri indipendentemente dall'ascoltatore). A sua volta, la funzione sociale si divide in funzioni comunicative (l’oratore dirige l’attenzione sulla trasmissione di determinati contenuti) e “poetica” (l’attenzione di chi parla è diretta alla forma del messaggio).
Le idee PLS continuano a influenzare lo sviluppo dei concetti linguistici moderni.
Fonetica(dal greco phone) – branca della linguistica che studia il lato sonoro della lingua, cioè metodi di formazione (articolazione) e proprietà acustiche dei suoni, i loro cambiamenti nel flusso del discorso, il loro ruolo nel funzionamento del linguaggio come mezzo di comunicazione tra le persone, nonché stress e intonazione.
Puoi studiare la fonetica di una lingua per scopi diversi, sotto aspetti diversi. A seconda di ciò, la fonetica generale e specifica, descrittiva e storica differisce.
Fonetica generale basato sul materiale di varie lingue, esamina i metodi e la natura della formazione dei suoni del parlato, la natura delle vocali e delle consonanti, la struttura delle sillabe, i tipi di stress, ecc. Viene studiata la struttura del suono di una particolare lingua fonetica privata.
Fonetica descrittiva (sincronica). esplora la struttura sonora di una particolare lingua in una certa fase del suo sviluppo storico. Fonetica storica (diacronica). studia i cambiamenti del sistema fonetico avvenuti in un periodo di tempo più o meno lungo.
La fonetica, come uno dei livelli del sistema linguistico, ha le sue specificità.
Le unità sonore del linguaggio (suoni), a differenza delle altre unità - morfemi, parole, frasi, frasi - non hanno significato. La parola ha un certo significato, il suffisso aggiunge significato alla parola (ad esempio -tel, -ik). Ma non possiamo stabilire il significato della vocale [o] o della consonante [d], non hanno un significato indipendente. Tuttavia, i suoni servono a formare altre unità linguistiche: lessicali, grammaticali (parole e morfemi, frasi e frasi). Pertanto, dicono che il lato sano di una lingua non esiste in sé e non per sé, ma nella grammatica e nel vocabolario di questa lingua. Le unità sonore e le loro combinazioni si realizzano nel vocabolario e nella struttura grammaticale, ad es. svolgere un certo ruolo funzionale.
Suono e lettera
La scrittura è come il rivestimento del discorso orale. Trasmette la lingua parlata.
Il suono viene pronunciato e ascoltato e la lettera viene scritta e letta.
La mancata distinzione tra suoni e lettere rende difficile comprendere la struttura del linguaggio. Scriveva I.A. Baudouin de Courtenay: chiunque confonde suono e lettera, scrittura e linguaggio, “disimparerà difficilmente, e forse non disimparerà mai, a confondere una persona con un passaporto, una nazionalità con l’alfabeto, la dignità umana con un rango e un titolo”, quelli . entità con qualcosa di esterno .
Il suono come oggetto della fonetica
Il focus della fonetica è suono.
Il suono è studiato da tre lati, in tre aspetti:
1) l'aspetto acustico (fisico) considera i suoni del parlato come una tipologia di suoni in generale;
2) studia l'articolazione (biologica) dei suoni del linguaggio come risultato dell'attività degli organi del linguaggio;
3) l'aspetto funzionale (linguistico) considera le funzioni dei suoni del parlato;
4) l'aspetto percettivo studia la percezione dei suoni del parlato.
Viene chiamato il lavoro (insieme di movimenti) degli organi vocali durante la formazione del suono articolazione del suono.
L'articolazione del suono si compone di tre fasi:
Escursione (attacco)– gli organi della parola si spostano dalla posizione precedente alla posizione necessaria per pronunciare un dato suono (Panov: “gli organi della parola si mettono al lavoro”).
Estratto– gli organi vocali sono nella posizione necessaria per pronunciare un suono.
Ricorsione (rientro)– gli organi della parola lasciano la posizione occupata (Panov: “lasciare il lavoro”).
Le fasi si compenetrano a vicenda, questo porta a vari tipi di cambiamenti nei suoni.
Viene chiamato l'insieme dei movimenti e delle posizioni degli organi del linguaggio familiari a chi parla una determinata lingua base articolatoria.