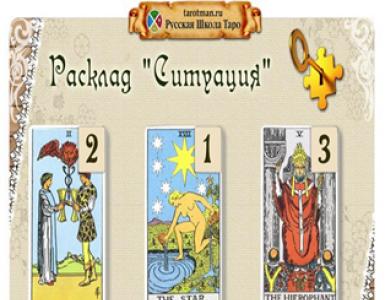Leucociti. Leucociti polimorfonucleati - PMN. Agranulociti (cellule mononucleate). Leucociti polimorfonucleati Nuovi dati scientifici sul metabolismo del ferro
Man mano che la cellula matura, si accumula emoglobina, formata durante le reazioni enzimatiche. Prima di entrare nel flusso sanguigno, la cellula perde il suo nucleo a causa dell'estrusione (spremitura) o della distruzione da parte degli enzimi cellulari. Con una significativa perdita di sangue, i globuli rossi si formano più velocemente del normale e, in questo caso, forme immature contenenti un nucleo possono entrare nel flusso sanguigno; Ciò si verifica apparentemente perché le cellule lasciano il midollo osseo troppo rapidamente. Il periodo di maturazione degli eritrociti nel midollo osseo - dal momento in cui appare la cellula più giovane, riconoscibile come il precursore dell'eritrocita, fino alla sua completa maturazione - è di 4-5 giorni. La durata della vita di un eritrocita maturo nel sangue periferico è in media di 120 giorni. Tuttavia, in caso di alcune anomalie delle cellule stesse, di una serie di malattie o sotto l'influenza di alcuni farmaci, la durata della vita dei globuli rossi può essere ridotta.
La maggior parte dei globuli rossi viene distrutta nel fegato e nella milza; in questo caso l'emoglobina viene rilasciata e si scompone nei suoi componenti eme e globina. L'ulteriore destino della globina non è stato tracciato; Per quanto riguarda l'eme, da esso vengono rilasciati ioni ferro (e restituiti al midollo osseo). Perdendo ferro, l'eme si trasforma in bilirubina, un pigmento biliare rosso-marrone. Dopo piccole modifiche che si verificano nel fegato, la bilirubina contenuta nella bile viene escreta attraverso la cistifellea nel tratto digestivo. In base al contenuto del prodotto finale della sua trasformazione nelle feci, è possibile calcolare la velocità di distruzione dei globuli rossi. In media, in un corpo adulto, ogni giorno vengono distrutti e riformati 200 miliardi di globuli rossi, ovvero circa lo 0,8% del loro numero totale (25 trilioni).
Emoglobina.
La funzione principale dei globuli rossi è trasportare l'ossigeno dai polmoni ai tessuti del corpo. Un ruolo chiave in questo processo è svolto dall'emoglobina, un pigmento rosso organico costituito da eme (un composto porfirinico con ferro) e dalla proteina globina. L'emoglobina ha un'elevata affinità per l'ossigeno, grazie alla quale il sangue è in grado di trasportare molto più ossigeno di una normale soluzione acquosa. Il grado di legame dell'ossigeno con l'emoglobina dipende principalmente dalla concentrazione di ossigeno disciolto nel plasma. Nei polmoni, dove c'è molto ossigeno, si diffonde dagli alveoli polmonari attraverso le pareti dei vasi sanguigni e l'ambiente acquoso del plasma ed entra nei globuli rossi; Lì si lega all'emoglobina: si forma l'ossiemoglobina. Nei tessuti in cui la concentrazione di ossigeno è bassa, le molecole di ossigeno vengono separate dall'emoglobina e penetrano nel tessuto per diffusione. L'insufficienza di globuli rossi o di emoglobina porta ad una diminuzione del trasporto di ossigeno e quindi all'interruzione dei processi biologici nei tessuti.
feto adulto-adulto). Sono note molte varianti genetiche dell'emoglobina, la cui formazione porta ad anomalie dei globuli rossi o della loro funzione. Tra questi, il più famoso è l’emoglobina S, che causa l’anemia falciforme.
Leucociti.
I globuli bianchi periferici, o leucociti, si dividono in due classi a seconda della presenza o assenza di granuli speciali nel loro citoplasma. Le cellule che non contengono granuli (agranulociti) sono linfociti e monociti; i loro chicchi hanno forma prevalentemente rotonda e regolare. Le cellule con granuli specifici (granulociti) sono solitamente caratterizzate dalla presenza di nuclei di forma irregolare con molti lobi e sono quindi chiamate leucociti polimorfonucleati. Si dividono in tre tipologie: neutrofili, basofili ed eosinofili. Differiscono tra loro per la trama dei granuli colorati con vari coloranti.
In una persona sana, 1 mm 3 di sangue contiene 4.000 leucociti (in media circa 6.000), ovvero lo 0,5–1% del volume sanguigno. La proporzione dei singoli tipi di cellule nella composizione dei globuli bianchi può variare in modo significativo tra persone diverse e anche all'interno della stessa persona in momenti diversi. I valori tipici sono riportati nella tabella. 2.
Leucociti polimorfonucleati
(neutrofili, eosinofili e basofili) si formano nel midollo osseo a partire da cellule precursori, che danno origine a cellule staminali, probabilmente le stesse che danno origine ai precursori dei globuli rossi. Man mano che il nucleo matura, le cellule sviluppano granuli tipici di ciascun tipo cellulare. Nel flusso sanguigno, queste cellule si muovono lungo le pareti dei capillari principalmente a causa dei movimenti ameboidi. I neutrofili sono in grado di lasciare lo spazio interno della nave e accumularsi nel sito dell'infezione. La durata della vita dei granulociti sembra essere di ca. 10 giorni, dopodiché vengono distrutti nella milza.
Il diametro dei neutrofili è 12-14 µm. La maggior parte dei coloranti colora il nucleo viola; il nucleo dei neutrofili del sangue periferico può avere da uno a cinque lobi. Il citoplasma si colora di rosato; al microscopio si distinguono in esso numerosi granuli di colore rosa intenso. Nelle donne, circa l'1% dei neutrofili trasporta la cromatina sessuale (formata da uno dei due cromosomi X), un corpo a forma di bacchetta attaccato a uno dei lobi nucleari. Questi cosiddetti I corpi di Barr consentono di determinare il sesso esaminando campioni di sangue.
Gli eosinofili hanno dimensioni simili ai neutrofili. Il loro nucleo raramente ha più di tre lobi e il citoplasma contiene molti granuli grandi, che si colorano chiaramente di rosso vivo con il colorante eosina.
Monociti.
Il diametro di questi leucociti non granulari è di 15–20 µm. Il nucleo è ovale o a forma di fagiolo e solo in una piccola parte delle cellule è suddiviso in grandi lobi sovrapposti tra loro. Quando colorato, il citoplasma è grigio-bluastro e contiene un piccolo numero di inclusioni che si colorano di blu-viola con colorante azzurro. I monociti si formano sia nel midollo osseo che nella milza e nei linfonodi. La loro funzione principale è la fagocitosi.
Linfociti.
Queste sono piccole cellule mononucleari. La maggior parte dei linfociti del sangue periferico hanno un diametro inferiore a 10 µm, ma a volte si trovano linfociti con un diametro maggiore (16 µm). I nuclei cellulari sono densi e rotondi, il citoplasma è di colore bluastro, con granuli molto radi.
Sebbene i linfociti appaiano morfologicamente uniformi, differiscono chiaramente nelle loro funzioni e nelle proprietà della membrana cellulare. Sono divisi in tre grandi categorie: cellule B, cellule T e cellule O (cellule nulle o né B né T).
I linfociti B maturano nel midollo osseo umano e poi migrano negli organi linfoidi. Servono come precursori delle cellule che formano gli anticorpi, i cosiddetti. plasmatico. Affinché le cellule B si trasformino in plasmacellule è necessaria la presenza delle cellule T.
La maturazione delle cellule T inizia nel midollo osseo, dove si formano i protimociti, che poi migrano verso la ghiandola del timo, un organo situato nel torace dietro lo sterno. Lì si differenziano in linfociti T, una popolazione altamente eterogenea di cellule del sistema immunitario che svolgono varie funzioni. Pertanto, sintetizzano fattori di attivazione dei macrofagi, fattori di crescita delle cellule B e interferoni. Tra le cellule T ci sono cellule induttrici (helper) che stimolano la formazione di anticorpi da parte delle cellule B. Esistono anche cellule soppressorie che sopprimono le funzioni delle cellule B e sintetizzano il fattore di crescita delle cellule T: l'interleuchina-2 (una delle linfochine).
I leucociti sono polimorfonucleati
“Leucociti polimorfonucleati” nei libri
Che ruolo svolgono i leucociti nel corpo?
Che ruolo svolgono i leucociti nel corpo? I leucociti sono cellule del sangue incolori negli esseri umani e negli animali. Tutti i tipi di leucociti (linfociti, monociti, basofili, eosinofili e neutrofili) hanno un nucleo e sono capaci di movimento ameboide attivo, ad esempio contro il flusso sanguigno o
Che ruolo svolgono i leucociti nel corpo?
Che ruolo svolgono i leucociti nel corpo? I leucociti sono cellule del sangue incolori negli esseri umani e negli animali. Tutti i tipi di leucociti (linfociti, monociti, basofili, eosinofili e neutrofili) hanno un nucleo e sono capaci di movimento ameboide attivo, ad esempio contro il flusso sanguigno o
Leucociti
Leucociti Normali: da 4 a 9 mila leucociti in 1 μl di sangue (4–9 × 109 /l). Pertanto, il numero di leucociti è 500-1000 volte inferiore al numero di globuli rossi. I leucociti sono le cellule che per prime rispondono a varie influenze dall'esterno e dall'interno del corpo, e molto spesso questo
Leucociti non granulari
Leucociti
Leucociti granulari
21. Leucociti
21. Leucociti Normali – 3,5–8,8 4 h 109 /l. Un aumento del numero dei leucociti è la leucocitosi, una diminuzione è la leucopenia. La leucocitosi è divisa in fisiologica e patologica. Le cause della leucocitosi fisiologica possono essere l'assunzione di cibo (il numero di leucociti non supera
Leucociti
Leucociti Un aumento del numero di leucociti nelle urine (leucocituria) è un segno di infiammazione dei reni e/o delle basse vie urinarie.NB! Nell'infiammazione cronica, la leucocituria è un segno più affidabile della batteriuria (vedi sotto), che spesso non viene rilevata.NB! A molto
Leucociti
Leucociti I leucociti sono globuli bianchi che svolgono un ruolo importante nella distruzione di microrganismi e complessi proteici di origine estranea. In altre parole, i leucociti svolgono un ruolo di primo piano nella formazione delle risposte immunitarie protettive dell’organismo. Leucociti
Leucociti
Leucociti I leucociti, o globuli bianchi, sono cellule incolori contenenti un nucleo e un protoplasma, di dimensioni variabili da 8 a 20 micron. Il numero di leucociti nel sangue periferico di un adulto varia da 4,0 a 9,0 109/l, o 4000-9000 in 1 µl. Aumento
Leucociti
Leucociti I globuli bianchi combattono virus e batteri e purificano il sangue dalle cellule morenti. Esistono diversi tipi di leucociti (eosinofili, basofili, neutrofili, linfociti, monociti). La conta leucocitaria permette di calcolare il contenuto di queste forme di leucociti nel sangue.
Leucociti
Leucociti I leucociti nelle urine di una persona sana sono contenuti in piccole quantità (negli uomini 0–3, nelle donne e nei bambini 0–6 leucociti per campo visivo). Un aumento del numero di leucociti nelle urine (leucocituria) indica processi infiammatori nei reni (pielonefrite) o
Leucociti
Leucociti Un aumento del numero di leucociti nelle urine (leucocituria) è un segno di infiammazione dei reni e/o delle basse vie urinarie. ATTENZIONE! Nell'infiammazione cronica, la leucocituria è un segno più affidabile della batteriuria (vedi sotto), che spesso non viene rilevata. ATTENZIONE! A molto
Leucociti
Leucociti I globuli bianchi, o leucociti, sono in realtà cellule incolori. Possono avere forma rotonda o irregolare e dimensioni variabili (da 6 a 20 micron). Inoltre, la loro caratteristica è la capacità di muoversi liberamente,
Leucociti. Leucociti polimorfonucleati - PMN. Agranulociti (cellule mononucleate).
I leucociti, o globuli bianchi, sono formazioni che hanno forme e dimensioni diverse.
Secondo la loro struttura, i leucociti sono divisi in due grandi gruppi: granulari o granulociti (leucociti polimorfonucleati - PMN) e non granulari o agranulociti (cellule mononucleari).
Questa divisione è puramente condizionale, perché al microscopio elettronico si può vedere che entrambi i leucociti contengono granuli sparsi. Tuttavia, al microscopio ottico, i granuli degli agranulociti sono praticamente indistinguibili. I leucociti granulari comprendono neutrofili, eosinofili e basofili, mentre gli agranulociti comprendono linfociti e monociti. Le cellule della serie granulare prendono il nome dalla loro capacità di essere colorate con coloranti: gli eosinofili percepiscono il colorante acido (eosina), i basofili percepiscono il colorante alcalino (ematossilina) e i neutrofili percepiscono entrambi.
Normalmente, il numero di leucociti negli adulti varia da 4,5 a 9mila per 1 mm3, ovvero da 4,5 a 9´109/litro. Il numero dei leucociti è soggetto a fluttuazioni stagionali. Ci sono più leucociti in autunno e inverno, meno in primavera e ancora meno in estate. Ma queste fluttuazioni non sono così evidenti e non vanno oltre le norme stabilite. Un aumento del numero dei leucociti oltre i limiti normali è chiamato leucocitosi, una diminuzione è chiamata leucopenia. La leucocitosi può essere fisiologica e patologica, mentre la leucopenia si verifica solo in patologia.
Biologia e medicina
Neutrofili (leucociti polimorfonucleati, PMN, PML, PMN, PMN)
La percentuale di tutti i leucociti è costituita da neutrofili, il cui contenuto nel sangue è di circa 4150 in 1 μl. Sono anche chiamati leucociti polimorfonucleati. I neutrofili polimorfonucleati sono cellule che non si dividono con un nucleo multilobato (segmentato) e un insieme di granuli che non sono colorati con coloranti come ematossilina ed eosina. Vengono rilasciati dal midollo osseo ad una velocità di circa 7 milioni/min. Rispetto ai monociti e ai macrofagi, che possono sopravvivere per mesi o addirittura anni, i neutrofili sono cellule di breve durata (2-3 giorni). Disfunzioni dei neutrofili, come varie forme di neutropenia [Sievers, ea 1996], deficit di adesione dei neutrofili [Lipnick. ea 1996] o granulomatosi cronica [Thrasher, ea 1994], portano a forme gravi di suscettibilità dei pazienti alle infezioni batteriche, il che sottolinea il ruolo chiave dei neutrofili nel fornire la forma innata di immunità. D'altra parte, l'iperattivazione dei neutrofili porta anche a patologie. Anomalie come il danno da riperfusione [Williams, ea 1994], la vasculite [Savage, ea 1994], la sindrome da distress respiratorio dell'adulto [Hasleton, ea 1999] o la glomerulonefrite [Lefkowith, ea 1997], suggeriscono l'importanza medica dell'iperattivazione dei neutrofili. Nella lotta contro i batteri, i neutrofili utilizzano un ricco insieme di metodi, come la fagocitosi [Kwiatkowska, ea 1999], la formazione di radicali dell'ossigeno [Segal, ea 1997] e la secrezione di vari enzimi di degradazione [Gullberg, ea 1997]. I neutrofili forniscono la difesa primaria contro i batteri piogeni (piogeni) e possono esistere in condizioni anaerobiche. Rimangono principalmente nel sangue, tranne quando sono localizzati in aree di infiammazione acuta. Una mancanza di neutrofili porta a infezioni croniche. Vedi Barriera immunitaria non specifica
La funzione principale di queste cellule è la fagocitosi. L'azione dei neutrofili, come i macrofagi, non è specifica. Il loro tempo di permanenza nel flusso sanguigno è in media di ore, poiché migrano rapidamente verso le mucose. Nelle malattie infettive acute, il numero di neutrofili aumenta rapidamente. Sono in grado di ottenere energia attraverso la glicolisi anaerobica e possono quindi esistere anche in tessuti poveri di ossigeno: tessuti infiammati, tessuti edematosi o tessuti con scarso apporto di sangue. I neutrofili fagocitano i batteri e i prodotti di degradazione dei tessuti e li distruggono con i loro enzimi lisosomiali (proteasi, peptidasi, ossidasi, desossiribonucleasi e lipasi). Il pus è costituito principalmente da neutrofili e dai loro resti. Gli enzimi lisosomiali rilasciati durante la degradazione dei neutrofili provocano l'ammorbidimento dei tessuti circostanti, ad es. formazione di un fuoco purulento (ascesso).
Il sesso di una persona può essere determinato dai neutrofili: nelle donne, 7 neutrofili su 500 contengono formazioni speciali - "bacchette di neutrofili". I neutrofili catturano, uccidono e digeriscono i microrganismi, in particolare i batteri, ad es. sono i principali “fagociti professionali” insieme ai macrofagi, ma sono significativamente inferiori a loro per dimensioni e durata di vita. I neutrofili hanno un precursore comune insieme ad altre cellule del sangue e dominano tra gli altri leucociti. Le principali tossine dei neutrofili sono il perossido e i suoi radicali; alcuni granuli contengono anche proteine battericide, come la lattoferrina. I neutrofili forniscono la difesa primaria contro i batteri piogeni (piogeni) e possono esistere in condizioni anaerobiche. Rimangono principalmente nel sangue, tranne quando sono localizzati in aree di infiammazione acuta. Una mancanza di neutrofili porta a infezioni croniche. Un neutrofilo polimorfonucleare è una cellula che non si divide, di breve durata con un nucleo segmentato e una serie di granuli che non sono colorati con coloranti come ematossilina ed eosina.
I neutrofili circolanti inattivi sono cellule sferiche con un diametro di circa 7 micron [Worthen, ea 1989]. Quando stimolati, cambiano drasticamente la loro forma a causa della formazione di proiezioni asimmetriche chiamate pseudopodi, necessarie per la migrazione. Per entrare nel tessuto infiammato, i neutrofili lasciano il flusso sanguigno principalmente nelle venule postcapillari. L'attraversamento dell'endotelio di un vaso sanguigno da parte di un neutrofilo avviene in più fasi (Fig. 1). Il neutrofilo tocca la parete endoteliale e vi rotola per qualche tempo, poi si attacca saldamente all'endotelio e infine penetra attraverso di esso (questo fenomeno è chiamato diapedesi) [Springer. ea 1995]. Nella diapedesi, il neutrofilo si stringe tra le cellule endoteliali attraverso uno spazio molte volte più stretto del suo diametro, dimostrando la notevole flessibilità delle sue membrane e del citoscheletro (Fig. 1). Il citoscheletro di actina è assolutamente essenziale per il movimento delle cellule ameboidi, che è la principale modalità di movimento cellulare negli organismi multicellulari. Il bordo anteriore della cellula migrante è arricchito con filamenti di actina appena polimerizzati [Fechheimer, ea 1983, Valerius, ea 1981]. Inoltre, la formazione degli pseudopodi coincide esattamente nel tempo con l'aumento della quantità di actina polimerizzata [Wymann, ea 1990]. D'altra parte, l'inibizione della polimerizzazione dell'actina rende impossibile la chemiotassi [Carter, ea 1967, Becker, ea 1972, Zigmond, ea 1972, Norgauer, ea 1988]. Questi e altri dati costituiscono la base della teoria ampiamente accettata secondo cui la polimerizzazione dell'actina è la forza trainante per l'avanzamento del bordo anteriore di una cellula migrante [Condeelis, ea 1993, Elson, ea 1999].
I precursori dei neutrofili negli ultimi stadi di maturazione non si dividono più e, superato lo stadio di metamielociti, si trasformano in un neutrofilo a fascia con nucleo a forma di salsiccia (Fig. IV. 17). Man mano che la banda dei neutrofili matura, il suo nucleo diventa segmentato. Normalmente, il nucleo dei neutrofili contiene fino a quattro segmenti.
Collegamenti:
Estrazione casuale
Attenzione! Informazioni sul sito web
destinato esclusivamente a scopi didattici
Leucociti polimorfonucleati.
SULLA PRATICA DI PRODUZIONE (SPECIALIZZATA).
Luogo di tirocinio: filiale dell'istituzione sanitaria di bilancio federale “Centro di igiene ed epidemiologia nella regione di Murmansk a Monchegorsk, Olenegorsk e distretto di Lovozersky”
Compilato da: Studente 3° anno Bb14o-2 gr., aree di formazione 06.03.01 “Biologia” profilo “Microbiologia”
(cognome, iniziali dello studente)
Controllato da: docente del Dipartimento di Microbiologia e Biochimica, Candidato di Scienze Biologiche, Professore Associato
Bykova Anna Viktorovna
(cognome, iniziali dell'insegnante)
Allestimento di un laboratorio istologico. 20
Un campione (striscio) di sangue umano. 22
Microscopia. Decodifica. 23
Metodo di colorazione con azzurro-eosina secondo Maksimov. 27
RISULTATI E DISCUSSIONI... 29
Il sangue è un tessuto connettivo liquido e mobile dell'ambiente interno del corpo che svolge importanti funzioni volte al mantenimento dell'omeostasi.
Questo tessuto connettivo gioca un ruolo importante, poiché è uno di quelli fondamentali nel determinare le malattie. Vari tipi di malattie possono essere identificati determinando anomalie negli elementi formati del sangue: globuli rossi (eritrociti), globuli bianchi (leucociti) e piastrine (piastrine). Il loro cambiamento o norma mostra in quale stato si trova l'organismo vivente: infezione acuta, decorso cronico della malattia, forma latente della malattia (infezione) o trasporto e ci consente anche di determinare un organismo completamente sano.
Rilevanza dell'opera. Uno dei principali problemi in medicina al momento sono gli esami del sangue prematuri per rilevare le malattie. Ciò rallenta il processo di recupero dei pazienti o li priva completamente di tale possibilità. Questo lavoro mostra l'importanza degli esami del sangue e, in generale, il loro significato per un organismo vivente.
Lo scopo e gli obiettivi del lavoro. L'obiettivo è dare un'idea più precisa dei componenti del sangue umano e della loro partecipazione ai processi vitali del corpo umano.
1. Determinazione dell'analisi normale e dei componenti del sangue umano;
2. Determinazione della deviazione dei parametri ematici dalla norma;
3. Identificazione e studio teorico delle malattie del sangue.
Il sangue è un fluido che circola nel sistema circolatorio e trasporta gas e altre sostanze disciolte necessarie per il metabolismo o formate a seguito di processi metabolici. Il sangue è costituito da plasma (un liquido limpido, giallo pallido) e da elementi cellulari in esso sospesi. Esistono tre tipi principali di elementi cellulari del sangue: globuli rossi (eritrociti), globuli bianchi (leucociti) e piastrine (piastrine) (Nazarenko, 2000).
Il colore rosso del sangue è determinato dalla presenza del pigmento rosso emoglobina nei globuli rossi. Nelle arterie, attraverso le quali il sangue che entra nel cuore dai polmoni viene trasportato ai tessuti del corpo, l'emoglobina è satura di ossigeno e colorata di rosso vivo; nelle vene attraverso le quali il sangue scorre dai tessuti al cuore, l'emoglobina è praticamente priva di ossigeno ed è di colore più scuro.
Il sangue è un liquido piuttosto viscoso e la sua viscosità è determinata dal contenuto di globuli rossi e proteine disciolte. La viscosità del sangue influenza notevolmente la velocità con cui il sangue scorre attraverso le arterie (strutture semielastiche) e la pressione sanguigna. La fluidità del sangue è determinata anche dalla sua densità e dallo schema di movimento dei vari tipi di cellule. I globuli bianchi, ad esempio, si muovono singolarmente, in prossimità delle pareti dei vasi sanguigni; i globuli rossi possono muoversi individualmente o in gruppi come monete impilate, creando un movimento assiale, cioè flusso concentrato al centro del vaso (Vorobiev, 1979).
Il volume del sangue di un maschio adulto è di circa 75 ml per chilogrammo di peso corporeo; in una donna adulta questa cifra è di circa 66 ml. Di conseguenza, il volume totale del sangue in un maschio adulto è in media di ca. 5 litri; più della metà del volume è costituito da plasma e il resto è costituito principalmente da eritrociti (Vorobiev, 1979).
Figura 1 - Composizione del sangue
Dopo la separazione degli elementi cellulari sospesi nel sangue, rimane una soluzione acquosa di composizione complessa, chiamata plasma. Di norma il plasma è un liquido limpido o leggermente opalescente, il cui colore giallastro è determinato dalla presenza di piccole quantità di pigmento biliare e di altre sostanze organiche colorate. Tuttavia, dopo aver consumato cibi grassi, molte goccioline di grasso (chilomicroni) entrano nel sangue, rendendo il plasma torbido e oleoso (Vorobiev, 1979).
Il plasma è coinvolto in molti processi vitali del corpo. Trasporta le cellule del sangue, i nutrienti e i prodotti metabolici e funge da collegamento tra tutti i fluidi extravascolari (cioè situati all'esterno dei vasi sanguigni); questi ultimi comprendono, in particolare, il fluido intercellulare, e attraverso di esso avviene la comunicazione con le cellule e il loro contenuto. Pertanto, il plasma entra in contatto con i reni, il fegato e altri organi e mantiene così la costanza dell'ambiente interno del corpo, ad es. omeostasi.
I principali componenti del plasma e le loro concentrazioni sono riportati nella tabella. 1. Tra le sostanze disciolte nel plasma vi sono composti organici a basso peso molecolare (urea, acido urico, aminoacidi, ecc.); molecole proteiche grandi e molto complesse; sali inorganici parzialmente ionizzati. I cationi più importanti (ioni caricati positivamente) includono sodio (Na+), potassio (K+), calcio (Ca 2+) e magnesio (Mg 2+); Gli anioni più importanti (ioni caricati negativamente) sono gli anioni cloruro (Cl –), bicarbonato (HCO 3–) e fosfato (HPO4 2– o H2PO 4–). I principali componenti proteici del plasma sono l'albumina, le globuline e il fibrinogeno (Vorobiev, 1979).
Di tutte le proteine, l'albumina, sintetizzata nel fegato, è presente nella concentrazione più alta nel plasma. È necessario mantenere l'equilibrio osmotico, garantendo la normale distribuzione del fluido tra i vasi sanguigni e lo spazio extravascolare. Durante il digiuno o un'assunzione insufficiente di proteine dal cibo, il contenuto di albumina nel plasma diminuisce, il che può portare ad un aumento dell'accumulo di acqua nei tessuti (edema). Questa condizione, associata a carenza proteica, è chiamata edema da fame (Vorobiev, 1979).
Il plasma contiene diversi tipi o classi di globuline, le più importanti delle quali sono designate con le lettere greche α (alfa), β (beta) e g (gamma), e le proteine corrispondenti sono α1, α2, β, γ1 e γ2. Dopo la separazione delle globuline (mediante elettroforesi), gli anticorpi vengono rilevati solo nelle frazioni γ1, γ2 e β. Sebbene gli anticorpi siano spesso chiamati gammaglobuline, il fatto che alcuni di essi siano presenti anche nella frazione β ha portato all'introduzione del termine "immunoglobulina". Le frazioni α e β contengono molte proteine diverse che forniscono il trasporto nel sangue di ferro, vitamina B12, steroidi e altri ormoni. Questo stesso gruppo di proteine comprende anche i fattori della coagulazione che, insieme al fibrinogeno, sono coinvolti nel processo di coagulazione del sangue.
La funzione principale del fibrinogeno è quella di formare coaguli di sangue (trombi). Durante il processo di coagulazione del sangue, se in vivo(in un organismo vivente) o in vitro(fuori dal corpo), il fibrinogeno viene convertito in fibrina, che costituisce la base di un coagulo di sangue; Il plasma privo di fibrinogeno, che solitamente appare come un liquido limpido, di colore giallo pallido, è chiamato siero (Berkow, 1997).
I globuli rossi, o eritrociti, sono dischi rotondi con un diametro di 7,2–7,9 µm e uno spessore medio di 2 µm (μm = micron = 1/106 m). 1 mm3 di sangue contiene 5-6 milioni di globuli rossi. Costituiscono il 44-48% del volume totale del sangue (Vorobiev, 1979).
I globuli rossi hanno la forma di un disco biconcavo, cioè I lati piatti del disco sono compressi, facendolo sembrare una ciambella senza buco. I globuli rossi maturi non hanno nuclei. Contengono principalmente emoglobina, la cui concentrazione nel mezzo acquoso intracellulare è di ca. 34%. In termini di peso secco, il contenuto di emoglobina negli eritrociti è del 95%; per 100 ml di sangue, il contenuto di emoglobina è normalmente di 12-16 g (12-16 g%) e negli uomini è leggermente superiore che nelle donne. Oltre all'emoglobina, i globuli rossi contengono ioni inorganici disciolti (principalmente K +) e vari enzimi. I due lati concavi forniscono al globulo rosso una superficie ottimale attraverso la quale possono avvenire gli scambi di gas: anidride carbonica e ossigeno. Pertanto, la forma delle cellule determina in gran parte l'efficienza dei processi fisiologici. Negli esseri umani, l'area delle superfici attraverso le quali avviene lo scambio di gas è in media di 3820 m2, ovvero 2000 volte maggiore della superficie del corpo (Vorobiev, 1979).
Nel feto, i globuli rossi primitivi si formano prima nel fegato, nella milza e nel timo. Dal quinto mese di sviluppo intrauterino, nel midollo osseo inizia gradualmente l'eritropoiesi: la formazione di globuli rossi a tutti gli effetti. In circostanze eccezionali (ad esempio, quando il midollo osseo normale viene sostituito da tessuto canceroso), il corpo adulto può tornare a produrre globuli rossi nel fegato e nella milza. Tuttavia, in condizioni normali, l'eritropoiesi in un adulto si verifica solo nelle ossa piatte (coste, sterno, ossa pelviche, cranio e colonna vertebrale) (Vorobiev, 1979).
I globuli rossi si sviluppano da cellule precursori, la cui fonte è la cosiddetta. cellule staminali. Nelle prime fasi della formazione dei globuli rossi (nelle cellule ancora nel midollo osseo), il nucleo cellulare è chiaramente visibile. Man mano che la cellula matura, si accumula emoglobina, formata durante le reazioni enzimatiche. Prima di entrare nel flusso sanguigno, la cellula perde il suo nucleo a causa dell'estrusione (spremitura) o della distruzione da parte degli enzimi cellulari. Con una significativa perdita di sangue, i globuli rossi si formano più velocemente del normale e, in questo caso, forme immature contenenti un nucleo possono entrare nel flusso sanguigno; Ciò si verifica apparentemente perché le cellule lasciano il midollo osseo troppo rapidamente. Il periodo di maturazione degli eritrociti nel midollo osseo - dal momento in cui appare la cellula più giovane, riconoscibile come il precursore dell'eritrocita, fino alla sua completa maturazione - è di 4-5 giorni. La durata della vita di un eritrocita maturo nel sangue periferico è in media di 120 giorni. Tuttavia, a causa di alcune anomalie delle cellule stesse, di una serie di malattie o sotto l'influenza di alcuni farmaci, la durata della vita dei globuli rossi può essere ridotta (Berkow, 1997).
La maggior parte dei globuli rossi viene distrutta nel fegato e nella milza; in questo caso l'emoglobina viene rilasciata e si scompone nei suoi componenti eme e globina. L'ulteriore destino della globina non è stato tracciato; Per quanto riguarda l'eme, da esso vengono rilasciati ioni ferro (e restituiti al midollo osseo). Perdendo ferro, l'eme si trasforma in bilirubina, un pigmento biliare rosso-marrone. Dopo piccole modifiche che si verificano nel fegato, la bilirubina contenuta nella bile viene escreta attraverso la cistifellea nel tratto digestivo. In base al contenuto del prodotto finale della sua trasformazione nelle feci, è possibile calcolare la velocità di distruzione dei globuli rossi. In media, in un corpo adulto, ogni giorno vengono distrutti e riformati 200 miliardi di globuli rossi, ovvero circa lo 0,8% del loro numero totale (25 trilioni) (Vorobiev, 1979).
La funzione principale dei globuli rossi è trasportare l'ossigeno dai polmoni ai tessuti del corpo. Un ruolo chiave in questo processo è svolto dall'emoglobina, un pigmento rosso organico costituito da eme (un composto porfirinico con ferro) e dalla proteina globina. L'emoglobina ha un'elevata affinità per l'ossigeno, grazie alla quale il sangue è in grado di trasportare molto più ossigeno di una normale soluzione acquosa. Il grado di legame dell'ossigeno con l'emoglobina dipende principalmente dalla concentrazione di ossigeno disciolto nel plasma. Nei polmoni, dove c'è molto ossigeno, si diffonde dagli alveoli polmonari attraverso le pareti dei vasi sanguigni e l'ambiente acquoso del plasma ed entra nei globuli rossi; Lì si lega all'emoglobina: si forma l'ossiemoglobina. Nei tessuti in cui la concentrazione di ossigeno è bassa, le molecole di ossigeno vengono separate dall'emoglobina e penetrano nel tessuto per diffusione. L'insufficienza di globuli rossi o di emoglobina porta ad una diminuzione del trasporto di ossigeno e quindi all'interruzione dei processi biologici nei tessuti (Vorobiev, 1979).
Nell'uomo si distingue l'emoglobina fetale (tipo F, da feto– feto) e l’emoglobina dell’adulto (tipo A, da adulto-adulto). Sono note molte varianti genetiche dell'emoglobina, la cui formazione porta ad anomalie dei globuli rossi o della loro funzione. Tra questi, il più famoso è l'emoglobina S, che causa l'anemia falciforme (Vorobiev, 1979).
I globuli bianchi periferici, o leucociti, si dividono in due classi a seconda della presenza o assenza di granuli speciali nel loro citoplasma. Le cellule che non contengono granuli (agranulociti) sono linfociti e monociti; i loro chicchi hanno forma prevalentemente rotonda e regolare. Le cellule con granuli specifici (granulociti) sono solitamente caratterizzate dalla presenza di nuclei di forma irregolare con molti lobi e sono quindi chiamate leucociti polimorfonucleati. Si dividono in tre tipologie: neutrofili, basofili ed eosinofili. Differiscono tra loro per il modello di colorazione dei granuli con vari coloranti (Vorobiev, 1979).
In una persona sana, 1 mm 3 di sangue contiene 4.000 leucociti (in media circa 6.000), ovvero lo 0,5–1% del volume sanguigno. La proporzione dei singoli tipi di cellule nella composizione dei leucociti può variare significativamente tra persone diverse e anche all'interno della stessa persona in momenti diversi (Berkow, 1997).
I leucociti polimorfonucleati (neutrofili, eosinofili e basofili) si formano nel midollo osseo a partire da cellule progenitrici, che danno origine a cellule staminali, probabilmente le stesse che danno origine ai precursori dei globuli rossi. Man mano che il nucleo matura, le cellule sviluppano granuli tipici di ciascun tipo cellulare. Nel flusso sanguigno, queste cellule si muovono lungo le pareti dei capillari principalmente a causa dei movimenti ameboidi. I neutrofili sono in grado di lasciare lo spazio interno della nave e accumularsi nel sito dell'infezione. La durata della vita dei granulociti sembra essere di ca. 10 giorni, dopodiché vengono distrutti nella milza (Nazarenko, 2000).
Il diametro dei neutrofili è 12-14 µm. La maggior parte dei coloranti colora il nucleo viola; il nucleo dei neutrofili del sangue periferico può avere da uno a cinque lobi. Il citoplasma si colora di rosato; al microscopio si distinguono in esso numerosi granuli di colore rosa intenso. Nelle donne, circa l'1% dei neutrofili trasporta la cromatina sessuale (formata da uno dei due cromosomi X), un corpo a forma di bacchetta attaccato a uno dei lobi nucleari. Questi cosiddetti I corpi di Barr consentono di determinare il sesso durante l'esame dei campioni di sangue (Vorobiev, 1979).
Gli eosinofili hanno dimensioni simili ai neutrofili. Il loro nucleo raramente ha più di tre lobi e il citoplasma contiene molti granuli di grandi dimensioni, chiaramente colorati di rosso vivo con colorante eosina (Vorobiev, 1979).
A differenza degli eosinofili, i basofili hanno granuli citoplasmatici colorati di blu con coloranti basici.
Il diametro di questi leucociti non granulari è di 15–20 µm. Il nucleo è ovale o a forma di fagiolo e solo in una piccola parte delle cellule è suddiviso in grandi lobi sovrapposti tra loro. Quando colorato, il citoplasma è grigio-bluastro e contiene un piccolo numero di inclusioni che si colorano di blu-viola con colorante azzurro. I monociti si formano sia nel midollo osseo che nella milza e nei linfonodi. La loro funzione principale è la fagocitosi (Vorobiev, 1979).
Queste sono piccole cellule mononucleari. La maggior parte dei linfociti del sangue periferico hanno un diametro inferiore a 10 µm, ma a volte si trovano linfociti con un diametro maggiore (16 µm). I nuclei cellulari sono densi e rotondi, il citoplasma è di colore bluastro, con granuli molto radi (Vorobiev, 1979).
Sebbene i linfociti appaiano morfologicamente uniformi, differiscono chiaramente nelle loro funzioni e nelle proprietà della membrana cellulare. Sono divise in tre grandi categorie: cellule B, cellule T e cellule 0 (cellule nulle, ovvero né B né T) (Vorobiev, 1979).
I linfociti B maturano nel midollo osseo umano e poi migrano negli organi linfoidi. Servono come precursori delle cellule che formano gli anticorpi, i cosiddetti. plasmatico. Affinché le cellule B si trasformino in plasmacellule è necessaria la presenza delle cellule T (Vorobiev, 1979).
La maturazione delle cellule T inizia nel midollo osseo, dove si formano i protimociti, che poi migrano verso la ghiandola del timo, un organo situato nel torace dietro lo sterno. Lì si differenziano in linfociti T, una popolazione altamente eterogenea di cellule del sistema immunitario che svolgono varie funzioni. Pertanto, sintetizzano fattori di attivazione dei macrofagi, fattori di crescita delle cellule B e interferoni. Tra le cellule T ci sono cellule induttrici (helper) che stimolano la formazione di anticorpi da parte delle cellule B. Esistono anche cellule soppressorie che sopprimono le funzioni delle cellule B e sintetizzano il fattore di crescita delle cellule T: l'interleuchina-2 (una delle linfochine). Le cellule O differiscono dalle cellule B e T in quanto non hanno antigeni di superficie. Alcuni di loro fungono da “assassini naturali”, cioè uccidere le cellule tumorali e le cellule infette da un virus. Tuttavia, in generale, il ruolo delle cellule 0 non è chiaro (Vorobiev, 1979).
Le piastrine sono corpi incolori, anucleati, di forma sferica, ovale o bastoncellare con un diametro di 2–4 µm. Normalmente, il contenuto di piastrine nel sangue periferico è di 1 mm3. La loro durata di vita è di 8-10 giorni. I coloranti standard (azzurro-eosina) conferiscono loro un colore rosa pallido uniforme. Utilizzando la microscopia elettronica, è stato dimostrato che la struttura del citoplasma delle piastrine è simile alle cellule ordinarie; non si tratta però di cellule, ma di frammenti del citoplasma di cellule molto grandi (megacariociti) presenti nel midollo osseo. I megacariociti derivano dai discendenti delle stesse cellule staminali che danno origine ai globuli rossi e bianchi (Berkow, 1997).
Danni al midollo osseo dovuti a farmaci, radiazioni ionizzanti o cancro possono portare ad una significativa diminuzione del numero delle piastrine nel sangue, che provoca ematomi e sanguinamenti spontanei (Berkow, 1997)
È comune pensare che la funzione del sangue sia quella di trasportare nutrienti e scorie metaboliche, ma in realtà la cosa è più complessa. Nel sangue sono trasportati anche gli ormoni che controllano molti processi vitali; il sangue regola la temperatura corporea e protegge il corpo da danni e infezioni in qualsiasi sua parte. Di seguito considereremo le funzioni del sangue in modo più dettagliato.
Indice dell'argomento "Immunità delle specie. Fattori di difesa dell'organismo. Cellule fagocitiche":Cellule fagocitiche. Fagociti. Leucociti polimorfonucleati (granulociti). Neutrofili. Il fenomeno dell'edge standing. Neutrofilia. Eosinofilia.
Fagociti svolgere non solo funzioni protettive (assorbire e distruggere agenti estranei), ma anche funzioni di drenaggio (rimuovere strutture morte e degradate del corpo). Fagociti rappresentato da cellule della serie mielopoietica ( leucociti polimorfonucleati) e sistema macrofago-monociti (monociti, macrofagi tissutali). Le principali proprietà delle cellule fagocitiche sono presentate nella tabella. 10-5.
Neutrofili- principali cellule effettrici dell'infiammazione acuta; negli adulti costituiscono la più grande popolazione di leucociti. La maggior parte dei neutrofili circola nel sangue per 6-7 ore, poi si accumula nei capillari, dove forma un pool marginale, attaccandosi all'endotelio (lungo il perimetro del flusso sanguigno); in questo stato, i neutrofili sono pronti a lasciare immediatamente il flusso sanguigno (fenomeno di edge standing). Neutrofilia(un aumento del loro numero nel sangue periferico) indica spesso la presenza di una reazione infiammatoria.
I leucociti, o globuli bianchi, sono incolori nel sangue fresco, cosa che li distingue dai globuli rossi colorati. Il loro numero è in media 4 - 9 x 109 in 1 litro di sangue (cioè 1000 volte inferiore ai globuli rossi). I leucociti sono capaci di movimenti attivi e possono passare attraverso la parete dei vasi sanguigni nel tessuto connettivo degli organi, dove svolgono le principali funzioni protettive. In base alle caratteristiche morfologiche e al ruolo biologico, i leucociti si dividono in due gruppi: leucociti granulari, o granulociti, e leucociti non granulari, o agranulociti.
Secondo un'altra classificazione, tenendo conto della forma del nucleo dei leucociti, si distinguono i leucociti con un nucleo non segmentato rotondo o ovale, i cosiddetti. leucociti mononucleari, o cellule mononucleate, nonché leucociti con un nucleo segmentato costituito da più parti - segmenti - leucociti segmentati.
Nella colorazione ematologica standard secondo Romanovsky-Giemsa vengono utilizzati due coloranti: eosina acida e azzurro-II basico. Le strutture colorate con eosina (rosa) sono chiamate eosinofile, ossifile o acidofile. Le strutture colorate con il colorante azzurro-II (rosso viola) sono chiamate basofile o azzurrofile.
Nei leucociti granulari, quando colorati con azzurro-II - eosina, nel citoplasma vengono rivelati una granularità specifica (eosinofila, basofila o neutrofila) e nuclei segmentati (cioè tutti i granulociti appartengono a leucociti segmentati). In base al colore della granularità specifica, si distinguono i granulociti neutrofili, eosinofili e basofili.
Il gruppo dei leucociti non granulari (linfociti e monociti) è caratterizzato dall'assenza di granularità specifica e di nuclei non segmentati. Quelli. tutti gli agranulociti appartengono ai leucociti mononucleari.
La percentuale dei principali tipi di leucociti è chiamata formula dei leucociti o leucogramma. Il numero totale di leucociti e la loro percentuale in una persona può variare normalmente a seconda del cibo consumato, dello stress fisico e mentale e di varie malattie. Lo studio dell'emocromo è necessario per stabilire una diagnosi e prescrivere un trattamento.
Tutti i leucociti sono capaci di movimento attivo formando pseudopodi, mentre la forma del loro corpo e il nucleo cambiano. Sono in grado di passare tra le cellule endoteliali vascolari e le cellule epiteliali, attraverso le membrane basali e spostarsi attraverso la sostanza fondamentale del tessuto connettivo. La direzione del movimento dei leucociti è determinata dalla chemiotassi sotto l'influenza di stimoli chimici, ad esempio prodotti di degradazione dei tessuti, batteri e altri fattori.
I leucociti svolgono funzioni protettive, fornendo la fagocitosi di microbi, sostanze estranee, prodotti di degradazione cellulare e partecipando alle reazioni immunitarie.
Granulociti (leucociti granulari)
I granulociti comprendono i leucociti neutrofili, eosinofili e basofili. Si formano nel midollo osseo rosso, contengono granularità specifica nel citoplasma e hanno nuclei segmentati.
I granulociti neutrofili (o neutrofili) sono il gruppo più numeroso di leucociti, costituendo (48-78% del numero totale di leucociti). In un neutrofilo segmentato maturo, il nucleo contiene 3-5 segmenti collegati da sottili ponti. La popolazione dei neutrofili del sangue può contenere cellule con vari gradi di maturità: giovani, a bande e segmentate. I primi due tipi sono cellule giovani. Le cellule giovani normalmente non superano lo 0,5% o sono assenti; sono caratterizzate da un nucleo a forma di fagiolo. I colpi costituiscono l'1-6%, hanno un nucleo non segmentato a forma di lettera inglese S, un bastone ricurvo o un ferro di cavallo. Un aumento del numero di forme giovani e a banda di neutrofili nel sangue (il cosiddetto spostamento della formula dei leucociti a sinistra) indica la presenza di perdita di sangue o di un processo infiammatorio acuto nel corpo, accompagnato da un aumento dell'emopoiesi nel sangue midollo osseo e il rilascio di forme giovani.
Il citoplasma dei neutrofili è colorato debolmente ossifilo, in esso sono visibili grani molto fini di colore rosa-violetto (colorati sia con coloranti acidi che basici), quindi è chiamato neutrofilo o eterofilo. Non ci sono granuli o organelli nello strato superficiale del citoplasma. Qui si trovano granuli di glicogeno, filamenti di actina e microtubuli, che forniscono la formazione di pseudopodi per il movimento cellulare. Nella parte interna del citoplasma ci sono organelli per scopi generali, la granularità è visibile.
Nei neutrofili si possono distinguere due tipi di granuli: specifici e azzurrofili, circondati da un'unica membrana.
Specifici granuli, più piccoli e numerosi, contengono sostanze batteriostatiche e battericide: lisozima e fosfatasi alcalina, oltre alla proteina lattoferrina. Il lisozima è un enzima che distrugge la parete batterica. La lattoferrina lega gli ioni ferro, favorendo l'adesione batterica. Inoltre avvia un feedback negativo inibendo la produzione di neutrofili nel midollo osseo.
I granuli azurofili sono più grandi e di colore rosso violaceo. Sono i lisosomi primari e contengono enzimi lisosomiali e mieloperossidasi. La mieloperossidasi produce ossigeno molecolare dal perossido di idrogeno, che ha un effetto battericida. I granuli azurofili compaiono prima nel processo di differenziazione dei neutrofili, quindi sono chiamati primari in contrasto con quelli secondari-specifici.
La funzione principale dei neutrofili è la fagocitosi dei microrganismi, motivo per cui sono chiamati microfagi. Nel processo di fagocitosi dei batteri, granuli specifici si fondono prima con il fagosoma risultante, i cui enzimi uccidono il batterio, formando così un complesso costituito da un fagosoma e un granulo specifico. Successivamente, un lisosoma si fonde con questo complesso, i cui enzimi idrolitici digeriscono i microrganismi. Nel sito dell'infiammazione, i batteri uccisi e i neutrofili morti formano pus.
La fagocitosi è potenziata dall'opsonizzazione con immunoglobuline o dal sistema del complemento plasmatico. Questa è la cosiddetta fagocitosi mediata dai recettori. Se una persona ha anticorpi per un tipo specifico di batteri, allora il batterio è avvolto da questi anticorpi specifici. Questo processo è chiamato opsonizzazione. Gli anticorpi vengono poi riconosciuti da un recettore sul plasmalemma dei neutrofili e si legano ad esso. Il composto risultante sulla superficie del neutrofilo innesca la fagocitosi.
Nella popolazione di neutrofili di persone sane, le cellule fagocitiche costituiscono il 69-99%. Questo indicatore è chiamato attività fagocitica. L'indice fagocitico è un altro indicatore che stima il numero di particelle assorbite da una cellula. Per i neutrofili è 12-23.
La durata della vita dei neutrofili è di 5-9 giorni.
Granulociti eosinofili (o eosinofili). Il numero di eosinofili nel sangue varia dallo 0,5 al 5% del numero totale di leucociti. Il nucleo eosinofilo ha solitamente 2 segmenti collegati da un ponte. Organelli e granuli di uso generale si trovano nel citoplasma. Tra i granuli si distinguono i granuli azurofili (primari) e quelli eosinofili (secondari), che sono lisosomi modificati.
Specifici granuli eosinofili riempiono quasi l'intero citoplasma. Tipicamente, al centro del granulo è presente un cristalloide, che contiene il cosiddetto. principali proteine basiche ricche di arginina, enzimi idrolitici lisosomiali, perossidasi, proteina cationica eosinofila e istaminasi.
Gli eosinofili sono cellule mobili e sono capaci di fagocitosi, ma la loro attività fagocitaria è inferiore a quella dei neutrofili.
Gli eosinofili hanno una chemiotassi positiva per l'istamina rilasciata dai mastociti del tessuto connettivo durante l'infiammazione e le reazioni allergiche, per le linfochine secrete dai linfociti T e per gli immunocomplessi costituiti da antigeni e anticorpi.
Il ruolo degli eosinofili è stato stabilito nelle reazioni alle proteine estranee, nelle reazioni allergiche e anafilattiche, dove partecipano al metabolismo dell'istamina prodotta dai mastociti del tessuto connettivo. L'istamina aumenta la permeabilità vascolare, causando lo sviluppo di edema tissutale; a dosi elevate può causare shock fatale.
Gli eosinofili aiutano a ridurre i livelli di istamina nei tessuti in vari modi. Distruggono l'istamina utilizzando l'enzima istaminasi, fagocitano i granuli di mastociti contenenti istamina, assorbono l'istamina sul plasmalemma, legandola con l'aiuto dei recettori e, infine, producono un fattore che inibisce la degranulazione e il rilascio di istamina dai mastociti.
Gli eosinofili rimangono nel sangue periferico per meno di 12 ore e poi passano nei tessuti. I loro obiettivi includono organi come la pelle, i polmoni e il tratto gastrointestinale. Un cambiamento nel contenuto degli eosinofili può essere osservato sotto l'influenza di mediatori e ormoni: ad esempio, durante una reazione allo stress, si osserva una diminuzione del numero di eosinofili nel sangue, a causa di un aumento del contenuto degli ormoni surrenali.
Granulociti basofili (o basofili). Il numero di basofili nel sangue rappresenta fino all'1% del numero totale di leucociti. I nuclei dei basofili sono segmentati e contengono 2-3 lobuli. Caratterizzato dalla presenza di specifici granuli metacromatici di grandi dimensioni, che spesso ricoprono il nucleo.
I basofili mediano l’infiammazione e secernono il fattore chemiotattico degli eosinofili. I granuli contengono proteoglicani, glicosaminoglicani (inclusa l'eparina), istamina vasoattiva e proteasi neutre. Alcuni granuli sono lisosomi modificati. La degranulazione dei basofili si verifica nelle reazioni di ipersensibilità immediata (p. es., asma, anafilassi, eruzione cutanea che può essere associata ad arrossamento della pelle). Il fattore scatenante della degranulazione anafilattica è il recettore delle immunoglobuline di classe E. La metacromasia è causata dalla presenza di eparina, un glicosaminoglicano acido.
I basofili si formano nel midollo osseo. Loro, come i neutrofili, rimangono nel sangue periferico per circa 1-2 giorni.
I basofili contengono, oltre a granuli specifici, anche granuli azzurrofili (lisosomi). I basofili, come i mastociti del tessuto connettivo, secernono eparina e istamina e partecipano alla regolazione della coagulazione del sangue e della permeabilità vascolare. I basofili sono coinvolti nelle reazioni immunologiche dell'organismo, in particolare nelle reazioni allergiche.
Agranulociti (leucociti non granulari)
Questo gruppo di leucociti comprende linfociti e monociti. A differenza dei granulociti, non contengono granularità specifica nel citoplasma e i loro nuclei non sono segmentati.
I linfociti nel sangue degli adulti costituiscono il 20-35% del numero totale di leucociti. I linfociti si dividono in linfociti piccoli, medi e grandi. Grandi linfociti si trovano nel sangue dei neonati e dei bambini; sono assenti negli adulti. La maggior parte di tutti i linfociti del sangue umano sono piccoli linfociti.
Tutti i tipi di linfociti sono caratterizzati dalla presenza di un nucleo rotondo o a forma di fagiolo intensamente colorato. Il citoplasma dei linfociti contiene una piccola quantità di granuli azzurrofili (lisosomi).
La funzione principale dei linfociti è quella di partecipare alle reazioni immunitarie. Tuttavia, la popolazione dei linfociti è eterogenea in termini di caratteristiche dei recettori di superficie e del loro ruolo nelle risposte immunitarie. Tra i linfociti ci sono tre classi funzionali principali: linfociti B, linfociti T e i cosiddetti. zero linfociti.
I linfociti B furono scoperti per la prima volta in un organo speciale negli uccelli: la borsa di Fabricius (bursa, bursa Fabricius), e quindi ricevettero il nome corrispondente. Si formano nel midollo osseo. I linfociti B costituiscono circa il 30% dei linfociti circolanti. La loro funzione principale è partecipare alla produzione di anticorpi, ad es. fornire l’immunità umorale. Il plasmalemma dei linfociti B contiene molti recettori immunoglobulinici. Quando esposti agli antigeni, i linfociti B sono capaci di proliferare e differenziarsi in plasmaciti - cellule capaci di sintetizzare e secernere proteine protettive - anticorpi o immunoglobuline, che entrano nel sangue, fornendo l'immunità umorale.
I linfociti T, o linfociti timo-dipendenti, si formano da cellule staminali nel midollo osseo e maturano nel timo (ghiandola del timo), da cui deriva il loro nome. Predominano nella popolazione linfocitaria, rappresentando circa il 70% dei linfociti circolanti. Le cellule T, a differenza dei linfociti B, sono caratterizzate da un basso livello di recettori immunoglobulinici di superficie nel plasmalemma. Ma le cellule T hanno recettori specifici in grado di riconoscere e legare gli antigeni e partecipare alle reazioni immunitarie. Le funzioni principali dei linfociti T sono fornire risposte immunitarie cellulari e regolare l'immunità umorale (cioè stimolazione o soppressione della differenziazione dei linfociti B). I linfociti T sono in grado di produrre sostanze di segnalazione - linfochine, che regolano l'attività dei linfociti B e di altre cellule nelle reazioni immunitarie. Tra i linfociti T sono stati identificati diversi gruppi funzionali: T-helper, T-soppressori, T-killer.
I linfociti nulli non hanno marcatori di superficie sul plasmalemma caratteristici dei linfociti B e T. Sono considerati una popolazione di riserva di linfociti indifferenziati.
La durata della vita dei linfociti varia da alcune settimane a diversi anni. I linfociti T sono cellule “di lunga vita” (mesi e anni), mentre i linfociti B sono “di breve durata” (settimane e mesi).
I linfociti T sono caratterizzati dal fenomeno del riciclo, cioè escono dal sangue nei tessuti e ritornano attraverso il tratto linfatico nel sangue. Pertanto, effettuano la sorveglianza immunologica dello stato di tutti gli organi, rispondendo rapidamente all'introduzione di agenti estranei.
Tra le cellule che hanno la morfologia di piccoli linfociti ci sono le cellule staminali del sangue circolanti che entrano nel sangue dal midollo osseo. Dalle cellule che entrano negli organi emopoietici si differenziano varie cellule del sangue e da quelle che entrano nel tessuto connettivo si differenziano mastociti, fibroblasti e altre cellule del tessuto connettivo.
Monociti. Queste cellule sono più grandi degli altri globuli bianchi. Nel sangue umano, il numero di monociti varia dal 6 all'8% del numero totale di leucociti.
I nuclei dei monociti sono a forma di fagiolo, a ferro di cavallo e raramente lobulati.
Il citoplasma dei monociti è meno basofilo del citoplasma dei linfociti. Ha un colore azzurro pallido, ma lungo la periferia è leggermente più scuro che vicino al nucleo. Il citoplasma contiene un numero variabile di granuli azzurrofili molto piccoli (lisosomi), molto spesso situati vicino al nucleo.
Caratteristica è la presenza di escrescenze a forma di dita del citoplasma e la formazione di vacuoli fagocitici. Il citoplasma contiene numerose vescicole pinocitotiche.
I monociti appartengono al sistema macrofagico del corpo, o al cosiddetto sistema fagocitico mononucleare. Le cellule di questo sistema sono caratterizzate dalla loro origine dai promonociti del midollo osseo, dalla capacità di attaccarsi alla superficie del vetro, dall'attività di pinocitosi e fagocitosi immunitaria e dalla presenza di recettori per le immunoglobuline e il complemento sulla membrana. I monociti circolanti nel sangue sono un pool mobile di cellule relativamente immature nel loro percorso dal midollo osseo ai tessuti. Il tempo di permanenza dei monociti nel sangue periferico va da 1,5 giorni a 4 giorni.
I monociti che si spostano nei tessuti si trasformano in macrofagi e sviluppano un gran numero di lisosomi, fagosomi e fagolisosomi.
Alcuni termini della medicina pratica:
le leuchine sono sostanze battericide termostabili sintetizzate dai leucociti;
leucemia, leucemia - il nome generale dei tumori derivanti dalle cellule ematopoietiche e che colpiscono il midollo osseo;
le leucopoietine sono sostanze endogene che stimolano la leucopoiesi (proliferazione e differenziazione dei leucociti);
cerotto adesivo: un foglio sottile o una pellicola polimerica con un rivestimento adesivo su un lato; utilizzato, ad esempio, quando si applicano bende
I leucociti sono polimorfonucleati
(granulociti, microfagi) - una popolazione di globuli rotondi bianchi (incolori) con un diametro di 10-14 micron, che, a differenza dei leucociti mononucleari, hanno un nucleo segmentato a forma di ferro di cavallo e un citoplasma granulare (granulare). Si formano nel midollo osseo e circolano nel sangue e nei tessuti. A seconda dell'affinità dei granuli (lisosomi) per i coloranti, si dividono in neutrofili, basofili ed eosinofili. I neutrofili costituiscono il 50-70% di tutti i leucociti del sangue. Le cellule differenziate non sono in grado di riprodursi e muoiono rapidamente se rilasciate nei tessuti e nel corpo. L. p. contengono fosfatasi alcalina, esterasi, ossidasi (3-glucuronidasi, sintetizzano lisozima, defensine, probabilmente alcune frazioni di C, nonché proteine basiche e proteasi acide che aumentano la permeabilità vascolare. Hanno pronunciata motilità ameboide, chemocinesi e la capacità di esocitosi , agglomerazione e adesione, attività fagocitaria. Quest'ultima è più pronunciata nei neutrofili. Sono i primi a comparire nel sito dell'infiammazione, fagocitano i microrganismi e i tessuti morti. I neutrofili morti vengono fagocitati dai macrofagi. A differenza dei macrofagi, L. p. I basofili, come i mastociti, svolgono un certo ruolo nello sviluppo del tipo mediatore dell'HNT. Gli eosinofili migrano nel sito dell'infiammazione più tardi dei neutrofili, si accumulano nei luoghi di interazione tra Ag e Ab e sono in grado di fagocitare il sistema immunitario complessi Si presume un ruolo importante degli eosinofili nello sviluppo della risposta immunitaria del corpo durante le elmintiasi e i protozoi.
(Fonte: Dizionario dei termini di microbiologia)
- - vedi Leucociti polimorfonucleati...
Dizionario di microbiologia
- - leucociti, uno dei tipi di cellule del sangue. In base alle caratteristiche del citoplasma, i L. si distinguono: granulari, o granulociti, e non granulari, o agranulociti...
Dizionario enciclopedico veterinario
- - globuli bianchi; Cellule del sangue incolori, funzionalmente diverse e mobili di animali ed esseri umani, capaci di catturare e digerire microrganismi e corpi estranei, nonché di produrre anticorpi...
Gli inizi della scienza naturale moderna
- - cellule del sangue incolori e con funzioni diverse di animali e esseri umani. Hanno un'origine comune con gli eritrociti sia nella filogenesi che nell'ontogenesi...
Dizionario enciclopedico biologico
- - lo stesso dei granulociti...
- - incolore cellule del sangue umano e animale. Tutti i tipi di L. hanno un nucleo e sono capaci di movimento ameboide attivo. Il corpo assorbe batteri e cellule morte e produce anticorpi...
Scienze naturali. Dizionario enciclopedico
- - vedi Globuli bianchi e Sangue...
Dizionario enciclopedico di Brockhaus ed Euphron
- - globuli bianchi; come i granulociti...
- - globuli bianchi, globuli incolori di animali e esseri umani. L. hanno un'origine comune con i globuli rossi - eritrociti, sia nella filogenesi che nell'ontogenesi...
Grande Enciclopedia Sovietica
- - globuli incolori di esseri umani e animali. Formato negli organi emopoietici. Tutti i tipi di leucociti hanno un nucleo e sono capaci di movimento attivo...
Enciclopedia moderna
- - globuli incolori di esseri umani e animali. Tutti i tipi di leucociti hanno un nucleo e sono capaci di movimento ameboide attivo. Il corpo assorbe batteri e cellule morte e produce anticorpi...
Ampio dizionario enciclopedico
- - pl., R. leucociti/tov...
Dizionario ortografico della lingua russa
- - LEUCOCITI, -s, unità. -it, -a, marito. . Un componente del sangue, cellule incolori che assorbono i batteri e producono anticorpi...
Dizionario esplicativo di Ozhegov
- - leucociti plurale. Cellule del sangue incolori di esseri umani e animali che assorbono batteri e cellule morte e producono anticorpi...
Dizionario esplicativo di Efremova
- - leucocitosi, -ov, unità h. -ts...
Dizionario ortografico russo
- - I globuli bianchi, a differenza di quelli rossi...
Dizionario delle parole straniere della lingua russa
"Leucociti polimorfonucleati" nei libri
autoreChe ruolo svolgono i leucociti nel corpo?
Dal libro Il più recente libro dei fatti. Volume 1. Astronomia e astrofisica. Geografia e altre scienze della terra. Biologia e medicina autore Kondrashov Anatoly PavlovichChe ruolo svolgono i leucociti nel corpo? I leucociti sono cellule del sangue incolori negli esseri umani e negli animali. Tutti i tipi di leucociti (linfociti, monociti, basofili, eosinofili e neutrofili) hanno un nucleo e sono capaci di movimento ameboide attivo, ad esempio contro il flusso sanguigno o
Che ruolo svolgono i leucociti nel corpo?
Dal libro Il più recente libro dei fatti. Volume 1 [Astronomia e astrofisica. Geografia e altre scienze della terra. Biologia e Medicina] autore Kondrashov Anatoly PavlovichChe ruolo svolgono i leucociti nel corpo? I leucociti sono cellule del sangue incolori negli esseri umani e negli animali. Tutti i tipi di leucociti (linfociti, monociti, basofili, eosinofili e neutrofili) hanno un nucleo e sono capaci di movimento ameboide attivo, ad esempio contro il flusso sanguigno o
Leucociti
Dal libro Home Enciclopedia medica. Sintomi e trattamento delle malattie più comuni autore Team di autoriLeucociti Normali: da 4 a 9 mila leucociti in 1 μl di sangue (4–9 × 109 /l). Pertanto, il numero di leucociti è 500-1000 volte inferiore al numero di globuli rossi. I leucociti sono le cellule che per prime rispondono a varie influenze dall'esterno e dall'interno del corpo, e molto spesso questo
Leucociti non granulari
Dal libro Grande Enciclopedia Sovietica (NON) dell'autore TSBLeucociti
Dal libro Grande Enciclopedia Sovietica (LE) dell'autore TSBLeucociti granulari
Dal libro Grande Enciclopedia Sovietica (ZE) dell'autore TSB21. Leucociti
Dal libro Immunologia generale e clinica autore Anokhin N V21. Leucociti Normali – 3,5–8,8 4 h 109 /l. Un aumento del numero dei leucociti è la leucocitosi, una diminuzione è la leucopenia. La leucocitosi è divisa in fisiologica e patologica. Le cause della leucocitosi fisiologica possono essere l'assunzione di cibo (il numero di leucociti non supera
Leucociti
Dal libro Analisi. Guida completa autore Ingerleib Michail BorisovičLeucociti Un aumento del numero di leucociti nelle urine (leucocituria) è un segno di infiammazione dei reni e/o delle basse vie urinarie.NB! Nell'infiammazione cronica, la leucocituria è un segno più affidabile della batteriuria (vedi sotto), che spesso non viene rilevata.NB! A molto
Leucociti
Dal libro Malattie renali. Pielonefrite autore Fadeev Pavel AlexandrovichLeucociti I leucociti sono globuli bianchi che svolgono un ruolo importante nella distruzione di microrganismi e complessi proteici di origine estranea. In altre parole, i leucociti svolgono un ruolo di primo piano nella formazione delle risposte immunitarie protettive dell’organismo. Leucociti
Leucociti
Dal libro Fisiologia normale autore Agadzhanyan Nikolay AlexandrovichLeucociti I leucociti, o globuli bianchi, sono cellule incolori contenenti un nucleo e un protoplasma, di dimensioni variabili da 8 a 20 micron. Il numero di leucociti nel sangue periferico di un adulto varia da 4,0 a 9,0 109/l, o 4000-9000 in 1 µl. Aumento
Leucociti
autoreLeucociti I globuli bianchi combattono virus e batteri e purificano il sangue dalle cellule morenti. Esistono diversi tipi di leucociti (eosinofili, basofili, neutrofili, linfociti, monociti). La conta leucocitaria permette di calcolare il contenuto di queste forme di leucociti nel sangue.
Leucociti
Dal libro Tutto quello che devi sapere sui tuoi test. Autodiagnosi e monitoraggio sanitario autore Pigulevskaya Irina StanislavovnaLeucociti I leucociti nelle urine di una persona sana sono contenuti in piccole quantità (negli uomini 0–3, nelle donne e nei bambini 0–6 leucociti per campo visivo). Un aumento del numero di leucociti nelle urine (leucocituria) indica processi infiammatori nei reni (pielonefrite) o
Leucociti
Dal libro Libro di consultazione completo di analisi e ricerche in medicina autore Ingerleib Michail BorisovičLeucociti Un aumento del numero di leucociti nelle urine (leucocituria) è un segno di infiammazione dei reni e/o delle basse vie urinarie. ATTENZIONE! Nell'infiammazione cronica, la leucocituria è un segno più affidabile della batteriuria (vedi sotto), che spesso non viene rilevata. ATTENZIONE! A molto
Leucociti
Dal libro Imparare a comprendere le proprie analisi autore Pogosyan Elena V.Leucociti I globuli bianchi, o leucociti, sono in realtà cellule incolori. Possono avere forma rotonda o irregolare e dimensioni variabili (da 6 a 20 micron). Inoltre, la loro caratteristica è la capacità di muoversi liberamente,
I leucociti, o globuli bianchi, sono formazioni che hanno forme e dimensioni diverse.
Secondo la loro struttura, i leucociti sono divisi in due grandi gruppi: granulari o granulociti (leucociti polimorfonucleati - PMN) e non granulari o agranulociti (cellule mononucleari).
Questa divisione è puramente condizionale, perché al microscopio elettronico si può vedere che entrambi i leucociti contengono granuli sparsi. Tuttavia, al microscopio ottico, i granuli degli agranulociti sono praticamente indistinguibili. I leucociti granulari comprendono neutrofili, eosinofili e basofili, mentre gli agranulociti comprendono linfociti e monociti. Le cellule della serie granulare prendono il nome dalla loro capacità di essere colorate con coloranti: gli eosinofili percepiscono il colorante acido (eosina), i basofili percepiscono il colorante alcalino (ematossilina) e i neutrofili percepiscono entrambi.
Normalmente, il numero di leucociti negli adulti varia da 4,5 a 9mila per 1 mm3, ovvero da 4,5 a 9´109/litro. Il numero dei leucociti è soggetto a fluttuazioni stagionali. Ci sono più leucociti in autunno e inverno, meno in primavera e ancora meno in estate. Ma queste fluttuazioni non sono così evidenti e non vanno oltre le norme stabilite. Un aumento del numero dei leucociti oltre i limiti normali è chiamato leucocitosi, una diminuzione è chiamata leucopenia. e patologico, mentre la leucopenia si verifica solo in patologia.