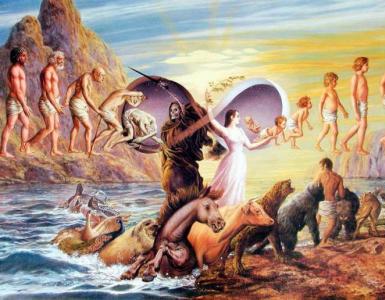Cuore umano e sistema circolatorio. Sangue e sistema circolatorio. Vene e arterie
Questo è un SISTEMA CIRCOLARE. È costituito da due sistemi complessi: circolatorio e linfatico, che lavorano insieme per formare il sistema di trasporto del corpo.
Struttura del sistema circolatorio
Sangue
Il sangue è un tessuto connettivo specifico contenente cellule situate in un plasma liquido. È un sistema di trasporto che collega il mondo interno del corpo con il mondo esterno.
Il sangue è composto da due parti: plasma e cellule. Il plasma è un fluido color paglierino che costituisce circa il 55% del sangue. È costituito per il 10% da proteine, tra cui: albumina, fibrinogeno e protrombina, e per il 90% da acqua in cui sono disciolte o sospese sostanze chimiche: prodotti di degradazione, nutrienti, ormoni, ossigeno, sali minerali, enzimi, anticorpi e antitossine.
Le cellule costituiscono il restante 45% del sangue. Sono prodotti nel midollo osseo rosso, che si trova nelle ossa spugnose.
Esistono tre tipi principali di cellule del sangue:
- I globuli rossi sono dischi concavi ed elastici. Non hanno nucleo, poiché scompare man mano che si forma la cellula. Rimosso dal corpo dal fegato o dalla milza; vengono costantemente sostituiti da nuove cellule. Milioni di nuove cellule sostituiscono quelle vecchie ogni giorno! I globuli rossi contengono emoglobina (emo=ferro, globina=proteina).
- I leucociti sono incolori, di forme diverse e hanno un nucleo. Sono più grandi dei globuli rossi, ma quantitativamente inferiori a loro. I globuli bianchi vivono da alcune ore a diversi anni, a seconda della loro attività.
Esistono due tipi di leucociti:
- I granulociti, o leucociti granulari, costituiscono il 75% dei globuli bianchi e proteggono l'organismo da virus e batteri. Possono cambiare forma e penetrare dal sangue nei tessuti adiacenti.
- Leucociti non granulari (linfociti e monociti). I linfociti fanno parte del sistema linfatico, sono prodotti dai linfonodi e sono responsabili della formazione di anticorpi, che svolgono un ruolo di primo piano nella resistenza dell'organismo alle infezioni. I monociti sono in grado di ingerire batteri nocivi. Questo processo è chiamato fagocitosi. Elimina efficacemente il pericolo per il corpo.
- Le piastrine, o piastrine, sono molto più piccole dei globuli rossi. Sono fragili, non hanno nucleo e partecipano alla formazione di coaguli di sangue nel sito della lesione. Le piastrine si formano nel midollo osseo rosso e vivono per 5-9 giorni.
Cuore
Il cuore si trova nel torace tra i polmoni ed è leggermente spostato a sinistra. Ha le dimensioni del pugno del suo proprietario.
Il cuore funziona come una pompa. È il centro del sistema circolatorio ed è coinvolto nel trasporto del sangue in tutte le parti del corpo.
- La circolazione sistemica si riferisce alla circolazione del sangue tra il cuore e tutte le parti del corpo attraverso i vasi sanguigni.
- La circolazione polmonare si riferisce alla circolazione del sangue tra cuore e polmoni attraverso i vasi della circolazione polmonare.
Il cuore è costituito da tre strati di tessuto:
- L'endocardio è il rivestimento interno del cuore.
- Il miocardio è il muscolo cardiaco. Esegue contrazioni involontarie: battito cardiaco.
- Il pericardio è un sacco pericardico formato da due strati. La cavità tra gli strati è riempita di liquido, che impedisce l'attrito e consente agli strati di muoversi più liberamente durante il battito cardiaco.
Il cuore ha quattro compartimenti, o cavità:
- Le cavità superiori del cuore sono gli atri sinistro e destro.
- Le cavità inferiori sono i ventricoli sinistro e destro.
Una parete muscolare, il setto, separa i lati sinistro e destro del cuore, impedendo la miscelazione del sangue dai lati sinistro e destro del corpo. Il sangue nella parte destra del cuore è povero di ossigeno, mentre il sangue nella parte sinistra è ricco di ossigeno.
Gli atri sono collegati ai ventricoli tramite valvole:
- La valvola tricuspide collega l'atrio destro al ventricolo destro.
- La valvola bicuspide collega l'atrio sinistro al ventricolo sinistro.
Vasi sanguigni
Il sangue circola in tutto il corpo attraverso una rete di vasi chiamati arterie e vene.
I capillari formano le estremità delle arterie e delle vene e forniscono la comunicazione tra il sistema circolatorio e le cellule dell'intero corpo.
Le arterie sono tubi cavi con pareti spesse, costituiti da tre strati di cellule. Hanno un guscio esterno fibroso, uno strato intermedio di tessuto muscolare liscio ed elastico e uno strato interno di tessuto epiteliale squamoso. Le arterie sono più grandi vicino al cuore. Man mano che si allontanano da esso diventano più sottili. Lo strato intermedio di tessuto elastico è più grande nelle arterie grandi che in quelle piccole. Le grandi arterie consentono il flusso di una maggiore quantità di sangue e il tessuto elastico consente loro di allungarsi. Aiuta a mantenere la pressione del sangue proveniente dal cuore e gli consente di continuare a muoversi in tutto il corpo. Le cavità arteriose possono ostruirsi, bloccando il flusso sanguigno. Le arterie terminano con le artepiole, che sono simili nella struttura alle arterie, ma hanno più tessuto muscolare, che consente loro di rilassarsi o contrarsi a seconda della necessità. Ad esempio, quando lo stomaco ha bisogno di ulteriore flusso sanguigno per iniziare la digestione, le arteriole si rilassano. Una volta completato il processo di digestione, le arteriole si contraggono, inviando il sangue ad altri organi.
Le vene sono tubi, anch'essi costituiti da tre strati, ma più sottili delle arterie e presentano una grande percentuale di tessuto muscolare elastico. Le vene fanno molto affidamento sui movimenti volontari dei muscoli scheletrici per aiutare il sangue a ritornare al cuore. La cavità delle vene è più larga di quella delle arterie. Proprio come le arterie alla fine si diramano nelle arteriole, le vene si dividono in venule. Le vene hanno valvole che impediscono al sangue di refluire all'indietro. Problemi alle valvole portano a uno scarso flusso al cuore, che può causare vene varicose, che si verificano soprattutto nelle gambe, dove il sangue rimane intrappolato nelle vene provocandone la dilatazione e il dolore. A volte nel sangue si forma un coagulo o un trombo che viaggia attraverso il sistema circolatorio e può causare un blocco, il che è molto pericoloso.
I capillari creano una rete nei tessuti, garantendo lo scambio gassoso di ossigeno e anidride carbonica e il metabolismo. Le pareti dei capillari sono sottili e permeabili e consentono alle sostanze di entrare e uscire da esse. I capillari sono la fine del percorso del sangue dal cuore, dove l'ossigeno e i nutrienti da essi provenienti entrano nelle cellule, e l'inizio del suo percorso dalle cellule, dove l'anidride carbonica entra nel sangue, che trasporta al cuore.
Struttura del sistema linfatico
Linfa
La linfa è un liquido color paglierino simile al plasma sanguigno, che si forma a seguito dell'ingresso di sostanze nel fluido che bagna le cellule. Si chiama tessuto o interstiziale. liquido ed è formato dal plasma sanguigno. La linfa collega il sangue e le cellule, consentendo all'ossigeno e ai nutrienti di fluire dal sangue alle cellule e ai prodotti di scarto e all'anidride carbonica di rifluire. Alcune proteine plasmatiche penetrano nei tessuti adiacenti e devono essere raccolte per prevenire l’edema. Circa il 10% del fluido tissutale penetra nei capillari linfatici, che consentono facilmente il passaggio delle proteine plasmatiche, dei prodotti di scarto, dei batteri e dei virus. Le restanti sostanze che lasciano le cellule vengono raccolte dal sangue dei capillari e trasportate attraverso le venule e le vene fino al cuore.
Vasi linfatici
I vasi linfatici iniziano con i capillari linfatici, che prelevano il fluido tissutale in eccesso dai tessuti. Si trasformano in tubi più grandi e corrono paralleli alle vene. I vasi linfatici sono simili alle vene, poiché sono dotati anch’essi di valvole che impediscono alla linfa di fluire nella direzione opposta. Il flusso linfatico è stimolato dai muscoli scheletrici, in modo simile al flusso sanguigno venoso.
Linfonodi, tessuti e dotti
I vasi linfatici passano attraverso i linfonodi, i tessuti e i dotti prima di connettersi con le vene e condurre al cuore, a quel punto l’intero processo ricomincia.
Linfonodi
Conosciute anche come ghiandole, sono situate in punti strategici del corpo. Sono formati da tessuto fibroso contenente cellule diverse dai globuli bianchi:
- I macrofagi sono cellule che distruggono le sostanze indesiderate e nocive (antigeni) e filtrano la linfa che passa attraverso i linfonodi.
- I linfociti sono cellule che producono anticorpi protettivi contro gli antigeni raccolti dai macrofagi.
La linfa entra nei linfonodi attraverso i vasi afferenti e li lascia attraverso i vasi efferenti.
Tessuto linfatico
Oltre ai linfonodi, il tessuto linfatico si trova anche in altre zone del corpo.
I dotti linfatici prelevano la linfa purificata che esce dai linfonodi e la inviano alle vene.
Ci sono due dotti linfatici:
- Il dotto toracico è il condotto principale che va dalla vertebra lombare alla base del collo. È lungo circa 40 cm e raccoglie la linfa dal lato sinistro della testa, dal collo e dal torace, dal braccio sinistro, da entrambe le gambe, dalle aree addominali e pelviche e la rilascia nella vena succlavia sinistra.
- Il dotto linfatico destro è lungo solo 1 cm e si trova alla base del collo. Raccoglie la linfa e la rilascia nella vena succlavia destra.
Successivamente, la linfa viene inclusa nella circolazione sanguigna e l'intero processo viene ripetuto di nuovo.
Funzioni del sistema circolatorio
Ogni cellula fa affidamento sul sistema circolatorio per svolgere le sue funzioni individuali. Il sistema circolatorio svolge quattro funzioni principali: circolazione, trasporto, protezione e regolazione.
Circolazione
Il movimento del sangue dal cuore alle cellule è controllato dal battito cardiaco: puoi sentire e sentire come le camere del cuore si contraggono e si rilassano.
- Gli atri si rilassano e si riempiono di sangue venoso e si può sentire il primo suono cardiaco quando le valvole si chiudono mentre il sangue scorre dagli atri ai ventricoli.
- I ventricoli si contraggono, spingendo il sangue nelle arterie; Quando le valvole si chiudono, impedendo al sangue di refluire, si sente un secondo suono cardiaco.
- Il rilassamento è chiamato diastole e la contrazione è chiamata sistole.
- Il cuore batte più velocemente quando il corpo ha bisogno di più ossigeno.
Il battito cardiaco è controllato dal sistema nervoso autonomo. I nervi rispondono ai bisogni del corpo e il sistema nervoso mette in allerta cuore e polmoni. La respirazione accelera, la velocità con cui il cuore spinge l'ossigeno in entrata aumenta.
La pressione viene misurata con uno sfigmomanometro.
- Pressione massima associata alla contrazione ventricolare = pressione sistolica.
- Pressione minima associata al rilassamento ventricolare = pressione diastolica.
- La pressione alta (ipertensione) si verifica quando il cuore non lavora abbastanza per spingere il sangue dal ventricolo sinistro nell’aorta, l’arteria principale. Di conseguenza, il carico sul cuore aumenta e i vasi sanguigni nel cervello possono rompersi, provocando un ictus. Le cause più comuni di ipertensione arteriosa sono lo stress, la cattiva alimentazione, l'alcol e il fumo; Un'altra possibile causa è la malattia renale, l'indurimento o il restringimento delle arterie; a volte la causa è l'ereditarietà.
- La bassa pressione sanguigna (ipotensione) si verifica a causa dell'incapacità del cuore di forzare una quantità sufficiente di sangue a defluire da esso, con conseguente scarso apporto di sangue al cervello e provocando vertigini e debolezza. Le cause della pressione bassa possono essere ormonali ed ereditarie; Anche lo shock potrebbe esserne la causa.
Si può sentire la contrazione e il rilassamento dei ventricoli - questo è il polso - la pressione del sangue che passa attraverso le arterie, le arteriole e i capillari fino alle cellule. Il polso può essere sentito premendo l'arteria contro l'osso.
La frequenza del polso corrisponde alla frequenza cardiaca e la sua forza corrisponde alla pressione del sangue che lascia il cuore. Il polso si comporta in modo molto simile alla pressione sanguigna, cioè aumenta durante l'attività e diminuisce a riposo. La frequenza cardiaca normale di un adulto a riposo è di 70-80 battiti al minuto, durante i periodi di massima attività raggiunge i 180-200 battiti.
Il flusso di sangue e linfa al cuore è controllato da:
- Movimenti dei muscoli ossei. Contraendosi e rilassandosi, i muscoli dirigono il sangue attraverso le vene e la linfa attraverso i vasi linfatici.
- Valvole nelle vene e nei vasi linfatici che impediscono il flusso nella direzione opposta.
La circolazione del sangue e della linfa è un processo continuo, ma può essere divisa in due parti: polmonare e sistemica con le parti portale (relativa al sistema digestivo) e coronaria (relativa al cuore) della circolazione sistemica.
La circolazione polmonare si riferisce alla circolazione del sangue tra i polmoni e il cuore:
- Quattro vene polmonari (due per ciascun polmone) trasportano il sangue ossigenato all'atrio sinistro. Passa attraverso la valvola bicuspide nel ventricolo sinistro, da dove si diffonde in tutto il corpo.
- Le arterie polmonari destra e sinistra trasportano il sangue privo di ossigeno dal ventricolo destro ai polmoni, dove l’anidride carbonica viene rimossa e sostituita con ossigeno.
La circolazione sistemica comprende il flusso principale del sangue dal cuore e il ritorno del sangue e della linfa dalle cellule.
- Il sangue arricchito di ossigeno passa attraverso la valvola bicuspide dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro e attraverso l'aorta (arteria principale) fuori dal cuore, dopo di che viene trasportato alle cellule di tutto il corpo. Da lì, il sangue scorre al cervello attraverso l'arteria carotide, alle braccia attraverso le arterie clavicolare, ascellare, bronchiale, radiale e ulnare e alle gambe attraverso le arterie iliaca, femorale, poplitea e tibiale anteriore.
- Le vene principali trasportano il sangue privo di ossigeno all'atrio destro. Questi includono: vene tibiale anteriore, poplitea, femorale e iliaca delle gambe, vene ulnare, radiale, bronchiogenica, ascellare e clavicolare delle braccia e vene giugulari della testa. Da tutti loro, il sangue entra nelle vene superiore e inferiore, nell'atrio destro, attraverso la valvola tricuspide nel ventricolo destro.
- La linfa scorre attraverso i vasi linfatici paralleli alle vene e viene filtrata nei linfonodi: popliteo, inguinale, sopratrocleare sotto i gomiti, auricolare e occipitale sulla testa e sul collo, prima di raccogliersi nei dotti linfatici e toracici destri e da questi nei dotti linfatici e toracici destri. vene succlavie e poi nel cuore.
- La circolazione portale si riferisce al flusso di sangue dal sistema digestivo al fegato attraverso la vena porta, che controlla e regola il flusso di nutrienti verso tutte le parti del corpo.
- La circolazione coronarica si riferisce al flusso di sangue da e verso il cuore attraverso le arterie e le vene coronarie, garantendo l'apporto della quantità necessaria di nutrienti.
La variazione del volume del sangue in diverse aree del corpo porta alla fuoriuscita di sangue, che viene inviato in quelle aree in cui è necessario in base alle esigenze fisiche di un particolare organo, ad esempio, dopo aver mangiato, c'è più sangue nelle vene. sistema digestivo che nei muscoli, poiché il sangue è necessario per stimolare la digestione. Le procedure non dovrebbero essere eseguite dopo un pasto pesante, poiché in questo caso il sangue lascerà il sistema digestivo ai muscoli sottoposti a lavoro, causando problemi digestivi.
Trasporti
Le sostanze vengono trasportate in tutto il corpo dal sangue.
- I globuli rossi trasportano ossigeno e anidride carbonica tra i polmoni e tutte le cellule del corpo utilizzando l'emoglobina. Quando inspiri, l'ossigeno si mescola con l'emoglobina per formare l'ossiemoglobina. È di colore rosso brillante e trasporta l'ossigeno disciolto nel sangue alle cellule attraverso le arterie. L'anidride carbonica, sostituendo l'ossigeno, forma la deossiemoglobina con l'emoglobina. Il sangue rosso scuro ritorna ai polmoni attraverso le vene e l'anidride carbonica viene espulsa durante l'espirazione.
- Oltre all'ossigeno e all'anidride carbonica, altre sostanze disciolte nel sangue vengono trasportate in tutto il corpo.
- I prodotti di scarto delle cellule, come l'urea, vengono trasportati agli organi emuntori: fegato, reni, ghiandole sudoripare e vengono rimossi dal corpo sotto forma di sudore e urina.
- Gli ormoni secreti dalle ghiandole inviano segnali a tutti gli organi. Il sangue li trasporta ai sistemi del corpo secondo necessità. Per esempio,
Se è necessario evitare un pericolo, l'adrenalina secreta dalle ghiandole surrenali viene trasportata ai muscoli. - I nutrienti e l'acqua provenienti dal sistema digestivo entrano nelle cellule, consentendo loro di dividersi. Questo processo nutre le cellule, permettendo loro di riprodursi e ripararsi.
- I minerali, ottenuti dal cibo e prodotti dall'organismo, sono necessari affinché le cellule mantengano i livelli di pH e svolgano le loro funzioni vitali. I minerali includono cloruro di sodio, carbonato di sodio, potassio, magnesio, fosforo, calcio, iodio e rame.
- Gli enzimi, o proteine, prodotti dalle cellule hanno la capacità di produrre o accelerare cambiamenti chimici senza cambiare se stessi. Questi catalizzatori chimici vengono trasportati anche nel sangue. Pertanto, gli enzimi pancreatici vengono utilizzati dall'intestino tenue per la digestione.
- Gli anticorpi e le antitossine vengono trasportati dai linfonodi, dove vengono prodotti quando le tossine di batteri o virus entrano nel corpo. Il sangue trasporta anticorpi e antitossine nel sito dell’infezione.
Trasporti linfatici:
- Prodotti di decadimento e fluido tissutale dalle cellule ai linfonodi per la filtrazione.
- Fluido dai linfonodi ai dotti linfatici per restituirlo al sangue.
- Grassi dal sistema digestivo nel flusso sanguigno.
Protezione
Il sistema circolatorio svolge un ruolo importante nella protezione del corpo.
- I leucociti (globuli bianchi) aiutano a distruggere le cellule vecchie e danneggiate. Per proteggere il corpo da virus e batteri, alcuni globuli bianchi sono in grado di moltiplicarsi per mitosi per far fronte alle infezioni.
- I linfonodi ripuliscono la linfa: i macrofagi e i linfociti assorbono gli antigeni e producono anticorpi protettivi.
- La purificazione del sangue nella milza è per molti versi simile alla purificazione della linfa nei linfonodi e contribuisce alla difesa dell'organismo.
- La superficie della ferita ispessisce il sangue per prevenire un'eccessiva perdita di sangue/fluidi. Questa funzione vitale è svolta dalle piastrine (piastrine del sangue), che rilasciano enzimi che alterano le proteine plasmatiche per formare una struttura protettiva sulla superficie della ferita. Il coagulo di sangue si asciuga formando una crosta che protegge la ferita finché il tessuto non guarisce. Successivamente, la crosta viene sostituita da nuove cellule.
- Quando si verifica una reazione allergica o un danno alla pelle, il flusso sanguigno in quest'area aumenta. L'arrossamento della pelle associato a questo fenomeno si chiama eritema.
Regolamento
Il sistema circolatorio è coinvolto nel mantenimento dell’omeostasi nei seguenti modi:
- Gli ormoni trasportati nel sangue regolano molteplici processi che si verificano nel corpo.
- Il sistema tampone del sangue mantiene il suo livello di acidità tra 7,35 e 7,45. Un aumento significativo (alcalosi) o una diminuzione (acidosi) di questo valore può essere fatale.
- La struttura del sangue mantiene l'equilibrio dei liquidi.
- La normale temperatura del sangue - 36,8 ° C - viene mantenuta grazie al trasporto di calore. Il calore è prodotto da muscoli e organi come il fegato. Il sangue è in grado di distribuire il calore in diverse aree del corpo contraendo e rilassando i vasi sanguigni.
Il sistema circolatorio è la forza che collega tutti i sistemi del corpo e il sangue contiene tutti i componenti necessari per la vita.
Possibili violazioni
Possibili disturbi del sistema circolatorio dalla A alla Z:
- ACROCIANOSI - insufficiente apporto di sangue alle mani e/o ai piedi.
- L'ANEURISMO è un'infiammazione localizzata di un'arteria che può svilupparsi a seguito di una malattia o di un danno a quel vaso sanguigno, soprattutto in caso di pressione alta.
- ANEMIA: diminuzione del livello di emoglobina.
- TROMBOSI ARTERIOSA - formazione di un coagulo di sangue in un'arteria che interferisce con il normale flusso sanguigno.
- ARTERITE - infiammazione di un'arteria, spesso associata all'artrite reumatoide.
- L'ARTERIOSCLEROSI è una condizione in cui le pareti delle arterie perdono elasticità e si induriscono. Per questo motivo, la pressione sanguigna aumenta.
- ATEROSCLEROSI - restringimento delle arterie causato da un aumento dei grassi, compreso il colesterolo.
- MALATTIA DI HODKINS - cancro del tessuto linfatico.
- GANGRENA - mancanza di afflusso di sangue alle dita, a causa della quale marciscono e alla fine muoiono.
- EMOFILIA - non coagulabilità del sangue, che porta alla sua eccessiva perdita.
- EPATITE B e C - infiammazione del fegato causata da virus trasportati dal sangue contaminato.
- IPERTENSIONE - pressione alta.
- Il DIABETE è una condizione in cui il corpo non è in grado di assorbire zuccheri e carboidrati ottenuti dal cibo. L'ormone insulina è prodotto dalle ghiandole surrenali.
- La TROMBOSI CORONARICA è una tipica causa di infarto quando si verifica un'ostruzione delle arterie che forniscono sangue al cuore.
- LEUCEMIA: produzione eccessiva di globuli bianchi che porta al cancro del sangue.
- Il LINFEDEMA è un'infiammazione di un arto che colpisce la circolazione linfatica.
- L'EDEMA è il risultato dell'accumulo di liquidi in eccesso dal sistema circolatorio nei tessuti.
- ATTACCO REUMATICO - infiammazione del cuore, spesso complicazione della tonsillite.
- La SEPSIS è un'infezione del sangue causata dall'accumulo di sostanze tossiche nel sangue.
- SINDROME DI RAYNAUD - contrazione delle arterie che alimentano mani e piedi, con conseguente intorpidimento.
- UN BAMBINO BLU (CIANOTICO) è un difetto cardiaco congenito che fa sì che non tutto il sangue passi attraverso i polmoni per ricevere ossigeno.
- L’AIDS è una sindrome da immunodeficienza acquisita causata dall’HIV, il virus dell’immunodeficienza umana. I linfociti T sono colpiti, il che rende impossibile il normale funzionamento del sistema immunitario.
- ANGINA: diminuzione del flusso sanguigno al cuore, solitamente a causa dello sforzo fisico.
- Lo STRESS è una condizione che fa battere il cuore più velocemente, aumentando la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Lo stress grave può causare problemi cardiaci.
- TROMBO - un coagulo di sangue nei vasi o nel cuore.
- FIBRILLAZIONE ATRIALE: battito cardiaco irregolare.
- FLEBITI - infiammazione delle vene, solitamente delle gambe.
- COLESTEROLO ALTO LIVELLO - crescita eccessiva dei vasi sanguigni con la sostanza grassa colesterolo, che causa ATEROSCLEROSI e IPERTENSIONE.
- EMBOLISMO POLMONARE - blocco dei vasi sanguigni dei polmoni.
Armonia
Il sistema circolatorio e linfatico collega tutte le parti del corpo e fornisce ad ogni cellula componenti vitali: ossigeno, sostanze nutritive e acqua. Il sistema circolatorio purifica anche il corpo dai prodotti di scarto e trasporta gli ormoni che determinano le azioni delle cellule. Per eseguire efficacemente tutti questi compiti, il sistema circolatorio richiede una certa attenzione per mantenere l’omeostasi.
Liquido
Come tutti gli altri sistemi, il sistema circolatorio dipende dall'equilibrio dei liquidi nel corpo.
- Il volume del sangue nel corpo dipende dalla quantità di liquido ricevuto. Se il corpo non riceve abbastanza liquidi, si verifica la disidratazione e diminuisce anche il volume del sangue. Di conseguenza, possono verificarsi cali di pressione sanguigna e svenimenti.
- Il volume della linfa nel corpo dipende anche dall'assunzione di liquidi. La disidratazione porta ad un ispessimento della linfa, che ne impedisce il flusso e provoca gonfiore.
- La mancanza di acqua influisce sulla composizione del plasma e di conseguenza il sangue diventa più viscoso. Ciò impedisce il flusso sanguigno e aumenta la pressione sanguigna.
Nutrizione
Il sistema circolatorio, che fornisce nutrienti a tutti gli altri sistemi del corpo, è esso stesso molto dipendente dall’alimentazione. Lei, come altri sistemi, ha bisogno di una dieta equilibrata, ricca di antiossidanti, in particolare di vitamina C, che mantiene anche la flessibilità vascolare. Altre sostanze necessarie:
- Ferro - per la formazione dell'emoglobina nel midollo osseo rosso. Contenuto in semi di zucca, prezzemolo, mandorle, anacardi e uva passa.
- Acido folico - per lo sviluppo dei globuli rossi. Gli alimenti più ricchi di acido folico sono i chicchi di grano, gli spinaci, le arachidi e i germogli verdi.
- Vitamina B6 - favorisce il trasporto dell'ossigeno nel sangue; si trova nelle ostriche, nelle sardine e nel tonno.
Riposo
Durante il riposo il sistema circolatorio si rilassa. Il cuore batte più lentamente, la frequenza e la forza del polso diminuiscono. Il flusso di sangue e linfa rallenta e l'apporto di ossigeno diminuisce. È importante ricordare che il sangue venoso e la linfa che ritornano al cuore sperimentano resistenza, e quando siamo sdraiati, questa resistenza è molto più bassa! Il loro flusso è ulteriormente migliorato quando ci sdraiamo con le gambe leggermente sollevate, cosa che attiva il flusso inverso di sangue e linfa. Il riposo deve necessariamente sostituire l’attività, ma in eccesso può essere dannoso. Le persone costrette a letto sono più suscettibili ai problemi circolatori rispetto alle persone attive. Il rischio aumenta con l’età, la cattiva alimentazione, la mancanza di aria fresca e lo stress.
Attività
Il sistema circolatorio richiede un'attività che stimoli il flusso del sangue venoso al cuore e il flusso della linfa ai linfonodi, ai dotti e ai vasi. Il sistema risponde molto meglio ai carichi regolari e costanti che a quelli improvvisi. Per stimolare la frequenza cardiaca, il consumo di ossigeno e purificare l'organismo, si consigliano sessioni di 20 minuti tre volte a settimana. Se il sistema viene improvvisamente sovraccaricato, possono verificarsi problemi cardiaci. Affinché l'esercizio possa apportare benefici al corpo, la frequenza cardiaca non deve superare l'85% del “massimo teorico”.
Le attività di salto, come il trampolino elastico, sono particolarmente buone per la circolazione sanguigna e linfatica, mentre gli esercizi che fanno lavorare il torace fanno bene al cuore e al dotto toracico. Inoltre, è importante non sottovalutare i benefici che apportano camminare, salire e scendere le scale e perfino svolgere i lavori domestici, che mantengono attivo tutto il corpo.
Aria
Quando alcuni gas entrano nel corpo, influenzano l’emoglobina negli eritrociti (globuli rossi), rendendo difficile il trasporto dell’ossigeno. Questi includono il monossido di carbonio. Una piccola quantità di monossido di carbonio è contenuta nel fumo di sigaretta: un altro punto sui pericoli del fumo. Nel tentativo di correggere la situazione, l’emoglobina difettosa stimola la produzione di più globuli rossi. In questo modo il corpo può far fronte ai danni causati da una sigaretta, ma il fumo a lungo termine ha effetti a cui il corpo non può resistere. Di conseguenza, la pressione sanguigna aumenta, il che può portare a malattie. Quando si sale ad alta quota, si verifica la stessa stimolazione dei globuli rossi. L’aria rarefatta ha un basso contenuto di ossigeno, il che fa sì che il midollo osseo rosso produca più globuli rossi. Con un aumento del numero di cellule contenenti emoglobina, l'apporto di ossigeno aumenta e il suo contenuto nel sangue ritorna normale. Quando l’apporto di ossigeno aumenta, la produzione di globuli rossi diminuisce e quindi viene mantenuta l’omeostasi. Questo è il motivo per cui il corpo impiega del tempo per adattarsi alle nuove condizioni ambientali, come l’alta quota o la profondità. L'atto stesso della respirazione stimola il flusso della linfa attraverso i vasi linfatici. I movimenti dei polmoni massaggiano il dotto toracico, stimolando il flusso della linfa. La respirazione profonda aumenta questo effetto: le fluttuazioni della pressione nel torace stimolano un ulteriore flusso linfatico, che aiuta a purificare il corpo. Ciò impedisce l'accumulo di tossine nel corpo ed evita molti problemi, incluso l'edema.
Età
L’invecchiamento ha i seguenti effetti sul sistema circolatorio:
- A causa della cattiva alimentazione, del consumo di alcol, dello stress, ecc. La pressione sanguigna può aumentare, il che può portare a problemi cardiaci.
- Meno ossigeno raggiunge i polmoni e, di conseguenza, le cellule, con conseguente difficoltà a respirare con l'avanzare dell'età.
- Una diminuzione dell'apporto di ossigeno influisce sulla respirazione cellulare, causando un deterioramento delle condizioni della pelle e del tono muscolare.
- Con una diminuzione dell'attività complessiva, l'attività del sistema circolatorio diminuisce e i meccanismi protettivi perdono la loro efficacia.
Colore
Il colore rosso è associato al sangue arterioso ossigenato e il blu è associato al sangue venoso privo di ossigeno. Il rosso stimola, il blu calma. Si dice che il colore rosso faccia bene all'anemia e alla pressione bassa, mentre il blu faccia bene alle emorroidi e alla pressione alta. Il verde, il colore del quarto chakra, è associato al cuore e alla ghiandola del timo. Il cuore è maggiormente interessato alla circolazione sanguigna e la ghiandola del timo è maggiormente interessata alla produzione di linfociti per il sistema linfatico. Quando parliamo dei nostri sentimenti più profondi, spesso tocchiamo l'area del cuore, l'area associata al colore verde. Il verde, situato al centro dell'arcobaleno, simboleggia l'armonia. La mancanza di colore verde (soprattutto nelle città dove c'è poca vegetazione) è considerata un fattore che sconvolge l'armonia interna. L'eccesso di colore verde porta spesso a una sensazione di traboccamento di energia (ad esempio durante una gita fuori porta o una passeggiata nel parco).
Conoscenza
Una buona salute generale del corpo è importante affinché il sistema circolatorio funzioni in modo efficace. La persona assistita si sentirà benissimo sia mentalmente che fisicamente. Pensa a quanto un buon terapista, un capo premuroso o un partner amorevole migliorano le nostre vite. La terapia migliora il colore della pelle, gli elogi del capo migliorano l'autostima e un segno di attenzione ti riscalda dall'interno. Tutto ciò stimola il sistema circolatorio, da cui dipende la nostra salute. Lo stress, d’altro canto, aumenta la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, che possono sovraccaricare questo sistema. Bisogna quindi cercare di evitare uno stress eccessivo: allora i sistemi del corpo potranno funzionare meglio e più a lungo.
Cura speciale
Il sangue è spesso associato alla personalità. Dicono che una persona ha sangue “buono” o “cattivo” e le forti emozioni vengono espresse con frasi come “il pensiero fa ribollire il sangue” o “il suono fa gelare il sangue”. Questo mostra la connessione tra il cuore e il cervello, che funzionano all'unisono. Se si vuole raggiungere l’armonia tra mente e cuore non si possono ignorare le esigenze del sistema circolatorio. Un'attenzione particolare in questo caso sta nel comprenderne la struttura e le funzioni, che ci permetteranno di utilizzare razionalmente e massimizzare il nostro corpo e di insegnarlo ai nostri pazienti.
Il sistema circolatorio svolge una delle funzioni più importanti del corpo: fornisce ossigeno e sostanze nutritive necessarie per il funzionamento del corpo agli organi e ai tessuti, rimuovendo contemporaneamente da essi l'anidride carbonica e i prodotti di scarto. Un'altra funzione altrettanto importante del sistema circolatorio è la regolazione dell'attività dell'intero corpo e dei suoi singoli sistemi e organi. Ciò si ottiene attraverso il trasferimento di ormoni dalle ghiandole endocrine in tutto il corpo. Il sistema circolatorio e quello nervoso insieme formano un unico sistema di regolazione, coordinazione, adattamento e protezione del corpo
COMPONENTI DEL SISTEMA CIRCOLATORE.
Sangue
La parte principale e funzionale del sistema circolatorio. È un tessuto connettivo liquido costituito da plasma e elementi formati: eritrociti (globuli rossi), leucociti (globuli bianchi), piastrine (piastrine del sangue). Il colore rosso del sangue deriva dall'emoglobina contenuta nei globuli rossi. Il sangue è caratterizzato da una relativa costanza della composizione chimica, della pressione osmotica e della reazione attiva (pH). Trasferisce l'ossigeno dagli organi respiratori ai tessuti e l'anidride carbonica dai tessuti agli organi respiratori, fornisce i nutrienti dagli organi digestivi ai tessuti e i prodotti metabolici agli organi escretori, partecipa alla regolazione del metabolismo del sale marino e dell'acidità equilibrio base nel corpo, nel mantenere una temperatura corporea costante. A causa della presenza di anticorpi, antitossine e lisina nel sangue, nonché della capacità dei leucociti di assorbire microrganismi e corpi estranei, il sangue svolge una funzione protettiva.
Funzioni del sangue
Funzione di trasporto.
Circolando attraverso i vasi, il sangue trasporta molti composti, tra cui gas, sostanze nutritive, ecc.
Funzione respiratoria
Questa funzione è quella di legare e trasportare ossigeno e anidride carbonica.
Funzione trofica (nutrizionale).
Il sangue fornisce sostanze nutritive a tutte le cellule del corpo: glucosio, aminoacidi, grassi, vitamine, minerali
Funzione escretoria
Il sangue trasporta i prodotti finali del metabolismo dai tessuti: urea, acido urico e altre sostanze rimosse dal corpo dagli organi escretori
Funzione termoregolatrice
Il sangue raffredda gli organi interni e trasferisce il calore agli organi che dissipano il calore. Mantenere un ambiente interno costante. Il sangue mantiene la stabilità di un numero di costanti corporee
Garantire il metabolismo del sale marino
Il sangue garantisce lo scambio salino tra sangue e tessuti. Nella parte arteriosa dei capillari liquidi e sali entrano nei tessuti e nella parte venosa dei capillari ritornano nel sangue
Funzione protettiva
Il sangue svolge una funzione protettiva, essendo il fattore più importante per l’immunità, ovvero la difesa dell’organismo contro corpi viventi e sostanze geneticamente estranee.
Regolazione umorale
Grazie alla sua funzione di trasporto, il sangue garantisce l'interazione chimica tra tutte le parti del corpo, cioè regolazione umorale. Il sangue trasporta ormoni e altre sostanze fisiologicamente attive
La quantità totale di sangue raggiunge il 10% del peso grasso dell'animale. Tuttavia, solo il 54% circola nei vasi, il resto fino al 20% nel fegato, circa il 16% nella milza e non più del 10% nella pelle.
COMPONENTI DEL SANGUE
|
Le cellule del sangue includono:
globuli rossi
Globuli rossi, cellule anucleate sotto forma di dischi appiattiti con un diametro di 4,2-10 micron. Forniscono ossigeno dai polmoni alle cellule, prelevano l'anidride carbonica da queste ultime e la trasferiscono ai polmoni. Il numero di globuli rossi varia da 5,2 a 8,4 milioni/μl. I globuli rossi vivono non più di 120 giorni
Leucociti (linfociti, monociti, granulociti)
I globuli bianchi hanno una struttura diversa e partecipano alla funzione protettiva del corpo. Esistono diversi tipi di leucociti. Il loro numero varia da 8,5 a 10,5 mila/μl. I globuli bianchi vivono circa 24 ore
Piastrine
Le piastre del sangue sono responsabili del processo di coagulazione del sangue. Il loro numero varia da 250 a 550 mila/μl
Anticorpi
proteine globulari (immunoglobuline) del plasma sanguigno che hanno la capacità di legarsi specificamente agli antigeni (sostanze che vengono percepite dall'organismo come estranee e causano una risposta immunitaria specifica. In grado di interagire con le cellule del sistema immunitario e gli anticorpi. L'ingresso degli antigeni nel corpo può causare la formazione di immunità, l'insorgenza di una condizione di tolleranza immunologica o allergia.Le proteine, i polisaccaridi e altre macromolecole hanno le proprietà degli antigeni.). Interagendo con i microrganismi, ne impediscono la riproduzione o neutralizzano le sostanze tossiche che rilasciano.
Antitossine
proteine specifiche (anticorpi) che neutralizzano le tossine di microrganismi (ad es. Tetano, difterite), piante (ricina, abrina) e animali (veleno di serpente, karakurt).
Lisina
un amminoacido alifatico con proprietà basiche pronunciate. Parte delle proteine. Un amminoacido essenziale, non è sintetizzato dalle cellule animali e umane ed entra nell'organismo come parte delle proteine alimentari. L'assenza o la carenza di aminoacidi essenziali porta all'arresto della crescita, alla perdita di peso, a disturbi metabolici e, in caso di carenza acuta, alla morte dell'organismo
PRINCIPALI ORGANI CHE FORMANO IL SANGUE
|
Il sistema circolatorio è costituito da un numero enorme di vasi con diversi diametri, lunghezze e strutture. Permeano tutto il corpo e formano un letto vascolare assolutamente chiuso.
VASI SANGUIGNI, formazioni tubolari elastiche presenti nel corpo degli animali e dell'uomo attraverso le quali il sangue si sposta dal cuore o vaso pulsante centrale ai tessuti del corpo (arterie, arteriole, capillari arteriosi) e da questi al cuore (capillari venosi, venule, vene). La violazione dell'integrità della parete vascolare porta al sanguinamento. L'intensità del sanguinamento dipende dal diametro della nave, dalla posizione del danno e da altri fattori. La perdita di oltre il 50% del sangue porta alla morte.
|
L'organo principale che effettua il flusso sanguigno è il cuore.
Il cuore è una specie di pompa muscolare che pompa il sangue. All'interno del muscolo cardiaco esiste uno speciale meccanismo di regolazione che garantisce il funzionamento automatico del cuore. L'arresto cardiaco porta alla morte del corpo.
Il cuore è un organo muscolare cavo; ha una forma arrotondata, con la punta leggermente smussata. Il cuore si trova dietro lo sterno, nella parte inferiore del mediastino anteriore, sul diaframma.
Si trova in una speciale cavità pericardica, nell'area da 3 a 7 costole. La metà più grande viene spostata a sinistra
Sulla superficie del cuore sono presenti dei solchi in cui si trovano le arterie e le vene che lo riforniscono. La cavità cardiaca è divisa in quattro camere: gli atri destro e sinistro e i ventricoli destro e sinistro.
L'atrio sinistro riceve il sangue arterioso dalle quattro vene polmonari. Comunica con il ventricolo sinistro attraverso un'apertura dotata di valvola bicuspide. Quando il ventricolo sinistro si contrae, il sangue entra nell'aorta.
Nell'atrio destro confluiscono la vena cava superiore e quella inferiore, nonché le vene proprie del cuore. Dall'atrio destro, il sangue venoso entra nel ventricolo destro attraverso l'apertura con la valvola tricuspide e da esso nel tronco polmonare. Pertanto, la circolazione sistemica inizia nel ventricolo sinistro e la piccola circolazione inizia nel ventricolo destro.
 |
L'apparato valvolare è di grande importanza per la corretta organizzazione del flusso sanguigno nel cuore. Il funzionamento delle valvole è il seguente. Quando i ventricoli si contraggono (un processo chiamato sistole), le tre e le due valvole lembi sono posizionate in modo tale da impedire il flusso inverso del sangue dai ventricoli agli atri. Quindi il sangue dai ventricoli destro e sinistro può fluire rispettivamente nel tronco delle arterie polmonari e nell'aorta. La funzione delle valvole del tronco polmonare e dell'aorta è che quando i ventricoli si rilassano (diastole), il sangue che entra nel tronco polmonare e nell'aorta ritorna indietro. Allo stesso tempo, afferra i lembi della valvola e li posiziona nel piano della base di questi vasi. I lembi della valvola toccano i loro bordi e impediscono al sangue di rientrare nelle cavità dei ventricoli. .
La parete del cuore è costituita da tre strati: quello esterno (epicardio), quello medio (muscolare) (miocardio) e quello interno (endocardio). Speciali fibre muscolari che hanno la capacità di trasmettere l'eccitazione da nodi speciali - pacemaker - al miocardio degli atri e dei ventricoli formano il sistema di conduzione del cuore. Questo sistema garantisce l'automaticità delle contrazioni cardiache.
CERCHI DI CIRCOLAZIONE DEL SANGUE
 |
Nel sistema circolatorio generale si distinguono la circolazione sistemica e quella polmonare. Il compito di un grande cerchio è l'afflusso di sangue agli organi. Inizia con l'aorta. L'aorta è il più grande vaso arterioso spaiato.) dal ventricolo sinistro del cuore. Da esso, il sangue scorre alla testa, al collo e agli arti toracici attraverso le arterie brachiale e succlavia, e al resto del corpo attraverso l'aorta toracica e addominale. Dalle ultime due si dipartono grandi arterie, che si dividono ripetutamente, formando un letto vascolare inorganico. Penetrando negli organi, le arterie formano un letto terminale (emomicrocircolare). Quest'ultimo è costituito da cinque unità - arteriola, precapillare, capillare, postcapillare e venula - fornisce processi metabolici.
Anche all'interno degli organi, le venule si fondono nelle vene intraorgano, che a loro volta formano un letto venoso extraorgano. Attraverso di esso, il sangue scorre nella vena cava cranica e caudale. Questi ultimi confluiscono nell'atrio destro, dove termina la circolazione sistemica. Va ricordato che da tutti gli organi digestivi situati nella cavità addominale (ad eccezione della parte caudale del retto)), il deflusso del sangue venoso avviene nella vena porta. Quest'ultimo nel fegato si divide in capillari, formando una meravigliosa rete venosa. Il deflusso del sangue dal fegato avviene attraverso le vene epatiche, che si aprono nella vena cava caudale. Dall'atrio destro, il sangue entra nel ventricolo destro attraverso i capillari dei polmoni. .
Il compito del piccolo circolo (respiratorio o polmonare) è trasportare questo sangue venoso attraverso i polmoni, dove si satura di ossigeno e diventa arterioso. Inizia dal ventricolo destro del cuore attraverso il tronco delle arterie polmonari. Quest'ultimo sopra il cuore è diviso nelle arterie polmonari destra e sinistra, che entrano attraverso l'ilo dei polmoni nei suoi tessuti. Lo scambio di gas avviene nei capillari degli acini dei polmoni e il sangue ossigenato ritorna attraverso le vene polmonari al ventricolo sinistro, cioè di nuovo all'inizio della circolazione sistemica.
SISTEMA CIRCOLATORIO FETALE
Durante il periodo della vita intrauterina, si sviluppa e funziona un organo speciale: la placenta, che garantisce che l'organismo in via di sviluppo riceva non solo ossigeno dal sangue della madre, ma anche tutti i nutrienti necessari per la sua crescita e sviluppo. I prodotti metabolici vengono rilasciati attraverso la placenta. In questo caso, il sangue del feto e della madre non si mescola.
 |
1 – vena cava craniale (anteriore).
2 – vena cava caudale (posteriore).
3 – atrio destro.
4 – flusso sanguigno nel forame ovale.
5 – ventricolo destro.
6 – tronco polmonare.
7 – arterie polmonari.
7* – dotto arterioso.
8 – atrio sinistro.
9 – ventricolo sinistro.
10 – arco aortico.
11 – aorta toracica.
12 – vena ombelicale
12* – flusso venoso.
13 – capillari epatici.
Nel feto, come nell'adulto, l'aorta emerge dal ventricolo sinistro del cuore, trasportando il sangue a tutti gli organi e tessuti. Da esso, a livello delle ultime vertebre lombari - le prime vertebre sacrali, partono le arterie ombelicali accoppiate. Passano a destra e a sinistra della vescica e vanno all'apertura ombelicale. Attraverso di esso, le arterie lasciano il corpo del feto e vanno alla placenta, dove si dividono in capillari. Lo scambio di gas e la saturazione del sangue con le sostanze nutritive avvengono nei capillari della placenta.
Dalla rete vascolare della placenta, il sangue arterioso entra nella vena ombelicale. Quest'ultimo, attraverso l'apertura ombelicale come parte del cordone ombelicale, penetra nella cavità addominale del feto e si dirige verso la porta del fegato. Attraverso di loro, la vena ombelicale penetra nel tessuto epatico e si divide in capillari. Qui entra anche nel fegato il sangue venoso che scorre dallo stomaco, dall'intestino tenue e crasso, dalla milza e dal pancreas del feto. È qui che avviene la prima miscelazione del sangue arterioso e venoso fetale. Nel cane, parte del sangue proveniente dalla vena ombelicale passa attraverso il dotto venoso direttamente nella vena cava, bypassando il fegato.
Dal fegato emergono numerose vene epatiche che si aprono nella vena cava. E il sangue venoso scorre attraverso di esso dagli organi della cavità pelvica, dell'arto pelvico, della parete addominale e dei reni fetali, ad es. nella vena cava avviene una seconda miscelazione del sangue venoso fetale con sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive. Attraverso la vena caudale, il sangue entra nell'atrio destro, dove si mescola per la terza volta con il sangue venoso che scorre dalla parte anteriore (craniale) del corpo fetale attraverso la vena cava cranica.
Dall'atrio destro il sangue scorre in due direzioni:
- Una parte del sangue entra nel ventricolo destro attraverso l'orifizio atrioventricolare destro del cuore. E da esso proviene il tronco delle arterie polmonari, da cui inizia il piccolo circolo respiratorio della circolazione sanguigna. Poiché i polmoni del feto non funzionano, quasi tutto il sangue proveniente dal tronco delle arterie polmonari entra nell'aorta attraverso il flusso arterioso. Quest'ultimo si trova leggermente più lontano dall'aorta delle arterie brachiocefalica e succlavia, il che garantisce che il sangue, più saturo di ossigeno e sostanze nutritive, scorra verso la parte anteriore del feto. Ciò crea le condizioni per uno sviluppo più intenso della parte anteriore del corpo dell’embrione.
- Parte del sangue scorre attraverso il forame ovale nel setto interatriale nell'atrio sinistro e da esso attraverso il forame atrioventricolare sinistro del cuore nel ventricolo sinistro. Da quest'ultimo nasce l'aorta, che trasporta il sangue in tutto il corpo fetale, compresa l'arteria ombelicale. Questo chiude i circoli della circolazione sanguigna.
Dopo un breve periodo, anche il dotto arterioso cresce eccessivamente, trasformandosi in un legamento arterioso. Con la chiusura del dotto arterioso il sangue comincia a fluire in tutte le parti del corpo alla stessa pressione.
Con l'esclusione della placenta, le arterie ombelicali si svuotano, trasformandosi nel legamento rotondo della vescica, e la vena ombelicale spaiata, al momento della nascita, nel legamento rotondo del fegato.
DIFFERENZE NEL SISTEMA CIRCOLATORE DEL FETO E DELL'ADULTO.
- Il sangue arterioso entra attraverso l'arteria ombelicale nel fegato, poi nel cuore, poi nei polmoni, nel cuore e nella circolazione sistemica, cioè. nel cuore e nei polmoni non c'è sangue arterioso, come negli animali adulti, ma misto.
- La presenza del dotto botallus nel feto tra l'aorta e l'arteria ombelicale - Il sangue venoso che entra nel tronco polmonare attraverso il dotto arterioso (botallus) viene scaricato nell'aorta sotto i punti di partenza da essa di grandi vasi che riforniscono la testa, collo e arti superiori. Di conseguenza, il resto dell'aorta contiene sangue misto, la cui composizione è sufficiente a fornire sangue agli organi e alle pareti della cavità addominale, del bacino e degli arti inferiori. Una parte significativa di questo sangue misto viene trasportata nella placenta attraverso due arterie ombelicali, che nascono dai vasi pelvici.
- Il feto ha un'apertura ovale tra gli atri destro e sinistro: dalla placenta, il sangue arterioso attraverso la vena ombelicale entra infine nella vena cava inferiore e attraverso di essa nell'atrio destro. Qui, il flusso di questo sangue attraverso il foro nel setto tra gli atri (forame ovale) scorre direttamente nell'atrio sinistro e poi nel ventricolo sinistro e nella circolazione sistemica, bypassando il piccolo circolo.
- Nell'adulto i polmoni funzionano pienamente, ma nel feto, durante il periodo intrauterino dello sviluppo, i polmoni non funzionano come organi respiratori.
- Tutti i circoli circolatori funzionano perfettamente, mentre nel feto lo scambio gassoso avviene con la partecipazione della placenta, quindi nel feto la circolazione polmonare non funziona completamente.
- Immediatamente dopo la nascita, con i primi movimenti respiratori, il flusso sanguigno nel dotto arterioso e nel foro ovale si interrompe e nelle settimane e nei mesi successivi essi stessi si chiudono completamente. Se ciò non accade, stiamo parlando di un grave difetto di sviluppo.
SISTEMA CIRCOLATORIO
(sistema circolatorio), un gruppo di organi coinvolti nella circolazione sanguigna nel corpo. Il normale funzionamento di qualsiasi corpo animale richiede un'efficiente circolazione sanguigna poiché trasporta ossigeno, sostanze nutritive, sali, ormoni e altre sostanze vitali a tutti gli organi del corpo. Inoltre, il sistema circolatorio restituisce il sangue dai tessuti a quegli organi, dove può essere arricchito con sostanze nutritive, così come ai polmoni, dove è saturo di ossigeno e rilasciato dall'anidride carbonica (anidride carbonica). Infine, il sangue deve fluire verso una serie di organi speciali, come il fegato e i reni, che neutralizzano o eliminano i prodotti di scarto metabolico. L’accumulo di questi prodotti può portare a malattie croniche e persino alla morte. Questo articolo discute il sistema circolatorio umano. (Sui sistemi circolatori in altre specie
vedere l'articolo ANATOMIA COMPARATIVA.)
Componenti del sistema circolatorio. Nella sua forma più generale, questo sistema di trasporto è costituito da una pompa muscolare a quattro camere (cuore) e da numerosi canali (vasi), la cui funzione è quella di fornire il sangue a tutti gli organi e tessuti e il suo successivo ritorno al cuore e ai polmoni. In base ai componenti principali di questo sistema, viene anche chiamato cardiovascolare o cardiovascolare. I vasi sanguigni si dividono in tre tipologie principali: arterie, capillari e vene. Le arterie portano il sangue lontano dal cuore. Si ramificano in vasi di diametro sempre più piccolo, attraverso i quali il sangue scorre verso tutte le parti del corpo. Più vicine al cuore, le arterie hanno il diametro maggiore (circa le dimensioni di un pollice); negli arti hanno le dimensioni di una matita. Nelle parti del corpo più lontane dal cuore, i vasi sanguigni sono così piccoli che possono essere visti solo al microscopio. Sono questi vasi microscopici, i capillari, che forniscono alle cellule ossigeno e sostanze nutritive. Dopo la consegna, il sangue, carico di prodotti di scarto metabolico e anidride carbonica, viene inviato al cuore attraverso una rete di vasi chiamati vene, e dal cuore ai polmoni, dove avviene lo scambio di gas, a seguito del quale il sangue viene liberato. dal carico di anidride carbonica ed è saturo di ossigeno. Mentre attraversa il corpo e i suoi organi, una parte del liquido penetra attraverso le pareti dei capillari nei tessuti. Questo fluido opalescente, simile al plasma, è chiamato linfa. Il ritorno della linfa al sistema circolatorio generale avviene attraverso il terzo sistema di canali: i tratti linfatici, che si fondono in grandi condotti che confluiscono nel sistema venoso in prossimità del cuore. (Descrizione dettagliata della linfa e dei vasi linfatici
vedi articolo SISTEMA LINFATICO.)
LAVORO DEL SISTEMA CIRCOLATORE



Circolazione polmonare.È conveniente iniziare a descrivere il normale movimento del sangue in tutto il corpo dal momento in cui ritorna alla metà destra del cuore attraverso due grandi vene. Una di queste, la vena cava superiore, porta il sangue dalla metà superiore del corpo, mentre la seconda, la vena cava inferiore, porta il sangue dalla metà inferiore. Il sangue di entrambe le vene entra nel compartimento di raccolta del lato destro del cuore, l'atrio destro, dove si mescola con il sangue portato dalle vene coronarie, che si aprono nell'atrio destro attraverso il seno coronarico. Nelle arterie e nelle vene coronarie circola il sangue necessario al funzionamento del cuore stesso. L'atrio si riempie, si contrae e spinge il sangue nel ventricolo destro, che si contrae per forzare il sangue attraverso le arterie polmonari nei polmoni. Il flusso costante di sangue in questa direzione è mantenuto dal funzionamento di due importanti valvole. Una di queste, la valvola tricuspide, situata tra il ventricolo e l'atrio, impedisce il ritorno del sangue nell'atrio, mentre la seconda, la valvola polmonare, si chiude quando il ventricolo si rilassa e impedisce così il ritorno del sangue dalle arterie polmonari. Nei polmoni, il sangue passa attraverso i rami dei vasi, entrando in una rete di sottili capillari che sono in diretto contatto con le sacche d'aria più piccole: gli alveoli. Tra il sangue capillare e gli alveoli avviene uno scambio di gas che completa la fase polmonare della circolazione sanguigna, cioè fase in cui il sangue entra nei polmoni
(Guarda anche ORGANI RESPIRATORI). Circolazione sistemica. Da questo momento inizia la fase sistemica della circolazione sanguigna, cioè fase di trasferimento del sangue a tutti i tessuti del corpo. Depurato dall'anidride carbonica e arricchito di ossigeno (ossigenato), il sangue ritorna al cuore attraverso quattro vene polmonari (due da ciascun polmone) ed entra nell'atrio sinistro a bassa pressione. Il percorso del flusso sanguigno dal ventricolo destro del cuore ai polmoni e da essi all'atrio sinistro è il cosiddetto. circolazione polmonare. L'atrio sinistro, pieno di sangue, si contrae contemporaneamente a quello destro e lo spinge nel massiccio ventricolo sinistro. Quest'ultimo, una volta riempito, si contrae, inviando sangue ad alta pressione nell'arteria di diametro maggiore: l'aorta. Dall'aorta partono tutti i rami arteriosi che forniscono i tessuti del corpo. Proprio come nella parte destra del cuore, a sinistra ci sono due valvole. La valvola bicuspide (mitrale) dirige il flusso sanguigno nell'aorta e impedisce al sangue di ritornare al ventricolo. L'intero percorso del sangue dal ventricolo sinistro fino al ritorno (attraverso le vene cave superiore e inferiore) all'atrio destro è denominato circolazione sistemica.
Arterie. In una persona sana, il diametro dell'aorta è di circa 2,5 cm, questo grande vaso si estende dal cuore verso l'alto, forma un arco e poi scende attraverso il torace nella cavità addominale. Lungo il decorso dell'aorta si dipartono da essa tutte le grandi arterie che entrano nella circolazione sistemica. I primi due rami, che si estendono dall'aorta quasi al cuore, sono le arterie coronarie, che forniscono sangue al tessuto cardiaco. A parte loro, l'aorta ascendente (la prima parte dell'arco) non ramifica. Tuttavia, nella parte superiore dell'arco, da esso si dipartono tre importanti vasi. La prima, l'arteria anonima, si divide immediatamente nell'arteria carotide destra, che fornisce sangue al lato destro della testa e al cervello, e nell'arteria succlavia destra, che passa sotto la clavicola nel braccio destro. Il secondo ramo dell'arco aortico è l'arteria carotide sinistra, il terzo è l'arteria succlavia sinistra; Questi rami trasportano il sangue alla testa, al collo e al braccio sinistro. Dall'arco aortico inizia l'aorta discendente, che fornisce sangue agli organi del torace, per poi entrare nella cavità addominale attraverso un'apertura nel diaframma. Separate dall'aorta addominale ci sono due arterie renali che riforniscono i reni, così come il tronco addominale con le arterie mesenteriche superiore e inferiore, che si estendono all'intestino, alla milza e al fegato. L'aorta si divide quindi in due arterie iliache, che forniscono sangue agli organi pelvici. Nella zona inguinale le arterie iliache diventano femorali; questi ultimi, scendendo lungo le cosce, a livello dell'articolazione del ginocchio passano nelle arterie poplitee. Ciascuno di essi, a sua volta, è diviso in tre arterie: le arterie tibiale anteriore, tibiale posteriore e peroneale, che nutrono i tessuti delle gambe e dei piedi. Lungo l'intera lunghezza del flusso sanguigno, le arterie diventano sempre più piccole man mano che si ramificano e infine acquisiscono un calibro che è solo molte volte più grande della dimensione delle cellule del sangue che contengono. Questi vasi sono chiamati arteriole; continuando a dividersi, formano una rete diffusa di vasi (capillari), il cui diametro è approssimativamente uguale al diametro di un globulo rosso (7 μm).
Struttura delle arterie. Sebbene le arterie grandi e piccole differiscano leggermente nella loro struttura, le pareti di entrambe sono costituite da tre strati. Lo strato esterno (avventizia) è uno strato relativamente sciolto di tessuto connettivo fibroso ed elastico; attraverso di esso passano i vasi sanguigni più piccoli (i cosiddetti vasi vascolari), che alimentano la parete vascolare, nonché i rami del sistema nervoso autonomo che regolano il lume del vaso. Lo strato intermedio (media) è costituito da tessuto elastico e muscoli lisci, che forniscono elasticità e contrattilità alla parete vascolare. Queste proprietà sono essenziali per regolare il flusso sanguigno e mantenere la normale pressione sanguigna in condizioni fisiologiche mutevoli. Tipicamente, le pareti dei vasi più grandi, come l’aorta, contengono più tessuto elastico rispetto alle pareti delle arterie più piccole, che sono prevalentemente tessuto muscolare. In base a questa caratteristica del tessuto, le arterie si dividono in elastiche e muscolari. Lo spessore dello strato interno (intima) raramente supera il diametro di diverse cellule; È questo strato, rivestito di endotelio, che conferisce alla superficie interna del vaso una levigatezza che facilita il flusso sanguigno. Attraverso di esso, i nutrienti fluiscono negli strati profondi dei media. Man mano che il diametro delle arterie diminuisce, le pareti si assottigliano e i tre strati diventano meno distinguibili finché, a livello arteriolare, rimangono per lo più fibre muscolari spirali, qualche tessuto elastico e un rivestimento interno di cellule endoteliali.

Capillari. Infine, le arteriole si trasformano impercettibilmente in capillari, le cui pareti sono rivestite solo da endotelio. Sebbene questi minuscoli tubi contengano meno del 5% del volume del sangue circolante, sono estremamente importanti. I capillari formano un sistema intermedio tra le arteriole e le venule, e le loro reti sono così fitte e larghe che nessuna parte del corpo può essere perforata senza perforarne un gran numero. È in queste reti che, sotto l'influenza delle forze osmotiche, l'ossigeno e i nutrienti vengono trasferiti alle singole cellule del corpo e, in cambio, i prodotti del metabolismo cellulare entrano nel sangue. Inoltre questa rete (il cosiddetto letto capillare) svolge un ruolo fondamentale nella regolazione e nel mantenimento della temperatura corporea. La costanza dell'ambiente interno (omeostasi) del corpo umano dipende dal mantenimento della temperatura corporea entro limiti ristretti della norma (36,8-37°). Normalmente, il sangue dalle arteriole entra nelle venule attraverso il letto capillare, ma in condizioni di freddo i capillari si chiudono e il flusso sanguigno diminuisce, principalmente nella pelle; in questo caso il sangue proveniente dalle arteriole entra nelle venule, bypassando molti rami del letto capillare (bypass). Al contrario, quando è necessario il trasferimento di calore, ad esempio ai tropici, tutti i capillari si aprono e il flusso sanguigno cutaneo aumenta, favorendo la perdita di calore e mantenendo la normale temperatura corporea. Questo meccanismo esiste in tutti gli animali a sangue caldo.
Vienna. Sul lato opposto del letto capillare, i vasi si fondono in numerosi piccoli canali, le venule, di dimensioni paragonabili alle arteriole. Continuano a connettersi per formare vene più grandi che trasportano il sangue da tutte le parti del corpo al cuore. Il flusso sanguigno costante in questa direzione è facilitato da un sistema di valvole presente nella maggior parte delle vene. La pressione venosa, a differenza della pressione nelle arterie, non dipende direttamente dalla tensione dei muscoli della parete vascolare, quindi il flusso sanguigno nella direzione desiderata è determinato principalmente da altri fattori: la forza di spinta creata dalla pressione arteriosa della circolazione sistemica ; l'effetto “risucchio” della pressione negativa che si verifica nel torace durante l'inspirazione; l'azione di pompaggio dei muscoli degli arti, che, durante le normali contrazioni, spingono il sangue venoso verso il cuore. Le pareti delle vene sono simili nella struttura a quelle arteriose in quanto anch'esse sono costituite da tre strati, tuttavia, molto meno pronunciate. Per il movimento del sangue nelle vene, che avviene praticamente senza pulsazioni e ad una pressione relativamente bassa, non sono necessarie pareti spesse ed elastiche come quelle delle arterie. Un'altra importante differenza tra vene e arterie è la presenza di valvole al loro interno, che mantengono il flusso sanguigno in una direzione a bassa pressione. Le valvole si trovano in maggior numero nelle vene delle estremità, dove le contrazioni muscolari svolgono un ruolo particolarmente importante nel riportare il sangue al cuore; le vene grandi, come la cava, la porta e iliaca, sono prive di valvole. Nel loro percorso verso il cuore, le vene raccolgono il sangue che scorre dal tratto gastrointestinale attraverso la vena porta, dal fegato attraverso le vene epatiche, dai reni attraverso le vene renali e dagli arti superiori attraverso le vene succlavie. Vicino al cuore si formano due vene cave, attraverso le quali il sangue entra nell'atrio destro. I vasi della circolazione polmonare (polmonare) assomigliano ai vasi della circolazione sistemica, con la sola eccezione che sono privi di valvole e le pareti sia delle arterie che delle vene sono molto più sottili. A differenza della circolazione sistemica, il sangue venoso e non ossigenato scorre attraverso le arterie polmonari nei polmoni, mentre il sangue arterioso scorre attraverso le vene polmonari. saturo di ossigeno. I termini "arterie" e "vene" si riferiscono alla direzione del flusso sanguigno nei vasi - dal cuore o al cuore, e non al tipo di sangue che contengono.
Organi ausiliari. Numerosi organi svolgono funzioni che completano il lavoro del sistema circolatorio. La milza, il fegato e i reni sono quelli più strettamente associati ad esso.
Milza. Quando i globuli rossi (eritrociti) attraversano ripetutamente il sistema circolatorio, vengono danneggiati. Tali cellule “di scarto” vengono rimosse dal sangue in molti modi, ma il ruolo principale qui spetta alla milza. La milza non solo distrugge i globuli rossi danneggiati, ma produce anche linfociti (che sono globuli bianchi). Nei vertebrati inferiori, la milza svolge anche il ruolo di serbatoio di globuli rossi, ma negli esseri umani questa funzione è debolmente espressa.
Guarda anche Milza.
Fegato. Per svolgere le sue oltre 500 funzioni, il fegato ha bisogno di un buon apporto di sangue. Pertanto, occupa un posto importante nel sistema circolatorio ed è provvisto di un proprio sistema vascolare, chiamato sistema portale. Numerose funzioni epatiche sono direttamente correlate al sangue, come la rimozione dei globuli rossi di scarto dal sangue, la produzione di fattori di coagulazione e la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue immagazzinando lo zucchero in eccesso sotto forma di glicogeno.
Guarda anche FEGATO .
Reni. I reni ricevono circa il 25% del volume totale di sangue espulso dal cuore ogni minuto. Il loro ruolo speciale è quello di purificare il sangue dai rifiuti contenenti azoto. Quando questa funzione viene interrotta, si sviluppa una condizione pericolosa: l'uremia. La perdita di afflusso di sangue o danni ai reni provocano un forte aumento della pressione sanguigna che, se non trattata, può portare a morte prematura per insufficienza cardiaca o ictus.
Guarda anche RENI; UREMIA.
PRESSIONE SANGUIGNA (ARTERIOSA).
Ad ogni contrazione del ventricolo sinistro del cuore, le arterie si riempiono di sangue e si allungano. Questa fase del ciclo cardiaco è chiamata sistole ventricolare, mentre la fase di rilasciamento ventricolare è chiamata diastole. Durante la diastole, invece, entrano in gioco le forze elastiche dei grandi vasi sanguigni, che mantengono la pressione sanguigna e impediscono l'interruzione del flusso di sangue verso le varie parti del corpo. Il cambiamento della sistole (contrazione) e della diastole (rilassamento) conferisce al flusso sanguigno nelle arterie un carattere pulsante. Il polso può essere rilevato in qualsiasi arteria principale, ma di solito viene percepito al polso. Negli adulti, la frequenza cardiaca è solitamente 68-88 e nei bambini - 80-100 battiti al minuto. L'esistenza della pulsazione arteriosa è testimoniata anche dal fatto che quando viene tagliata un'arteria, il sangue rosso vivo fuoriesce a getti, e quando viene tagliata una vena, il sangue bluastro (a causa del basso contenuto di ossigeno) scorre uniformemente, senza tremori visibili. Per garantire un adeguato apporto di sangue a tutte le parti del corpo durante entrambe le fasi del ciclo cardiaco, è necessario un certo livello di pressione sanguigna. Sebbene questo valore vari in modo significativo anche nelle persone sane, la pressione sanguigna normale è in media di 100-150 mmHg. durante la sistole e 60-90 mm Hg. durante la diastole. La differenza tra questi indicatori è chiamata pressione del polso. Ad esempio, una persona con una pressione sanguigna di 140/90 mm Hg. la pressione del polso è 50 mm Hg. Un altro indicatore, la pressione arteriosa media, può essere approssimato calcolando la media della pressione sistolica e diastolica o aggiungendo metà della pressione del polso alla pressione diastolica. La pressione sanguigna normale è determinata, mantenuta e regolata da molti fattori, i principali sono la forza di contrazione del cuore, il ritorno elastico delle pareti delle arterie, il volume del sangue nelle arterie e la resistenza delle piccole arterie (di tipo muscolare) e delle arteriole al movimento del sangue. Tutti questi fattori insieme determinano la pressione laterale sulle pareti elastiche delle arterie. Può essere misurato in modo molto accurato utilizzando una speciale sonda elettronica inserita nell'arteria e registrando i risultati su carta. Tali dispositivi, tuttavia, sono piuttosto costosi e vengono utilizzati solo per studi speciali, e i medici, di regola, effettuano misurazioni indirette utilizzando il cosiddetto. sfigmomanometro (tonometro). Uno sfigmomanometro è costituito da un bracciale che viene avvolto attorno all'arto su cui viene effettuata la misurazione, e da un dispositivo di registrazione, che può essere una colonna di mercurio o un semplice manometro aneroide. In genere, il bracciale viene avvolto strettamente attorno al braccio sopra il gomito e gonfiato fino all'assenza di pulsazioni al polso. L'arteria brachiale si trova a livello del gomito e sopra di essa viene posizionato uno stetoscopio, dopodiché l'aria viene rilasciata lentamente dal bracciale. Quando la pressione nel bracciale scende a un livello tale da riprendere il flusso sanguigno attraverso l'arteria, viene prodotto un suono udibile con uno stetoscopio. Le letture del dispositivo di misurazione al momento della comparsa di questo primo suono (tono) corrispondono al livello della pressione sanguigna sistolica. Con un ulteriore rilascio d'aria dal bracciale, la natura del suono cambia in modo significativo o scompare completamente. Questo momento corrisponde al livello della pressione diastolica. In una persona sana, la pressione sanguigna oscilla durante il giorno a seconda dello stato emotivo, dello stress, del sonno e di molti altri fattori fisici e mentali. Queste fluttuazioni riflettono alcuni cambiamenti nel delicato equilibrio normalmente esistente, che è mantenuto sia dagli impulsi nervosi provenienti dai centri del cervello attraverso il sistema nervoso simpatico, sia dai cambiamenti nella composizione chimica del sangue, che hanno un effetto regolatore diretto o indiretto. effetto sui vasi sanguigni. Con un forte stress emotivo, i nervi simpatici causano un restringimento delle piccole arterie muscolari, che porta ad un aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Di ancora maggiore importanza è l'equilibrio chimico, la cui influenza è mediata non solo dai centri cerebrali, ma anche dai singoli plessi nervosi associati all'aorta e alle arterie carotidi. La sensibilità di questa regolazione chimica è illustrata, ad esempio, dall'effetto dell'accumulo di anidride carbonica nel sangue. All’aumentare del suo livello aumenta l’acidità del sangue; ciò provoca sia direttamente che indirettamente la contrazione delle pareti delle arterie periferiche, che si accompagna ad un aumento della pressione sanguigna. Allo stesso tempo, la frequenza cardiaca aumenta, ma i vasi sanguigni del cervello paradossalmente si espandono. La combinazione di queste reazioni fisiologiche garantisce un apporto stabile di ossigeno al cervello aumentando il volume del sangue in entrata. È la regolazione fine della pressione sanguigna che consente di cambiare rapidamente la posizione orizzontale del corpo in verticale senza un movimento significativo di sangue verso gli arti inferiori, che potrebbe causare svenimenti a causa di un insufficiente apporto di sangue al cervello. In questi casi, le pareti delle arterie periferiche si contraggono e il sangue ossigenato viene diretto principalmente agli organi vitali. I meccanismi vasomotori (vasomotori) sono ancora più importanti per animali come la giraffa, il cui cervello, quando alza la testa dopo aver bevuto, si solleva di quasi 4 m in pochi secondi.Una diminuzione simile del contenuto di sangue nei vasi della pelle, tratto digestivo e fegato si verifica in momenti di stress, disagio emotivo, shock e trauma, il che aiuta a fornire più ossigeno e sostanze nutritive al cervello, al cuore e ai muscoli. Tali fluttuazioni della pressione sanguigna sono normali, ma i cambiamenti si osservano anche in una serie di condizioni patologiche. Nell’insufficienza cardiaca, la forza di contrazione del muscolo cardiaco può diminuire così tanto che la pressione sanguigna diventa troppo bassa (ipotensione). Allo stesso modo, la perdita di sangue o di altri liquidi a causa di una grave ustione o sanguinamento può far scendere la pressione sanguigna sia sistolica che diastolica a livelli pericolosi. Con alcuni difetti cardiaci congeniti (ad esempio, dotto arterioso pervio) e una serie di lesioni dell'apparato valvolare del cuore (ad esempio, insufficienza della valvola aortica), la resistenza periferica diminuisce drasticamente. In questi casi, la pressione sistolica può rimanere normale, ma la pressione diastolica diminuisce in modo significativo, il che significa un aumento della pressione del polso. Alcune malattie non sono accompagnate da una diminuzione, ma, al contrario, da un aumento della pressione sanguigna (ipertensione arteriosa). Le persone anziane i cui vasi sanguigni perdono elasticità e diventano più rigidi di solito sviluppano una forma benigna di ipertensione arteriosa. In questi casi, a causa della diminuzione della distensibilità vascolare, la pressione arteriosa sistolica raggiunge un livello elevato, mentre la pressione arteriosa diastolica rimane quasi normale. In alcune malattie dei reni e delle ghiandole surrenali entrano nel sangue grandi quantità di ormoni come le catecolamine e la renina. Queste sostanze provocano la costrizione dei vasi sanguigni e, quindi, l'ipertensione. Sia in questa che in altre forme di aumento della pressione sanguigna, le cui cause sono meno conosciute, aumenta anche l'attività del sistema nervoso simpatico, il che aumenta ulteriormente la contrazione delle pareti vascolari. L'ipertensione arteriosa a lungo termine, se non trattata, porta ad uno sviluppo accelerato dell'aterosclerosi, nonché ad una maggiore incidenza di malattie renali, insufficienza cardiaca e ictus.
Guarda anche IPERTENSIONE ARTERIOSA. La regolazione della pressione sanguigna nel corpo e il mantenimento dell'apporto di sangue necessario agli organi consentono al meglio di comprendere l'enorme complessità dell'organizzazione e del funzionamento del sistema circolatorio. Questo sistema di trasporto davvero straordinario è una vera e propria "ancora di salvezza" del corpo, poiché un apporto di sangue insufficiente a qualsiasi organo vitale, in primo luogo al cervello, per almeno alcuni minuti porta a danni irreversibili e persino alla morte.
MALATTIE DEI VASI SANGUIGNI
Le malattie dei vasi sanguigni (malattie vascolari) sono opportunamente considerate in base al tipo di vasi in cui si sviluppano i cambiamenti patologici. Lo stiramento delle pareti dei vasi sanguigni o del cuore stesso porta alla formazione di aneurismi (protuberanze simili a sacche). Questo di solito è una conseguenza dello sviluppo di tessuto cicatriziale in una serie di malattie dei vasi coronarici, lesioni sifilitiche o ipertensione. L'aneurisma dell'aorta o dei ventricoli del cuore è la complicanza più grave delle malattie cardiovascolari; potrebbe rompersi spontaneamente, causando un'emorragia fatale.
Aorta. L'arteria più grande, l'aorta, deve accogliere il sangue espulso sotto pressione dal cuore e, grazie alla sua elasticità, spostarlo nelle arterie più piccole. Nell'aorta possono svilupparsi processi infettivi (il più delle volte sifilitici) e arteriosclerotici; è anche possibile la rottura dell'aorta a causa di lesioni o debolezza congenita delle sue pareti. L’ipertensione arteriosa spesso porta ad un ingrossamento cronico dell’aorta. Tuttavia, le malattie dell’aorta sono meno importanti delle malattie cardiache. Le lesioni più gravi sono l'aterosclerosi estesa e l'aortite sifilitica.
Aterosclerosi. L'aterosclerosi aortica è una forma di arteriosclerosi semplice del rivestimento interno dell'aorta (intima) con depositi di grasso granulari (ateromatosi) all'interno e al di sotto di questo strato. Una delle gravi complicazioni di questa malattia dell'aorta e dei suoi rami principali (arteria anonima, iliaca, carotide e renale) è la formazione di coaguli di sangue nello strato interno, che possono ostruire il flusso sanguigno in questi vasi e portare a un'interruzione catastrofica dell’afflusso di sangue al cervello, alle gambe e ai reni. Questo tipo di lesioni ostruttive (che ostruiscono il flusso sanguigno) di alcuni vasi di grandi dimensioni possono essere eliminate chirurgicamente (chirurgia vascolare).
Aortite sifilitica. Una diminuzione della prevalenza della sifilide stessa rende meno comune l’infiammazione dell’aorta da essa provocata. Si manifesta circa 20 anni dopo l'infezione ed è accompagnata da una significativa dilatazione dell'aorta con formazione di aneurismi o dalla diffusione dell'infezione alla valvola aortica, che porta alla sua insufficienza (rigurgito aortico) e sovraccarico del ventricolo sinistro del cuore . È anche possibile il restringimento della bocca delle arterie coronarie. Ognuna di queste condizioni può portare alla morte, a volte molto rapidamente. L'età in cui si manifesta l'aortite e le sue complicanze varia dai 40 ai 55 anni; la malattia è più comune negli uomini. L'arteriosclerosi dell'aorta, accompagnata dalla perdita di elasticità delle sue pareti, è caratterizzata da danni non solo all'intima (come nell'aterosclerosi), ma anche allo strato muscolare della nave. Questa è una malattia della vecchiaia e, poiché la popolazione vive più a lungo, sta diventando sempre più comune. La perdita di elasticità riduce l'efficienza del flusso sanguigno, il che di per sé può portare ad una dilatazione dell'aorta simile ad un aneurisma e persino alla rottura, soprattutto nella regione addominale. Al giorno d'oggi è talvolta possibile far fronte a questa condizione attraverso un intervento chirurgico ( Guarda anche ANEURISMA).
Arteria polmonare. Le lesioni dell'arteria polmonare e dei suoi due rami principali sono poche. Talvolta in queste arterie si verificano alterazioni arteriosclerotiche e si verificano anche difetti congeniti. I due cambiamenti più importanti sono: 1) dilatazione dell'arteria polmonare dovuta all'aumento della pressione al suo interno dovuta a qualche ostruzione del flusso sanguigno nei polmoni o nel percorso del sangue nell'atrio sinistro e 2) blocco (embolia) di uno dei i suoi rami principali a causa del passaggio di un coagulo di sangue dalle grandi vene infiammate della gamba (flebite) attraverso la metà destra del cuore, che è una causa comune di morte improvvisa.
Arterie di medio calibro. La malattia più comune delle arterie medie è l’arteriosclerosi. Quando si sviluppa nelle arterie coronarie del cuore, viene interessato lo strato interno del vaso (intima), il che può portare al completo blocco dell'arteria. A seconda dell'entità del danno e delle condizioni generali del paziente, viene eseguita l'angioplastica con palloncino o l'intervento di bypass coronarico. Nell'angioplastica con palloncino, un catetere con un palloncino all'estremità viene inserito nell'arteria interessata; il gonfiaggio del palloncino porta all'appiattimento dei depositi lungo la parete arteriosa e all'espansione del lume del vaso. Nell'intervento di bypass, una sezione di un vaso viene tagliata da un'altra parte del corpo e cucita nell'arteria coronaria, bypassando l'area ristretta e ripristinando il normale flusso sanguigno. Quando le arterie delle gambe e delle braccia sono danneggiate, lo strato medio, muscolare, dei vasi sanguigni (media) si ispessisce, causando il loro ispessimento e curvatura. Il danno a queste arterie ha conseguenze relativamente meno gravi.
Arteriole. Il danno alle arteriole crea un’ostruzione al libero flusso sanguigno e porta ad un aumento della pressione sanguigna. Tuttavia, anche prima che le arteriole diventino sclerotiche, possono verificarsi spasmi di origine sconosciuta, che sono una causa comune di ipertensione.
Vienna. Le malattie venose sono molto comuni. Le più comuni sono le vene varicose degli arti inferiori; questa condizione si sviluppa sotto l'influenza della gravità a causa dell'obesità o della gravidanza e talvolta a causa dell'infiammazione. In questo caso, la funzione delle valvole venose viene interrotta, le vene si allungano e si riempiono di sangue, accompagnato da gonfiore delle gambe, dolore e persino ulcerazioni. Per il trattamento vengono utilizzate varie procedure chirurgiche. L'alleviamento della malattia è facilitato dall'allenamento dei muscoli della parte inferiore delle gambe e dalla riduzione del peso corporeo. Un altro processo patologico - l'infiammazione delle vene (flebite) - si osserva più spesso anche nelle gambe. In questo caso si verificano ostruzioni del flusso sanguigno con interruzione della circolazione locale, ma il pericolo principale della flebite è il distacco di piccoli coaguli di sangue (emboli), che possono passare attraverso il cuore e causare arresto circolatorio nei polmoni. Questa condizione, chiamata embolia polmonare, è molto grave e spesso fatale. Il danno alle vene di grandi dimensioni è molto meno pericoloso ed è molto meno comune. Guarda anche
Il sistema circolatorio è molto spesso chiamato sistema cardiovascolare, quindi a priori è la stessa cosa.
Organi del sistema circolatorio
Il sistema circolatorio è costituito dal cuore e dai vasi sanguigni: arterie, vene e capillari. Il cuore, come una pompa, pompa il sangue attraverso i vasi. Il sangue espulso dal cuore entra nelle arterie, che trasportano il sangue agli organi.
L'arteria più grande è l'aorta. Le arterie si ramificano ripetutamente in arterie più piccole e formano capillari sanguigni, nei quali avviene lo scambio di sostanze tra il sangue e i tessuti corporei.
I capillari sanguigni si fondono nelle vene, vasi attraverso i quali il sangue ritorna al cuore. Le vene piccole si fondono in vene più grandi fino a raggiungere finalmente il cuore.
Il sistema circolatorio umano è chiuso. C'è sempre una barriera tra il sangue e le cellule del corpo: la parete del vaso sanguigno, lavata dal fluido tissutale.
Le arterie e le vene hanno pareti spesse, quindi i nutrienti, l'ossigeno e i prodotti di degradazione contenuti nel sangue non possono dissiparsi lungo il percorso. Il sangue li porterà nel luogo in cui sono necessari senza perdite.
Lo scambio tra sangue e tessuti è possibile solo nei capillari, che hanno pareti estremamente sottili, costituite da un unico strato di tessuto epiteliale. Parte del plasma sanguigno fuoriesce attraverso di esso, reintegrando la quantità di fluido tissutale, sostanze nutritive, ossigeno, anidride carbonica e altre sostanze che passano.
La struttura delle arterie, dei capillari, delle vene e dei vasi linfatici
Tutti i vasi, ad eccezione dei capillari sanguigni e linfatici, sono costituiti da tre strati. Lo strato esterno è costituito da tessuto connettivo, lo strato intermedio è costituito da tessuto muscolare liscio e, infine, lo strato interno è costituito da epitelio a strato singolo.
Le arterie hanno le pareti più spesse. Devono resistere all'alta pressione del sangue spinto dentro di loro dal cuore. Le arterie hanno uno spesso strato esterno di tessuto connettivo e uno strato muscolare. Grazie ai muscoli lisci che comprimono la nave, il sangue riceve ulteriore accelerazione. A questo contribuisce anche la membrana esterna del tessuto connettivo: quando l'arteria è piena di sangue, si allunga e quindi, grazie alla sua elasticità, esercita pressione sul contenuto del vaso.
Le pareti delle vene e dei vasi linfatici sono elastiche e vengono facilmente compresse dai muscoli scheletrici attraverso i quali passano. Lo strato epiteliale interno delle vene di medie dimensioni forma valvole a forma di sacca. Impediscono al sangue e alla linfa di fluire nella direzione opposta. Il lavoro muscolare contribuisce al normale movimento del sangue e della linfa.
La ragione del movimento del sangue attraverso i vasi
La ragione del movimento del sangue è il lavoro del cuore, che crea una differenza di pressione tra l'inizio e la fine del letto vascolare. Il sangue, come qualsiasi liquido, si sposta da un'area ad alta pressione a un'area in cui è più bassa. La pressione più alta si registra nell'aorta e nelle arterie polmonari, quella più bassa nella vena cava inferiore e superiore e nelle vene polmonari.
La pressione sanguigna diminuisce gradualmente, ma non in modo uniforme. Nelle arterie è più alto, nei capillari è più basso, nelle vene diminuisce ancora di più, poiché viene spesa molta energia spingendo il sangue attraverso il sistema capillare: quando si muove, il flusso sanguigno incontra resistenza, che dipende dal diametro del vaso e la viscosità del sangue.
Pressione sanguigna
La particolarità della pressione sanguigna è che non è la stessa: più il vaso arterioso è lontano dal cuore, minore è la pressione al suo interno. Nel frattempo, è necessario conoscere la pressione sanguigna, poiché è un importante indicatore di salute.
Velocità del flusso sanguigno
La velocità del movimento del sangue dipende dall'area della sezione trasversale dei vasi attraverso i quali passa. Quindi la velocità del flusso sanguigno nella vena cava superiore e inferiore è due volte inferiore rispetto all'aorta. Infatti, la velocità del sangue nell'aorta è approssimativamente di 50 cm/s e nella vena cava di soli 25 cm/s. Nei capillari, la cui area totale è 500-600 volte maggiore dell'area dell'aorta, il sangue si muoverà 500-600 volte più lentamente.
Distribuzione del sangue nel corpo
Gli organi che lavorano attivamente sono meglio riforniti di sangue. Il dosaggio dei nutrienti e dell'ossigeno in entrata si ottiene riducendo o espandendo il diametro dei capillari. A causa del fatto che al loro interno viene creata un'alta pressione, molto sangue passa attraverso di essi. Se la pressione sanguigna diminuisce, alcuni capillari si restringono e il sangue non passa attraverso di essi.
Il costante movimento del sangue garantisce l'equilibrio delle sostanze apportate e utilizzate. Grazie a ciò è garantita la costanza dell'ambiente interno del corpo. Questo processo è controllato da recettori che determinano i limiti superiore e inferiore dei livelli normali di varie sostanze nel sangue.
Funzione di trasporto Il corpo ha un sistema circolatorio chiuso e un sistema linfatico aperto. Forniscono nutrienti e ossigeno alle cellule e rimuovono i prodotti di scarto da cellule e tessuti. Il sistema circolatorio e quello linfatico sono strettamente collegati e si completano a vicenda.
Attraverso questi sistemi viene effettuata la comunicazione umorale tra gli organi e la difesa immunitaria dell’organismo contro sostanze e antigeni estranei.
Malattie del sistema cardiovascolare
Navi. Con un'alimentazione eccessiva o scorretta, o con il fumo, si verificano cambiamenti nelle pareti dei vasi sanguigni. Perdono elasticità e diventano fragili. Ciò accade perché sulle pareti, solitamente dove si diramano le arterie, si deposita una sostanza organica chiamata colesterolo. Su di esso si depositano sali di calcio che ricoprono le paretiki di vasi dall'interno. Questo processo si chiama sclerosi(dal greco "sclerosi" - indurimento, compattazione dei tessuti) dei vasi sanguigni.
Se i vasi sanguigni del cervello diventano sclerotici, il suo apporto di sangue si deteriora, quindi le cellule nervose ricevono quantità insufficienti di ossigeno e sostanze nutritive. Ciò porta a interruzioni significative delle funzioni cerebrali e persino all’indebolimento delle funzioni mentali. La memoria di una persona inizia a soffrire e le prestazioni diminuiscono in modo significativo.
Ecco perché nella vita di tutti i giorni con la parola “sclerosi” spesso intendiamo qualcosa di completamente diverso. Immaginiamo una persona che dimentica tutto, confonde tutto. Questo concetto quotidiano non deve essere confuso con quello scientifico. Non solo le pareti dei vasi sanguigni, ma anche le cellule di altri organi, come il fegato, possono ispessirsi e diventare sclerotiche.
Nella sclerosi, le pareti dei vasi sanguigni non possono allungarsi, il loro lume rimane ristretto e il cuore continua a pompare la stessa quantità di sangue. Di conseguenza, la pressione inizia ad aumentare, inizialmente solo durante lo sforzo fisico e lo stress mentale, quindi a riposo. Si verifica una malattia chiamata ipertensione sì.
All'inizio è asintomatico, molte persone non sospettano nemmeno di essere malate. Quindi sviluppano debolezza, avvertono dolore alla parte posteriore della testa e iniziano a preoccuparsi per il cuore. Gli attacchi improvvisi associati all'aumento della pressione sanguigna sono chiamati crisi ipertensive. Il pericolo delle crisi ipertensive è che possono portare a complicazioni. I più pericolosi sono l'infarto miocardico e l'ictus.
Un ictus è chiamato ictus cerebrale. Durante un ictus, la circolazione del sangue nel cervello viene bruscamente interrotta, una persona sviluppa un forte mal di testa, vomito, confusione, perdita della parola e della sensibilità e può manifestare paralisi.
Angina pectoris. Il nome della malattia "angina pectoris" deriva da due parole greche: "stenos" - stretto, stretto e "cardia" - cuore. La causa di questa malattia è il restringimento dei vasi coronarici, che nutrono il cuore e gli forniscono ossigeno.
L'angina può anche essere causata dalla sclerosi dei vasi cardiaci, che, diventando meno elastici, non possono cambiare rapidamente il loro lume e adattarsi ai bisogni del corpo, e da forti esperienze emotive, durante le quali gli ormoni vengono rilasciati nel sangue, restringendo i vasi del cuore. il cuore, mentre gli impulsi vengono inviati dal sistema nervoso centrale, provocando la stessa reazione.
Diverse cause di angina richiedono trattamenti diversi, sebbene i sintomi della malattia possano essere gli stessi. L'angina è caratterizzata da attacchi di forte dolore e sensazione di compressione dietro lo sterno o nella zona del cuore. Ciò accade quando al cuore affluisce meno sangue del necessario. Il dolore si irradia al braccio sinistro o sotto la scapola. Di solito gli attacchi durano diversi minuti, ma se durano più a lungo si può sospettare un attacco di cuore. Pertanto, se l'attacco continua per un lungo periodo e non può essere alleviato dalle misure di primo soccorso, è necessario chiamare un'ambulanza.
Gli attacchi di angina nei pazienti possono verificarsi mentre si cammina. Si fermano quando ti fermi tu e poi,non appena il paziente inizia a muoversi, riprendono di nuovo. In altri pazienti, gli attacchi di angina iniziano durante il sonno, spesso la sera o la mattina presto. Tali pazienti non tollerano bene la posizione orizzontale: quando si alzano, il dolore diminuisce leggermente.
Per alleviare un attacco di angina, si consiglia di somministrare al paziente una compressa di nitroglicerina o validolo. Dovrebbe mettere la medicina sotto la lingua. La compressa si dissolve e il farmaco viene assorbito nel sangue. Provoca vasodilatazione ed elimina gli spasmi. Puoi migliorare l'effetto di validol con cerotti alla senape. Sono posizionati sul lato sinistro del torace.
Crisi ipertensiva. Un improvviso aumento della pressione sanguigna, che dura solitamente 2-3 ore, è tipico di una crisi ipertensiva. In questo momento, una persona avverte una sensazione di calore, la pelle del viso diventa rossa, si osserva un aumento del battito cardiaco, compaiono dolori lancinanti nell'area del cuore, mal di testa, spesso nella regione occipitale, a volte nausea e vomito.
Il paziente deve essere seduto su una sedia, gli vengono somministrati farmaci che abbassano la pressione sanguigna e devono essere posizionati cerotti di senape sulla parte posteriore della testa e del collo. È necessario chiamare un'ambulanza. Anche il massaggio della testa e del collo aiuta.
CONCLUSIONE
Affinché il nostro sangue, che rifornisce il nostro corpo di sostanze nutritive, possa lavare, nutrire e raggiungere liberamente tutti gli organi, dobbiamo avere vasi buoni e puliti e il sangue che scorre attraverso di essi deve essere liquido e fluido. Sapendo questo, puoi vivere a lungo, evitando molti problemi e malattie. Dopotutto, come si suol dire: "avvisato è salvato!"
 LE NOSTRE NAVI AMANO:
LE NOSTRE NAVI AMANO:
1) Esercizio aerobico(cyclette, corsa, nuoto, camminata).
2) Alimentazione adeguatamente bilanciata(proteine, grassi, carboidrati, vitamine, micro e macroelementi, nonché acidi grassi polinsaturi).
3) Aria fresca.
 ALLE NOSTRE NAVI NON PIACE:
ALLE NOSTRE NAVI NON PIACE:
1) Alcol provoca vasospasmo. I vasi prima si dilatano e poi si restringono.
2) Fumare. Sotto l'influenza delle sostanze contenute nel fumo di tabacco, il cuore inizia a lavorare di più e più spesso e i vasi sanguigni si restringono: ciò porta ad un aumento persistente della pressione sanguigna. Le arterie delle gambe sono particolarmente spesso colpite nei fumatori.
3) Peso corporeo in eccesso(le placche compaiono nei vasi sanguigni) comporta:
- restringimento delle arterie da parte delle placche aterosclerotiche, causando carenza di ossigeno nei tessuti;
- aterosclerosi delle arterie cardiache, che causa ischemia e quindi infarto;
- l'aterosclerosi dell'arteria carotide (bacino cerebrale) provoca ictus.
4) Pressione alta. Un aumento persistente della pressione sanguigna è chiamato ipertensione e si verifica a causa del restringimento (spasmo) delle arteriole, piccoli vasi arteriosi. In questo caso, l'afflusso di sangue ai tessuti viene interrotto e c'è il rischio di rottura della parete del vaso. La nutrizione dell'area del tessuto corrispondente viene interrotta e può svilupparsi necrosi. Se l'emorragia si verifica, ad esempio, nel cervello o nel cuore, la morte può verificarsi rapidamente. Un'emorragia nel cervello è chiamata ictus, un'emorragia nel muscolo cardiaco che porta alla morte della sua area è chiamata infarto del miocardio.
Bassa pressione sanguigna: l'ipotensione interrompe anche l'afflusso di sangue agli organi e porta a un deterioramento del benessere.
5) Inattività fisica.(mancanza di attività fisica). Di conseguenza, non solo i muscoli del cuore e del corpo si indeboliscono, ma si verificano anche altri disturbi: le ossa diventano più sottili e il calcio in esse contenuto entra nel sangue. Si deposita sulle pareti dei vasi sanguigni, rendendoli fragili, perdendo elasticità e danneggiandosi facilmente. La parete che ha perso la sua elasticità non può espandersi se necessario e diventa più difficile mantenere la normale pressione sanguigna nei vasi.
Il sito fornisce informazioni di riferimento solo a scopo informativo. La diagnosi e il trattamento delle malattie devono essere effettuati sotto la supervisione di uno specialista. Tutti i farmaci hanno controindicazioni. È necessaria la consultazione con uno specialista!
Sistema circolatorioè una struttura piuttosto complessa. A prima vista, è associato ad una vasta rete di strade che consente la circolazione dei veicoli. Tuttavia, la struttura dei vasi sanguigni a livello microscopico è piuttosto complessa. Le funzioni di questo sistema includono non solo la funzione di trasporto, la complessa regolazione del tono dei vasi sanguigni e le proprietà della membrana interna gli consentono di partecipare a molti complessi processi di adattamento del corpo. Il sistema vascolare è riccamente innervato ed è sotto la costante influenza dei componenti del sangue e delle istruzioni provenienti dal sistema nervoso. Pertanto, per comprendere correttamente come funziona il nostro corpo, è necessario considerare questo sistema in modo più dettagliato.Alcuni fatti interessanti sul sistema circolatorio
Sapevi che la lunghezza dei vasi del sistema circolatorio è di 100mila chilometri? Che nel corso della vita attraverso l'aorta passano 175.000.000 di litri di sangue?Un fatto interessante sono i dati sulla velocità con cui il sangue si muove attraverso i vasi principali: 40 km/h.
Struttura dei vasi sanguigni
 Ci sono tre membrane principali nei vasi sanguigni:
Ci sono tre membrane principali nei vasi sanguigni: 1. Guscio interno– rappresentato da uno strato di cellule e si chiama endotelio. L'endotelio ha molte funzioni: previene la formazione di trombi, a condizione che non vi siano danni ai vasi, e garantisce il flusso sanguigno negli strati parietali. È attraverso questo strato a livello dei vasi più piccoli ( capillari) nei tessuti del corpo avviene uno scambio di liquidi, sostanze e gas.
2. Conchiglia centrale– rappresentato dal muscolo e dal tessuto connettivo. In diversi vasi, il rapporto tra muscolo e tessuto connettivo varia ampiamente. I vasi più grandi sono caratterizzati da una predominanza di tessuto connettivo ed elastico: ciò consente loro di resistere all'alta pressione creata in essi dopo ogni battito cardiaco. Allo stesso tempo, la capacità di modificare leggermente passivamente il proprio volume consente a questi vasi di superare il flusso sanguigno ondulatorio e rendere il suo movimento più fluido e uniforme.
Nei vasi più piccoli si osserva una graduale predominanza del tessuto muscolare. Il fatto è che questi vasi sono attivamente coinvolti nella regolazione della pressione sanguigna e nella ridistribuzione del flusso sanguigno, a seconda delle condizioni esterne ed interne. Il tessuto muscolare avvolge la nave e regola il diametro del suo lume.
3. Guscio esterno nave ( avventizia) – fornisce la connessione tra i vasi e i tessuti circostanti, grazie alla quale avviene la fissazione meccanica del vaso ai tessuti circostanti.
Quali tipi di vasi sanguigni esistono?
Esistono molte classificazioni delle navi. Per non stancarci di leggere queste classificazioni e per acquisire le informazioni necessarie, ci soffermeremo su alcune di esse.Secondo la natura del movimento del sangue
– I vasi si dividono in vene e arterie. Il sangue scorre attraverso le arterie dal cuore alla periferia e attraverso le vene scorre all'indietro, dai tessuti e dagli organi al cuore.
Arterie hanno una parete vascolare più massiccia, hanno uno strato muscolare pronunciato, che consente di regolare il flusso sanguigno verso determinati tessuti e organi a seconda delle esigenze del corpo.
Vienna hanno una parete vascolare abbastanza sottile, di norma nel lume delle vene di grosso calibro sono presenti valvole che impediscono il flusso inverso del sangue.
Per calibro dell'arteria
possono essere suddivisi in calibro grande, medio e piccolo  1.
Grandi arterie– aorta e vasi del secondo e terzo ordine. Questi vasi sono caratterizzati da una spessa parete vascolare: ciò impedisce la loro deformazione quando il cuore pompa il sangue ad alta pressione, allo stesso tempo, una certa conformità ed elasticità delle pareti consente di ridurre il flusso sanguigno pulsante, ridurre la turbolenza e garantire una continuità circolazione sanguigna.
1.
Grandi arterie– aorta e vasi del secondo e terzo ordine. Questi vasi sono caratterizzati da una spessa parete vascolare: ciò impedisce la loro deformazione quando il cuore pompa il sangue ad alta pressione, allo stesso tempo, una certa conformità ed elasticità delle pareti consente di ridurre il flusso sanguigno pulsante, ridurre la turbolenza e garantire una continuità circolazione sanguigna.  2.
Navi di medio calibro– prendere parte attiva nella distribuzione del flusso sanguigno. Nella struttura di questi vasi c'è uno strato muscolare abbastanza massiccio che, sotto l'influenza di molti fattori ( chimica del sangue, effetti ormonali, risposte immunitarie dell'organismo, effetti del sistema nervoso autonomo), modifica il diametro del lume del vaso durante la contrazione.
2.
Navi di medio calibro– prendere parte attiva nella distribuzione del flusso sanguigno. Nella struttura di questi vasi c'è uno strato muscolare abbastanza massiccio che, sotto l'influenza di molti fattori ( chimica del sangue, effetti ormonali, risposte immunitarie dell'organismo, effetti del sistema nervoso autonomo), modifica il diametro del lume del vaso durante la contrazione.
 3.
Le navi più piccole- queste navi, chiamate capillari. I capillari sono la rete vascolare più ramificata e più lunga. Il lume del vaso consente a malapena il passaggio di un globulo rosso: è così piccolo. Tuttavia, questo diametro del lume fornisce la massima area e durata di contatto dell'eritrocito con i tessuti circostanti. Mentre il sangue passa attraverso i capillari, i globuli rossi si allineano uno alla volta e si muovono lentamente, scambiando contemporaneamente gas con i tessuti circostanti. Lo scambio di gas e lo scambio di sostanze organiche, il flusso di liquidi e il movimento degli elettroliti avvengono attraverso la parete sottile del capillare. Pertanto, questo tipo di nave è molto importante dal punto di vista funzionale.
3.
Le navi più piccole- queste navi, chiamate capillari. I capillari sono la rete vascolare più ramificata e più lunga. Il lume del vaso consente a malapena il passaggio di un globulo rosso: è così piccolo. Tuttavia, questo diametro del lume fornisce la massima area e durata di contatto dell'eritrocito con i tessuti circostanti. Mentre il sangue passa attraverso i capillari, i globuli rossi si allineano uno alla volta e si muovono lentamente, scambiando contemporaneamente gas con i tessuti circostanti. Lo scambio di gas e lo scambio di sostanze organiche, il flusso di liquidi e il movimento degli elettroliti avvengono attraverso la parete sottile del capillare. Pertanto, questo tipo di nave è molto importante dal punto di vista funzionale.
Quindi, lo scambio di gas, il metabolismo avviene proprio a livello dei capillari, quindi questo tipo di nave non ha un centro ( muscolare) conchiglia.
Quali sono le circolazioni polmonare e sistemica?
Circolazione polmonare- Questo è, infatti, il sistema circolatorio del polmone. Il piccolo cerchio inizia con la nave più grande: il tronco polmonare. Attraverso questo vaso, il sangue scorre dal ventricolo destro al sistema circolatorio del tessuto polmonare. Successivamente, i vasi si diramano, prima nelle arterie polmonari destra e sinistra, e poi in quelle più piccole. Il sistema vascolare arterioso termina con capillari alveolari che, come una rete, avvolgono gli alveoli polmonari pieni d'aria. È a livello di questi capillari che l’anidride carbonica viene rimossa dal sangue e aggiunta alla molecola dell’emoglobina ( l'emoglobina si trova all'interno dei globuli rossi) ossigeno.Dopo l'arricchimento con ossigeno e la rimozione dell'anidride carbonica, il sangue ritorna attraverso le vene polmonari al cuore, nell'atrio sinistro.
Circolazione sistemica- questo è l'intero insieme di vasi sanguigni che non fanno parte del sistema circolatorio del polmone. Attraverso questi vasi, il sangue si sposta dal cuore ai tessuti e agli organi periferici, nonché il flusso sanguigno inverso verso il lato destro del cuore.
La circolazione sistemica inizia dall'aorta, quindi il sangue si muove attraverso i vasi dell'ordine successivo. I rami dei vasi principali dirigono il sangue agli organi interni, al cervello e agli arti. Non ha senso elencare i nomi di questi vasi, ma è importante per regolare la distribuzione del flusso sanguigno pompato dal cuore a tutti i tessuti e organi del corpo. Una volta raggiunto l'organo rifornito di sangue, si verifica una forte ramificazione dei vasi sanguigni e si verifica la formazione di una rete sanguigna di minuscoli vasi - microvascolarizzazione. A livello dei capillari si verificano processi metabolici e il sangue, che ha perso ossigeno e parte delle sostanze organiche necessarie al funzionamento degli organi, si arricchisce di sostanze formate a seguito del lavoro delle cellule dell'organo e di anidride carbonica.
Come risultato di tale lavoro continuo del cuore, della circolazione polmonare e sistemica, si verificano processi metabolici continui in tutto il corpo: avviene l'integrazione di tutti gli organi e sistemi in un unico organismo. Grazie al sistema circolatorio è possibile fornire ossigeno agli organi distanti dal polmone, rimuoverlo e neutralizzarlo ( fegato, reni) prodotti di decomposizione e anidride carbonica. Il sistema circolatorio consente agli ormoni di distribuirsi in tutto il corpo nel più breve tempo possibile e alle cellule immunitarie di raggiungere qualsiasi organo e tessuto. In medicina, il sistema circolatorio viene utilizzato come elemento principale per la distribuzione dei farmaci.
Distribuzione del flusso sanguigno nei tessuti e negli organi
 L'intensità dell'afflusso di sangue agli organi interni non è uniforme. Ciò dipende in gran parte dall’intensità e dall’intensità energetica del lavoro che svolgono. Ad esempio, la massima intensità di afflusso di sangue si osserva nel cervello, nella retina, nel muscolo cardiaco e nei reni. Gli organi con un livello medio di afflusso di sangue sono rappresentati dal fegato, dal tratto digestivo e dalla maggior parte degli organi endocrini. La bassa intensità del flusso sanguigno è inerente ai tessuti scheletrici, al tessuto connettivo e alla retina adiposa sottocutanea. Tuttavia, in determinate condizioni, l’afflusso di sangue a un particolare organo può aumentare o diminuire molte volte. Ad esempio, durante l'attività fisica regolare, il tessuto muscolare può essere rifornito di sangue più intensamente; con un'improvvisa e massiccia perdita di sangue, di norma, l'afflusso di sangue viene mantenuto solo negli organi vitali: il sistema nervoso centrale, i polmoni, il cuore ( il flusso sanguigno verso altri organi è parzialmente limitato).
L'intensità dell'afflusso di sangue agli organi interni non è uniforme. Ciò dipende in gran parte dall’intensità e dall’intensità energetica del lavoro che svolgono. Ad esempio, la massima intensità di afflusso di sangue si osserva nel cervello, nella retina, nel muscolo cardiaco e nei reni. Gli organi con un livello medio di afflusso di sangue sono rappresentati dal fegato, dal tratto digestivo e dalla maggior parte degli organi endocrini. La bassa intensità del flusso sanguigno è inerente ai tessuti scheletrici, al tessuto connettivo e alla retina adiposa sottocutanea. Tuttavia, in determinate condizioni, l’afflusso di sangue a un particolare organo può aumentare o diminuire molte volte. Ad esempio, durante l'attività fisica regolare, il tessuto muscolare può essere rifornito di sangue più intensamente; con un'improvvisa e massiccia perdita di sangue, di norma, l'afflusso di sangue viene mantenuto solo negli organi vitali: il sistema nervoso centrale, i polmoni, il cuore ( il flusso sanguigno verso altri organi è parzialmente limitato).Pertanto, è chiaro che il sistema circolatorio non è solo un sistema di autostrade vascolari - è un sistema altamente integrato che è attivamente coinvolto nella regolazione del funzionamento del corpo, svolgendo contemporaneamente molte funzioni - trasporto, sistema immunitario, termoregolazione, regolazione della velocità del flusso sanguigno nei vari organi.