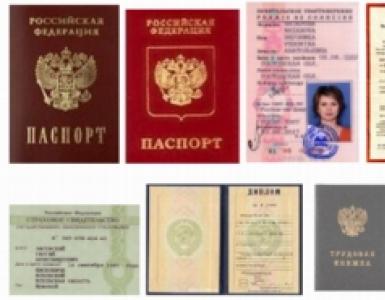Portata dell'acido cloridrico. Acidità del succo gastrico. Tipi. Unità. Ora di addebito HCI Ora di addebito
Per una valutazione più obiettiva della funzione acidogena dello stomaco, viene calcolata la produzione assoluta di acido per unità di tempo, solitamente per 1 ora (flusso-ora). A seconda dell'indicatore di acidità utilizzato nel calcolo, viene fatta una distinzione tra l'ora di produzione dell'acido cloridrico libero (la quantità di acido cloridrico libero rilasciata in 1 ora) e l'ora di produzione dell'acido cloridrico (la produzione totale di acido in 1 ora). . Si ritiene che quest'ultimo indicatore, determinato sulla base dei valori di acidità totale, rifletta più correttamente la funzione acidificante dello stomaco.
Il flusso-ora (D-H) è espresso in millimoli (o milligrammi) e calcolato con la formula: dove Y è il volume di una porzione di contenuto gastrico, ml; E - concentrazione di acido cloridrico libero o acidità totale, titolo. unità (mmol/l); 0,001 - il numero di millimoli di acido cloridrico in 1 ml di contenuto gastrico ad una concentrazione di 1 tit. unità
Per esprimere la portata (D) in milligrammi, ciascuno dei termini viene moltiplicato per il peso molecolare dell'acido cloridrico (36).
Il numero di termini nella formula è uguale al numero di porzioni di contenuto gastrico ricevute durante lo studio (nel calcolo di D-Ch, di solito ce ne sono quattro).
Il valore dell'ora di addebito dipende dalla tensione oraria di secrezione (volume del succo) e dalla quantità di acidità, quindi si dovrebbe ottenere l'estrazione più completa del contenuto gastrico (rispetto della condizione di pompaggio continuo del succo).
Per facilitare il calcolo della portata viene proposto un nomogramma. Il nomogramma si usa così: collega con un righello i numeri sui rami opposti della curva, corrispondenti al volume e all'acidità di una porzione di succo gastrico, e trova la portata all'intersezione del righello con la linea verticale.
La produzione totale di acido durante il periodo di secrezione basale è denominata BAO (produzione acida basale), con massimo - MAO (produzione acida massima), con stimolazione submassimale con istamina - SAO. Gli indicatori MAO dipendono dalla massa delle cellule parietali e quindi consentono di giudicare lo stato morfologico della mucosa gastrica.
Questo indicatore riflette il contenuto di sostanze alcaline che rimangono non legate dall'acido ed è determinato nel contenuto gastrico senza acido cloridrico libero. Il principio di determinazione si basa sull'aggiunta di acido cloridrico al contenuto gastrico fino alla comparsa di una reazione qualitativa con acido cloridrico libero.
A 5 ml di contenuto gastrico filtrato aggiungere 1 goccia di una soluzione alcolica allo 0,5% di dimetilammidoazobenzolo (in assenza di acido cloridrico libero il colore è giallo) e titolare con 0,1 N. soluzione di acido cloridrico finché non appare una colorazione rossa. La quantità di acido consumata moltiplicata per 20 corrisponde ad una carenza di acido cloridrico.
Secondo Lambling, una carenza di acido cloridrico pari o superiore a 40 ml indica una completa cessazione della secrezione di acido cloridrico (acloridria assoluta). Se la carenza è minore, viene rilasciato acido cloridrico e, combinandosi con il muco, forma la mucina acida: questa è acloridria relativa o chimica.
Esamini le porzioni ricevute di contenuti gastrici:
1. Colore: il contenuto gastrico normale è leggermente grigiastro. Se il succo gastrico che riceve è giallo, ciò indica che il paziente ha un reflusso duodeno-gastrico (reflusso del contenuto del duodeno nello stomaco); dal rosso al marrone - dalla presenza di sangue, a seconda della quantità di sangue e del grado di acidità dell'ambiente.
2. Consistenza: normalmente il contenuto gastrico è liquido, a seconda della quantità di muco: più muco, più viscoso e viscoso è il contenuto gastrico. Una grande quantità di muco può indicare la presenza di gastrite. Il muco che galleggia in superficie o si trova sotto forma di scaglie e grumi grossolani proviene dalla bocca e dal rinofaringe.
3. Odore: il contenuto gastrico normale ha un odore leggermente acido, che ricorda l'odore del pane. Un odore putrido si verifica quando le proteine marciscono (con ristagno a causa della stenosi pilorica, disintegrazione di un tumore canceroso), quando la concentrazione di acido cloridrico diminuisce a causa dei prodotti di fermentazione risultanti: acido butirrico, acetico, lattico.
4. Impurità: nel contenuto dello stomaco a stomaco vuoto si formano talvolta resti del cibo di ieri (con stenosi pilorica), che indica una violazione del suo svuotamento.
Inizia uno studio chimico sul succo gastrico - la funzione di formazione di acido dello stomaco:
In ciascuna porzione, mediante titolazione, determinare l'acido cloridrico libero (sotto forma di ioni idrogeno dissociato e cloro), l'acidità totale (la somma di tutte le valenze acide dello stomaco), l'acido cloridrico legato (situato in connessione con le molecole proteiche) e acido lattico.
Inizia quantificando il totale
acidità del succo gastrico:
La determinazione quantitativa dell'acidità totale del succo gastrico viene effettuata mediante titolazione con una soluzione di idrossido di sodio 0,1 N in presenza dell'indicatore fenolftaleina. L'acidità è espressa dal numero di ml di idrossido di sodio necessari per neutralizzare 100 ml di succo. I risultati sono registrati in unità di titolazione o mmol/l (unità SI), che sono gli stessi in termini numerici. Misurare 10 ml di succo gastrico filtrato da 1 porzione nel pallone, aggiungere 2 gocce di soluzione di fenolftaleina allo 0,5%. Versare idrossido di sodio 0,1 N in una buretta. Titolare con una soluzione di idrossido di sodio 0,4 N da una buretta fino a quando appare un colore rosa tenue che non scompare entro 1/2 - 1 minuto. Notare quanti ml di alcali sono stati utilizzati per la titolazione, poiché è necessario convertirli in 100 ml di succo; moltiplicare la quantità di alcali utilizzati per la titolazione per 10. Esempio di calcolo: se la titolazione di 10 ml di succo richiede 5 ml di idrossido di sodio 0,1 N, l'acidità totale è pari a 5X10 = 50 ml di alcali o 50 i.e. in 100 ml di succo. Pertanto, determina l'acidità totale in tutte le porzioni ricevute (da 1 a 12), annota i risultati.
Determinare la quantità di acido cloridrico libero:
La quantità di acido cloridrico libero nel succo gastrico viene misurata dalla quantità di ml di idrossido di sodio 0,1 N spesi per neutralizzare 100 ml di succo gastrico in presenza dell'indicatore dimetilamminoazobenzene. A 10 ml di succo aggiungere 2 gocce di soluzione alcolica allo 0,5% di dimetilaminoazobenzene e titolare con soluzione di idrossido di sodio 0,1 N fino alla comparsa di una colorazione arancione, che ricorda il colore del salmone (in presenza di acido cloridrico libero, il dimetilaminoazobenzene acquisisce un colore rosso ). Successivamente, è necessario ricalcolare anche i dati ottenuti per 100 ml di succo. Se per la titolazione di 10 ml di succo sono stati utilizzati 3 ml di indicatore, per 100 ml - 10 volte di più, ovvero 3 X 10 = 30 ml o 30 i.e.
Questi studi possono essere effettuati CONTEMPORANEAMENTE:
A 10 ml di succo aggiungere 2 gocce di dimetilaminoazobenzene e 2 gocce di fenolftaleina. Titolare la soluzione di soda caustica 0,1 N fino al colore salmone (1 tacca della quantità di soda caustica consumata corrisponde alla quantità acido cloridrico libero), quindi titolare fino al colore giallo limone (per determinare si utilizza la 2a tacca). acido cloridrico legato), quindi titolare finché il colore vira al rosa (la 3a tacca corrisponde a acidità totale). Moltiplichiamo anche gli indicatori risultanti per 10 (convertiti in 100 ml di succo). Si ritiene adeguata la media aritmetica compresa tra 2 e 3 punti acido cloridrico generale.
Utilizzando questo metodo, determinare l'acidità totale, l'acido cloridrico libero, legato e totale in tutte le 12 porzioni e annotare i risultati.
Nella fase della secrezione basale (prima dell'introduzione della colazione), il livello di acidità totale è normale fino a 40, cioè acido cloridrico libero - fino a 20. Dopo la stimolazione secondo Leporsky con brodo di cavolo, i valori massimi normali di l’acidità totale è 40-60, ovvero gli acidi dell’acido cloridrico libero – 20-40, ovvero dopo la stimolazione submassimale con istamina, l’acidità totale aumenta a 80-100, ovvero l’acido cloridrico libero – 60-85. Con la massima stimolazione da parte dell'istamina, l'acidità totale è 100-120, ovvero l'acido cloridrico libero è 90-110.
Se si riscontra un aumento dei livelli di acidità nel paziente esaminato (iperacidite), è necessario escludere in questo paziente un'ulcera duodenale o una duodenite. Una diminuzione (ipoaciditas) o una completa assenza di acido cloridrico libero (anaciditas) si osserva nel cancro dello stomaco, nella gastrite cronica con ridotta secrezione e nella colecistite cronica. Se hai condotto uno studio secondo Leporsky con una colazione a base di cavolo e hai ricevuto valori pari a zero di acido cloridrico libero, è necessario condurre uno studio sulla secrezione gastrica con somministrazione sottocutanea di istamina. Se, dopo la sua somministrazione, non compare acido cloridrico libero (non vi è alcuna reazione all'introduzione dell'istamina), ciò indica in modo più affidabile uno stato anaacido.
Inizia a tracciare le curve di acidità dalla concentrazione di acido cloridrico libero.
a) Selezionare la scala di costruzione: il tempo è tracciato lungo l'asse delle ascisse, ogni 5 mm dell'asse corrispondono a 15 minuti di ricerca. L'ordinata è la quantità di acido cloridrico libero in unità di titolazione, 1 mm sull'asse corrisponde al numero di unità di titolazione di acido cloridrico libero.
b) Costruisci un grafico- curva di acidità.
Valutare il tipo di acidità: in una persona sana, dopo l'introduzione di uno stimolo - una colazione di prova - si osserva un graduale aumento dell'acidità. Il suo aumento massimo si osserva al 55° minuto. Esistono diversi tipi di curva di acidità:
· tipo eccitabile, quando la concentrazione di acido cloridrico libero raggiunge rapidamente livelli elevati e diminuisce gradualmente;
· la tipologia astenica rappresenta un rapido aumento ed una altrettanto rapida diminuzione della concentrazione di acido cloridrico libero fino a 0 (picco di concentrazione a 20-30 minuti);
· tipo inerte e inibitorio: un lento aumento della concentrazione e una lenta diminuzione e la concentrazione massima di acido cloridrico libero viene significativamente ridotta oltre il tempo dello studio;
· quarto tipo di curva - l'acidità si mantiene costantemente ad un livello elevato;
· quinto tipo di curva - l'acidità rimane costantemente a un livello basso, praticamente senza alcuna reazione allo stimolo.
In una persona sana, gli indicatori dell'acido cloridrico totale e libero nel succo gastrico cambiano in parallelo. La differenza tra loro non supera 10-15, ad es. Un divario tra l'acidità totale e quella libera superiore a 15, cioè indica un aumento della quantità di acidi organici o di prodotti proteici (proteine alimentari, essudato infiammatorio, prodotti di degradazione del tumore del cancro).
Per una valutazione più obiettiva della funzione acidogena dello stomaco, calcolare flusso-ora di acido cloridrico.
Portata dell'acido cloridrico- la quantità di acido rilasciata per unità di tempo.
Ora di addebito- la quantità di acido prodotta dallo stomaco in un'ora.
Calcolare la portata di acido cloridrico in mg in ciascuna porzione utilizzando la formula:
D= (VE X 36,5) / 1000, dove
V è la quantità di succo gastrico ricevuto in un certo periodo di tempo;
E è il livello di acido cloridrico libero nello stesso tempo nelle unità di titolazione;
36,5 - peso molecolare relativo dell'acido cloridrico.
Esempio di calcolo. In 1 porzione, la quantità di succo ottenuto è di 40 ml, la quantità di acido cloridrico libero in questa porzione è 12, ovvero la portata di acido cloridrico in 1 porzione:
D= 40 X 12 X 36,5 / 1000 (mg)
Allo stesso modo, calcoliamo la portata dell'acidità totale, dove E è la quantità di acidità totale in ciascuna porzione in unità di titolazione.
Calcolare la portata di acido cloridrico e l'acidità totale in ciascuna porzione (da 1 a 12), procedere al calcolo della portata di acido cloridrico, cioè la quantità di acido libero rilasciata ogni ora nella fase di secrezione basale (prima dell'introduzione della colazione ), nella tensione oraria di fase I e nella tensione di fase 2 ore. Sommare la portata di acido cloridrico in 1 porzione con la portata di acido cloridrico in 2, 3, 4 porzioni e ottenere la portata di acido cloridrico nella fase di secrezione basale. Quindi sommare la produzione di acido cloridrico in 5, 6, 7, 8 porzioni, ottenere l'ora di produzione nella fase 1 della tensione di secrezione oraria, ecc.
Normalmente, il debito orario dell'acido cloridrico libero nella fase di secrezione basale è di 50-150 mg, nella fase di tensione oraria 50-100 mg.
Un aumento del flusso orario è tipico dell'ulcera peptica, in particolare con localizzazione dell'ulcera nel bulbo duodenale, disturbi funzionali dello stomaco con aumento della secrezione. L'ora di flusso diminuisce in caso di cancro allo stomaco e gastrite atrofica.
Negli ultimi anni è stata attribuita grande importanza pratica ai dati sull'acidità generale quando si utilizza il metodo dell'intubazione gastrica con una sonda sottile, ciò è dovuto al fatto che quando si preleva il contenuto dello stomaco dal seno (una miscela di secrezioni delle ghiandole fundiche e antrali), il livello di acido cloridrico libero non rifletterà il quadro reale dello stato di formazione dell'acido gastrico a causa del legame dell'acido cloridrico da parte della secrezione antrale. Pertanto, nella pratica clinica, viene attribuita sempre maggiore importanza alla portata calcolata sulla base dell'acidità totale.
La produzione oraria di produzione di acido durante il periodo di secrezione basale è denominata BAO (produzione di acido basale), durante la fase di tensione oraria durante la stimolazione submassimale - SAO (produzione di acido submassimale), durante la stimolazione massima - MAO (produzione di acido massimale). Gli indicatori MAO e SAO dipendono dalla massa delle cellule parietali, quindi consentono di giudicare lo stato della mucosa gastrica.
Eseguire la reazione qualitativa di Uffelmann
per l'acido lattico
A 20 gocce di una soluzione all'1% di acido fenico (fenolo), aggiungere 1-2 gocce di una soluzione al 10% di cloruro ferrico. La soluzione risultante è di colore viola (fenolato di ferro). Versare goccia a goccia il succo gastrico in una provetta con fenolato di ferro. In presenza di acido lattico il colore viola vira al giallo-verde per la formazione di ferro lattico.
I metodi di titolazione che utilizzano indicatori coloranti non consentono di determinare con precisione l'acidità del contenuto gastrico con una miscela di bile e sangue; inoltre, l'acidità nell'intervallo di pH compreso tra 3,5 e 7,0 è definita da questi metodi come anaacidità. Dati più accurati sulla reale acidità del succo gastrico vengono forniti misurando la concentrazione di ioni idrogeno liberi mediante la pHmetria intragastrica.
4,0 mmol/h significa:
A) normale secrezione di acido cloridrico libero
b) elevata secrezione di acido cloridrico libero
c) bassa secrezione di acido cloridrico libero
d) secrezione bruscamente ridotta di acido cloridrico libero
e) secrezione bruscamente aumentata di acido cloridrico libero
124. Se il sangue del paziente entra in contatto con la pelle non protetta, è necessario:
a) lavare con acqua e sapone, trattare con soluzione di alcool etilico al 70%.
B) trattarli con soluzione di alcol etilico al 70%, lavare con acqua e sapone, ripetere il trattamento con soluzione di alcol etilico al 70%
c) lavare con acqua e sapone, trattare con tintura alcolica di iodio al 5%.
125. Se la pelle intatta è contaminata dal sangue del paziente, è necessario
A) prelevare il sangue con un tampone, trattare la pelle con alcool a 70 gradi, lavare con acqua corrente e sapone, trattare nuovamente con alcool a 70 gradi
b) lavare il sangue sotto acqua corrente e sapone
c) lavare via il sangue, trattare la pelle con iodio
126. L'indicatore dei globuli bianchi (globuli bianchi) sulla macchina ematologica è:
127. L'indicatore dei globuli rossi (globuli rossi) sulla macchina ematologica è:
A) contenuto assoluto di globuli rossi
b) concentrazione di emoglobina nel sangue intero
c) conta leucocitaria assoluta
d) volume medio di un globulo rosso in micrometri cubi (μm) o femtolitri (fl)
128. L'indicatore MCV su una macchina ematologica è:
a) contenuto assoluto di eritrociti
b) concentrazione di emoglobina nel sangue intero
c) conta leucocitaria assoluta
D) volume medio di un globulo rosso in micrometri cubi (μm) o femtolitri (fl)
129. L'indicatore HGB (Hb, emoglobina) sulla macchina ematologica è questo?:
a) contenuto assoluto di eritrociti
B) concentrazione di emoglobina nel sangue intero
c) conta leucocitaria assoluta
d) volume medio di un globulo rosso in micrometri cubi (μm) o femtolitri (fl)
130. L'indicatore MCHC su una macchina ematologica è:
d) volume piastrinico medio
131. L'indicatore MCV su una macchina ematologica è:
a) conta piastrinica assoluta
b) contenuto medio di emoglobina in un singolo globulo rosso in unità assolute
d) volume piastrinico medio
e) concentrazione media di emoglobina in un eritrocito
132. L'indicatore MCH sulla macchina per ematologia è:
a) conta piastrinica assoluta
B) contenuto medio di emoglobina in un singolo globulo rosso in unità assolute
c) volume medio di un globulo rosso in micrometri cubi
d) volume piastrinico medio
e) concentrazione media di emoglobina in un eritrocito
133. L'indicatore PLT su una macchina ematologica è:
A) conta piastrinica assoluta
b) contenuto medio di emoglobina in un singolo globulo rosso in unità assolute
c) volume medio di un globulo rosso in micrometri cubi
d) volume piastrinico medio
e) concentrazione media di emoglobina in un eritrocito
134. L'indicatore MPV (volume medio delle piastrine) su una macchina ematologica è:
a) conta piastrinica assoluta
b) contenuto medio di emoglobina in un singolo globulo rosso in unità assolute
c) volume medio di un globulo rosso in micrometri cubi
D) volume piastrinico medio
e) concentrazione media di emoglobina in un eritrocito
135. L'indicatore MCV su una macchina ematologica è:
a) conta piastrinica assoluta
b) contenuto medio di emoglobina in un singolo globulo rosso in unità assolute
B) volume medio di un globulo rosso in micrometri cubi
d) volume piastrinico medio
e) concentrazione media di emoglobina in un eritrocito
136. L'indicatore PDW su una macchina ematologica è:
b) volume piastrinico medio
137. L'indicatore HCT su una macchina ematologica è:
a) ampiezza relativa della distribuzione piastrinica in volume, indicatore dell'eterogeneità piastrinica.
b) volume piastrinico medio
c) trombocrito, la proporzione (%) del volume di sangue intero occupato dalle piastrine.
D) ematocrito (norma 0,39-0,49), parte (% = l/l) del volume sanguigno totale attribuibile alle cellule del sangue.
e) concentrazione di emoglobina nel sangue intero
138. L'indicatore PCT (crito piastrinico) su una macchina ematologica è:
a) ampiezza relativa della distribuzione piastrinica in volume, indicatore dell'eterogeneità piastrinica.
b) volume piastrinico medio
C) trombocrito, la proporzione (%) del volume di sangue intero occupato dalle piastrine.
d) ematocrito (norma 0,39-0,49), parte (% = l/l) del volume sanguigno totale attribuibile alle cellule del sangue.
e) concentrazione di emoglobina nel sangue intero
139. L'indicatore della concentrazione di emoglobina nel sangue intero su un apparato ematologico è:
a) PCT (crito piastrinico)
D) HGB (Hb, emoglobina)
e) MPV (volume piastrinico medio)
140. Il volume medio delle piastrine su una macchina ematologica è:
a) PCT (crito piastrinico)
d) HGB (Hb, emoglobina)
D) MPV (volume piastrinico medio)
141. L'indicatore del contenuto assoluto dei leucociti sull'apparato ematologico è:
A) WBC (globuli bianchi)
d) HGB (Hb, emoglobina)
e) MPV (volume piastrinico medio)
142. L'indicatore del volume medio degli eritrociti su un apparato ematologico è:
a) WBC (globuli bianchi)
d) HGB (Hb, emoglobina)
e) MPV (volume piastrinico medio)
143. L'indicatore dell'ematocrito su un apparato ematologico è:
a) WBC (globuli bianchi)
d) HGB (Hb, emoglobina)
e) MPV (volume piastrinico medio)
144. Il contenuto medio di emoglobina in un singolo globulo rosso su una macchina ematologica è:
a) WBC (globuli bianchi)
145. L'indicatore della concentrazione media di emoglobina in un eritrocita su un apparato ematologico è:
a) WBC (globuli bianchi)
146. La conta piastrinica assoluta sull'apparato ematologico è:
a) WBC (globuli bianchi)
D) PLT (piastrine)
147. L'indicatore del contenuto assoluto di eritrociti sull'apparato ematologico è:
a) WBC (globuli bianchi)
B) RBC (globuli rossi)
d) PLT (piastrine)
148. Indicatori dell'indice eritrocitario:
A) (MCV, MCH, MCHC):
b) (MPV, PDW, PCT):
c)(LYM, MXD, GRAN)
149. Indicatori dell'indice dei leucociti:
a) (MCV, MCH, MCHC):
b) (MPV, PDW, PCT):
B)(LYM,MXD,GRANDE)
150. Indicatori dell'indice piastrinico:
a) (MCV, MCH, MCHC):
B) (MPV, PDW, PCT):
c)(LYM, MXD, GRAN)
151. L'indicatore RDW-SD su una macchina per ematologia è:
152. L'indicatore RDW-CV su una macchina ematologica è:
a) ampiezza relativa della distribuzione degli eritrociti in volume, deviazione standard.
B) ampiezza relativa della distribuzione degli eritrociti in volume, coefficiente di variazione
c) un indicatore non specifico della condizione patologica del corpo.
d) contenuto medio di emoglobina in un eritrocito.
153. L’indicatore ESR (ESR) è:
a) ampiezza relativa della distribuzione degli eritrociti in volume, deviazione standard.
b) larghezza relativa di distribuzione degli eritrociti in volume, coefficiente di variazione
C) un indicatore non specifico della condizione patologica del corpo.
d) contenuto medio di emoglobina in un eritrocito.
154. L'emoglobina (Hb, Hgb) in un esame del sangue è:
A) il componente principale dei globuli rossi,
b) il componente principale dei leucociti,
c) il componente principale dei linfociti,
d) il componente principale delle piastrine,
155. Su un analizzatore ematologico, il contenuto di leucociti viene misurato in:
156. Su un analizzatore ematologico, il contenuto di emoglobina è indicato in:
157. Su un analizzatore ematologico, il contenuto di eritrociti è indicato in:
In quale percentuale si formano gli elementi del sangue:
159. Volume del plasma sanguigno:
Opzione n. 5
160. Che percentuale occupa in laboratorio la fase post-analitica:
161. Quale percentuale occupa la fase post-analitica fuori dal laboratorio:
162. Quale percentuale assume la fase preanalitica fuori dal laboratorio:
163. Quale percentuale occupa la fase preanalitica in laboratorio:
164. Con quanto alcol dovresti lavarti le mani prima di prelevare il sangue:
165. Da quale estremità della falange del dito viene prelevato il sangue:
166. Profondità di puntura durante il prelievo di sangue da un dito:
167. Norma dell'emoglobina nelle donne:
a) 130-160 g/l
B) 120-140 g/l
c) 125-145 g/l
d) 160-240 g/l
e) 105-125 g/l
168. Norma dell'emoglobina negli uomini:
A) 130-160 g/l
b) 120-140 g/l
c) 125-145 g/l
d) 160-240 g/l
e) 105-125 g/l
169. L'urina acquista odore fruttato quando:
UN). pielonefrite
B). coma diabetico
V). cistite
G). Sindrome nevrotica
e) cirrosi
170. La proteinuria può accompagnare:
UN. glomerulonefrite acuta
B. glomerulonefrite cronica
V. pielonefrite acuta
D. tutto quanto sopra è vero
171. La causa della glicosuria è:
UN. mangiare zucchero in eccesso
B. ipersecrezione di tiroxina
V. situazioni stressanti
D. tutto quanto sopra è vero
d.diabete mellito
172. Nelle urine di pazienti con glomerulonefrite acuta si osserva quanto segue:
UN. poliuria significativa, relativa densità 1.030 - 1.035, glicosuria, chetonuria
B. Dolore. conteggio - nei leucociti, eritrociti. fino a 100 in p/zr, molti polimorfi epiteliali
V. significa. quantità invariata Er, Le un po', ialino. cilindri e cellule renali. epitelio
g. poliuria, isostenuria, ipostenuria, L 8-10 v/zr, er 3-4, renale. epit, unità cilindri
173. La filtrazione dell'urina è:
A. transizione del liquido da disciolto. contiene cose dal plasma sanguigno al primario. urina
B. ritorno assorbimento di acqua e soluzione dall'urina primaria nel sangue. ci sono cose dentro
V. ulteriore escrezione di una sostanza estranea dal plasma sanguigno nelle urine. per le sostanze organiche
d.formazione dell'urina finale
174. Il riassorbimento dell'urina è:
UN. transizione del fluido con sostanze disciolte in esso dal plasma sanguigno all'urina primaria
B. riassorbimento dell'acqua con sostanze disciolte dall'urina primaria nel sangue
V. formazione di urina primaria dal plasma sanguigno
d.rilascio di sostanze estranee al corpo dal plasma sanguigno nelle urine
d. i punti 1 e 3 sono corretti
175. I reni regolano:
UN. pressione sanguigna
B. composizione elettrolitica dell'ambiente interno
V. eritropoiesi
D. tutto quanto sopra è vero
176. Sulla base del campione di Zemnitsky si può giudicare:
UN. proteinuria
B. ematuria
V. leucocituria
G. capacità escretoria e di concentrazione dei reni
d.glicosuria
177. Un aumento del peso specifico dell'urina è:
UN. enuresi
B. disuria
V. isostenuria
G. iperstenuria
d. ipostenuria
178. Gli elementi del sedimento urinario organizzato non includono:
UN. leucociti, eritrociti
B. sali acidi delle urine
V. sali alcalini delle urine
D. epitelio, cilindri
D. i punti 2 e 3 sono corretti
179. Test qualitativi per il rilevamento delle proteine:
UN. test con acido solfosalicilico al 3%.
B. con acido solfosalicilico al 20%.
V. Prova dell'anello di Heller
g. Campione di Gaines
D. i punti 2 e 3 sono corretti
180. Reazioni qualitative alla rilevazione del glucosio nelle urine:
UN. Test di guadagno
B. strisce reattive diagnostiche
V. La prova della colofonia
d.Test di Fouché
D. campioni specificati ai paragrafi 2 e 3
181. L'urina ha un forte odore di ammoniaca quando:
UN. coma diabetico
B. glomerulonefrite acuta
V. mangiare cibi vegetali
D. decomposizione batterica dovuta alla prolungata conservazione al caldo
d. per la cirrosi
182. Metodo quantitativo per la determinazione del glucosio nelle urine:
UN. Metodo del cianuro di emoglobina
B. metodo enzimatico della glucosio ossidasi (FKD)
V. metodo del rosso pirogollovy
d.metodo nefelometrico
d.metodo turbidimetrico
183. Metodi per determinare la bilirubina nelle urine:
UN. Il test di Fouché
B. strisce reattive diagnostiche
V. test con acido solfosalicilico al 20%.
d.test dell'azopiram
D. campioni di cui ai paragrafi 1 e 2
184. L'ipostenuria corrisponde alla densità relativa:
UN. 1.021 - 1.037
B.1.003 - 1.004
V. 1.015 - 1.026
1.007-1.023
d.1.035 - 1.036
185. Aumenta significativamente la densità relativa delle urine al di sopra del normale:
1. bilirubina
2. urobilina
3. leucociti
4. glucosio
5. piastrine
186. L'urina del colore della “brodo di carne” si osserva quando:
UN. glomerulonefrite acuta
B. pielonefrite
V. cistite
d. Insufficienza renale cronica
D. i punti 1 e 3 sono corretti
187. Nell'ittero emolitico, colore delle urine:
A. marrone scuro (marrone arancio)
B. giallo verdastro
V. giallo paglierino
ad esempio scuro, quasi nero
d. i punti 2 e 3 sono corretti
188. Il colore rosa o rosso delle urine può indicare la presenza di:
UN. globuli rossi
B. emoglobina
V. mioglobina
D. tutto quanto sopra è vero
189. Un alto contenuto di urato conferisce al sedimento urinario il suo colore:
UN. marrone o nero
B. giallastro
V. rosato con tinta mattone
ad esempio a forma di crema con una sfumatura verdastra
190. L'isostenuria indica:
UN. infiammazione della mucosa della vescica
B. la comparsa di proteine nelle urine
V. la comparsa di glucosio nelle urine
D. disturbo del riassorbimento tubulare di acqua ed elettroliti
191. La proteinuria può essere un indicatore di danno a:
UN. glomeruli dei reni
B. tubuli renali
V. tratto urinario
D. tutto quanto sopra è vero
192. Il grado di proteinuria riflette:
UN. insufficienza renale funzionale
B. grado di danno nefronale
V. grado di compromissione del riassorbimento
D. tutto quanto sopra è vero
d. i punti 2 e 3 sono corretti
193. La proteinuria renale è causata da:
A. filtrazione e riassorbimento alterati delle proteine
B. infiammazione del parenchima epatico
V. ingestione di essudato a causa di infiammazione degli ureteri e della vescica
ad esempio calcoli renali
194. La proteinuria glomerulare può verificarsi con:
A. aumentare la permeabilità del filtro renale
B. processi infiammatori delle vie urinarie
V. disturbo del riassorbimento nei tubuli nefronali
uretrite
195. In caso di malattie renali con danno predominante ai glomeruli, si osserva quanto segue:
UN. glicosuria
B. interruzione dei processi di filtrazione
V. interruzione dei processi di riassorbimento
d.violazione del processo di secrezione
196. Per identificare la proteinuria patologica, si raccomanda di prelevare l'urina:
UN. in qualsiasi momento della giornata
B. prima bevanda mattutina
B. indennità giornaliera
d. dopo aver assunto diuretici
197. Sindrome clinica accompagnata da proteinuria renale:
UN. insufficienza cardiaca
B. cistite
B. glomerulonefrite
D. tumore della vescica
198. Test qualitativo per le proteine:
UN. con il 10% di alcali
B. con acido solfosalicilico al 3%.
B. con acido solfosalicilico al 20%.
con acido cloridrico al 20%.
199. Metodi per rilevare l'urobilina nelle urine:
UN. La prova di Firenze
B. Prova di Lang
V. Test di guadagno
D. Strisce reattive diagnostiche
Opzione n. 6
200. metodi per la rilevazione dei corpi chetonici nelle urine
UN. Prova di Lang
B. La prova di Heller
V. strisce reattive diagnostiche
d.test con acido solfosalicilico al 20%.
D. campioni di cui ai paragrafi 1 e 3
201. Se non vengono seguite le regole per la raccolta delle urine per l'analisi generale, nel sedimento appare quanto segue:
UN. cristalli di sale in grandi quantità
B. epitelio polimorfico in gran numero
B. epitelio squamoso in grandi quantità
d. epitelio renale
202. L'epitelio piatto nel sedimento in grandi quantità può indicare un'infiammazione:
UN. bacino
B. mucosa della vescica
B. genitali esterni
parenchima renale
203. Al microscopio del sedimento urinario, i cilindri ialini appaiono come:
UN. formazioni cilindriche granulari
B. strutture cilindriche ruvide con estremità rotte
B. formazioni cilindriche tenere, pallide, appena percettibili
d.formazioni cilindriche giallastre
204. I cilindri eritrocitari si formano quando:
UN. leucocituria renale
B. ematuria renale
V. calcoli nell'uretere
ad esempio calcoli alla vescica
205. Al microscopio del sedimento urinario, i cilindri cerosi appaiono come:
UN. formazioni cilindriche incolori e trasparenti
B. formazioni cilindriche giallastre e ruvide con estremità rotte
V. fili cilindrici trasparenti, un'estremità è divisa o estesa sotto forma di filo
d. formazioni cilindriche granulari
206. Con piuria grave:
UN. leucociti 10 - 30 per campo visivo.
B. leucociti 80 - 100 per campo visivo.
V. eritrociti fino a 10 per campo visivo.
ad esempio i cilindri 4 - 6 nel campo visivo.
207. Gli urati si dissolvono nel sedimento urinario:
A. riscaldamento, aggiunta di alcali
B. nel reagente al selenio
V. aggiungendo acido acetico
d. Centrifugazione e filtrazione
208. Sali presenti nell'urina alcalina:
UN. acido urico, urati
B. tripelfosfati, urato di ammonio, ossalati
V. ossalati, fosfati amorfi, urati
d. urato di ammonio, ossalati, urati
209. La piuria è:
A. la comparsa di pus nelle urine
B. la comparsa di un gran numero di globuli rossi nelle urine
V. alta concentrazione di proteine nelle urine
d. epitelio renale
210. Il volume della camera di Goryaev è pari a:
B. 0,9 µl
211. I cristalli di acetosella (ossalati) nel sedimento urinario sono presenti sotto forma di:
A. formazioni rotonde, ovali e ottaedri
B. botti marroni
V. aghi sottili trasparenti
sabbia grigiastra
212. La colorazione dei preparati preparati a partire dal sedimento urinario secondo il metodo Ziehl-Nelson viene effettuata se:
UN. tumore del rene
B. cistite
B. tubercolosi
pielonefrite
213. Il test di Nechiporenko determina:
UN. numero di elementi sagomati isolati in 1 minuto
B. funzione escretoria dei reni
B. il numero di elementi formati escreti in 1 ml di urina
d.funzione di concentrazione dell'urina
214. Indicatori normali secondo il metodo di Nechiporenko durante il conteggio nella camera di conteggio di Goryaev (in 1 ml):
UN. globuli rossi fino a 1000, leucociti fino a 4000, cilindri fino a 20
B. eritrociti fino a 1000, leucociti fino a 2000, senza cilindri
V. eritrociti fino a 2000, leucociti fino a 4000, senza cilindri
d. eritrociti fino a 4000, leucociti fino a 1000, senza cilindri
d. eritrociti fino a 4000, leucociti fino a 3000, senza cilindri
215. Nei neonati, l'emoglobina è normale:
a) 130-160 g/l
b) 120-140 g/l
c) 125-145 g/l
d) 160-240 g/l
D) 136-196 g/l
216. Norma dell'emoglobina all'età di 1 anno:
e) 5,5-6,3*/l
221. Diametro eritrocitario normale:
A) 6-8 micron
d) 12-14 micron
222. Diametro degli eritrociti nella microcitosi:
UN)< 6 мкм
b) >6 µm
V)<9 мкм
d) >12-14 µm
Diametro dei globuli rossi nella macrocitosi:
UN)< 6 мкм
b) >6 µm
B) >9 µm
d) >12-14 µm
224. Diametro degli eritrociti nella megalocitosi:
UN)< 6 мкм
b) >12 µm
V)<12 мкм
D) circa 12 micron
225. Indicatore di colore normale:
226. Ematocrito normale nelle donne:
227. Ematocrito normale negli uomini:
228. Norma dell'ematocrito per un bambino di 3 mesi:
D) 32-44%
236. Percentuale normale di eosinofili:
237. La percentuale di basofili è normale:
238. La percentuale di linfociti è normale:
239. La percentuale di monociti è normale:
240. Con quale angolazione si tiene il vetro smerigliato quando si prepara uno striscio?
Succo gastrico- la secrezione delle ghiandole tubulari situate nella mucosa gastrica. Il succo gastrico è costituito da numerosi composti organici e inorganici che aiutano nel processo di digestione.
Il materiale per lo studio è il contenuto gastrico a stomaco vuoto, con estrazione simultanea e con intubazione frazionata.
Indicatori di secrezione gastrica
| Indice | Secrezione gastrica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a stomaco vuoto | basale | dopo una colazione di prova | prova submassimale | prova massima | |
| Volume del succo gastrico,ml | 5-40 | 50-100 | 50-100 | 100-140 | 180-220 |
| Acidità totale, mmol/l | 6-8 | 40-60 | 40-60 | 80-100 | 100-120 |
| Acido cloridrico libero, mmol/l | 0 | 20-40 | 20-40 | 65-85 | 90-100 |
| Debito orario dell'acido cloridrico, mmol/l | 0 | 1,5-5,5 | 1,5-6,0 | 8-14 | 16-26 |
| Flusso orario di acido cloridrico libero, mmol/l | 0 | 1,0-4,0 | 1,0-4,5 | 6,5-12 | 16-24 |
| Ora di addebito della pepsina,mg/l | 0-21 | 10-40 | 20-40 | 50-90 | 90-160 |
Quantità di succo gastrico
Norma: 2-3 l/giorno.
Aumento della quantità di succo gastrico:
- aumento della secrezione: ulcera peptica, gastrite iperacida, sindrome di Zollinger-Ellison);
- evacuazione più lenta: spasmo persistente, stenosi pilorica, tumore allo stomaco);
- aumento dei riflessi: colecistite acuta, appendicite acuta.
Quantità ridotta di succo gastrico:
- diminuzione della secrezione;
- evacuazione accelerata, chiusura incompleta del portiere;
- assunzione di farmaci: atropina, bloccanti gangliari, insulina, diazepam.
Colore del succo gastrico
Normale: incolore.
- Verde-giallastro: impurità biliari;
- Marrone: permanenza prolungata del sangue nello stomaco;
- Sangue sotto forma di striature: lesioni alla mucosa, sanguinamento dal tratto respiratorio superiore.
L'odore del succo dello stomaco
Norma: assente.
- Odore putrido - con ristagno, stenosi, mancanza di acido cloridrico, decadimento del tumore, proteine in decomposizione.
Melma
Normale: piccola quantità.
Aumento della quantità di muco:
- gastrite, ulcera peptica;
- poliposi, cancro.
Microscopia del contenuto del succo gastrico
Tutti gli elementi riscontrati durante la microscopia sono suddivisi in:
- elementi della mucosa;
- cibo avanzato;
- microrganismi.
Il contenuto della porzione a stomaco vuoto viene sottoposto ad attenta analisi per individuare elementi di ristagno e neoplasie in essa presenti.
Succo gastrico stagnante- contiene acido lattico, formatosi a seguito dell'attività vitale delle bacchette di fermentazione dell'acido lattico o del metabolismo delle neoplasie, ed è accompagnato dalla comparsa di fibre vegetali, grasso, leucociti, eritrociti, sarcia, funghi di lievito ed epitelio.
Cellule atipiche- rilevato nella fase iniziale di crescita maligna, adenocarcinoma, neoplasie.
Leucopedesi- determinazione del numero di leucociti nel succo gastrico. Normalmente è pari a 0,2-0,3·10 9 /l e aumenta notevolmente in caso di infiammazione della mucosa gastrica.
Acidità gastrica - pH
L'acidità del contenuto gastrico viene determinata mediante test di acido cloridrico. La concentrazione di acido cloridrico al momento della formazione è indicata come acidità primaria.
Quando si studia la funzione di formazione di acido dello stomaco, viene determinata acidità totale(acidità totale di tutti i reagenti acidi contenuti nel succo gastrico), acido cloridrico libero(contenuto nello stomaco sotto forma di ioni idrogeno e cloro dissociati) e acido cloridrico legato(situati nello stomaco sotto forma di molecole indissociate e legate chimicamente alle proteine), residuo acido.
Metodi di ricerca della sonda
- Rilevamento simultaneo(viene utilizzata una sonda Kussmaul spessa) - una porzione del contenuto gastrico viene prelevata per l'analisi.
- Metodo frazionario(viene utilizzata una sottile sonda Eingorn) - il sondaggio multi-momento consente di studiare la secrezione gastrica in diverse fasi dell'attività gastrica. Per stimolare la secrezione si utilizzano le seguenti colazioni di test enterale:
- secondo Leporsky - 200 ml di succo di cavolo;
- secondo Petrova - 300 ml di brodo di cavolo al 7%;
- secondo Zimnitsky - 300 ml di brodo di carne;
- secondo Erman - 300 ml di soluzione alcolica al 5%;
- secondo Kach e Kalk - 0,5 g di caffeina per 300 ml di acqua.
- Metodo elettrometrico- test dell'acidità con una sonda sottile con elettrodi incorporati all'estremità della sonda.
Metodi di ricerca senza sonda
Utilizzato nei casi in cui il sondaggio è controindicato:
- difetti cardiaci;
- ischemia cardiaca;
- malattia ipertonica;
- aneurisma aortico;
- malattie polmonari scompensate;
- stenosi esofagea;
- gravidanza.
Test desmoide secondo Saly basato sulla capacità del succo gastrico di digerire il catgut. Il paziente ingoia un sacchetto di gomma con una tintura, che è ricoperto di catgut. L'urina del paziente viene raccolta dopo 3, 5 e 20 ore. Indica la colorazione intensa di tutte e tre le porzioni iperacido condizione; colorare la seconda e la terza porzione - o normale acidità; colorare l'ultima porzione - o ipocloridria; l'urina non è affatto colorata acloridria.
Metodo della resina a scambio ionico si basa sulla capacità degli ioni indicatori di scambiarsi nello stomaco con la stessa quantità di ioni idrogeno dell'acido cloridrico. In questo caso l'indicatore viene rilasciato dalla resina, assorbito nell'intestino ed escreto nelle urine, dove viene rilevato.
Formazione eccessiva di acido ( ipercloridria):
- localizzazione duodenale dell'ulcera;
- gastroduodenite iperacida;
- Sindrome di Zollinger-Ellison;
- l'effetto di alcune sostanze: istamina, caffeina, alcol, glucocorticoidi.
Ridotta formazione di acido ( ipocloridria):
- ulcera allo stomaco;
- gastrite ipoacida cronica;
- Sindrome di Plummer-Vinson.
Completa assenza di acido cloridrico ( acloridria):
- gastrite atrofica diffusa;
- tumori allo stomaco;
- Sindromi di Werner-Morrison, Plummer-Vinson;
- intossicazione, infezione.
Mancanza di acido cloridrico e pepsina ( ahilia):
- tumori allo stomaco;
- B 12 - anemia da carenza di folati;
- intossicazione, infezione.
Pepsina
Norma: 0-21 mg/l
Aumento della pepsina
- ulcera peptica;
- ipertiroidismo, dopo somministrazione di ACTH.
Diminuzione della pepsina
- gastrite atopica;
- malattia di Addison-Beermer;
- ipotiroidismo;
- intossicazione, infezione.
ATTENZIONE! Informazioni fornite sul sito sito webè solo per riferimento. L'amministrazione del sito non è responsabile per possibili conseguenze negative se si assumono farmaci o procedure senza prescrizione medica!
L'elemento principale del sistema di approvvigionamento idrico è la fonte di approvvigionamento idrico. Per i sistemi autonomi nelle abitazioni private, nelle dacie o nelle fattorie, come fonti vengono utilizzati pozzi o pozzi trivellati. Il principio dell'approvvigionamento idrico è semplice: la falda acquifera li riempie d'acqua, che viene fornita agli utenti tramite una pompa. Quando la pompa funziona per un lungo periodo, qualunque sia la sua potenza, non può fornire più acqua di quella che il portatore d'acqua rilascia nel tubo.
Qualsiasi fonte ha un volume limite di acqua che può fornire al consumatore per unità di tempo.
Definizioni di flusso
Dopo la perforazione, l'organizzazione che ha eseguito i lavori fornisce un rapporto di prova, ovvero un passaporto del pozzo, in cui sono inseriti tutti i parametri necessari. Tuttavia, quando si perfora per uso domestico, gli appaltatori spesso inseriscono valori approssimativi nel passaporto.
Puoi ricontrollare l'accuratezza delle informazioni o calcolare tu stesso la portata del tuo pozzo.
Dinamica, statica e altezza della colonna d'acqua
Prima di iniziare a effettuare le misurazioni, è necessario capire qual è il livello statico e dinamico dell'acqua nel pozzo, nonché l'altezza della colonna d'acqua nella colonna del pozzo. La misurazione di questi parametri è necessaria non solo per calcolare la produttività del pozzo, ma anche per selezionare correttamente l'unità di pompaggio per il sistema di approvvigionamento idrico.
- Il livello statico è l'altezza della colonna d'acqua in assenza di presa d'acqua. Dipende dalla pressione in situ e viene impostato durante i tempi di inattività (solitamente almeno un'ora);
- Livello dinamico – livello costante acqua durante l'assunzione di acqua, cioè quando l'afflusso di liquido è uguale al deflusso;
- L'altezza della colonna è la differenza tra la profondità del pozzo e il livello statico.
Dinamica e statica vengono misurate in metri dal suolo e in altezza della colonna dal fondo del pozzo
Puoi effettuare una misurazione utilizzando:
- Indicatore di livello elettrico;
- Un elettrodo che entra in contatto quando interagisce con l'acqua;
- Un peso ordinario legato ad una corda.
 Misurazione mediante elettrodo di segnalazione
Misurazione mediante elettrodo di segnalazione Determinazione delle prestazioni della pompa
Quando si calcola la portata, è necessario conoscere le prestazioni della pompa durante il pompaggio. Per fare ciò, è possibile utilizzare i seguenti metodi:
- Visualizzare i dati del misuratore di portata o del contatore;
- Leggi il passaporto della pompa e scopri le prestazioni per punto operativo;
- Calcolare la portata approssimativa in base alla pressione dell'acqua.
In quest'ultimo caso è necessario fissare un tubo di diametro inferiore in posizione orizzontale all'uscita del tubo di sollevamento dell'acqua. Ed effettuare le seguenti misurazioni:
- Lunghezza del tubo (min. 1,5 m) e suo diametro;
- Altezza da terra al centro del tubo;
- La lunghezza del getto dall'estremità del tubo al punto di impatto al suolo.

Dopo aver ricevuto i dati, è necessario confrontarli utilizzando un diagramma.
 Confronta i dati per analogia con l'esempio
Confronta i dati per analogia con l'esempio La misurazione del livello dinamico e della portata di un pozzo deve essere effettuata con una pompa di capacità non di meno il flusso d'acqua di picco stimato.
Calcolo semplificato
La portata del pozzo è il rapporto tra il prodotto dell'intensità del pompaggio dell'acqua e l'altezza della colonna d'acqua per la differenza tra i livelli dell'acqua dinamici e statici. Per determinare la portata di un pozzo si utilizza la seguente formula:
Dt = (V/(Hdin-Nst))*Hv, Dove
- Dt – portata richiesta;
- V – volume del liquido pompato;
- Hdin – livello dinamico;
- Hst – livello statico;
- Hv – altezza della colonna d'acqua.
Noi ad esempio abbiamo un pozzo profondo 60 metri; la cui statica è di 40 metri; il livello dinamico durante il funzionamento di una pompa con una capacità di 3 metri cubi all'ora è stato stabilito a circa 47 metri.
In totale la portata sarà: Dt = (3/(47-40))*20= 8,57 metri cubi/ora.
Un metodo di misurazione semplificato prevede la misurazione del livello dinamico quando la pompa funziona a una capacità; per il settore privato ciò può essere sufficiente, ma non per determinare il quadro esatto.
Portata specifica
Con un aumento delle prestazioni della pompa, il livello dinamico e, di conseguenza, la portata effettiva diminuisce. Pertanto, l'assunzione di acqua è caratterizzata più accuratamente dal coefficiente di produttività e dalla portata specifica.
Per calcolare quest'ultimo, non una, ma due misurazioni del livello dinamico dovrebbero essere effettuate a diversi tassi di assunzione di acqua.
La portata specifica di un pozzo è il volume d'acqua liberato quando il suo livello diminuisce per ogni metro.
La formula lo definisce come il rapporto tra la differenza tra i valori maggiori e minori dell'intensità dell'assunzione di acqua e la differenza tra i valori della caduta nella colonna d'acqua.
Dsp=(V2-V1)/(h2-h1), Dove
- Dsp – portata specifica
- V2 – volume di acqua pompata durante la seconda presa d'acqua
- V1 – volume primario pompato
- h2 – diminuzione del livello dell'acqua alla seconda presa d'acqua
- h1 – riduzione del livello alla prima presa d'acqua
Ritornando al nostro pozzo condizionale: con un prelievo d'acqua con un'intensità di 3 metri cubi all'ora, la differenza tra dinamica e statica era di 7 m; rimisurando con una capacità della pompa di 6 metri cubi all'ora, la differenza era di 15 m.
In totale la portata specifica sarà: Dsp = (6-3)/(15-7)= 0,375 metri cubi/ora
Portata reale
Il calcolo si basa sull'indicatore specifico e sulla distanza dalla superficie del terreno al punto più alto della zona filtrante, tenendo conto della condizione che l'unità di pompaggio non venga sommersa al di sotto. Questo calcolo è il più vicino possibile alla realtà.
DT= (HF-Hst) * Doud, Dove
- Dt – portata del pozzo;
- Hf – distanza dall'inizio della zona di filtrazione (nel nostro caso la prenderemo pari a 57 m);
- Hst – livello statico;
- Dsp – portata specifica.
In totale la portata reale sarà: Dt = (57-40)*0,375= 6,375 metri cubi/ora.
Come potete vedere, nel caso del nostro pozzo immaginario, la differenza tra le misurazioni semplificate e quelle successive è stata di quasi 2,2 metri cubi all'ora in direzione di una produttività decrescente.
Diminuzione della portata
Durante il funzionamento, la produttività del pozzo può diminuire, il motivo principale della diminuzione della portata è l'intasamento e per riportarla al livello precedente è necessario pulire i filtri.

Con il passare del tempo, le giranti di una pompa centrifuga possono usurarsi, soprattutto se il tuo pozzo è nella sabbia, in questo caso le sue prestazioni diminuiranno.
Tuttavia, la pulizia potrebbe non essere d’aiuto se inizialmente si dispone di un pozzo d’acqua a basso rendimento. Le ragioni sono diverse: il diametro del tubo di produzione è insufficiente, è caduto oltre la falda acquifera o contiene poca umidità.