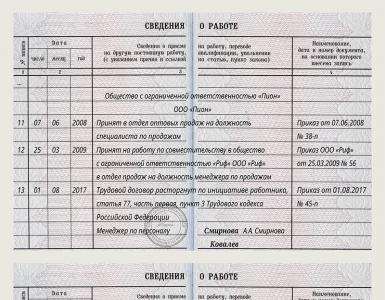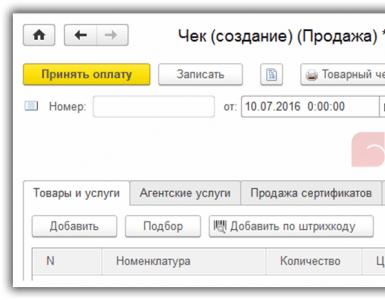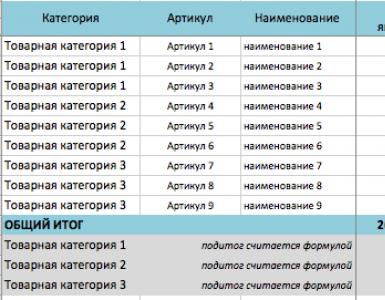Saponina - glicosidi. Cosa sono i glicosidi cardiaci, da cosa sono composti, elenco dei farmaci Saponine triterpeniche
Un gruppo speciale di glicosidi la cui caratteristica distintiva è la formazione di schiuma stabile (sapo - sapone) se miscelato con acqua. Le saponine, che hanno un elevato effetto tossico, sono spesso chiamate sapotossine.
La loro influenza si manifesta principalmente sulle cellule del sangue (emolisi), nonché in caso di grave irritazione dei tessuti e delle mucose.
In natura possono verificarsi anche combinazioni di alcaloidi e glucosio. glicoalcaloidi(ad esempio solanina di patate, ecc.).
I glicosidi che contengono oli di senape allilica durante la loro decomposizione hanno un effetto irritante particolarmente forte e questi composti hanno un effetto vescicolare sulla pelle.
Glicosidi contenenti azoto - glicosidi nitrilici,
I glicosidi nitrilici differiscono significativamente nella loro struttura dai glicosidi convenzionali.
Contengono azoto e, a seguito della scissione, si forma una quantità più o meno significativa di acido cianidrico libero (HCN). L'avvelenamento degli animali è causato da questo componente della degradazione del glicoside nitrilico. Allo stato non diviso, le molecole di tali glicosidi nitrilici non rappresentano un pericolo.
I glicosidi che rimuovono l'HCN hanno nomi diversi, ma tutti, decomponendosi sotto l'influenza degli enzimi, hanno un effetto sull'organismo adeguato alla quantità di HCN.
Toxoalbumine
Queste sostanze sono contenute in un piccolo numero di piante, ma in termini di effetto sul corpo sono molto attive. Chimicamente sono difficili da classificare. Possono essere paragonati alle proteine tossiche (albumina) solo per la reattività del corpo nei loro confronti. Il fatto è che il corpo reagisce all'introduzione di queste sostanze allo stesso modo dell'introduzione di una proteina estranea, ad es. sembrano avere proprietà immunogeniche.
Il loro significato tossicologico in medicina veterinaria è molto grande (ad esempio, avvelenamento con una pietra miliare - cicutossina, semi di ricino - ricina, corteccia di acacia bianca - pettirosso, ecc.).
Oli essenziali.
Chimicamente e fisicamente, gli oli essenziali sono sostanze molto diverse. Gli oli essenziali solidi sono spesso chiamati con il nome comune “canfora”, o “sostanze simili alla canfora”. Le piante contengono un numero enorme di oli essenziali diversi, che determinano anche l'odore specifico dell'una o dell'altra pianta.
Una caratteristica comune per loro è la scarsa solubilità in acqua, il peso specifico è inferiore all'unità (solo gli oli ossidati sono più pesanti dell'acqua). Chimicamente, questi sono i terpeni stessi o i loro derivati più vicini.
Delle piante essenziali, molte hanno un significato tossicologico (ad esempio l'assenzio, ecc.).
Altri principi attivi
Altri principi attivi comprendono gli acidi organici e le loro anidridi. L'importanza tossicologica degli acidi di questo gruppo per animali e uccelli è relativamente piccola.
Tra le piante contenenti acidi organici figurano l'acetosella (acido ossalico), l'euforbia (anidride dell'acido euforbico), ecc. Questo gruppo comprende anche sostanze attive come i lattoni (dicoumarina del meliloto, santonina dell'assenzio citvar, ecc.).
Brevi informazioni sull'origine delle sostanze tossiche nelle piante e sull'influenza delle condizioni sul loro accumulo
A seconda delle condizioni ambientali, una pianta può modificare notevolmente le sue proprietà, nonché la deposizione di alcuni composti chimici.
Anche le cosiddette erbe infestanti e le piante velenose dei pascoli e dei prati naturali variano in termini di tossicità. Inoltre, le stesse piante, a seconda del luogo di crescita, in alcuni casi sono altamente tossiche, in altri vengono utilizzate con successo come piante foraggere. Ciò vale ad esempio per gli equiseti, i cerasti, ecc.
Nelle stesse piante si verificano fluttuazioni nell'accumulo di sostanze tossiche in diverse fasi della stagione di crescita (prima e dopo la fioritura), in diverse parti delle piante e in base alle condizioni meteorologiche in determinati mesi (ad esempio, l'accumulo di acido cianidrico nel sorgo dopo il gelo).
La maggior parte delle piante, indipendentemente dal tempo di crescita, dalla posizione, ecc., conservano la loro tossicità.
GLICOSIDI (eterosidi) sono diffuse in natura, soprattutto nel mondo vegetale, sostanze nelle cui molecole residui zuccherini (residui glicosilici) sono legati tramite un atomo di ossigeno, zolfo o azoto ad una molecola di sostanza non zuccherina detta aglicone. Di conseguenza, si distinguono i glicosidi O-(I), S-(II) e N-(III). Il termine “C-glicosidi” si riferisce a composti in cui il residuo glicosilico è legato direttamente all’atomo di aglicone (IV):
G. comprende molte sostanze medicinali, comprese quelle che hanno un effetto selettivo sul muscolo cardiaco. Gli O- e N-glicosidi sono della massima importanza e distribuzione in natura.
G. sono suddivisi in piranosidi e furanosidi a seconda della presenza di un anello a sei o cinque membri nel residuo zuccherino (vedi Monosaccaridi), nonché alfa glicosidi e beta glicosidi a seconda della configurazione alfa e beta dell'atomo di C legato attraverso l'ossigeno con la parte aglicone della molecola.
O-glicosidi
Gli O-glicosidi possono essere considerati derivati degli zuccheri in cui l'atomo di idrogeno nell'idrossile emiacetale è sostituito da un radicale di un composto alifatico, carbociclico o eterociclico. Sebbene in molti O-glicosidi la parte glicone della molecola sia costituita da residui di zuccheri semplici, può anche essere costituita da residui di oligosaccaridi (di-, tri-, ecc. Saccaridi). Gli O-glicosidi presenti in natura sono per lo più beta-glicosidi. Infine, a seconda della natura della componente zuccherina, si distinguono pentosidi (O-glicosidi dei pentosi), ad esempio xilosidi (O-glicosidi dello xilosio), arabinosidi (O-glicosidi dell'arabinosio), ecc.; esosidi (O-glicosidi degli esosi), ad esempio glucosidi (derivati del glucosio), galattosidi (derivati del galattosio), fruttosidi, nonché biosidi (O-glicosidi dei bios - disaccaridi), ad esempio maltosidi, lattosidi, ecc. Essi sono costruiti in base alla tipologia dei glicosidi: oligosaccaridi (vedi) e polisaccaridi superiori (vedi).
In base alla natura dell'aglicone, gli O-glicosidi sono suddivisi in numerosi gruppi, tra cui cerebrosidi (vedi) - sfingosina galattosidi; O-glicosidi steroidei, ad esempio glicosidi cardiaci (vedi), saponine (vedi), ecc.; O-glicosidi contenenti azoto, ad esempio amigdalina, indicano; glicoalcaloidi, composti in cui la componente zuccherina è collegata mediante un legame O-glicosidico ad un residuo alcaloide (solanina, demissina), ecc.
Gli O-glicosidi possono essere ottenuti sinteticamente o isolati da fonti naturali. Pertanto, gli alchil glicosidi si ottengono facendo reagire lo zucchero con l'alcol in eccesso in presenza di acido cloridrico secco ad azione catalitica o di enzimi alfa e beta-glucosidasi. Molti O-glicosidi naturali di struttura complessa (glicosidi flavonici, glicosidi steroidei, ecc.) possono essere isolati economicamente da fonti naturali. La biosintesi degli O-glicosidi nelle piante avviene prevalentemente mediante il trasferimento di un residuo glicosilico da un nucleoside difosfato di zucchero a un fenolo o un alcol, ad esempio uridina difosfato glucosio + idrochinone -> uridina fosfato + idrochinone beta-D-glucoside (arbutina).
Gli O-glicosidi sono sostanze cristalline solide, molto spesso con una varietà di gusti specifici. La stragrande maggioranza degli O-glicosidi non viene idrolizzata dagli alcali; le uniche eccezioni sono alcuni gliconi, i cui agliconi sono fenoli, enoli e alcoli contenenti gruppi carichi negativamente nella posizione β (ad esempio CO; NO 2). Gli O-glicosidi di solito non hanno capacità riducente, ad eccezione dei cloridrati sensibili agli alcali, così come quei cloridrati i cui agliconi stessi hanno proprietà riducenti.
G. sono idrolizzati dalle sostanze e i furanosidi vengono girolizzati molte volte più velocemente dei piranosidi. La natura dell'aglicone, così come la configurazione di tutti gli atomi asimmetrici del residuo zuccherino, influenzano la velocità di idrolisi; gli alfa e beta glicosidi vengono idrolizzati da specifici enzimi - alfa e beta glucosidasi (vedi glucosidasi).
Molti O-glicosidi sono utilizzati in medicina come farmaci preziosi (vedi sotto); alcuni hanno tossicolo. prezioso (saponine, solanina) o utilizzati come vitamine (rutina - vitamina P).
S-glicosidi
Gli S-glicosidi (tioglicosidi) sono derivati delle forme cicliche degli I-tiosaccaridi, nel gruppo mercapto (-SH) l'atomo di idrogeno è sostituito da un radicale.
Gli S-glicosidi possono essere ottenuti facendo reagire gli acetati di glicosilbromuro con tiofenoli in presenza di alcali, seguita dalla saponificazione dei gruppi acetilici del derivato acetilico S-glicoside risultante. Gli S-glicosidi sono molto resistenti all'idrolisi acida, ma gli alcali forti li scompongono per formare tiosaccaridi.
Il più importante S-glicoside naturale è il G. della senape nera - sinigrina, che viene scisso dall'enzima tioglucosidasi (mirosinasi, sinigrinasi; K F 3.2.3.1) con formazione di olio di senape allilica; noto a S. 40 glicosidi S naturali legati alla sinigrina.
N-glicosidi
Gli N-Glicosidi (glicosilamine secondarie o terziarie) sono considerati derivati della glicozimina (glicosilammina primaria); si formano a seguito della sostituzione di uno o due atomi di idrogeno del gruppo amminico con residui di composti della serie alifatica o eterociclica.
Come gli O-glicosidi, gli N-glicosidi possono essere costruiti come piranosidi o furanosidi e avere una forma alfa (I) e beta (II). A differenza degli O-glicosidi, gli N-glicosidi in soluzione si possono trovare parzialmente sotto forma di forme tautomeriche acicliche (come le basi di Schiff), che sono intermedie (III):

Per la prima volta, gli N-glicosidi cristallini sono stati ottenuti dall'interazione di anilina e zuccheri; molti N-glicosidi sono ottenuti dall'interazione diretta di zucchero e ammina al freddo o quando riscaldati in un alcool, alcool-acqua o mezzo acquoso, in assenza o presenza di catalizzatori: acido acetico o cloridrico, cloruro di ammonio, ecc.
Le proprietà degli N-glicosidi dipendono in gran parte dalla natura degli agliconi. Gli alchil e aril-N-glicosidi (ad esempio purina e pirimidina-N-glicosidi) sono resistenti agli acidi e agli alcali.
Gli N-glicosidi comprendono prodotti metabolici estremamente importanti della degradazione degli acidi nucleici e delle nucleoproteine (nucleotidi e nucleosidi), alcuni dei coenzimi più importanti (vedi), acido adenosina trifosforico (vedi), uridina trifosfato, nicotinammide adenina dinucleotide, nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NAD e NADP), alcuni antibiotici, ecc.
Gli N-glicosidi dei farmaci sulfamidici sono stati sintetizzati artificialmente: "glucostreptocide", N-glucoside sulfidina, norsulfazol glucoside, che differiscono dagli agliconi originali per una solubilità molto maggiore, una minore tossicità e talvolta una natura d'azione modificata.
Gli N-glicosidi delle ammine alifatiche a catena lunga (dodecil- e ottadecilammine) vengono utilizzati nell'industria tessile.
Gli N-glicosidi di alcune ammine aromatiche sono stati proposti come antiossidanti della gomma.
C-glicosidi
I glicosidi C sono presenti in natura (bergenina, pseudouritina) e possono essere prodotti sinteticamente; Differiscono da tutti gli altri gruppi di idrolisi per la loro incapacità di idrolizzare.
Glicosidi medicinali
I glicosidi medicinali non costituiscono un unico gruppo farmacologico: il loro spettro d'azione è molto ampio, dovuto alla struttura sia della parte aglicone che della parte glicone della loro molecola. La parte glicone potenzia e accelera l'azione dell'aglicone, ne aumenta la solubilità, ne favorisce una migliore penetrazione nelle cellule del corpo, conferisce stabilità alla molecola G. e determina la corrispondente caratteristica dell'azione.
Dell'ampia classe degli O-glicosidi, i più importanti sono gli steroidi G. e principalmente i derivati del ciclopentaperidrofenantrene, che appartengono al gruppo dei glicosidi cardiaci (vedi). Altri steroidi G. sono usati per trattare l'aterosclerosi (diosponina, ecc.), Malattie delle vene (ascina, esflazide, ecc.). G. sono stati ottenuti preparati ad effetto antinfiammatorio, ormonale, neurotropico, tonico e gonadotropico (aralosidi, ABC-saporal, panaxosidi da radice di ginseng, ecc.). Tra gli O-glicosidi vale la pena notare anche i farmaci con effetti lassativi e diuretici, nonché i bioflavonoidi (vedi).
Per trattare alcune malattie vascolari vengono utilizzati G. cumarine e cromoni (esculina, kelloside).
Numerosi farmaci hanno effetti antimicrobici, antivirali e citopatici. Questi G. includono alcuni antibiotici ottenuti da Streptomyces (vedi Streptomyces) e altre fonti, amigdalina, ecc. Esistono informazioni che gli N-glicosidi sintetici, aventi ribosio e desossiribosio come parte del glicone o nella sua composizione, hanno un'azione medicinale ad ampio spettro e sono usati come stimolanti metabolici, immunosoppressori (vedi Sostanze immunosoppressori), agenti chemioterapici, ecc.
I glicosidi S e C si trovano in numerose piante (senape, montenegrina, biancospino, ecc.). Molte erbe medicinali hanno un sapore amaro, quindi le piante che le contengono (centaurea, assenzio, ecc.) vengono utilizzate come amari (vedi).
Nella maggior parte dei casi, i farmaci sono farmaci potenti e vengono utilizzati a piccole dosi.
I glicosidi in medicina legale
L'identificazione di G. è di grande importanza in caso di avvelenamento accidentale.
Molto spesso, i gas cardiaci sono i più tossici e l'intossicazione può svilupparsi anche con l'uso di dosi terapeutiche. A corte medica nello stabilire l'avvelenamento di G., le caratteristiche del cuneo e le immagini sono di grande importanza: grave debolezza, convulsioni, coma, bradicardia; disturbi della conduzione e comparsa di eccitazione dell'attività cardiaca, che può causare tachiaritmia dei ventricoli del cuore. La completa cessazione dell'attività cardiaca può verificarsi principalmente nella fase diastole. In caso di avvelenamento da G. si può osservare la disfunzione di c. N. Con. e giallo-kish. tratto, così come oliguria. Quando si esamina un cadavere non si riscontrano cambiamenti specifici negli organi; a volte si nota una certa quantità di pletora.
Per dimostrare l'avvelenamento mortale di G., i dati chimici forensi sono di grande importanza. esame del materiale cadaverico, nonché dei residui di farmaci che presumibilmente furono la causa della morte.
G. vengono escreti dal corpo umano principalmente con la bile e parzialmente con l'urina. Per la chimica forense esame di particolare importanza è l'esame della bile e della cistifellea, nonché delle aree del fegato adiacenti alla cistifellea e del tessuto dal sito di iniezione.
La conservazione di G. nel materiale cadaverico per 1 anno si ottiene mediante inscatolamento con etanolo, che dovrebbe essere effettuato immediatamente dopo il prelievo degli oggetti di ricerca.
Schema di chimica forense. definizioniG. comprende diverse fasi principali: estrazione del materiale cadaverico con etanolo al 70% a pH 7,0; precipitazione delle proteine nell'estratto; purificazione mediante estrazione con tetracloruro di carbonio; estrazione dell'oleandrina e dei lanatosidi con una miscela cloroformio-alcool 9:1 (essendo la strofantina un composto altamente idrofilo, non viene estratta in queste condizioni); purificazione della frazione estratta di oleandrina e lanatosidi dalle sostanze di accompagnamento con alcali; determinazione quali-quantitativa, ecc.; estrazione della strofantina con una miscela di alcool e cloroformio (8:2); precipitazione della strofantina dalla fase acquosa con solfato di ammonio a completa saturazione, dissoluzione del precipitato, precipitazione ripetuta ed estrazione della strofantina, seguita dalla sua determinazione qualitativa e quantitativa.
Il rilevamento qualitativo della strofantina viene effettuato con il metodo della cromatografia su carta, oleandrina e lanatosidi - con il metodo della cromatografia su strato sottile (vedi). Le macchie di strofantina si manifestano specificamente con l'acido 3,5-dinitrobenzoico, il meta-dinitrobenzene e il 2,4-dinitrodifenilsulfone; Oltre ai reagenti indicati, l'oleandrina si manifesta anche come acido solforico concentrato contenente tracce di ferro.
La determinazione quantitativa di G. negli eluati viene effettuata principalmente mediante fotocolorimetria di soluzioni colorate dopo reazione con 2,4-dinitrodifenilsulfone in un mezzo alcalino.
Lo schema di ricerca descritto consente di scoprire 30-50 μg di G. per 100 g di peso del tessuto umido.
Bibliografia: Vlasenko L. M. Sulla questione della determinazione chimica forense sistematica dei glicosidi cardiaci, nel libro: Vopr. Tribunale. med., ed. V. I. Prozorovsky, p. 233, M., 1971; WatchalB. E. e S. LutskyM. K. Glicosidi cardiaci, M., 1973; Kochetkov N.K. et al. Chimica dei carboidrati, M., 1967; Savitsky N. N. Farmacodinamica dei glicosidi cardiaci. L., 1974, bibliogr.; Stepanenko B. N. Carboidrati, Progressi nello studio della struttura e del metabolismo, M., 1968.
BN Stepanenko; Ya. I. Khadzhai (farm.), A. F. Rubtsov (sentenza).
Le saponine (saponizidi) sono un ampio gruppo di composti naturali ad alto peso molecolare di natura glicosidica che hanno attività superficiale ed emolitica (detergenti), nonché tossicità per gli animali a sangue freddo.
Il termine "saponina" o "saponizide" fu proposto per la prima volta nel 1819 da Malone per una sostanza isolata da Schreider nel 1811 dalla saponaria.
Le soluzioni acquose di saponine, quando agitate, formano una schiuma abbondante e persistente (come il sapone), per cui queste sostanze vengono chiamate saponine (dal latino. sapo- sapone).
La molecola di saponina è costituita da una parte di carboidrati e da un aglicone chiamato sapogenina. La parte carboidratica può contenere da 1 a 11 monosaccaridi. I più comuni sono il D-glucosio, il D-galattosio, l'L-ramnosio, l'L-arabinosio, il D-xilosio, l'L-fruttosio, nonché gli acidi D-glucuronico e D-galatturonico.
Classificazione delle saponine
Dipende da struttura aglicone le saponine si dividono in steroide E triterpene.
Steroide le saponine, a loro volta, si dividono in:
1. Spirostanoli(caratterizzato dalla presenza di un gruppo spiro-chetale di 8 atomi di carbonio e di un anello chiuso F);
2. Furostanoli(dove l'anello F è aperto e la catena laterale contiene glucosio).
Come risultato dell'idrolisi, i glicosidi furostanolo possono essere convertiti in glicosidi spirostanolo. A seconda dell'orientamento dell'anello F rispetto al resto della molecola aglicone, questi ultimi si dividono in spirostanoli della serie “normale” e della serie “iso”.
Il rappresentante più tipico degli agliconi steroidei è la diosgenina, contenuta nei rizomi con radici di Dioscorea nipponensis:

Diosgenina
Attualmente sono noti circa 150 glicosidi steroidei, di cui più di 100 sono spirostanoli e 40 sono furostanoli.
Gli agliconi delle saponine steroidee hanno sempre un gruppo OH in C3 e talvolta nelle posizioni C1, C2, C5 e C12. Molte saponine steroidee hanno un doppio legame in posizione 5-6. Le saponine steroidee sono 3-O-glicosidi.
Saponine triterpeniche a seconda di numero di cicli Come parte dell'aglicone, sono divisi in tetraciclici e pentaciclici.
A saponine tetracicliche includere derivati dammaran (damarandiolo), cicloartano (cicloartenolo) e lanostano:
Il sottogruppo dammaran comprende le saponine del ginseng - panaxosidi (ginsenosidi); al gruppo dei cicloartani - saponine dell'Astragalus Wooliflora - daziantosidi.
A pentaciclico comprendono saponine, derivati:
1) ursana :

-AMIN ACIDO URSOLIC
2) oleana :

-AMIN ACIDO GLICIRRETICO
(acido C-28-COOH-oleanolico)
I derivati oleani si trovano nelle radici di liquirizia, aralia, nei rizomi con radici cianotiche, ecc.
3) lupana :

LUPEOLO
Derivati del lupan - betulina, acido betulinico - isolati dalla betulla.
4) hopana e così via.:

GOPAN
Le sapogenine delle saponine triterpeniche hanno sempre un gruppo OH in C3, talvolta nelle posizioni C16, C21, C22, C24; i gruppi carbossilici possono essere a C 28, C 29 (acidi ursolico, oleanolico e glicirretinico); carbonile - a C 11. Il doppio legame si trova spesso nella posizione 12-13.
Le saponine triterpeniche possono essere neutre o acide, il carattere acido è dovuto al gruppo carbossilico nell'aglicone o alla presenza di acidi uronici nella parte carboidratica. I gruppi idrossilici possono essere acilati con acidi acetico, propionico, angelico e altri.
La parte carboidratica può essere attaccata all'aglicone tramite gruppi idrossilici o carbossilici; può essere lineare e ramificato.
Le saponine sono glicosidi privi di azoto che, se agitati in acqua, formano una schiuma stabile. Le saponine prendono il nome dal latino “sapo”, che significa sapone. Le prime saponine furono isolate nel 1819 dalla saponaria, che appartiene alla famiglia dei chiodi di garofano. La molecola della saponina, come ogni altra cosa, è costituita da una parte di carbonio: un monosaccaride e un aglicone chiamato sapogenina. Sono altamente solubili in acqua e alcool e non contengono zolfo.
Distribuzione delle saponine
.Le saponine si trovano sia nel regno vegetale che in quello animale. Le piante contengono saponine nelle radici, ad esempio cianosi, primula, dioscorea, nelle foglie di digitale e nei fiori di verbasco, allo stato disciolto nella linfa cellulare. Nel mondo animale sono ricchi di saponine le sanguisughe, le api e il serpente dagli occhiali.
Classificazione delle saponine
.Secondo la struttura chimica dell'aglicone, le saponine si dividono in steroidi e triterpeni.
Saponine steroidee.
Le saponine steroidee appartengono al gruppo dei glicosidi naturali, caratterizzati da una significativa attività emolitica. Le saponine steroidee si trovano in diverse piante, ma principalmente nelle piante delle famiglie delle leguminose, delle ranuncolacee, del giglio e delle dioscoreacee. Durante lo studio dell'effetto biologico delle saponine steroidee, sono stati rivelati significativi effetti fungicidi, antitumorali e citostatici. Abbassano la pressione sanguigna, normalizzano la frequenza cardiaca, rallentano e approfondiscono la respirazione. Il farmaco polisponina, ottenuto dalla dioscorea, viene utilizzato per i pazienti con. Le saponine steroidee sono il materiale di partenza per la sintesi degli ormoni steroidei.
Saponine triterpeniche.
La maggior parte delle saponine triterpeniche hanno un effetto emolitico. Distruggono la membrana dei globuli rossi e rilasciano emoglobina. Le saponine triterpeniche hanno un sapore amaro, irritano la mucosa della faringe, dello stomaco e dell'intestino, provocano vomito e aumentano la secrezione bronchiale. Le saponine sono prescritte per la tosse secca per fluidificare l'espettorato. Le saponine triterpeniche provenienti da piante diverse hanno effetti farmacologici diversi. Le saponine della liquirizia glabra hanno attività estrogenica, le saponine dell'eleuterococco aumentano la resistenza dell'organismo e i panaxosidi della radice di ginseng hanno un effetto adattogeno. Le saponine triterpeniche dell'acido oleico, presenti nelle radici dell'Aralia della Manciuria, sono utilizzate per alleviare lo stress, migliorare la contrazione del miocardio e sono utilizzate per le condizioni astenonevrotiche.
Le saponine triterpeniche sono ampiamente utilizzate nell'industria alimentare e leggera. La radice di liquirizia viene utilizzata per produrre birra e bevande gassate, nonché per macerare mele e mirtilli rossi e per preparare l'halva. La schiuma di saponine triterpeniche non contiene alcali ed è quindi ampiamente utilizzata per lavare indumenti che non perdono struttura e colore. L'industria tessile utilizza le saponine triterpeniche per fissare il colore e l'industria degli incendi per formare la schiuma nei prodotti antincendio.
Saponine: cosa sono?... Cercheremo di considerare questa domanda e molti dei “misteri” che ne derivano. Questo articolo aiuterà a determinare la loro classificazione, i tipi esistenti, il significato del termine, i parametri qualitativi di natura fisica e chimica, ecc.
introduzione

In base alla struttura dell'aglicone, gli alcaloidi steroidei sono suddivisi in alcaloidi spirosolano e solanidano. L'atomo di azoto in tali sostanze agisce come un frammento secondario o terziario della catena. Lo spirosolan è un analogo dello spirostano, contenente azoto. Le solanidades contengono azoto solo nel frammento indolizzante della struttura. C'è una componente carboidratica di una certa serie di glicoalcaloidi, che ha il suo nome banale.
Un altro glicoside della solanidina è l'hakonina. Il suo frammento glicosidico (β-cacotriosio) è formato da due molecole di ramnosio e un monosaccaride: glucosio.
Processo di biosintesi
Per rispondere alla domanda su cosa siano le saponine, è necessario familiarizzare con il processo della loro formazione.
La biosintesi della saponina procede secondo le istruzioni della via isoprenoide, durante la quale si formano triterpeni e steroidi. Ciò che avviene è una combinazione di tre unità di isoprene e cinque atomi di carbonio, che si combinano per formare una “testa e coda” chiamata farnesil disfosfato a 15 atomi di carbonio. Due molecole di questa sostanza si combinano per formare squalene a 30 atomi di carbonio. La sostanza risultante (squalene) inizia a ossidarsi in ossidoxvalene, che funge da punto di partenza comune per la maggior parte delle reazioni di ciclizzazione nella biosintesi dei triterpenoidi. L'ossidosqualene risultante inizia a ciclare, ma solo dopo aver subito l'apertura e la protonazione dell'anello epossidico. Alla fine si formano i carbocationi.
Il processo di neutralizzazione procede con la rimozione di un protone, durante la quale si forma una forma di doppio legame o anello di ciclopropani. Quando reagisce con H2O crea un gruppo ossidrile. La specificazione della stereochimica e la forma dello scheletro sono determinate dall'insieme delle ciclasi che partecipano alla reazione.
Effetti fisiologici

Le saponine influenzano gli organismi in un’ampia varietà di modi. Se consideriamo a livello di attività emolitica, vale la pena notare la loro capacità di creare una formazione complessa con molecole di colesterolo. Questo processo crea pori situati nella cavità del doppio strato della membrana cellulare, come all'interno dei globuli rossi. Questa struttura porta al fenomeno dell'emolisi, che si verifica quando viene iniettato nelle vene. Permette all'emoglobina di penetrare liberamente nel plasma sanguigno. È importante sapere che solo i glicozimi hanno attività emolitica, ma sono tossici per l'organismo umano o animale se iniettati direttamente nel sangue. La somministrazione orale riduce il danno delle saponine.
Le sostanze in questione sono altamente tossiche per gli animali branchiali. Le saponine interrompono le capacità funzionali delle branchie che, oltre a svolgere la funzione respiratoria, sono coinvolte nella regolazione dei processi del metabolismo del sale e nel controllo della pressione osmotica nel corpo. Le saponine causano la paralisi e la morte degli abitanti a sangue freddo dei corpi idrici. Gli agliconi non sono tossici per tali animali.
Le saponine influenzano la permeabilità delle cellule vegetali. Una certa concentrazione di essi può accelerare la germinazione dei semi, nonché la coltivazione e lo sviluppo della pianta. L'uso di alte concentrazioni può portare all'effetto opposto in relazione ai processi menzionati. Queste sostanze hanno anche un effetto irritante sugli occhi, sul naso e sulla cavità orale dell'uomo. A seconda della loro concentrazione, possono provocare un aumento dell'attività di tutte le ghiandole del corpo o provocare avvelenamenti, diarrea, vomito e nausea.
Esistono sostanze saponiniche che hanno proprietà cardiotoniche e neurotrofiche, tra le quali possiamo notare: i composti araloside, calenduloside, patrizide e clematoside. Le saponine vegetali possono avere effetti medicinali.
Modalità di funzionamento
La capacità di formare schiuma consente alle saponine di trovare il loro impiego come detergenti per estintori. Le proprietà emulsionanti consentono loro di essere utilizzati per stabilizzare un sistema disperso di un'emulsione o sospensione. Sono sempre utilizzati nella fabbricazione di vari prodotti dell'industria dolciaria e vengono utilizzati anche per preparare la birra. L'azione farmacologica delle saponine dà loro la possibilità di essere utilizzate come mezzo per: espettorazione, escrezione di urina, mantenimento del tono corporeo, come sedativo o come vaccino.

Riassumendo possiamo dire che le saponine sono sostanze il cui contenuto principale è concentrato negli organismi vegetali. Possono avere effetti sia benefici che negativi sul corpo. Può essere tossico e portare alla morte di molte creature viventi. Sono ampiamente utilizzati in medicina e sono studiati in dettaglio dal ramo biochimico della scienza.