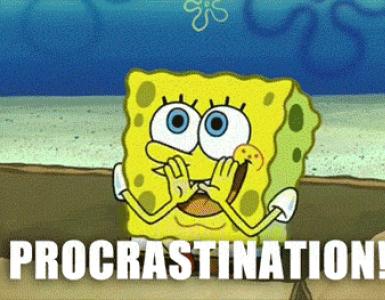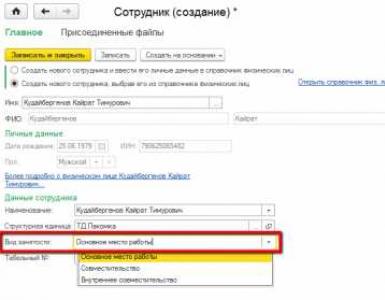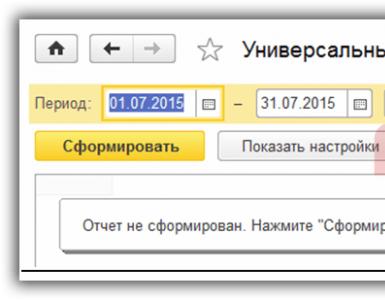Anatomia del cane: struttura corporea esterna ed interna. Struttura di un cane Struttura del diagramma del cuore di un cane
10 - gengive
11 - piega sublinguale-mascellare
22 - lingua
30 - smalto dei denti
31 - corona del dente
Il dente è costituito da dentina, smalto e cemento.
Dentina- tessuto che costituisce la base del dente.
La dentina è costituita da una matrice calcificata penetrata da tubuli dentinali contenenti processi di cellule odontoblastiche che rivestono la cavità del dente. La sostanza intercellulare contiene componenti organici (fibre di collagene) e minerali (cristalli di idrossiapatite). La dentina ha diverse zone che differiscono per microstruttura e colore.
Smalto- una sostanza che copre la dentina nella zona della corona. È costituito da cristalli di sali minerali, orientati in modo particolare a formare prismi di smalto. Lo smalto non contiene elementi cellulari e non è tessuto. Il colore normale dello smalto va dal bianco al crema con una sfumatura giallastra (distinguibile dalla placca).
Cemento- tessuto che ricopre la dentina nella zona della radice. La struttura del cemento è vicina al tessuto osseo. È costituito da cellule cementociti e cementoblasti e da una matrice calcificata. La nutrizione del cemento avviene diffusamente dal parodonto.
All'interno del dente c'è cavità, che è suddiviso in cavità coronale E canale radicolare, aprendo con quanto sopra circa apertura dell'apice del dente. Riempie la cavità dentale polpa dentale, costituito da nervi e vasi sanguigni immersi nel tessuto connettivo lasso e che fornisce il metabolismo nel dente. Distinguere coronale E polpa della radice.
Gomma- membrana mucosa che ricopre i bordi dentali delle ossa corrispondenti, strettamente fusa con il loro periostio.
La gengiva ricopre il dente nella zona del collo. È abbondantemente irrorato di sangue (tendenza al sanguinamento), ma relativamente poco innervato. La depressione scanalata situata tra il dente e il bordo libero della gengiva è chiamata solco gengivale.
Si formano il parodonto, la parete alveolare e le gengive apparato di sostegno del dente - parodonto.
Parodonto- fornisce l'attacco del dente all'alveolo dentale.
È costituito dal parodonto, dalla parete degli alveoli dentali e dalle gengive. Il parodonto svolge le seguenti funzioni: di sostegno e ammortizzante, di barriera, trofica e riflessa.
CAMBIAMENTO DEI DENTI
I denti di un cane, come quelli della maggior parte dei mammiferi, lo sono difiodonte tipo, cioè durante la vita dell'animale c'è un cambio di denti: la prima generazione - temporaneo, O denti da latte sostituiti da denti di seconda generazione - permanente. Nei cani, solo i denti P1 non cambiano; escono insieme ai denti da latte e rimangono permanenti.
Tabella Tempi di dentizione nei cani
(secondo J. Hozgood et al., 2000).
Cambiare i denti (radiografia generale)
 |
TIPI DI DENTI
I cani sono animali eterodonti, cioè hanno denti di struttura diversa a seconda delle funzioni che svolgono. Si distinguono i seguenti tipi di denti: incisivi, zanne E Denti permanenti: premolari (falsi, piccoli molari), O premolari E veramente autoctono, O molari che non hanno precursori del latte.
Denti disposti in ordine in una fila superioree arcate dentali inferiori (arcate) . L'arcata superiore è rappresentata da 20 denti e quella inferiore da 22 denti (rispettivamente 10 e 11 su ciascun lato).
Anatomia degli incisivi dell'arcata superiore
 |
Incisivi

|
Tra il margine e il canino dell'arcata superiore, così come tra il canino e il primo premolare dell'arcata inferiore, si trovano degli spazi - diastemi, che assicurano la chiusura dei canini.
I molari di ciascuna arcata aumentano di dimensioni distalmente ai denti secanti più grandi, detti anche predatore. I molari hanno una struttura diversa nell'arcata superiore e in quella inferiore, pertanto la loro struttura verrà considerata separatamente.
Premolari: 4 su ciascun lato.
P I - ha 1 (raramente 2) tubercoli coronali e 1 radice.
P 2.3 - la corona ha 3 denti: uno mediale grande e 2 distali più piccoli; il dente ha 2 radici: mediale e distale;
P 4 - la corona ha 3 tubercoli: mediale grande
sia distale che linguale minore; Ci sono 3 radici, corrispondono ai tubercoli in posizione.
Molari - 2 su ciascun lato. I loro assi longitudinali sono paralleli tra loro e perpendicolari al piano mediano.
M 1 - la corona ha 6 tubercoli: 2 grandi buccali, medio-linguali e 3 piccoli tra di loro. Il dente ha 3 radici: potente linguale
e 2 vestibolari più piccoli: mediale e distale.
M 2 - la corona ha 4-5 tubercoli: 2 vestibolari (mediale e distale) e 2-3 linguali. Ci sono 3 radici, la loro posizione è simile a quella di M 1.
 |
P 1-4 sono simili nella struttura a quelli dell'arcata superiore, ad eccezione delle radici leggermente più lunghe e più strette.
Il P 1 inferiore è talvolta indicato in letteratura come dente di lupo.
Molari- 3 su ciascun lato.
M 1 è il più grande dei molari. La corona ha 5 tubercoli: mediali, 2 distali e 2 medi tra loro: buccali potenti
e una linguale più piccola. 2 radici: mediale e distale.
M 2 - la corona ha 3-4 tubercoli: 2 mediali e 2 distali. Il dente ha 2 radici, di dimensioni identiche: mediale e distale.
M 3 è il più piccolo dei molari; la corona ha solitamente 1 o 2 cuspidi. C'è una radice, raramente due.
FORMULA DENTALE
Viene chiamata la registrazione dei denti sotto forma di serie numeriche, dove ciascun numero indica il numero di denti di un certo tipo su un lato di ciascuna arcata nella direzione dal piano mediano formula dentale.
La formula dentaria è:
denti da latte D: ICP/ICP
molari: P: IСРМ/IСРМ.
Formule per i denti di cane:
D:3130/3130
R: 3142/3143.
Quindi 28 denti da latte (qui non bisogna prendere in considerazione i primi premolari, che sono essenzialmente denti permanenti, anche se scoppiano con lo spostamento del latte) e 42 denti permanenti.
Nello studio medico odontoiatrico la formula dentaria viene scritta secondo il seguente schema: D: PCI|ICP/PCI|ICP; R: МРCI|ICРМ/ МРCI|ICРМ il numero dei denti si riflette nell'intera arcata e non solo su un lato. In questo caso, la formula dentale del cane sarà simile D: 313| 313/ 313|313; R: 2413|3142/3413|3143.
Questa forma di registrazione della formula dentaria sembra essere la più razionale. Usando questo tipo di notazione, puoi designare brevemente qualsiasi dente dell'arcata. Ad esempio, il secondo premolare permanente inferiore sinistro è designato come P|P2, il dente deciduo superiore destro come DI1|-, o OP in breve]. La voce D|Р1 è errata,
poiché nei cani non esiste il primo premolare primario.
MORSO
La chiusura delle arcate dentali si chiama occlusione, o occlusione.
Quando le mascelle del cane si chiudono, gli incisivi superiori si trovano davanti a quelli inferiori in modo tale che le superfici linguali dei primi siano in libero contatto con la superficie vestibolare (vestibolare) dei secondi, e i canini entrino liberamente nel corrispondente diastema , formando una cosiddetta serratura. Ciò avviene perché l'arcata dentale superiore è leggermente più larga di quella inferiore (arcate anisognate). Si chiama toccare i denti antagonisti.
Il morso può variare a seconda della forma e dimensione delle mascelle e dell'osso incisale, della direzione di crescita degli incisivi e dei canini, che a sua volta è determinata dalla razza, dal tipo di costituzione dell'animale, dall'età e da altri fattori.
Le opzioni di occlusione fisiologica sono:
Ortognazia o la chiusura a forbice sopra descritta. Caratteristico per i cani con costituzione gentile, forte e forte e ruvida. È normale per la maggior parte delle razze. Con questo tipo di morso, l'usura degli incisivi avviene più lentamente.
Se gli incisivi inferiori si trovano dietro quelli superiori, ma sono separati da essi ad una certa distanza, si chiama tale morso prognato.
In questo caso la superficie mesiale dei canini superiori e la superficie distale dei canini inferiori si consumano a causa dell'attrito.
Un tale morso può essere causato da anomalie nello sviluppo osseo (mascella superiore allungata e/o mascella inferiore accorciata - microgenia) o nella crescita dei denti. È più comune nei cani di razza dolicocefalica con muso affilato. Si trova nei cuccioli con una testa massiccia negli zigomi e un'ampia mascella inferiore tra i rami. Di norma, con il completamento della formazione dello scheletro, il morso in tali cuccioli viene ripristinato a forbice o morso dritto.
Per i cani adulti della maggior parte delle razze è considerato un difetto, poiché complica notevolmente l’alimentazione e riduce le prestazioni dell’animale. Inoltre, con il morso, le zanne della mascella inferiore non formano una serratura, ma feriscono il palato.
Progenie O merenda- Gli incisivi inferiori si trovano davanti a quelli superiori. Un significativo accorciamento delle ossa della regione facciale con una mascella inferiore normale o allungata provoca l'avanzamento non solo degli incisivi inferiori, ma anche dei canini: un morso di bulldog. È standard per razze come bulldog inglesi e francesi, carlini, boxer e alcuni altri, a condizione che gli incisivi e i canini della mascella inferiore non sporgano oltre il labbro superiore.
Morso dritto (a forma di tenaglia)- gli incisivi toccano i bordi.
Questo morso è tipico dei cani di costituzione sciolta grossolana e grossolana con una mascella inferiore massiccia. Per alcune razze, il morso diretto è consentito dallo standard incondizionatamente o a partire da una certa età. Ad esempio, lo standard FCI-335 per la razza del cane da pastore dell'Asia centrale (entrato in vigore il 22 marzo 2000) afferma: "morso a forbice, prognatismo dritto o stretto (senza sprechi), indipendentemente dall'età". Con un morso dritto, gli incisivi si digrignano più rapidamente.
La graduale erosione dello smalto e della dentina con l'età è un processo fisiologico. Con una corretta occlusione e stress fisiologico si verificano adeguati cambiamenti compensatori nell'organo dentale, garantendo il pieno funzionamento dei denti usurati.
DATE PER L'ABRASIONE DEI DENTI
I tempi di usura della corona nei cani, come in altri animali, dipendono da molti fattori. Questi includono, prima di tutto, il morso. Come accennato in precedenza, con il morso a forbice, il digrignamento degli incisivi e dei canini avviene molto più lentamente rispetto al morso dritto (a tenaglia) e ad altre opzioni di morso.
Non dobbiamo dimenticare che oltre alle tipologie descritte esiste una grande varietà di forme patologiche di occlusione, in cui il digrignamento dei singoli denti avviene in modo inappropriato rispetto all'età.
Inoltre, l'intensità dell'abrasione della corona è determinata dalle condizioni di alimentazione, quali: consistenza del cibo (cibo secco o umido); la profondità del piatto da cui il cane prende il cibo e il materiale di cui è composto (il cane ha la capacità di catturare fisiologicamente il cibo e di non ferirsi i denti). L'abitudine di alcuni cani di masticare e trasportare oggetti duri influisce notevolmente sul tempo necessario affinché gli incisivi e gli altri denti si consumino.
Di particolare importanza per l'abrasione dei denti sono le caratteristiche individuali della microstruttura e della composizione chimica dello smalto e della dentina. Tali deviazioni possono essere congenite (fattore ereditario, uso di farmaci teratogeni nelle cagne gravide, gravi disturbi alimentari e malattie durante la gravidanza) o acquisite (malattie e altre malattie infettive durante il periodo del cambio dei denti, assunzione di farmaci tetraciclinici negli animali giovani, eccesso di fluoro nel corpo (fluorosi dentale), l'uso di prodotti chimici aggressivi (acidi minerali) per il trattamento del cavo orale, ecc.
Tenendo conto dei fattori di cui sopra, diventa ovvio che è impossibile stabilire una stretta relazione tra il grado di abrasione dei singoli denti e l'età dell'animale. L'eccezione sono gli animali di età inferiore a 10-12 mesi, in cui l'ordine di eruzione dei denti permanenti è abbastanza stabile, e dopo il suo completamento (6-7 mesi) fino a 10-12 mesi, le corone dei denti permanenti finalmente si muovono nella cavità orale.
Oltre 1 anno, la correlazione tra cancellazione e età è molto condizionale.
 |
Cancellazione dei trilobi degli incisivi inferiori (2,5 anni)
Di seguito sono riportati i tempi approssimativi dei cambiamenti nell'apparato dentale nei cani.
I quadrifogli iniziano a svanire intorno ai 2 anni di età. Innanzitutto, vengono macinati sugli incisivi inferiori, di 3 anni - sui ganci superiori, di 4 anni - su quelli centrali e di 5-6 anni, i trifogli, di regola, sono assenti su tutti gli incisivi, ad eccezione di i bordi superiori.
Dai 5-6 ai 10-12 anni gli incisivi inferiori si muovono in avanti con intensità variabile (gli uncini inferiori sono solitamente i primi ad avanzare), i canini e i grossi tubercoli dei molari si consumano.
Nei cani di età superiore ai 10-12 anni, le corone delle dita inferiori sono solitamente quasi completamente consumate. Le corone degli altri denti vengono levigate in modo leggermente uniforme. Se l'animale non soffre di malattia parodontale (cosa rara nei cani da compagnia), la perdita naturale dei denti inizia all'età di 14-17 anni.
Si noti che con la parodontite e la malattia parodontale, la perdita completa dei denti può verificarsi all'età di 8-10 anni.
Un criterio più affidabile per determinare l'età di un cane è la dimensione relativa della cavità dentale. Con l'età si osserva una graduale diminuzione della cavità del dente fino alla sua completa obliterazione nei cani anziani. Questo parametro non è praticamente influenzato da fattori esterni e interni e può costituire la base per lo sviluppo di un metodo per determinare l'età.
Per determinare la dimensione della cavità del dente, è necessario eseguire una radiografia. Utilizzando questa tecnica sarà possibile determinare l'età da una radiografia o da un taglio, avendo a disposizione un solo dente.
DIGESTIONE MECCANICA
La digestione nella cavità orale avviene principalmente meccanicamente; durante la masticazione, grandi frammenti di cibo vengono frantumati e mescolati con la saliva. La masticazione è particolarmente importante per l’assorbimento degli ingredienti di origine vegetale, poiché i nutrienti sono spesso racchiusi in membrane contenenti cellulosa resistenti alla digestione. Queste membrane devono essere distrutte prima che i nutrienti al loro interno possano essere utilizzati.
La digestione meccanica aumenta anche l'area esposta agli enzimi digestivi.
PIEDE DELLA CAVITÀ ORALE
STRUTTURA
Il pavimento della cavità orale è ricoperto da una membrana mucosa, situata sotto la superficie libera della lingua e ai lati del suo corpo, è uno spazio a fessura sotto la mucosa sublinguale. Sagittalmente il pavimento della bocca è diviso da una piega del frenulo della lingua.
Ai lati del corpo della lingua, la mucosa del fondo con uno spesso strato sottomucoso forma delle pieghe in cui si aprono più condotti corti ghiandola salivare sublinguale. Lateralmente al frenulo della lingua si trovano piccole verruche sublinguali (della fame). Sono le aperture dei dotti escretori mandibolare
e lungo condotto sublinguale ghiandole salivari.
GHIANDOLE SALIVARI
1 - ghiandola parotide
2 - ghiandola mandibolare
3 - ghiandola sublinguale
7 - ghiandola zigomatica
Ghiandola salivare mascellare (mandibolare). situato dietro il ramo della mascella inferiore, ventrale alla ghiandola salivare parotide, raggiunge il collo, dove si trova tra le vene mascellari.
È grande, di forma ovale, di colore giallo-ceroso e più grande della ghiandola parotide. I suoi dotti escretori seguono nello spazio intermascellare sopra il muscolo premascellare medialmente dalla ghiandola salivare sublinguale nelle verruche affamate. La ghiandola secerne una secrezione mucosa sierosa.
Ghiandola salivare parotide si trova ventrale rispetto al padiglione auricolare, di dimensioni relativamente piccole. Il dotto escretore attraversa il muscolo masticatorio e si apre nel vestibolo buccale con una papilla salivare bassa.
Ghiandola salivare sublinguale si trova sotto la mucosa ai lati del corpo della lingua. Diviso in multicanale, che si apre in un gran numero di condotti sulla superficie laterale della piega sublinguale, e condotto singolo- un condotto - in una verruca affamata. Produce una secrezione mucosa.
DIGESTIONE ENZIMATICA
La saliva viene secreta nella cavità orale da quattro paia di ghiandole salivari.
In genere, in bocca è presente una piccola quantità di saliva, ma la quantità può essere aumentata dalla vista e dall'odore del cibo. Questo effetto, chiamato "reazione del gusto", fu studiato per la prima volta dall'accademico I.P. Pavlov.
La salivazione continua man mano che il cibo entra nella cavità orale e il suo effetto è potenziato dal processo di masticazione.
La saliva è composta per il 99% da acqua, mentre il restante 1% è costituito da muco, sali inorganici ed enzimi.
Il muco agisce come un lubrificante efficace e favorisce la deglutizione, soprattutto del cibo secco. A differenza degli esseri umani, la saliva di cani e gatti è priva dell'enzima amilasi che digerisce l'amido, che impedisce la rapida idrolisi dell'amido nella cavità orale.
L'assenza di questo enzima è coerente con il comportamento osservato dei cani, che tendono a deglutire senza masticare tutto tranne i pezzi di cibo più duri, e con il comportamento dei gatti, caratteristico dei carnivori, che tendono a consumare cibi a basso contenuto di amido.
LINGUA
Lingua- un organo muscolare e mobile che si trova sul fondo della cavità orale.
Struttura del linguaggio
Le papille della mucosa della lingua svolgono la funzione di analizzatore del gusto, la sua superficie fornisce la termoregolazione del corpo del cane e svolge anche la funzione del tatto.
Curvandosi come un cucchiaio, la lingua serve a ricevere l'acqua.
In termini di forma esterna, la lingua dei cani è lunga, larga e sottile. Lo scheletro della lingua costituisce la superficie interna della mascella inferiore, così come l'osso ioide.
Struttura del linguaggio
 |
2 - muscoli della lingua
3 - corpo della lingua
4 - radice della lingua
Nella lingua ci sono: radice, corpo E superiore.
Radice La lingua si trova tra i molari ed è ricoperta dalla mucosa dell'arco palatoglosso.
Corpo La lingua si trova tra i rami della mascella inferiore, su di essa si distinguono le superfici posteriore e laterale. Ci sono molte papille sul retro. Il dorso della lingua è concavo e diviso da un profondo solco sagittale che si estende fino all'apice della lingua. Ai lati del dorso, le superfici laterali del corpo della lingua convergono nel suo frenulo.
punta della lingua- la sua parte più mobile, espansa e appiattita, presenta la superficie ventrale libera dal frenulo. La superficie dorsale dell'apice è notevolmente più larga del dorso.
Nello spessore dell’apice della lingua si trova una specifica cartilagine intralinguale (un residuo dell’osso intralinguale), che sostiene la lingua sporgente del cane e aiuta l’assunzione di cibo liquido.
PAPIPI DELLA LINGUA
Le papille della lingua sono divise in meccanico E gusto.
Meccanico:
1. Filiforme
Ricopre l'intera superficie dorsale della lingua, lunga, sottile
e morbido.
2. Conico
Situato nella zona della radice della lingua anziché filamentosa.
Aromatizzazione(contengono recettori nervosi del gusto - papille gustative):
1. Fungo
Sparsi su tutta la superficie del dorso della lingua tra quelli filiformi.
2. A forma di rotolo (scanalato).
Si trovano sul bordo del corpo e sulla radice della lingua in 2-3 paia. Sono grandi, di forma rotonda, con una scanalatura attorno a ciascuno di essi. In quest'ultimo si aprono le ghiandole mucose.
3. A forma di foglia
Si trovano ai lati della radice della lingua davanti agli archi del palatoglosso. Di forma ovale, lunga 0,5 - 1,5 cm, divisa in segmenti - "foglie". Contiene ghiandole sierose-mucose.
GHIANDOLE DELLA LINGUA
Le ghiandole della lingua sono parietali, sono sparse su tutta la superficie e sui bordi della lingua, si trovano in profondità nella mucosa e secernono una secrezione mucosa.
MUSCOLI DELLA LINGUA
La lingua è basata su tessuto muscolare striato. Le sue fibre muscolari sono orientate in tre direzioni reciprocamente perpendicolari: longitudinale (davanti a dietro), trasversale (da destra a sinistra) e obliqua (dall'alto in basso) e formano muscoli differenziati, che si dividono nei muscoli della lingua e dell'osso ioide.
La base della lingua è muscolo linguale. È costituito da fibre muscolari verticali, oblique e longitudinali che vanno dall'osso ioide alla punta della lingua.
Funzione: cambia la forma (spessore, lunghezza, larghezza) della lingua in diverse direzioni.
Muscolo laterale linguale. Inizia dalla superficie laterale del segmento medio dell'osso ioide e segue la superficie laterale della lingua fino al suo apice.
Funzione: con azione bilaterale tira indietro la lingua, con unilaterale: lo gira nella direzione corrispondente.
Sublinguale - muscolo linguale. Inizia sul corpo e sulle corna laringee dell'osso ioide, termina nello spessore della lingua medialmente dal muscolo linguale laterale, lateralmente dal genioglosso.
Funzione: tira indietro la lingua, appiattisce la radice della lingua durante la deglutizione.
Muscolo genioglosso. Inizia sull'angolo mentale della mascella inferiore e si ramifica a forma di ventaglio nel piano mediosagittale dall'apice al centro del corpo della lingua.
Funzione: appiattisce la lingua, la sposta in avanti.
MUSCOLI DELL'IPOGLOO
Il muscolo genioioideo è fusiforme e corre dal mento della mascella inferiore all'osso ioide.
Funzione: tira in avanti l'osso ioide e con esso la lingua. Fornisce la massima estensione della lingua quando si lappa o si lecca.
Muscolo premascellare trasverso (ioide). Si estende dall'angolo mentale della mascella inferiore, lungo il bordo dentale lungo la linea del suo attacco muscolare alla sutura del tendine dello spazio sottomandibolare e termina sul corpo e sui grandi corni dell'osso ioide.
Funzione: solleva la lingua durante la masticazione. Si spinge indietro al palato duro.
Muscolo stiloioideo: origina dai corni maggiori e minori dell'osso ioide.
Funzione: unisce i rami durante la deglutizione.
Muscolo cornoioideo: segue dalle corna laringee dell'osso ioide fino alle sue corna minori.
Funzione: richiama i rami con nome.
Muscoli retrattori ioide: i muscoli sternoioideo e sternotiroideo ritraggono l'osso ioide durante la deglutizione.
2. Faringe (Faringe)
Gola - faringe - un organo mobile a forma di tubo in cui il tratto digestivo attraversa, attraversando la faringe, dalla cavità orale alla faringe e oltre all'esofago e alle vie respiratorie - attraverso le coane alla faringe e oltre alla laringe.
1 - esofago
2 - gola
4 - trachea
5 - laringe
6 – epiglottide
STRUTTURA
La cavità faringea è divisa in due parti diverse: quella superiore - respiratoria - rinofaringe e quella inferiore - digestiva - (laringe), che sono limitate l'una dall'altra dall'arco velofaringeo. Gli archi velofaringei convergono prima dell'inizio dell'esofago, formando il confine esofagofaringeo.
La parte respiratoria della faringe, situata sotto la base del cranio, funge da continuazione della cavità nasale dietro le coane. È rivestito da epitelio ciliato colonnare monostrato, mentre la parte digestiva è rivestita da epitelio squamoso stratificato. Le aperture faringee delle trombe uditive (di Eustachio) si aprono nelle parti laterali del rinofaringe, che collegano il rinofaringe con la cavità timpanica dell'orecchio medio (la faringite può provocare l'otite media).
La sezione anteriore della parte digestiva della faringe confina con la faringe, dalla quale è separata dal velo palatino e, quindi, funge da continuazione della cavità orale, ed è quindi chiamata cavità orale. Nella parte posteriore confina con la superficie anteriore dell'epiglottide. Quindi, situata sopra la laringe, la faringe prosegue fino all'ingresso
nell'esofago. Questa parte della sezione digestiva della faringe è chiamata parte laringea, poiché l'ingresso della laringe si apre dal basso. Quindi la faringe ha 7 fori.
Sulla parete dorsale della faringe nella zona del fornice si trova la tonsilla faringea.
La faringe si trova tra i segmenti medi dell'osso ioide, coprono l'organo dai lati e i segmenti superiori (prossimali) dell'osso ioide lo sospendono dalla parte mastoidea dell'osso petroso.
La contrazione dei muscoli faringei è alla base del complesso atto della deglutizione, che coinvolge anche il palato molle, la lingua, la laringe e l'esofago.
Radiografia: controllo radiografico
esecuzione di un'endoscopia dell'area della faringe

Allo stesso tempo, gli elevatori faringei lo spingono verso l'alto e i compressori restringono costantemente la sua cavità all'indietro, spingendo il bolo alimentare nell'esofago. Allo stesso tempo, anche la laringe si alza, il suo ingresso è strettamente coperto dall'epiglottide, a causa della pressione su di essa con la radice della lingua. In questo caso, i muscoli del palato molle lo tirano verso l'alto e caudalmente in modo tale che il velo palatino si appoggi sugli archi velofaringei, separando il rinofaringe.
Durante la respirazione, il velo palatino accorciato pende obliquamente verso il basso, coprendo la faringe, mentre l'epiglottide, costituita da cartilagine elastica, diretta verso l'alto e in avanti, fornisce l'accesso a un flusso d'aria nella laringe.
L'esterno della faringe è ricoperto da avventizia di tessuto connettivo.
È attaccato alla base del cranio attraverso la fascia faringea basilare.
La base della faringe è costituita da tre paia di costrittori (restringenti) e un dilatatore (dilatatore). Questi muscoli accoppiati formano una sutura del tendine sagittale medio sulla parete superiore dell'organo, che si estende dall'arco velofaringeo all'esofago.
1. Costrittore craniale (rostrale) della faringe - costituito da muscoli accoppiati: velofaringeo e pterigofaringeo.
Il muscolo velofaringeo costituisce le pareti laterali della parte craniale della faringe, così come l'arco velofaringeo, inizia dalle ossa palatina e pterigoideo e termina alla sutura tendinea faringea.
Funzione: avvicina la bocca dell'esofago alla radice della lingua.
Il muscolo pterigofaringeo inizia tendinosamente sull'osso pterigoideo e termina nella parte caudale della faringe. Si fonde con il muscolo velofaringeo.
Funzione: tira in avanti la parete faringea.
La funzione principale del costrittore faringeo anteriore è quella di bloccare l'ingressonel rinofaringe e l'espansione dell'esofago.
2. Il costrittore medio della faringe (muscolo ipoglosso) è formato da: i muscoli cartilaginei e orofaringei (appartengono al gruppo dei muscoli dell'osso ioide) - segue dalle corna laringee dell'osso ioide alla sutura del tendine dell'osso ioide faringe.
Funzione: spinge il bolo alimentare verso l'esofago.
3. Il costrittore caudale della faringe è formato: dal muscolo tirofaringeo, che va dalla cartilagine tiroidea della laringe alla sutura tendinea, e dal muscolo anulare faringeo, che va dalla cartilagine anulare alla sutura faringea.
Funzione: spinge il bolo alimentare verso l'esofago.
Dilatatore faringeo: segue dalla superficie mediale del segmento medio dell'osso ioide sotto i costrittori medio e caudale fino alla superficie laterale della faringe.
Funzione: espande la parte posteriore della faringe dopo la deglutizione, restringe il rinofaringe.
3. Esofago (esofago)
Esofago- è la parte iniziale dell'intestino
e nella struttura è un tipico organo a forma di tubo. È una continuazione diretta della parte laringea della faringe.
Viene raccolta la mucosa dell'esofago per tutta la sua lunghezza
in pieghe longitudinali, che si raddrizzano al passaggio del bolo alimentare. Lo strato sottomucoso contiene numerose ghiandole mucose che migliorano lo scorrimento del cibo. Il rivestimento muscolare dell'esofago è un complesso strato striato a più livelli.
STRUTTURA
La membrana esterna delle parti cervicale e toracica dell'esofago è l'avventizia del tessuto connettivo e la parte addominale è ricoperta dal peritoneo viscerale. I punti di attacco degli strati muscolari sono: lateralmente - le cartilagini aritenoidi della laringe, ventralmente - la sua cartilagine anulare e dorsalmente - la sutura del tendine della laringe.
Rappresentazione schematica dell'esofago

Lungo il percorso, il diametro dell'esofago non è uniforme: presenta 2 espansioni e 2 restringimenti. Nei cani di media taglia, il diametro all'ingresso è fino a 4 cm e all'uscita fino a 6 cm Ci sono parti cervicali, toraciche e addominali dell'esofago.
La lunghezza totale dell'esofago è in media di 60 cm e il diametro medio dell'esofago collassato è di circa 2 cm Topograficamente l'esofago è diviso in parti cervicale, toracica e addominale. La parte cervicale è lunga e costituisce circa la metà della lunghezza dell'esofago. Direttamente dietro la faringe, si trova sopra i semianelli della trachea
e sotto lo strato prevertebrale della fascia del collo (piastra di superficie).
Quindi, a livello di 4-6 vertebre cervicali, l'esofago fa una curva, scendendo verso il lato sinistro della trachea, e segue l'ingresso nella cavità toracica. Questa caratteristica della topografia consente di evitare la tensione sull'organo nella parte toracica durante i movimenti della testa e del collo, allo stesso tempo, dovrebbe essere presa in considerazione durante le manipolazioni mediche sull'organo.
Nella cavità toracica nel mediastino, l'esofago accompagna la trachea a sinistra, e poi nella regione della sua biforcazione (biforcazione) si trova nuovamente sulla trachea. La parte toracica dell'esofago passa prima sopra la base del cuore a destra dell'arco aortico, poi attraverso l'apertura esofagea del diaframma, situata a livello del terzo spazio intercostale, leggermente a sinistra. Dietro il diaframma, nella cavità addominale, la breve parte addominale dell'esofago forma l'ingresso allo stomaco o apertura cardiaca (cardias).
FUNZIONI
Non vi è secrezione di enzimi digestivi nell'esofago, tuttavia, le cellule epiteliali della mucosa esofagea secernono muco, che serve a lubrificare il bolo alimentare durante il processo di peristalsi, contrazioni muscolari automatiche a forma di onda che vengono stimolate dalla presenza di cibo nell'esofago e ne assicurano il movimento attraverso il canale digestivo. Il processo di spostamento del cibo dalla bocca allo stomaco richiede solo pochi secondi.
4. Stomaco (ventricolo)
Lo stomaco del cane è a camera singola, di tipo intestinale. È un'estensione del tubo digestivo dietro il diaframma.
Aspetto di uno stomaco isolato

1 - parte pilorica dello stomaco
2 - parte cardiaca dello stomaco
3 - parte fundica dello stomaco
4 - uscita del duodeno
5 - apertura cardiaca (ingresso dell'esofago)
Viene comunemente chiamata la flessura ventrale esterna dello stomaco grande curvatura, e la piccola curva dorsale tra l'ingresso e l'uscita dallo stomaco è piccola curvatura. La superficie anteriore dello stomaco compresa tra la curvatura minore e quella maggiore è rivolta verso il diaframma ed è chiamata diaframmatica, mentre la superficie posteriore opposta è chiamata viscerale. Si affaccia sulle anse intestinali.
Dal lato della grande curvatura, il grande omento è attaccato allo stomaco - mesentere gastrico. È molto esteso, ricopre come un grembiule tutto l'intestino fino all'ipogastrio e forma una sacca omentale. Sulla superficie sinistra della grande curvatura, nella piega del sacco omentale, la milza è adiacente allo stomaco.
È collegato alla maggiore curvatura dello stomaco legamento gastrosplenico, in cui si trovano numerose navi. Questo legamento è una continuazione del mesentere dello stomaco, il grande omento.
L'ingresso al sacco omentale si trova tra la vena cava caudale e la vena porta del fegato, medialmente al rene destro. Piccolo sigillo situato sulla curvatura minore, è corto e composto da legamento gastroepatico. Nella direzione craniale si fonde con legamento esofagoepatico, e nella caudale - con legamento epatoduodenale. I suddetti legamenti, oltre al legamento gastrosplenico, svolgono solo una funzione meccanica.
Endoscopia: l'aspetto dello stomaco è normale

Endoscopia: aspetto dello stomaco.
Gastrite ulcerosa

(varie proiezioni)

TOPOGRAFIA DELLO STOMACO
Lo stomaco è situato nell'ipocondrio sinistro, nella regione del 9°-12° spazio intercostale e della cartilagine xifoidea (epigastrio); quando è pieno, può estendersi oltre l'arco costale e scendere sulla parete addominale ventrale.
Nei cani di grossa taglia, questa caratteristica anatomica è alla base della patogenesi delle malattie non contagiose dello stomaco: la sua dilatazione acuta o volvolo.
PARTI DELLO STOMACO
È consuetudine distinguere tre parti di uno stomaco a camera singola: cardiaca, fondo (fundico), pilorico, che differiscono non solo nella struttura, ma anche nella specializzazione delle ghiandole. La parte cardiaca dello stomaco è più spessa e meno irrorata di sangue rispetto alle altre parti; questo fatto deve essere tenuto in considerazione quando si eseguono interventi chirurgici.
La parte cardiaca è un prolungamento dietro l'ingresso
nello stomaco e costituisce 1/10 dell'area della sua maggiore curvatura. La mucosa della parte cardiaca di tipo intestinale è di colore rosato, ricca di ghiandole cardiache parietali, che secernono una secrezione sierosa-mucosa di reazione alcalina.
La parte centrale dello stomaco dietro la pars cardias, sul lato della maggiore curvatura, è chiamata fondo dello stomaco. È la parte principale dello stomaco dove il cibo viene depositato a strati. Ci si trova zona ghiandolare inferiore(noto anche come funzionale o di fondo). Nei cani occupa la metà sinistra della grande curvatura dello stomaco.
La zona delle ghiandole fundi si distingue per una colorazione scura della mucosa ed è inoltre dotata di fosse gastriche - le bocche delle ghiandole parietali. La metà destra dello stomaco è occupata zona delle ghiandole piloriche. La mucosa gastrica, quando non è riempita, è raccolta in pieghe. Solo nella zona di minore curvatura sono orientati dall'ingresso dello stomaco al piloro.
La parte pilorica dello stomaco del cane ha un costrittore potentemente sviluppato (più stretto), che la copre circonferenzialmente a 5 - 7 cm dall'ingresso del duodeno e garantisce l'evacuazione del cibo dallo stomaco all'intestino.
ESTRAZIONI DELLO STOMACO

La mucosa è bianca, rivestita da epitelio squamoso stratificato, raccolto in numerose pieghe longitudinali. Lo strato sottomucoso ben sviluppato contiene ghiandole mucose.
Il rivestimento muscolare dello stomaco è costituito da tessuto muscolare liscio e presenta tre strati di fibre: longitudinale, circolare e obliqua.
Strato di fibre longitudinali sottile segue dall'esofago al piloro. Strato circolare situato prevalentemente nel fondo
e parti piloriche dello stomaco. Forma il costrittore pilorico.
Strato obliquo predomina nella metà sinistra dello stomaco; nella zona dello strato circolare raddoppia (in interno ed esterno).
La membrana sierosa dello stomaco passa dalla piccola curvatura al piccolo omento e dalla grande curvatura al legamento splenico e al grande omento.
EMBRIOLOGIA
Durante lo sviluppo embrionale, lo stomaco, come parte di un tubo digestivo diritto, subisce due rotazioni di 180 gradi. Uno sul piano frontale in senso antiorario e l'altro sul piano segmentale.
FUNZIONI
Lo stomaco svolge diverse funzioni:
Serve a conservare temporaneamente il cibo e controlla la velocità con cui il cibo entra nell'intestino tenue
Lo stomaco secerne anche gli enzimi necessari per la digestione delle macromolecole
I muscoli dello stomaco regolano la motilità, consentendo al cibo di spostarsi caudalmente (lontano dalla bocca) e aiutano la digestione mescolando e macinando il cibo.
Lo stomaco del cane è di grandi dimensioni, il suo volume massimo può avvicinarsi al volume dell'intero intestino tenue e crasso. Ciò è dovuto all’alimentazione irregolare del cane e al consumo di cibo “per uso futuro”.
È noto che il cane può utilizzare il proprio stomaco anche come serbatoio temporaneo per conservare il cibo: ad esempio, quando dà da mangiare ai cuccioli più grandi, la cagna rigurgita il cibo che ha procurato loro.
FASI DELLA SECREZIONE STOMATICA
La secrezione gastrica è regolata da complessi processi di interazione nervosa e ormonale, grazie ai quali viene effettuata al momento giusto e nel volume richiesto. Il processo di secrezione è diviso in tre fasi: cerebrale, gastrica e intestinale.
Fase cerebrale
La fase midollare della secrezione viene avviata dall'anticipazione dell'assunzione di cibo e dalla vista, dall'olfatto e dal gusto del cibo, che stimola la secrezione di pepsinogeno, sebbene anche la gastrina e l'acido cloridrico vengano rilasciati in piccole quantità.
Fase gastrica
La fase gastrica viene avviata dallo stiramento meccanico della mucosa gastrica, dalla diminuzione dell'acidità e dai prodotti della digestione delle proteine. Nella fase gastrica il principale prodotto della secrezione è la gastrina, che stimola anche la secrezione di acido cloridrico, pepsinogeno e muco. La secrezione di gastrina rallenta bruscamente se il pH scende al di sotto di 3,0 e può anche essere controllata da ormoni peptici come la secretina.
o enteroglucagone.
Fase intestinale
La fase intestinale viene avviata sia dalla distensione meccanica del tratto intestinale che dalla stimolazione chimica con aminoacidi e peptidi.
5. Intestino tenue (intestino tenue)
STRUTTURA
L'intestino tenue è una sezione ristretta del tubo intestinale.
L'intestino tenue è molto lungo, rappresenta la parte principale dell'intestino e varia da 2,1 a 7,3 metri nei cani. Sospeso su un lungo mesentere, l'intestino tenue forma delle anse che riempiono gran parte della cavità addominale.
L'intestino tenue emerge dall'estremità dello stomaco ed è diviso in tre diverse sezioni: duodeno, digiuno e ileo. Il duodeno rappresenta il 10% della lunghezza totale dell'intestino tenue, mentre il restante 90% della lunghezza dell'intestino tenue è costituito dal digiuno e dall'ileo.

RISERVA DI SANGUE
La parete della sezione sottile è riccamente vascolarizzata.
Il sangue arterioso scorre attraverso i rami dell'aorta addominale - l'arteria mesenterica cranica, e nel duodeno anche attraverso l'arteria epatica.
Il drenaggio venoso avviene nella vena mesenterica craniale, che è una delle radici della vena porta del fegato.
Il drenaggio linfatico dalla parete intestinale avviene dai seni linfatici dei villi e dei vasi intraorganici attraverso i linfonodi mesenterici (intestinali) nel tronco intestinale, che sfocia nella cisterna lombare, quindi nel dotto linfatico toracico e nella vena cava craniale.
INNERVAZIONE
Il rifornimento nervoso della piccola sezione è rappresentato dai rami del nervo vago e dalle fibre postgangliari del plesso solare dal ganglio semilunare, che formano due plessi nella parete intestinale: intermuscolare (di Auerbach) tra gli strati dello strato muscolare e sottomucoso ( Meissner) nello strato sottomucoso.
Il controllo dell'attività intestinale da parte del sistema nervoso viene effettuato sia attraverso i riflessi locali che attraverso i riflessi vagali che coinvolgono il plesso nervoso sottomucoso e il plesso nervoso intermuscolare. La funzione intestinale è regolata dal sistema nervoso parasimpatico, il cui centro è il midollo allungato, da dove il nervo vago (10° paio di nervi cranici, nervo respiratorio-intestinale) si estende fino all'intestino tenue. L'innervazione vascolare simpatica regola i processi trofici nell'intestino tenue.
TOPOGRAFIA
La sezione sottile inizia dal piloro dello stomaco a livello della 12a costa, è ricoperta ventralmente dalle foglie del grande omento, ed è limitata dorsolateralmente dalla sezione spessa. Non esistono confini chiari tra le sezioni dell'intestino tenue e l'identificazione delle singole sezioni è principalmente di natura topografica.
Si distingue più chiaramente solo il duodeno, che si distingue per il suo grande diametro e la vicinanza topografica al pancreas.
Radiografia con contrasto del bario dell'intestino tenue

ESTRAZIONI DELL'INTESTINO
DEFINIZIONE
Le caratteristiche funzionali dell'intestino tenue lasciano un'impronta sulla sua struttura anatomica. Ci sono la mucosa e lo strato sottomucoso, i muscoli (muscoli longitudinali esterni e trasversali interni) e la membrana sierosa dell'intestino.

MUCOSA INTESTINALE
La mucosa forma numerosi dispositivi che aumentano notevolmente la superficie di assorbimento.
Questi dispositivi includono pieghe circolari, o pieghe di Kirkring, nella cui formazione sono coinvolte non solo la mucosa, ma anche lo strato sottomucoso e i villi, che conferiscono alla mucosa un aspetto vellutato. Le pieghe coprono 1/3 o 1/2 della circonferenza dell'intestino. I villi sono ricoperti da uno speciale epitelio bordato, che effettua la digestione e l'assorbimento parietale. I villi, contraendosi e rilassandosi, eseguono movimenti ritmici con una frequenza di 6 volte al minuto, grazie ai quali agiscono come una sorta di pompe durante l'aspirazione.
Al centro del villo c'è un seno linfatico, che riceve i prodotti della lavorazione dei grassi. Ogni villo del plesso sottomucoso contiene 1-2 arteriole, che si scompongono in capillari. Le arteriole si anastomizzano tra loro e durante l'assorbimento tutti i capillari funzionano, mentre durante la pausa si formano brevi anastomosi. I villi sono escrescenze filiformi della mucosa, formati da tessuto connettivo lasso ricco di miociti lisci, fibre di reticolina ed elementi cellulari immunocompetenti, e ricoperti di epitelio.
La lunghezza dei villi è 0,95-1,0 mm, la loro lunghezza e densità diminuiscono nella direzione caudale, cioè nell'ileo la dimensione e il numero dei villi sono molto inferiori rispetto al duodeno e al digiuno.
ISTOLOGIA
La mucosa della sezione sottile e dei villi è ricoperta da un epitelio colonnare a strato singolo, che contiene tre tipi di cellule: cellule epiteliali colonnari con bordo striato, esocrinociti caliciformi (muco secreto) ed endocrinociti gastrointestinali.

La mucosa della sezione sottile è piena di numerose ghiandole parietali: le ghiandole intestinali comuni o di Lieberkühn (cripte di Lieberkühn), che si aprono nel lume tra i villi. Il numero delle ghiandole è in media di circa 150 milioni (nel duodeno e nel digiuno ci sono 10mila ghiandole per centimetro quadrato di superficie, e 8mila nell'ileo).
Le cripte sono rivestite da cinque tipi di cellule: cellule epiteliali con bordo striato, ghiandolociti caliciformi, endocrinociti gastrointestinali, piccole cellule senza bordi del fondo della cripta (cellule staminali dell'epitelio intestinale) ed enterociti con granuli acidofili (cellule di Paneth). Questi ultimi secernono un enzima coinvolto nella scomposizione dei peptidi e del lisozima.
FORMAZIONI LINFODICI
Il duodeno è caratterizzato dalle ghiandole duodenali tubolare-alveolari, o ghiandole di Bruner, che si aprono in cripte. Queste ghiandole sono una continuazione delle ghiandole piloriche dello stomaco e si trovano solo sui primi 1,5-2 cm del duodeno.
Il segmento finale della sezione sottile (ileo) è ricco di elementi linfoidi, che giacciono nella mucosa a diversa profondità dal lato opposto all'inserzione del mesentere, e sono rappresentati sia da follicoli singoli (solitari) che da loro grappoli in la forma delle placche di Peyer.
Le placche iniziano nella parte finale del duodeno.
Il numero totale di placche va da 11 a 25, sono di forma rotonda o ovale, lunghezza da 7 a 85 mm e larghezza da 4 a 15 mm.
L'apparato linfoide partecipa ai processi digestivi.
Come risultato della costante migrazione dei linfociti nel lume intestinale e della loro distruzione, vengono rilasciate interleuchine, che hanno un effetto selettivo sulla microflora intestinale, regolandone la composizione e la distribuzione tra le sezioni sottili e spesse. Negli organismi giovani l'apparato linfoide è ben sviluppato e le placche sono grandi.
Con l'età si verifica una graduale riduzione degli elementi linfoidi, che si esprime in una diminuzione del numero e delle dimensioni delle strutture linfatiche.
TRASCRIZIONE MUSCOLARE
La tunica muscolare è composta da due strati di tessuto muscolare liscio: longitudinale E circolare, e lo strato circolare è meglio sviluppato di quello longitudinale.
La muscolare propria fornisce movimenti peristaltici, movimenti pendolari e segmentazione ritmica che spingono e mescolano il contenuto intestinale.
SEROSA
La membrana sierosa - il peritoneo viscerale - forma il mesentere, sul quale è sospesa l'intera sezione sottile. Allo stesso tempo, il mesentere del digiuno e dell'ileo è meglio espresso, e quindi sono combinati sotto il nome di colon mesenterico.
FUNZIONI DELL'INTESTINO TENUE
Nell'intestino tenue la digestione del cibo viene completata sotto l'azione degli enzimi prodotti dalle ghiandole murali (fegato e pancreas) e parietali (Lieberkühn e Brunner), l'assorbimento dei prodotti digeriti nel sangue e nella linfa e la disinfezione biologica delle sostanze in entrata.
Quest'ultima avviene per la presenza di numerosi elementi linfoidi racchiusi nella parete del tubo intestinale.
Notevole è anche la funzione endocrina della sezione sottile, che consiste nella produzione di alcune sostanze biologicamente attive da parte degli endocrinociti intestinali (secretina, serotonina, motilina, gastrina, pancreozimina-colecistochinina, ecc.).
PARTI DEL PICCOLO INTESTINO
È consuetudine distinguere tre sezioni della sezione sottile: il segmento iniziale, o duodeno, il segmento medio, o digiuno, e il segmento finale, o ileo.
DUODENO
Struttura
Il duodeno è la sezione iniziale della sezione sottile, che è collegata al pancreas e al dotto biliare comune e ha la forma di un'ansa rivolta caudalmente e situata sotto la colonna lombare.
La lunghezza dell'intestino è in media di 30 cm ovvero il 7,5% della lunghezza della sezione sottile. Questa sezione della sezione sottile è caratterizzata dalla presenza di ghiandole duodenali (di Bruner) e di un breve mesentere, a seguito del quale l'intestino non forma anse, ma forma quattro circonvoluzioni pronunciate.
Radiografia con contrasto del bario
duodeno:

Topografia
Si forma la parte craniale dell'intestino A forma di S, O giro sigmoideo, che si trova nella regione del piloro, riceve i dotti del fegato e del pancreas e risale dorsalmente lungo la superficie viscerale del fegato.
Sotto il rene destro, l'intestino fa una svolta caudale: questo giro craniale del duodeno, e va a parte discendente, che si trova nell'iliaca destra. Questa parte passa a destra della radice del mesentere e sotto le 5-6 vertebre lombari passa al lato sinistro parte trasversale, dividendo il mesentere in due radici in questo luogo e forma giro caudale del duodeno.
L'intestino viene quindi diretto cranialmente a sinistra della radice mesenterica parte ascendente. Prima di raggiungere il fegato, si forma giro duodedigiunale e passa nel digiuno. Pertanto, sotto la colonna vertebrale si forma uno stretto anello della radice anteriore del mesentere, contenente il lobo destro del pancreas.
GEJUNUM
Struttura
Il digiuno è la parte più lunga del tratto piccolo ed è lungo circa 3 metri, ovvero il 75% della lunghezza del tratto piccolo.
L'intestino ha preso il nome dal fatto che ha un aspetto semi-dormiente, cioè non contiene contenuti voluminosi. Il diametro supera l'ileo situato dietro di esso e si distingue per un gran numero di vasi che passano attraverso un mesentere ben sviluppato.
Il digiuno, per la sua notevole lunghezza, le pieghe sviluppate, i numerosi villi e le cripte, ha la maggiore superficie di assorbimento, che è 4-5 volte maggiore della superficie del canale intestinale stesso.
Topografia
L'intestino forma 6-8 matasse, che si trovano nella regione della cartilagine xifoidea, nella regione ombelicale, nella parte ventrale degli iliaci e nell'inguine.
ILEO
Struttura
L'ileo è la parte finale della sezione sottile, raggiungendo una lunghezza di circa 70 cm, ovvero il 17,5% della lunghezza della sezione sottile. Esternamente, l'intestino non è diverso dal digiuno. Questa sezione è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di elementi linfoidi nella parete. La sezione finale dell'intestino ha pareti più spesse e la più alta concentrazione di placche di Peyer. Questo tratto corre dritto sotto la 1a-2a vertebra lombare da sinistra a destra e nella zona dell'ileo destro sfocia nel cieco, collegandosi con esso tramite un legamento. Nel punto in cui l'ileo entra nel cieco, si forma la parte ristretta e ispessita dell'ileo valvola ileo-cecale, O papilla ileale, che ha l'aspetto di uno smorzatore a forma di anello in rilievo.
Topografia
Questa sezione dell'intestino tenue ha preso il nome dalla sua vicinanza topografica alle ossa iliache, alle quali è adiacente.
PRESACOLPI DA PARETE. FEGATO.
Fegato- la ghiandola più grande del corpo, è un organo parenchimale di colore rosso scuro, del peso di 400-500 g, pari al 2,8-3,4% del peso corporeo.
Nel fegato si formano cinque sistemi tubulari:
1) dotti biliari;
2) arterie;
3) rami della vena porta (sistema portale);
4) vene epatiche (sistema cavale);
5) vasi linfatici.


STRUTTURA DEL FEGATO DI UN CANE
La forma del fegato è irregolarmente arrotondata con margine dorsale ispessito e margini ventrali e laterali affilati. I bordi appuntiti sono sezionati ventralmente da profonde scanalature in lobi. La superficie del fegato è liscia e lucida a causa del peritoneo che la ricopre, solo il bordo dorsale del fegato non è ricoperto di peritoneo, che in questo punto passa sul diaframma, e così si forma campo extraperitoneale fegato.
Sotto il peritoneo c'è una membrana fibrosa. Penetra nell'organo, lo divide in lobi e forme capsula fibrosa perivascolare(capsula di Glisson), che circonda i dotti biliari, i rami dell'arteria epatica e la vena porta.
La superficie anteriore del fegato - la superficie diaframmatica - entra nella nicchia formata dalla cupola del diaframma, e la superficie posteriore - la superficie viscerale è in contatto con gli organi situati nelle vicinanze del fegato.
Il margine dorsale presenta due tacche: a sinistra - depressione esofagea, e a destra - grondaia della vena cava. Situato sul bordo ventrale taglio del legamento rotondo. Al centro superficie viscerale situato circondato da tessuto connettivo porta del fegato- questo è il luogo in cui penetrano i vasi e i nervi, dove esce il dotto biliare comune e dove si trovano i linfonodi epatici.
Il legamento falciforme, che è un duplicato del peritoneo che passa dal diaframma al fegato, è una continuazione legamento rotondo- residuo della vena ombelicale, divide il fegato in due lobi: Giusto- grande e Sinistra- più piccola. Pertanto, l'intera porzione del fegato situata a destra del legamento rotondo è il lobo destro.
Sul lato destro del fegato si trova la cistifellea. L'area del fegato tra la cistifellea e il legamento rotondo è quota media. Il lobo medio della porta del fegato è diviso in due sezioni: quella inferiore è chiamata frazione quadrata, e quello in alto è lobo caudato. Quest'ultimo è composto da processo caudato, che ha depressione renale, E processo mastoideo, che occupa la minore curvatura dello stomaco. Infine, i lobi sinistro e destro vengono divisi
in due parti ciascuna: laterale e mediale.
Pertanto, il fegato ha sei lobi: laterale destro, mediale destro, laterale sinistro, mediale sinistro, quadrato e caudato.
Il fegato è un organo polimerico nel quale si possono distinguere diversi elementi strutturali e funzionali: lobulo epatico, settore (sezione del fegato rifornita da un ramo della vena porta del 2° ordine), segmento (sezione del fegato rifornita da un ramo della vena porta del 2° ordine), ramo della vena porta del 3° ordine), l'acino epatico (sezioni adiacenti di due lobuli adiacenti) e il lobulo epatico portale (aree di tre lobuli adiacenti).
L'unità morfofunzionale classica è il lobulo epatico, di forma esagonale, situato attorno alla vena centrale del lobulo epatico.
L'arteria epatica e la vena porta, entrate nel fegato, vengono ripetutamente divise in lobare, segmentale, ecc. si ramifica completamente
Prima arterie e vene interlobulari, che si trovano lungo le superfici laterali dei lobuli insieme a dotto biliare interlobulare, formando triadi epatiche. Da queste arterie e vene si dipartono rami che danno origine a capillari sinusoidali, che confluiscono nelle vene centrali del lobulo.
I lobuli sono costituiti da epatociti, che formano trabecole sotto forma di due cordoni cellulari. Una delle caratteristiche anatomiche più importanti del fegato è che, a differenza di altri organi, il fegato riceve il sangue da due fonti: sangue arterioso attraverso l'arteria epatica e sangue venoso attraverso la vena porta.
VIE BILIARI E FORMAZIONE DELLA BILE
Una delle funzioni più importanti del fegato è il processo di formazione della bile, che porta alla formazione dei dotti biliari. Tra gli epatociti che formano i lobuli si trovano i dotti biliari che confluiscono nei dotti interlobulari, i quali a loro volta formano due dotto epatico, uscendo da ciascun lobo: destro e sinistro. Unendosi, questi dotti formano il dotto epatico comune.
La cistifellea è un serbatoio per la bile, in cui la bile si addensa 3-5 volte, poiché viene prodotta più del necessario per il processo di digestione. Il colore della bile della cistifellea nei cani è rosso-giallo.
La vescica si trova sul lobo quadrato del fegato, in alto rispetto al bordo ventrale ed è visibile sia dalla superficie viscerale che da quella diaframmatica. La bolla ha metter il fondo a, corpo E collo. La parete della vescica è formata dalla mucosa, uno strato di tessuto muscolare liscio ed è rivestita esternamente dal peritoneo, mentre la parte della vescica adiacente al fegato è costituita da tessuto connettivo lasso. Il dotto cistico ha origine dalla vescica e contiene piega a spirale.
Come risultato della fusione del dotto cistico e del dotto epatico comune, si forma il dotto biliare comune, che si apre
nel giro a forma di S del duodeno accanto al dotto pancreatico all'apice papilla duodenale maggiore. Nel punto in cui entra nell'intestino, ha il condotto sfintere del dotto biliare(sfintere di Oddi).
Grazie alla presenza dello sfintere, la bile può defluire direttamente nell'intestino (se lo sfintere è aperto) o nella cistifellea (se lo sfintere è chiuso).
TOPOGRAFIA DEL FEGATO
Il fegato si trova davanti allo stomaco ed è in contatto con diaframma. Si trova quasi simmetricamente in entrambi gli ipocondri. Bordo caudale Il fegato corrisponde all'arco costale; solo negli animali anziani il fegato può sporgere oltre l'arco costale.
All'esame radiografico ed ecografico, la distanza tra il bordo caudale del fegato e il diaframma dovrebbe essere cinque volte la lunghezza della seconda vertebra lombare.

Il fegato è mantenuto nella sua posizione dall'apparato legamentoso, che lo comprende legamento rotondo fegato - collega il bordo ventrale del fegato con l'anello ombelicale, il legamento continua all'interno legamento falciforme, attaccando il fegato al diaframma; il fegato è collegato al diaframma anche tramite il legamento coronario, il legamento triangolare sinistro; Il fegato è collegato al rene destro tramite il legamento epatorenale, allo stomaco tramite il legamento epatogastrico e al duodeno tramite il legamento epatoduodenale.
3 - cavità della cistifellea.

Scansione longitudinale della cistifellea: 1 - cavità della colecisti,
2 - parete della cistifellea,

Scansione trasversale della cistifellea, 1 - cavità della cistifellea,
2 - parete della cistifellea,
Il fegato riceve l'apporto di sangue attraverso le arterie epatiche e la vena porta, mentre il deflusso venoso avviene attraverso le vene epatiche nella vena cava caudale.
L'innervazione del fegato è fornita dal nervo vago attraverso i gangli extra e intramurali e il plesso epatico simpatico, rappresentato da fibre postgangliari del ganglio semilunare. Il nervo frenico partecipa all'innervazione del peritoneo che ricopre il fegato, i suoi legamenti e la cistifellea.
FUNZIONI DEL FEGATO
Il fegato è un organo multifunzionale che partecipa a quasi tutti i tipi di metabolismo, svolge un ruolo di barriera e disinfettante, è un deposito di glicogeno e sangue (nel fegato si deposita fino al 20% del sangue) e svolge una funzione ematopoietica in il periodo embrionale.
La funzione digestiva del fegato è ridotta al processo di formazione della bile, che favorisce l'emulsificazione dei grassi e la dissoluzione degli acidi grassi e dei loro sali. I cani secernono 250-300 ml di bile al giorno.
La bile è una miscela di ioni bicarbonato, colesterolo, metaboliti organici e sali biliari. La base su cui funzionano i sali biliari è il grasso. I sali biliari scompongono le grandi particelle di grasso in piccole goccioline, che interagiscono con varie lipasi.
La bile serve anche ad espellere i residui organici, come il colesterolo e la bilirubina, durante la degradazione dell'emoglobina. Le cellule del fegato producono bilirubina dal sangue e la secernono attivamente nella bile. È grazie a questo pigmento che la bile acquisisce il suo colore giallo.
Struttura tridimensionale di un sale biliare
indicando i lati polari e non polari

PRESACOLPI DA PARETE. PANCREAS
Il pancreas è un organo parenchimale ampio e lasso, costituito da lobuli individuali uniti da tessuto connettivo lasso. In peso, il ferro è 30-40 g, ovvero lo 0,20-0,25% del peso corporeo, e il colore è rosa pallido.
Secondo la struttura del ferro, appartiene alle complesse ghiandole tubolare-alveolari a secrezione mista. La ghiandola non ha contorni netti, poiché è priva di capsula, è distesa lungo il tratto iniziale del duodeno e la minore curvatura dello stomaco, ricoperta di peritoneo ventro-caudalmente, la parte dorsale non è ricoperta di peritoneo.

Il pancreas è costituito da lobuli esocrini e parti endocrine.
Anatomicamente la ghiandola è divisa in corpo, che si trova nel giro a forma di S del duodeno, Sinistra il lobo o lobo gastrico, che è adiacente alla minore curvatura dello stomaco, si trova nel duplicato dell'omento e raggiunge la milza e il rene sinistro, e lobo destro, o lama duodenale, che si trova nel duplicato del mesentere del duodeno e raggiunge il rene destro.
Nei cani, il lobo destro è molto sviluppato, quindi la ghiandola ha una forma allungata (a nastro) piegata ad angolo. La ghiandola ha una parte principale (virzung) dotto pancreatico, che lascia il corpo della ghiandola e si apre accanto al dotto biliare nella parte superiore della papilla duodenale (a volte il dotto può essere assente),
e 1-2 condotti accessori (Santorini)., che si aprono ad una distanza di 3-5 cm da quella principale.
L'afflusso di sangue alla ghiandola è fornito dai rami delle arterie splenica, epatica, gastrica sinistra e mesenterica cranica e il deflusso venoso avviene nella vena porta del fegato.
L'innervazione viene effettuata dai rami del nervo vago e dal plesso simpatico del pancreas (fibre postgangliari del ganglio semilunare).
FUNZIONI DEL PANCREAS
Il pancreas è responsabile sia delle funzioni esocrine che endocrine, ma nel contesto di questa sezione verranno prese in considerazione solo le funzioni digestive esocrine.
Il pancreas esocrino è responsabile della secrezione delle secrezioni digestive e di grandi quantità di ioni bicarbonato di sodio, che neutralizzano l'acidità del chimo che proviene dallo stomaco.
Prodotti di secrezione:
Tripsina: scompone le proteine intere e parzialmente digerite in peptidi di varie dimensioni, ma non provoca il rilascio di singoli amminoacidi.
- chimotripsina: scompone le proteine intere e parzialmente digerite in peptidi di varie dimensioni, ma non provoca il rilascio dei singoli aminoacidi.
- carbossipeptidasi: scindono i singoli amminoacidi dal terminale amminico dei peptidi di grandi dimensioni.
- aminopeptidasi: scindono i singoli amminoacidi dall'estremità carbossilica dei grandi peptidi.
- lipasi pancreatica: idrolizza i grassi neutri in monogliceridi e acidi grassi.
- amilasi pancreatica: idrolizza i carboidrati, convertendoli in di- e trisaccaridi più piccoli.
6. Intestino crasso (Intestinum crassum)
L'intestino crasso è la sezione finale del tubo intestinale, è lungo in media 45 cm ed è diviso in cieco, colon e retto. Ha una serie di caratteristiche, che includono relativa brevità, volume, bassa mobilità (mesentere corto) e la presenza di un'escrescenza cieca - il cieco - al confine con la sezione sottile.


1 - stomaco
2, 3, 4, 5 - duodeno
6 - digiuno
7 - ileo
8 - cieco
9, 10, 11 - due punti
12 - retto

L'apporto di sangue al colon è fornito dai rami delle arterie mesenteriche craniale e caudale, mentre il retto è fornito da tre arterie rettali: cranico(ramo dell'arteria mesenterica caudale), medio e caudale(rami dell'arteria iliaca interna).
Il drenaggio venoso dal cieco, dal colon e dalla porzione craniale del retto avviene nella vena porta del fegato. Dalle porzioni media e caudale del retto del gatto nella vena cava caudale, bypassando il fegato.
L'innervazione della sezione spessa è assicurata dai rami vago(posizione trasversale del colon) e nervi pelvici(cieco, la maggior parte del colon e del retto). La parte caudale del retto è innervata anche dal sistema nervoso somatico attraverso i nervi pudendo e rettale caudale del plesso spinale sacrale. L'innervazione simpatica viene effettuata attraverso i plessi mesenterico e rettale, che sono formati da fibre postgangliari dei gangli mesenterici semilunari e caudali.
Il controllo muscolare da parte del sistema nervoso viene effettuato sia attraverso i riflessi locali che attraverso i riflessi vagali che coinvolgono il plesso nervoso sottomucoso e il plesso nervoso intermuscolare, che si trova tra gli strati muscolari circolari e longitudinali. La normale funzione intestinale è regolata dal sistema nervoso parasimpatico. Il controllo è diretto dalla parte midollare del nervo vago alla parte anteriore e dai nuclei della colonna sacrale
attraverso il nervo pelvico fino alla parte periferica dell'intestino crasso.
Il sistema nervoso simpatico (controllo diretto dai gangli nel tronco simpatico paravertebrale) svolge un ruolo meno importante. I processi di controllo locale e coordinazione della motilità e della secrezione dell'intestino e delle ghiandole associate sono di natura complessa e coinvolgono nervi e sostanze chimiche paracrine ed endocrine. Il rifornimento nervoso della piccola sezione è rappresentato dai rami del nervo vago e dalle fibre postgangliari del plesso solare dal ganglio semilunare, che formano due plessi nella parete intestinale: intermuscolare (di Auerbach) tra gli strati dello strato muscolare e sottomucoso ( Meissner) nello strato sottomucoso.
Il controllo dell'attività intestinale da parte del sistema nervoso viene effettuato sia attraverso i riflessi locali che attraverso i riflessi vagali che coinvolgono il plesso nervoso sottomucoso e il plesso nervoso intermuscolare.
La funzione intestinale è regolata dal sistema nervoso parasimpatico. Il controllo è diretto dalla porzione midollare del nervo vago all'intestino tenue. Il sistema nervoso simpatico (controllo diretto dai gangli nel tronco simpatico paravertebrale) svolge un ruolo meno importante.
I processi di controllo locale e coordinamento della motilità e della secrezione dell'intestino e delle ghiandole associate sono di natura più complessa, vi prendono parte nervi, sostanze chimiche paracrine ed endocrine.
Le anse dell'intestino crasso si trovano nelle cavità addominale e pelvica.
MEMBRANE DELL'INTESTINO crasso
La struttura del colon è costituita da diversi strati: mucosa, strato sottomucoso, strato muscolare (2 strati - strato longitudinale esterno e strato circolare interno) e sierosa.
L'epitelio del cieco non contiene villi, ma ha numerose cellule caliciformi sulla superficie che secernono muco.
La mucosa non presenta villi né pieghe circolari, per questo è liscia. I villi sono presenti solo allo stato embrionale e scompaiono subito dopo la nascita. Questo a volte si osserva in alcuni cani nei primi giorni di vita e nella maggior parte degli individui entro la fine della seconda settimana.
Nella mucosa si distinguono i seguenti tipi di cellule: cellule epiteliali intestinali con bordo striato, enterociti caliciformi, enterociti senza bordi - la fonte del ripristino della mucosa e singoli endocrinociti intestinali. Le cellule di Paneth, presenti nell'intestino tenue, sono assenti nell'intestino crasso.
Le ghiandole intestinali (Lieberkühn) sono ben sviluppate, si trovano in profondità e vicine l'una all'altra e ci sono fino a 1000 ghiandole per 1 cm2.
Le aperture delle ghiandole del Liberkühn conferiscono alla mucosa un aspetto irregolare. Nella parte iniziale del tratto spesso si accumulano elementi linfoidi che formano placche e campi linfatici. Un vasto campo è situato nel cieco alla confluenza dell'ileo e le placche si trovano sul corpo del cieco e alla sua estremità cieca.
Lo strato muscolare nella sezione spessa è ben sviluppato, il che conferisce all'intera sezione spessa un aspetto spesso.
FUNZIONI DELLA SEZIONE SPESSORE
I residui di cibo non digerito entrano nell'intestino crasso e sono esposti alla microflora che abita l'intestino crasso. La capacità digestiva dell'intestino crasso dei cani è trascurabile.
Alcuni escrementi (urea, acido urico) e sali di metalli pesanti vengono rilasciati attraverso la mucosa dell'intestino crasso; l'acqua viene assorbita intensamente principalmente nella parte iniziale del colon. La sezione spessa è funzionalmente più un organo di assorbimento ed escrezione che di digestione, il che lascia un'impronta nella sua struttura.
PARTI DELL'INTESTINO crasso
L’intestino crasso è costituito da tre parti principali: cieco, colon E retto.


cieco
Struttura
Il cieco è una escrescenza cieca al confine tra la sezione sottile e quella spessa. Il foro iliaco è ben marcato e rappresenta un meccanismo otturatore.
L'apertura cecumcolica di uscita non è chiaramente definita e non ha un meccanismo di bloccaggio. Il cieco nei cani è notevolmente ridotto. Ha l'aspetto di un'appendice contorta, formante da 1 a 3 riccioli, le sue pareti sono arricchite di elementi linfoidi, ma l'intestino non presenta appendice vermiforme, caratteristica dei primati superiori. A seconda della dimensione e del numero dei riccioli, si possono distinguere 5 tipi di cieco del cane.
Topografia
L'intestino pende sul mesentere destro nella regione lombare sotto le 2-4 vertebre lombari, la sua lunghezza varia da 2 a 16 cm, ovvero l'11% della lunghezza della sezione spessa.
Il cieco forma una sacca, chiusa ad un'estremità, situata sotto la giunzione dell'intestino crasso e tenue. Nei gatti, il cieco è un organo rudimentale, mentre nei cani la dimensione del cieco è significativa.
COLON
Struttura
Il colon costituisce il volume principale della sezione spessa.
Raggiunge circa 30 cm di lunghezza, ovvero il 66,7% della lunghezza totale della sezione grossa. L'intestino è molto stretto (più stretto del duodeno), ma con pareti spesse. La forma forma un bordo situato nel piano frontale, sotto la colonna vertebrale, che in apparenza ricorda un ferro di cavallo.
Il colon è costituito da tre sezioni relativamente diritte: il colon ascendente, il colon trasverso
e il colon discendente, che prosegue nel retto.
Topografia
Il colon inizia a destra nella regione lombare e decorre nella parte dorsale dell'ileo destro in linea retta fino al diaframma come colon ascendente.
Dietro il diaframma (nell'ipocondrio) forma una curva trasversale - il colon trasverso e, spostandosi verso il lato sinistro, decorre caudalmente nella parte dorsale dell'iliaca sinistra come colon discendente. Raggiunto l'inguine sinistro, il colon sigmoideo forma una curva sigmoidea e passa nel retto.
RETTO
Struttura
Il retto è il segmento finale dell'intestino crasso. La lunghezza del retto è di circa 10 cm, pari al 22,2% della lunghezza del colon. L'intestino è sospeso sul mesentere e nella cavità pelvica è circondato da tessuto connettivo lasso (tessuto pararettale).
Nella cavità pelvica, l'intestino forma un'ampolla poco sviluppata.
Il retto ha pareti lisce, elastiche e spesse, con uno strato muscolare uniformemente sviluppato. La mucosa è raccolta in pieghe longitudinali e contiene ghiandole di Lieberkühn modificate e numerose ghiandole mucose che secernono grandi quantità di muco.
Nello strato sottomucoso sono presenti molti plessi venosi, grazie ai quali l'acqua e le soluzioni acquose del retto vengono assorbite bene e rapidamente.
Topografia
Si trova sotto l'osso sacro e la prima vertebra caudale e termina con l'ano.
Ano
La parte perineale del retto è chiamata canale anale. La mucosa del retto 2-3 cm prima dell'ano termina con la linea anorettale, caudale da cui inizia l'epitelio squamoso stratificato. In quest'area si formano due zone a forma di anello. La zona interna è chiamata zona colonnare dell'ano, le cui pieghe longitudinali sono chiamate colonne anali. Tra di loro si formano delle depressioni: i seni anali, in cui si accumula il muco secreto dalle ghiandole anali.
La zona esterna è chiamata zona intermedia ed è separata dalla zona cutanea dell'ano dalla linea cutanea anale.
In quest'ultimo si aprono le ghiandole circonferenziali e i seni paranali. Il retto e l'ano possiedono un proprio apparato muscolare, che nella zona anale è rappresentato da due sfinteri: esterno ed interno. Il primo è un accumulo di tessuto muscolare liscio attorno all'ano, formato dallo strato muscolare del retto, mentre il secondo è il muscolo striato. Entrambi gli sfinteri funzionano in modo sincrono.
Numerosi muscoli si estendono dall'ano ai lati:
Il muscolo retto-coda è rappresentato da uno strato longitudinale della muscolatura rettale, che passa dalle pareti del retto alle prime vertebre caudali;
- elevatore dell'ano - origina dalla spina ischiatica e va dal lato del retto ai muscoli dell'ano;
- legamento sospensore dell'ano - ha origine dalla 2a vertebra caudale e sotto forma di un cappio copre il retto dal basso; costruito con tessuto muscolare liscio; nei maschi diventa un divaricatore del pene; e nelle femmine termina nelle labbra.
N. N. Vlasov, capitolo del libro "L'allevamento di cani da caccia".
Il corpo del cane è un sistema biologico complesso e integrale, comprendente vari organi (cuore, polmoni, stomaco, cervello, fegato, reni, ecc.) che svolgono determinate funzioni fisiologiche. Ogni organo è in stretta connessione anatomica e fisiologica con altri organi, e quelli di essi che svolgono funzioni diverse, ma coerenti di qualsiasi processo generale, formano sistemi di organi.
Nel corpo di un cane da caccia si distinguono i seguenti sistemi di organi: movimento, respirazione, digestione, circolazione sanguigna e linfatica, minzione, riproduzione o organi riproduttivi, nervosi e sensoriali, secrezione interna e pelle.
La struttura del corpo e le sue funzioni sono interconnesse. Il ruolo principale in questa relazione è svolto dal sistema nervoso con il suo organo di coordinamento: la corteccia cerebrale.
La pratica dell'allevamento del cane - il mantenimento, l'alimentazione, l'allevamento, l'allevamento, il trattamento, l'addestramento e l'uso alimentare di un cane, nonché la corretta valutazione della razza e delle qualità lavorative degli animali si basano sulla conoscenza dell'anatomia e della fisiologia.
Il sistema degli organi del movimento è formato dagli apparati scheletrici e muscolari del movimento.
Il movimento di un cane è un atto complesso di attività muscolare, collegato organicamente agli organi ossei e controllato dai centri nervosi del midollo spinale, a seguito del quale l'animale esegue vari movimenti. La base di ogni movimento è l'azione antagonista dei muscoli flessori ed estensori.
Apparato osseo. I suoi componenti sono ossa e legamenti che formano lo scheletro dell'animale. L'osso è un organo formato da tessuto osseo, ricoperto all'esterno da periostio e in punti di connessioni mobili con altre ossa - con cartilagine. Le ossa si dividono in tubolari e piatte. Le cavità delle ossa tubolari sono piene di midollo osseo: giallo - da cellule adipose e rosso, che è un organo che forma il sangue. I legamenti servono a collegare le ossa tra loro e ai muscoli.
Lo scheletro del cane è una base ossea elastica, che è il supporto di tutte le parti molli del corpo e una protezione affidabile dei suoi organi come cuore, polmoni, fegato, cervello e midollo spinale, ecc. (Fig. 1). Possiede 279-283 ossa, a seconda del numero delle vertebre caudali, e rappresenta il 7-8,5% della massa totale dell'animale.
L'asse scheletrico è la colonna vertebrale, costituita dalle sezioni cervicale, toracica, lombare, sacrale e caudale. Il componente principale della colonna vertebrale è la vertebra, una formazione ossea che ha un corpo, un arco, processi articolari, trasversali e spinosi. Quando le vertebre sono collegate alla colonna vertebrale, dai fori vertebrali si forma il canale spinale, in cui si trova il midollo spinale. La colonna vertebrale del cane presenta tre curvature: cervicale, cervico-dorsale e dorso-lombare.
La prima vertebra cervicale, l'atlante, è collegata al cranio, che è costituito dalle sezioni cerebrale e facciale (Fig. 2). Le ossa del cranio servono da protezione per il cervello, gli organi della vista e dell'udito; Le ossa della regione facciale formano le cavità nasali e orali.
Il cranio del cane è costituito da 32 ossa collegate da "suture", ad eccezione della mascella inferiore e dell'osso ioide. Le ossa del cranio sono divise in spaiate (occipitale, sfenoide, interparietale) e pari (parietali, frontali, temporali). Sull'osso occipitale c'è una protuberanza occipitale, poco appariscente, debolmente o bruscamente espressa. Le ossa facciali includono nasale, palatino, mascellare e sottomascellare, ioide, ecc. Le mascelle superiore e inferiore sono le basi per attaccare i denti.
Figura 1. Scheletro di un cane: 1 - cranio; 2 - mascella inferiore; 3 - colonna vertebrale (sezioni: Dietro - cervicale; 3b - toracico; 3c - lombare; 3d - sacrale; 3d - caudale), 4 - sterno; 5 - costole; 6 - lama; 7 - articolazione della spalla; 8 - omero; 9 - articolazione del gomito; 10 - ulna; 11 - raggio; 12 - polso; 13 - metacarpo; 14 - dita; 15 - osso pelvico; 16 - articolazione dell'anca; 17 - coscia; 18 - rotula; 19 - articolazione del ginocchio; 20 - perone; 21 - tibia; 22 - articolazione del garretto; 23 - tarso; 24 - metatarso.
La colonna cervicale è composta da 7 vertebre, la cui lunghezza totale determina la lunghezza del collo del cane. Avendo una mobilità limitata l'uno rispetto all'altro, insieme consentono all'animale di girare la testa. Le due vertebre superiori sono diverse dalle altre. Il primo (atlante) è un anello e garantisce la massima mobilità della testa; la seconda (epistrofe) si articola con l'atlante con l'ausilio del processo odontoideo, che permette la testa. ruotare rispetto all'asse cervicale.
La colonna vertebrale toracica è composta da 13 vertebre toraciche (dorsali), 13 paia di costole e lo sterno (sterno). Le vertebre toraciche, soprattutto le prime 5-6, che formano il garrese, presentano processi spinosi più sviluppati e rivolti all'indietro e fosse costali (sfaccettature), nelle quali entrano le teste delle costole. L'undicesima vertebra toracica - il diaframma - si distingue per la posizione verticale del processo spinoso.

Figura 2. Cranio: 1 - osso incisivo; 2 - osso nasale; 3 - mascella superiore; 4 - osso lacrimale; 5 - osso zigomatico; b - osso frontale; 7 - osso interparietale; 8 - osso parietale; 9 - osso occipitale; 10 - osso temporale; 11 - mascella inferiore.
Ad ogni vertebra toracica è attaccata una coppia di costole corrispondenti. Tutte le coppie di costole sono curve. Le prime 9 paia, chiamate vere costole, sono collegate allo sterno tramite cartilagine. Le ultime 4 paia - false costole - non si collegano allo sterno. Le loro cartilagini si fondono tra loro per formare l'arco costale. L'estremità anteriore dello sterno è chiamata manubrio, mentre l'estremità posteriore è chiamata processo xifoideo.
Il torace contiene il cuore e i polmoni. La larghezza del torace dipende dal grado di curvatura delle costole e la profondità dipende dalla loro lunghezza. Un torace ampio e profondo accoglie polmoni più grandi e crea condizioni migliori per l’attività cardiaca.
La colonna lombare è formata da 7 vertebre, i cui processi spinosi sono diretti in avanti. Avendo solo due punti di appoggio alle estremità, la parte bassa della schiena forma un cosiddetto “ponte sospeso” che collega la colonna dorsale con quella sacrale, e quindi le sue vertebre sono massicce.
La colonna sacrale è costituita da 3 vertebre sacrali che si fondono all'età di 6 mesi. Formano l'osso sacro o il sacro.
La sezione caudale della colonna vertebrale comprende 20-23 vertebre, che (a partire dalla 7a caudale) sono prive di archi e, quindi, di canale spinale. Le vertebre caudali del cane sono caratterizzate da elevata mobilità.
Lo scheletro dell'arto anteriore è costituito dalle ossa del cingolo scapolare e dalle ossa dell'arto anteriore libero. Le ossa del cingolo scapolare dell'arto anteriore includono la scapola, la cui lunghezza determina la larghezza del passo del cane, e la sua posizione obliqua fornisce un effetto più energetico sull'arto anteriore nel suo insieme.
Le ossa dell'arto anteriore libero sono costituite dall'omero e dalle ossa accoppiate del radio e dell'ulna, che formano l'avambraccio. Sotto l'avambraccio, in due file (3 e 4 ossa ciascuna), ci sono 7 ossa carpali e poi 5 ossa metacarpali. L'arto termina con le ossa di 5 dita anteriori - falangi - con 3 ossa ciascuna, ad eccezione della falange del primo dito, che ha 2 ossa.
Sugli arti anteriori si distinguono le seguenti articolazioni: omero - la giunzione della scapola con l'omero; ulna: la giunzione dell'omero con l'ulna e il radio; carpale: posizione delle ossa carpali; articolazioni metacarpo-falangee e falangee.
Lo scheletro dell'arto posteriore è costituito dalle ossa della cintura pelvica e dalle ossa dell'arto posteriore libero. La cintura pelvica ha due ossa iliache, pubiche (pubiche) e ischiatiche, che si fondono per formare il bacino, collegandosi all'osso sacro in corrispondenza dell'articolazione iliosacrale. La sporgenza dell'ischio è chiamata tuberosità ischiatica, mentre la sporgenza dell'ileo è chiamata maclacca. Nei cani maschi, le ossa pubiche vicino all'articolazione pelvica formano il tubercolo pubico.
Le ossa dell'arto posteriore libero sono costituite dal femore, dalle ossa della tibia (tibia e perone), che alle loro estremità inferiori sono collegate alle 7 ossa tarsali. Questi ultimi sono disposti su 3 file; Tra questi spicca il potente osso del tallone. Di seguito sono riportate le 4 ossa metatarsali. L'arto posteriore è completato da 4 dita, ciascuna composta da 3 falangi. L'estremità inferiore del femore si articola con le ossa della parte inferiore della gamba: tibia e perone nell'articolazione del ginocchio e nella rotula.
Sull'arto posteriore si distinguono le seguenti articolazioni: anca - giunzione del bacino con il femore; ginocchio - tra la coscia, la rotula e la parte inferiore della gamba; garretto: tra le ossa della parte inferiore della gamba e del tarso; articolazioni metatarso-falangee e falangee.
Lo scheletro del cane è il primo componente del sistema degli organi di movimento.

Figura 3. Muscoli: 1 - brachiocefalico; 2 - trapezoidale; 3 - dorsale; 4 - gluteo; 5 - tricipiti; 6 - petto; 7 addominali; 8 - femore bicipite.
L'apparato muscolare, o muscolatura, di un cane è costituito principalmente da muscoli scheletrici che svolgono le funzioni motorie dell'intero corpo e dei singoli organi (Fig. 3). Collegano le singole parti dello scheletro in un unico insieme e mettono in movimento l'apparato osseo dell'animale.
I muscoli sono costituiti da fibre muscolari, tessuto connettivo, vasi sanguigni e linfatici, nervi motori e sensoriali. Ogni muscolo è coperto da una sottile pellicola - fascia, attaccata agli organi ossei. Gli organi ausiliari dei muscoli comprendono le borse e le guaine tendinee situate lungo i tendini. Essendo riempiti con un fluido speciale (sinovia), servono a ridurre l'attrito sia nei muscoli che nelle articolazioni.
A seconda della loro forma, i muscoli si dividono in piatti, fusiformi, pennati e bipennati, bi-, tri- e quadricipiti, circolari, ecc. La loro forma e dimensione sono determinate dalle funzioni che svolgono, ma nella maggior parte dei casi la parte centrale è ispessita e passa nei tendini alle estremità. La forza d'azione dei muscoli dipende dal grado del loro sviluppo (dimensione), nonché dalla dimensione dei bracci di leva su cui agiscono.
Secondo la natura della loro azione, i muscoli si dividono in flessori ed estensori, adduttori e abduttori, elevatori, rotatori, ecc.
La proprietà principale dei muscoli è la loro capacità di contrarsi e rilassarsi. La contrazione muscolare è una risposta all'azione di determinati stimoli che raggiungono le cellule muscolari attraverso i nervi. Dopo che l'irritazione si è fermata, i muscoli ritornano nella loro posizione originale, cioè si rilassano. Quando i muscoli si contraggono, cambiano la posizione delle ossa a cui sono attaccati.
Insieme alle ossa dello scheletro, i muscoli formano sistemi di leve, in cui il ruolo della spalla è svolto dalle ossa, i punti fulcro sono le articolazioni e la forza applicata sono i muscoli. Nei muscoli che lavorano, l'energia chimica viene convertita in energia meccanica con il rilascio simultaneo di calore e un aumento dei processi metabolici al loro interno. Durante il lavoro, i muscoli si stancano. Per ripristinare le loro prestazioni, hanno bisogno di riposo, durante il quale vengono rimossi i prodotti di decadimento e vengono reintegrate le riserve energetiche esaurite.
I muscoli scheletrici sono il secondo componente del sistema di organi di movimento. Modella il fisico in rilievo, garantisce la mobilità dell’animale, gli conferisce flessibilità e destrezza. Lo sviluppo dei muscoli indica la forza e la salute del cane. Nei cani da caccia adulti, i muscoli dovrebbero essere prominentemente sporgenti, con contorni chiaramente definiti (spezzati) e mobilità ben definita. Il pelo lungo nasconde il grado di sviluppo muscolare.
I muscoli scheletrici sono i muscoli della testa, del busto, degli arti anteriori e posteriori.
I muscoli della testa si dividono in masticatori e facciali. Sollevano e comprimono le labbra, allargano le narici e tirano in avanti la cartilagine dell'orecchio. I muscoli del busto comprendono i muscoli del collo, del cingolo scapolare, del torace, delle pareti addominali e della colonna vertebrale. I muscoli del collo girano la testa e il collo, li abbassano e li sollevano, ritraggono la lingua e tendono la pelle del collo. I muscoli del cingolo scapolare sono coinvolti nel movimento della testa e del collo e forniscono la mobilità degli arti anteriori. I muscoli del torace svolgono le funzioni di inspirazione ed espirazione del corpo e partecipano alla flessione del collo. Del gruppo muscolare delle pareti addominali fa parte anche il diaframma, che separa la cavità toracica da quella addominale e facilita l'inspirazione. I muscoli della colonna vertebrale estendono e piegano la colonna vertebrale ai lati, la fissano e partecipano alla rotazione del collo e al movimento della coda.
I muscoli dell'arto anteriore sono costituiti dai muscoli del cingolo scapolare e dai muscoli situati direttamente sull'arto stesso. I primi flettono ed estendono gli arti all'altezza delle articolazioni della spalla e del gomito, i secondi attivano l'avambraccio, le dita degli arti anteriori, flettono ed estendono i polsi e uniscono le ossa metacarpali.
I muscoli dell'arto posteriore sono i muscoli della regione dell'anca e i muscoli situati sull'arto stesso. I primi flettono ed estendono gli arti alle articolazioni dell'anca e del ginocchio, attivano l'arto e lo flettono e raddrizzano le articolazioni del ginocchio e del tarso e mettono in movimento le dita delle zampe posteriori.
Il movimento è una necessità biologica per lo sviluppo e il mantenimento dell’attività vitale del corpo di un cane. Il cane si muove con andature diverse, che dipendono dalla velocità e dalle condizioni del terreno. La corsa consiste in morbide spinte successive di arti alternati o lanci bruschi, in cui, oltre agli arti, vengono coinvolte in sequenza altre parti del corpo del cane (parte bassa della schiena, schiena, collo, ecc.).
Le diverse andature (passo, trotto, galoppo, galoppo) dipendono dalla combinazione dei movimenti delle gambe. Il più economico dal punto di vista energetico è il galoppo, in cui, dopo una spinta dell'arto posteriore anteriore, il corpo del cane rimane sospeso in aria, "percorrendo" parte del percorso (Fig. 4). Nel galoppo questa fase è più lunga che nel trotto, e la fase di appoggio degli arti a terra è più breve, quindi i muscoli sono meno tesi. Un elemento del galoppo è anche un salto, caratterizzato da una spinta più forte degli arti posteriori e da un movimento in avanti più brusco degli arti anteriori.
Un galoppo particolarmente veloce sotto forma di lancio rapido su brevi distanze è chiamato preda. Si differenzia dal galoppo per gli scatti verticali più acuti della schiena e della vita e per l'estensione degli arti posteriori davanti a quelli anteriori.

Figura 4. Schema di un cane al galoppo.
I cani da caccia raramente si muovono al trotto nella loro forma pura. Solo quando il movimento è costretto a rallentare il galoppo si alterna al trotto.
Le condizioni principali per una corsa veloce e lunga sono il corretto posizionamento degli arti anteriori e posteriori e il buon sviluppo della loro muscolatura. Le elevate velocità di ricerca dei cani da caccia richiedono grandi quantità di energia e, quindi, la sua rapida compensazione, che avviene a causa della temperatura corporea costantemente elevata del cane (39°C).
Il sistema respiratorio, strettamente connesso al sistema circolatorio, assicura il ricevimento dell'ossigeno dall'aria atmosferica e la rimozione dell'anidride carbonica che si accumula nel processo di scambio gassoso. È costituito dalle vie respiratorie (cavità nasale, laringe, trachea, bronchi) e dai polmoni. Parte degli organi respiratori svolge anche alcune funzioni correlate. Pertanto, la cavità nasale è anche un organo dell'olfatto e la laringe isola le vie respiratorie dall'esofago.
La cavità nasale del cane è costituita da una struttura ossea e cartilaginea. Il naso, che è la parte d'uscita delle vie respiratorie del cane, è sempre umido a causa della secrezione secreta sulla sua superficie, con l'evaporazione che ne riduce la temperatura, e quindi in un cane sano è sempre fresco.
La cavità nasale è divisa dal setto nasale in due metà, ciascuna delle quali è divisa dai turbinati in 4 passaggi nasali. I seni nasali comunicano anche con la cavità nasale. Le superfici della cavità nasale, dei turbinati e dei seni paranasali sono ricoperte da una membrana mucosa, le cui ghiandole secernono una secrezione che idrata l'aria inalata. I nervi olfattivi sono ramificati nella mucosa della cavità nasale e nei turbinati paranasali. Passando attraverso la cavità nasale, l'aria atmosferica viene riscaldata a 30-32°C, ripulita dalle particelle estranee in essa sospese, e contemporaneamente vengono percepite ed esaminate le altre sostanze gassose e particelle odorose che la accompagnano. La cavità nasale comunica con la cavità orale attraverso il canale nasopalatino. Poi va in gola.
La laringe è un complesso organo muscolo-cartilagineo - la sezione iniziale del tubo respiratorio, che svolge le funzioni di un condotto d'aria, un isolante delle vie respiratorie dall'esofago del produttore del suono. Nella parte centrale, più stretta, della laringe si trovano le corde vocali, che formano la glottide.
Una continuazione della laringe è la trachea, che si ramifica nei bronchi principali destro e sinistro. Il diametro medio del bronco principale destro supera il diametro del sinistro, il che è associato ad un aumento del volume del polmone destro di circa il 25% rispetto al sinistro. Ciascun bronco principale è costituito da bronchi lobari che si collegano ai corrispondenti lobi dei polmoni.
I polmoni (destro e sinistro) sono l’organo principale dell’apparato respiratorio dell’animale, nel quale avviene lo scambio gassoso necessario all’organismo. Situato nella cavità toracica, ciascun polmone è costituito da lobi distinti. La cavità toracica e i polmoni sono ricoperti da una membrana sierosa: la pleura parietale e polmonare. Il sistema circolatorio dei polmoni fornisce loro non solo sangue arterioso ma anche venoso.
I bronchi sono divisi in rami, le cui pareti portano numerose piccole sacche: gli alveoli polmonari. In essi avviene lo scambio diffusivo necessario al corpo dell’animale tra l’aria inspirata e il sangue circolante. Quando espiri, l'anidride carbonica viene rimossa.
La frequenza respiratoria è regolata dal centro respiratorio del midollo allungato, che è altamente sensibile al contenuto di anidride carbonica nel sangue. A riposo, un cane di taglia media inala 0,5 litri alla volta. aria; frequenza respiratoria: 12 respiri al minuto. All'aumentare dell'attività del corpo, il numero di respiri aumenta fino a 30. Con l'aumento del lavoro muscolare, il cane inspira fino a 30 litri al minuto. aria.
Il sistema digestivo serve per la lavorazione meccanica e successiva chimica del cibo in uno stato in cui i nutrienti in esso contenuti possono essere assorbiti nel sangue e assorbiti dalle cellule del corpo (Fig. 5). Rimuove anche i residui di cibo non digerito dal corpo.

Figura 5. Disposizione degli organi: 1 - cavità orale; 2 - faringe; 3 - esofago; 4 - stomaco; 5 - fegato; 6 - pancreas; 7 - intestino tenue, 8, 9, 10 - intestino crasso.
Ci sono 4 sezioni nell'apparato digerente: la cavità orale e la faringe; esofageo-gastrico; fegato, pancreas e intestino tenue; intestino crasso.
L'inizio del tratto digestivo è la cavità orale, dove il cibo viene frantumato, inumidito con la saliva, mescolato con la partecipazione della lingua e inviato nell'esofago mediante il movimento della deglutizione. Il cane seleziona il cibo solido con i denti e il cibo liquido con la lingua. Le labbra non prendono quasi alcun ruolo nella cattura del cibo.
La lingua è un organo muscolare mobile coinvolto nella lappatura, miscelazione e deglutizione del cibo, nella termoregolazione del corpo e nella produzione dei suoni. Allo stesso tempo è anche un organo del gusto. La parte superiore della mucosa della lingua ha una superficie ruvida che facilita la ritenzione e la miscelazione del cibo.
Le ghiandole salivari sono rappresentate da tre paia di ghiandole parotidee, sottomandibolari e sublinguali. La saliva è una miscela di secrezioni di queste ghiandole, la cui natura e intensità dipendono dal gusto del cibo e dal grado di sazietà del cane. Viene secreta più saliva per il cibo secco e meno per il cibo liquido (una reazione simile alla fame e alla sazietà). La saliva del cane non contiene enzimi e quindi il cibo non subisce alcuna decomposizione chimica nella cavità orale.
I denti sono organi forti, simili a ossa. Servono per tritare e frantumare il cibo, catturare e recuperare la selvaggina catturata, trattenere gli animali feriti e proteggerli. Ogni dente è costituito da una corona, un collo e una radice, nascosti nell'alveolo dentale della gengiva.
I cani da caccia, indipendentemente dalla razza, hanno 42 denti, di cui 12 incisivi, 4 canini, 16 falsi molari (premolari) e 10 veri molari (molari). Ci sono 20 denti sulla mascella superiore, 22 su quella inferiore (Fig. 6). I quarti premolari della mascella superiore e i primi molari della mascella inferiore sono chiamati denti carnivori. Gli incisivi sono divisi in ganci, medi ed estremi (bordi).
I cuccioli iniziano a sviluppare i denti primari a 3 settimane di età: canini primari, incisivi superiori e quarti premolari inferiori. Entro la fine della 4a settimana sono spuntati gli incisivi primari inferiori, il quarto premolare superiore e il terzo inferiore. Entro i 3,5 mesi di età, gli incisivi primari vengono sostituiti, i molari sono permanenti. Entro 4 mesi Dovrebbero essere presenti tutti i denti da latte e dovrebbero apparire i denti permanenti: i primi due premolari e molari. A 5 mesi vengono sostituiti i canini permanenti e i quarti premolari superiori e spuntano i secondi molari permanenti inferiori. A 6 mesi Tutti i denti permanenti crescono tranne i terzi molari. Entro 7-8 mesi. il cane deve avere 42 denti.

Figura 6. Denti: i1, i2, i3 - incisivi; C - zanne; P1, P2, P3, P4 - premolari; M1, M2, M3 - molari.
La faringe è un organo muscolare membranoso comune al tratto digerente e respiratorio. È collegato alla cavità orale tramite un'ampia faringe e alla cavità nasale tramite aperture: le coane. La faringe prosegue con l'esofago, un tubo muscolare che trasporta il cibo dalla faringe allo stomaco.
La faringe e l'esofago trasportano il cibo dalla bocca allo stomaco, la prima parte del tratto digestivo dove il cibo si accumula, si liquefa e si mescola. Lo stomaco è la parte di questo tratto simile a una sacca, il cui volume varia a seconda del riempimento. Si trova nella parte anteriore sinistra della cavità addominale. Nelle pareti dello stomaco ci sono ghiandole che secernono succo gastrico contenente acido cloridrico ed enzimi. Sotto l'influenza del succo gastrico, avviene la digestione iniziale del cibo. Il ciclo di digestione dipende dalla sua composizione e raggiunge le 10-12 ore per la carne e le 4-6 ore per gli alimenti vegetali. La capacità dello stomaco è di 0,6 litri. nei cani di piccola taglia e 2,5-3,5 l. a quelli medi.
Il cibo processato nello stomaco si sposta in porzioni sotto forma di pappa nell'intestino tenue, costituito da duodeno, digiuno e ileo. Nel duodeno il cibo è esposto ai succhi biliari, pancreatici e intestinali.
Nel digiuno e nell'ileo si formano prodotti della degradazione di proteine, grassi e carboidrati, che vengono assorbiti dall'intestino tenue nel sangue e nella linfa. La lunghezza dell'intestino crasso è molte volte inferiore alla lunghezza dell'intestino tenue. È costituito dal cieco, dal colon e dal retto e serve a raccogliere, compattare e rimuovere i residui di cibo non digerito (feci) dal corpo.
La lunghezza totale dell'intestino di un cane è 5-6 volte la lunghezza del suo corpo.
Il fegato è la ghiandola più grande del corpo, composta da 6-7 lobi. Tra di loro c'è la cistifellea, in cui si accumula e viene temporaneamente immagazzinata la bile prodotta dal fegato, che entra nel duodeno durante il processo digestivo. Il pancreas, adiacente a questo intestino, secerne il succo pancreatico nel sistema digestivo e direttamente nel sangue: l'ormone insulina.
Il sistema circolatorio è costituito dal cuore, dai vasi sanguigni e linfatici e dai nodi, nonché dalla milza e dal midollo osseo rosso, che sono organi che producono sangue. La funzione principale dell'intero sistema è la fornitura di nutrienti, ossigeno e ormoni alle cellule del corpo, nonché la rimozione dell'anidride carbonica e di altri prodotti di scarto. Queste funzioni sono svolte dal sangue e dalla linfa.
Il sangue costituisce il 6-8% del peso corporeo di un cane. È costituito da plasma liquido trasparente e globuli rossi, leucociti e piastrine in sospensione.
Gli eritrociti, o globuli rossi a forma di disco, sono pieni di una sostanza rossa: l'emoglobina, che trasporta l'ossigeno dai polmoni alle cellule dei tessuti. I globuli rossi si formano nel midollo osseo delle ossa lunghe. I globuli rossi obsoleti vengono distrutti nel fegato e dai prodotti di degradazione si forma la bile. I leucociti, o globuli bianchi, catturano particelle e microbi estranei e dannosi per l'organismo e li distruggono con l'aiuto di enzimi. Le piastrine sono piastrine piatte del sangue che svolgono un ruolo importante nella coagulazione del sangue.
Un'importante proprietà protettiva del sangue è la sua capacità di sviluppare l'immunità: la produzione di sostanze che rendono il corpo immune da una serie di malattie. L'immunità può essere raggiunta anche introducendo artificialmente vaccini nel sangue del cane, microbi particolarmente indeboliti o le loro tossine.
Il cuore è l'organo centrale del sistema circolatorio, che spinge il sangue in movimento. Questo è un organo muscolare diviso da un setto in due metà: destra e sinistra. Ciascuno di essi, a sua volta, è diviso da valvole posizionate trasversalmente in due camere: l'atrio e il ventricolo.
L'attività del cuore si esprime in successive contrazioni e rilassamenti accoppiati degli atri e dei ventricoli. Quando gli atri si contraggono, i ventricoli si rilassano, mentre quando i ventricoli si contraggono, gli atri si rilassano. Grazie a questo ritmo, il cuore ha bisogno di lavorare solo per 8 ore durante il giorno.Il lavoro del cuore è regolato dal sistema nervoso, rallentandone o accelerandone il ritmo. La frequenza cardiaca normale per i cani adulti è di 70-100 battiti al minuto e per i cuccioli di 110-120 battiti al minuto.
Il sangue circola attraverso due circoli di circolazione sanguigna: piccolo (polmonare) e grande (corporeo). La circolazione polmonare inizia dal ventricolo destro del cuore, da dove il sangue venoso viene inviato ai polmoni e, liberato dall'anidride carbonica e arricchito di ossigeno, ritorna nell'atrio sinistro. Dal ventricolo sinistro del cuore inizia un ampio circolo di circolazione sanguigna, attraverso le cui arterie il sangue viene consegnato alle cellule dei tessuti di tutto il corpo e attraverso le vene ritorna nell'atrio destro. Il ciclo circolatorio dura circa 16 secondi nei cani.
Esistono tre tipi di vasi sanguigni: arterie, vene e capillari. Le arterie trasportano sangue arricchito di ossigeno e sostanze nutritive in tutto il corpo. Passando attraverso i capillari, cede ossigeno e sostanze nutritive alle cellule e, prelevando da esse anidride carbonica e prodotti metabolici, entra nelle vene. Le vene restituiscono il sangue al cuore.
La linfa è un fluido tissutale, quasi trasparente, giallastro, contenente plasma sanguigno e prodotti di scarto delle cellule e che costituisce 1/5-1/6 del peso corporeo. Il plasma sanguigno riempie gli spazi interstiziali e intercellulari attraverso le pareti dei capillari, formando in essi un fluido interstiziale, dal quale le cellule ricevono i nutrienti necessari e vi secernono i prodotti della loro attività vitale. La linfa è costituita da elementi del sangue: i linfociti ed è un complemento del sangue, ma si muove 60 volte più lentamente. La composizione della linfa è soggetta a modifiche e dipende dalla natura del metabolismo nelle cellule. I vasi linfatici passano attraverso i linfonodi, che producono linfociti (globuli bianchi) e agiscono come filtri meccanici e biologici che intrappolano i microbi patogeni che entrano nel corpo.
Gli organi emopoietici comprendono la milza e il midollo osseo rosso. La milza è un grande linfonodo attraverso il quale scorre il sangue. La milza, essendo un serbatoio di sangue nel corpo, funge da luogo per la formazione dei linfociti e la distruzione dei globuli rossi obsoleti. Aiuta anche il midollo osseo nella produzione di globuli rossi quando vi è una grande perdita di essi nel sangue. La perdita di globuli bianchi (linfociti) è sostituita dai linfonodi e dal midollo osseo rosso.
Il sistema nervoso regola tutti i processi che si verificano nel corpo e comunica con l'ambiente esterno. È costituito dal sistema nervoso centrale (midollo spinale e cervello), dal sistema nervoso periferico (ramificazione delle vie nervose e dei tronchi in tutto il corpo) e dal sistema nervoso autonomo, il regolatore dei processi negli organi interni. Gli organi di senso comprendono gli organi dell'olfatto, dell'udito, della vista, del gusto e del tatto.
Il sistema nervoso è un tessuto costituito da neuroni e neuroglia. Un neurone è costituito da una cellula nervosa e da numerose fibre nervose. I loro rami terminali, in contatto tra loro, formano catene nervose lungo le quali si diffondono le eccitazioni. Esistono due tipi di nervi. Alcuni di essi, che trasmettono la stimolazione nervosa dalla periferia al centro, sono detti sensibili, mentre altri, che trasmettono la stimolazione nervosa dal centro alla periferia, sono detti motori (secretori). La neuroglia forma una guaina attorno a ciascun neurone in cui si trovano i vasi sanguigni.
Il sistema nervoso centrale è costituito dal midollo spinale e dal cervello. Il midollo spinale è un tronco cilindrico che passa attraverso il canale midollare della colonna vertebrale. Ha origine dal cervello e si estende fino alla 6-7a vertebra lombare, da dove, trasformandosi in un filo, raggiunge la spina caudale. È protetto da forti traumi dal liquido cerebrospinale che riempie lo spazio esterno del canale spinale; Inoltre equalizza la pressione intracranica. Nelle regioni cervicale e lombare il midollo spinale è ispessito. All'interno del tronco encefalico si trova la materia grigia circondata dalla sostanza bianca del midollo spinale. Da esso, attraverso le aperture delle vertebre, le fibre nervose divergono simmetricamente in entrambe le direzioni, formando il sistema nervoso periferico.
Il midollo spinale del cane è composto da 36-37 segmenti. Contengono centri di controllo per i movimenti dell'animale e i riflessi degli organi interni. Le funzioni del midollo spinale sono strettamente correlate alle funzioni del cervello.

Figura 7. Cervello (sezione): 1 - midollo allungato; 2 - cervelletto; 3 - emisferi cerebrali; 4 - telencefalo.
Il cervello si trova nella cavità cranica ed è diviso in midollo allungato, cervelletto e cervello (Fig. 7). Le dimensioni e il peso del cervello dipendono dalla taglia del cane. Il suo peso assoluto varia da 35 a 150 g e il suo peso relativo varia da 1/30 a 1/400 del peso corporeo.
Il midollo allungato è simile nella struttura al midollo spinale. Contiene centri cardiaci, respiratori, alimentari e alcuni altri centri nervosi. Effettua tutte le connessioni con il midollo spinale.
Il cervelletto si trova sopra il midollo allungato e controlla il sistema muscolare durante i movimenti complessi del corpo e il suo equilibrio nello spazio.
Il cervello è diviso in mesencefalo, intermedio e prosencefalo. Il mesencefalo funge da autorità intermedia nella trasmissione degli impulsi al prosencefalo, controlla contemporaneamente il movimento degli occhi ed è collegato al canale uditivo. Tutte le vie sensoriali che conducono gli impulsi alla corteccia del prosencefalo sono concentrate nel diencefalo.
Il cervello è costituito da due emisferi, alla periferia dei quali si trova la materia grigia, che forma la corteccia cerebrale. Il numero di cellule nervose nella corteccia cerebrale è di miliardi.
La complessa struttura della corteccia cerebrale è associata alla complessità delle funzioni che svolge. In esso si formano tutti i riflessi condizionati che, insieme al sistema dei riflessi incondizionati, determinano il comportamento del cane. La corteccia di entrambi gli emisferi cerebrali controlla completamente l'attività nervosa superiore del corpo - regola tutte le sue azioni.
Il sistema nervoso periferico è costituito da rami di tronchi nervosi che si estendono dal midollo spinale e dal cervello a tutto il corpo. Ogni nervo spinale lascia il midollo spinale attraverso il corrispondente foro intervertebrale e prende il nome in base alla posizione di questo foro: cervicale, toracico, lombare, ecc. Dopo aver attraversato il foro intervertebrale, si divide in tre rami, due dei quali hanno sensoriali e fibre motorie. Quelli attraverso i quali l'impulso è diretto al centro sono detti sensibili, e dal centro ai muscoli e alle ghiandole sono detti motori. Il terzo ramo va al sistema nervoso simpatico.
I nervi cranici (olfattivi, ottici, trigeminali, uditivi, ecc.) contengono anche fibre sensoriali, motorie e autonome. Innervano l'azione dei muscoli della testa, degli organi dell'olfatto, della vista, dell'udito e delle ghiandole salivari.
I nervi periferici percepiscono stimoli di vario tipo: meccanici, termici, elettrici, ecc. Hanno eccitabilità in qualsiasi punto della loro intera lunghezza.
Il sistema nervoso autonomo regola i processi che si verificano negli organi interni ed è controllato dal più alto regolatore di tutte le funzioni del corpo: la corteccia cerebrale. Il sistema è diviso in simpatico e parasimpatico. In ciascuno di essi ci sono dipartimenti centrali e periferici. Le fibre del sistema nervoso autonomo sono interrotte da luoghi in cui si accumulano le cellule nervose: i gangli nervosi.
I sistemi nervoso simpatico e parasimpatico sono in interazione antagonista: se il sistema simpatico agisce in modo eccitatorio, allora il sistema parasimpatico inibisce queste azioni. Ciò garantisce l'unità dei processi di funzionamento del sistema nervoso autonomo. Ad esempio, il sistema nervoso simpatico accelera l'attività del cuore e il sistema nervoso parasimpatico la rallenta (altrimenti il cuore non sarebbe in grado di sopportare questa modalità di funzionamento).
Gli organi di senso comprendono gli organi dell'olfatto, dell'udito, della vista, del gusto e del tatto. Attraverso di essi il corpo comunica con l'ambiente. L'impatto dell'ambiente esterno ed interno su un organismo vivente è percepito dai recettori dei corrispondenti organi di senso e viene trasmesso lungo le vie conduttrici ai corrispondenti centri del cervello, dove si forma la risposta del corpo.
Ci sono estero- e interorecettori. I recettori esterni percepiscono le irritazioni provenienti dall'ambiente esterno: gli organi della vista - luce, gli organi dell'udito - suono, gli organi dell'olfatto - odori, gli organi del gusto - sostanze chimiche e gli organi del tatto - irritazioni meccaniche e termiche. Gli interorecettori percepiscono le irritazioni che si verificano nell'ambiente interno del corpo.
Odore. I cani da caccia hanno un senso dell'olfatto ben sviluppato. La percezione dell'olfatto è prodotta da una certa area della mucosa nasale, satura di cellule olfattive. Nei cani da caccia, questa membrana nasale contiene circa 200 milioni di cellule olfattive per 1 cm² di superficie olfattiva della cavità nasale. Un cane ne ha circa 40 volte di più di una persona. Molte razze di cani da caccia sono in grado di percepire concentrazioni molto basse di odori.
Gli odori sono impressi nella memoria del cane; può distinguere fino a 2.500 odori diversi. Tra i sensi, si fida soprattutto dell'olfatto. Dall'odore, il cane determina l'età della pista o del sidka, indica inequivocabilmente la presenza di selvaggina, escludendo così stand vuoti, falsi solchi o lavorando in una buca senza animale.
Udito. Le vibrazioni sonore vengono percepite dall'organo uditivo, costituito dall'orecchio esterno, medio ed interno. Le prime due sezioni servono solo per condurre le vibrazioni sonore all'orecchio interno con l'“apparato” uditivo - la coclea, dove si trovano i recettori uditivi - cellule uditive sensibili. Attraverso i nervi uditivi si collegano al centro uditivo del cervello.
E l'udito dei cani è più sviluppato di quello degli umani. Sono in grado di distinguere suoni con una frequenza fino a 90 kHz, cioè già nella gamma degli ultrasuoni. La capacità dell'apparecchio acustico umano è limitata alla gamma di frequenze da 20 a 60 kHz. I Laika hanno le capacità uditive più sviluppate.
La visione consente al cane di percepire il mondo esterno che lo circonda. L'organo visivo del cane è costituito dal bulbo oculare, dal sistema motorio, dai dispositivi di protezione e ausiliari.
Il bulbo oculare ha la forma di una palla, leggermente appiattita davanti, all'interno della quale si trovano una lente e un corpo vitreo, una massa semiliquida che conduce i raggi luminosi. Una membrana a tre strati copre l'intero bulbo oculare. Nella parte anteriore, questa membrana forma una cornea trasparente. Dietro c'è una piastra rotonda: l'iride, il foro in cui si chiama pupilla. Sotto l'influenza degli stimoli luminosi, l'iride (il suo colore determina il colore dell'occhio) restringe o dilata la pupilla, agendo come una sorta di diaframma. Dietro la pupilla dell'iride c'è il cristallino, un corpo trasparente a forma di lente biconvessa ed è la parte principale dell'occhio che rifrange la luce. Il cristallino cambia la sua convessità, permettendo all'occhio di percepire oggetti a diverse distanze. I muscoli oculari consentono sia al bulbo oculare destro che a quello sinistro di muoversi simultaneamente in una o diverse direzioni.
La retina interna dell'occhio è la sua parte più importante. La parte visiva di questa membrana è costituita da cellule nervose sensibili alla luce che trasmettono gli impulsi nervosi lungo il nervo ottico al centro visivo del cervello.
Gli organi protettivi e ausiliari dell'occhio comprendono le palpebre - pieghe della pelle con ciglia che coprono l'occhio, l'apparato lacrimale - i muscoli oculari. La direzione della visione è determinata dagli assi oculari, che formano un angolo di 92°. Sulla retina degli occhi del cane, il luogo della visione più chiara, non c'è la cosiddetta macula. Pertanto, la vista dei cani è meno sviluppata e la sua acutezza è solitamente insignificante. Ma il cane vede bene gli oggetti in movimento, il cui limite di visibilità è entro 250-350 m, a volte raggiungendo i 500-700 m, mentre i levrieri e gli husky sono più lungimiranti. Di notte e al crepuscolo i cani vedono meglio degli umani. Se un cane abbia la percezione del colore o solo del bianco e nero, questa domanda non è stata ancora risolta dagli scienziati.
Al gusto sono associate sensazioni che stimolano l’appetito del cane e attivano le ghiandole del tratto digestivo. L'organo principale del gusto è la lingua, sulla superficie superiore e sulle parti laterali di cui si trovano le papille gustative. Nel determinare il gusto, le sostanze gustative del cibo disciolte nella saliva, a contatto con le papille gustative, irritano le fibre del nervo gustativo. Lungo di esso, gli impulsi passano attraverso il midollo allungato fino alla corteccia cerebrale, dove viene creata la sensazione del gusto.
Il senso del tatto è una delle funzioni principali della pelle, che forma un'enorme superficie sensibile a diretto contatto con l'ambiente esterno. La percezione degli stimoli esterni è prodotta da numerose fibre nervose incastonate nella pelle. Le sensazioni tattili vengono trasmesse anche dalla mucosa della bocca, del naso, delle labbra, della lingua e dalle vibrisse, peli che rilevano i tocchi più deboli.
Si osserva una forte diminuzione dell'acuità di percezione dei sensi, ad eccezione dell'olfatto, associata all'inizio dell'invecchiamento del corpo del cane.
Il sistema urinario svolge la funzione di rimuovere le sostanze nocive dal corpo (prodotti di scarto trasformati delle cellule, prodotti di decomposizione - urea, acqua in eccesso, sali). Gli organi urinari comprendono i reni, gli ureteri, la vescica e l'uretra. Il processo di minzione è regolato dal centro nervoso nella parte lombosacrale del midollo spinale collegato al cervello.
Gli organi urinari e genitali sono collegati da dotti escretori comuni.
Lo sperma viene espulso attraverso l'uretra del cane maschio durante il rapporto sessuale.
Il sistema degli organi riproduttivi è formato dai genitali del maschio e della femmina. Svolgono funzioni legate alla procreazione - riproduzione.
Gli organi genitali di un cane maschio sono due testicoli (testicoli) nello scroto, collegati tramite i vasi deferenti e il canale urogenitale al pene e alla ghiandola prostatica. Nei testicoli si formano e maturano le cellule riproduttive maschili: gli spermatozoi, costituiti da una testa (nucleo cellulare) e una coda, grazie alla quale si muove il nucleo cellulare. In 1ml. sperma, che contiene i prodotti della secrezione dei testicoli e della prostata, 60.000-100.000 spermatozoi. Durante l'accoppiamento, lo sperma attraverso i vasi deferenti, i tubi, grazie alla loro peristalsi, entra nell'uretra, dove si mescola con la secrezione della ghiandola prostatica (diluisce lo sperma e attiva l'attività degli spermatozoi e del pene). Lo sperma liquefatto dalla secrezione entra nel pene.
I testicoli di un cucciolo appena nato si trovano nella cavità addominale, ma man mano che il cucciolo cresce, scendono nello scroto. Il mancato ingresso di uno o entrambi i testicoli nello scroto (criptorchidismo) è un difetto squalificante. I maschi con questo difetto sono chiamati rispettivamente nutres o semi-criptorchide e criptorchide.
I genitali femminili sono costituiti da due ovaie, ovidotti, utero e vagina. Le ovaie sono ghiandole pari di forma arrotondata, di dimensioni notevolmente più piccole rispetto ai testicoli di un cane maschio. In essi si formano e maturano le cellule riproduttive femminili - le uova. Ciascuna ovaia è costituita da due strati: quello esterno (follicolare) e quello interno (vascolare). Lo strato esterno contiene un gran numero di follicoli, sacche piene di liquido in cui si sviluppano le uova. I follicoli nell'ovaio si trovano in vari stadi di sviluppo e solo gli ovuli maturi entrano nell'ovidotto. Una cagna sviluppa contemporaneamente più follicoli in ciascuna ovaia. Nei follicoli sviluppati, a un certo punto, la quantità di liquido inizia ad aumentare, il loro guscio scoppia e le uova mature con fluido follicolare entrano nella cavità corporea e da lì negli ovidotti dotati di imbuti. Lì vengono fecondati dallo sperma. Al posto del follicolo fuso dopo la rottura si forma il cosiddetto corpo luteo. Durante la gravidanza rilascia ormoni speciali nel sangue, che fungono da agenti causali dei processi nell'utero dopo la fecondazione dell'uovo. Se l'ovulo non viene fecondato, il corpo luteo cessa di funzionare dopo pochi giorni.
Come risultato della contrazione peristaltica degli ovidotti e del movimento delle ciglia dello strato ciliato della loro mucosa, le uova fecondate passano nell'utero, nella cui parete sono impiantati gli embrioni; È qui che si sviluppano. I muscoli circolari ben sviluppati dell'utero si contraggono durante il parto e spingono fuori il feto maturo attraverso la vagina. La vagina è un organo di copulazione. Il vestibolo della vagina - le labbra (anello) è l'organo genitale esterno della cagnolina.
Nei cani, durante l'accoppiamento, a causa della contrazione delle pareti vaginali, si verificano delle aderenze, il cui significato biologico è che gli spermatozoi possano raggiungere rapidamente le uova ancora negli ovidotti.
Il sistema degli organi di secrezione interna è costituito da ghiandole che producono ormoni, sostanze che entrano nel sangue e nella linfa. Regolano le attività dei singoli organi, dei loro sistemi e del corpo nel suo insieme. Gli organi di secrezione interna comprendono la tiroide e le ghiandole paratiroidi, le ghiandole surrenali, l'appendice cerebrale o la ghiandola pituitaria, il pancreas, le gonadi, ecc.
Il sistema di organi cutanei serve a proteggere il corpo del cane dagli influssi ambientali, dalle irritazioni meccaniche e chimiche. È formato da pelle, pelo, artigli, polpa di zampe, varie ghiandole, ecc.
Le funzioni della pelle sono varie: percettiva (calore, freddo, dolore), protettiva (da irritanti meccanici e chimici), termoregolatrice (proteggendo il corpo dal surriscaldamento o dall'ipotermia), escretoria (attraverso le ghiandole). La pelle è composta da tre strati: la cuticola (epidermide), la pelle vera e propria (derma) e lo strato sottocutaneo (tessuto sottocutaneo). L'epidermide è lo strato superficiale della pelle costituito da epitelio squamoso stratificato, i cui strati esterni diventano cheratinizzati. Nello strato profondo dell'epidermide ci sono cellule pigmentate che conferiscono alla pelle diversi colori.
La pelle stessa, o derma, è costituita da un forte tessuto connettivo fibroso. Contiene ghiandole della pelle, radici dei capelli, vasi sanguigni e linfatici e fibre nervose. Il derma, senza confini netti, passa nello strato sottocutaneo, costituito da tessuto connettivo lasso, nella fibra di cui si deposita il grasso sottocutaneo. Lo strato sottocutaneo rende la pelle morbida e mobile e i depositi di grasso le forniscono i nutrienti necessari e proteggono il corpo dall'ipotermia. Lo spessore della pelle varia nelle diverse parti del corpo del cane. Sulla schiena, ad esempio, è più spesso che sulla pancia.
Il mantello protegge la pelle dall'esterno dagli effetti negativi dell'ambiente esterno e mantiene costante la normale temperatura corporea del cane. È diviso in guardia e sottopelo. Il pelo ricopre tutto il corpo del cane, ad eccezione del naso e delle zampe. Lo scroto dei cani maschi è debolmente ricoperto di pelo.
La lana (capelli) è una formazione cheratinizzata, elastica, filiforme, costituita da un'asta che si alza liberamente sopra la superficie della pelle e una radice nascosta nel suo spessore. La radice del capello termina con un ispessimento: un bulbo. Grazie ai nutrienti in esso contenuti, avviene la crescita dei capelli.
Il pelo esce dalla pelle in ciuffi: pelo di guardia (coprente, lungo) 3 pezzi ciascuno, sottopelo (corto, morbido) 6-12 pezzi ciascuno. Le radici del pelo sono dirette principalmente obliquamente verso la superficie della pelle, quindi la loro anche gli alberi giacciono obliquamente. I capelli hanno "sollevatori di capelli" - fibre muscolari, a causa della contrazione dei quali i capelli si alzano e il sebo viene secreto dalle ghiandole sebacee. Quest'ultimo, sporgendo sulla superficie della pelle, la lubrifica e i capelli. Ciò rende la cuticola più elastica, la penetrazione dell'umidità nel corpo e la sua evaporazione dai tessuti è limitata al minimo. Questo stesso grasso rende la lana elastica, lucida e idrorepellente. Con il passare del tempo, i capelli invecchiano e cadono, sostituiti da nuovi. Questo fenomeno è chiamato muta: nei cani avviene stagionalmente. Le condizioni di utilizzo della caccia e di detenzione di un cane determinano l'adattabilità vitale del suo mantello.
In alcune zone della pelle del cane crescono peli lunghi e rigidi che catturano i tocchi più deboli: le vibrisse. Appartengono agli organi del tatto e si trovano in piccoli gruppi sulle labbra superiori e inferiori, sul mento e sulle sopracciglia.
Le briciole sono ispessimenti della pelle a forma di cuscino sulla superficie posteriore delle zampe. Servono a sostenere le zampe, essendo allo stesso tempo organi del tatto. La superficie ruvida e glabra delle briciole garantisce un contatto affidabile della zampa con il terreno. Inoltre, sono ammortizzatori che intervengono quando il cane si muove e proteggono le zampe da eventuali danni. Ci sono briciole carpali, metacarpali e digitali delle zampe. Le briciole contengono ghiandole sudoripare, le uniche parti del corpo del cane che secernono sudore; il necessario raffreddamento del corpo si ottiene con la respirazione rapida.
L'artiglio è una punta corneo ricurva. Con il suo aiuto, il cane si aggrappa al terreno quando si muove, trattiene il cibo e scava il terreno.
Anche le ghiandole mammarie della cagna (mammelle), che sono funzionalmente collegate ai suoi genitali, sono derivati della pelle del cane. Le ghiandole mammarie si trovano su 2 file, a coppie, sulla parte inferiore delle pareti del torace e dell'addome. Il numero di capezzoli funzionanti in una cagna va da 6 a 10. Quelli più lattiginosi, di regola, sono 2-3 paia di capezzoli posteriori.
Prima della prima gravidanza, le ghiandole mammarie femminili sono poco sviluppate. Dopo l'accoppiamento con un cane maschio, a partire dalla metà della gravidanza, si gonfiano, formano letti di latte e con la nascita del primo cucciolo iniziano a secernere latte. L'allattamento si interrompe 45-55 giorni dopo il parto e i letti cadono.
>>Struttura esterna dei mammiferi usando l'esempio di un cane domestico
Classe mammiferi o animali
Mammiferi- animali che nutrono i loro piccoli con il latte. La maggior parte di loro sono ricoperti di pelo e hanno una temperatura corporea elevata e costante.
§ 66. Struttura esterna dei mammiferi usando l'esempio del cane domestico
Il cane è stato il primo animale domestico. L'uomo l'ha domato nei tempi antichi. Il cane aiutava l'uomo primitivo durante la caccia e custodiva la sua casa. Al giorno d'oggi sono conosciuti cani da lavoro, da caccia e decorativi, nonché bastardi (cani bastardi). I cani aiutano a proteggere i confini della nostra Patria e durante la Grande Guerra Patriottica cercarono i feriti, aiutarono nella ricognizione e nelle comunicazioni. Gli scienziati stanno conducendo ricerche sulle funzioni vitali del corpo dei cani. Un cane è andato nello spazio prima di un uomo.
Corpo del cane, come i cani da pastore o gli husky, snelli e muscolosi. I suoi arti non si trovano ai lati del corpo, come quelli dei rettili, ma sotto il corpo, quindi il corpo dell'animale non tocca il suolo. Il cane cammina appoggiandosi alle dita con forti artigli. Un collo flessibile consente una maggiore mobilità della testa. La bocca dell'animale è limitata da labbra mobili: superiore e inferiore. Sopra il labbro superiore c'è un naso con un paio di aperture nasali esterne: le narici. Gli occhi hanno palpebre ben sviluppate. La membrana nittitante (terza palpebra) di un cane, come tutti gli altri mammiferi, sottosviluppato. Di tutti gli animali, solo i mammiferi hanno un orecchio esterno: il padiglione auricolare. L'orecchio esterno di un cane è grande e mobile.
Veli.
La pelle dei mammiferi è forte ed elastica, nella maggior parte dei casi animali contiene le basi dei peli, che formano i peli caratteristici di questa classe di vertebrati. Ci sono peli spessi e lunghi - il pelo corto e quelli più corti e morbidi - il sottopelo. La tenda ruvida e resistente protegge il sottopelo e la pelle dai danni. Il sottopelo, che trattiene molta aria, trattiene bene il calore corporeo. Oltre alla colonna vertebrale e al sottopelo, gli animali sviluppano grandi peli: gli organi del tatto.
Peli di mammifero, simile piume di uccelli E scaglie di rettili, sono costituiti da sostanza corneo. Due volte all'anno, un cane, come molti altri mammiferi, perde il pelo: parte del suo pelo cade e viene sostituito con uno nuovo. La base del capello si trova all'interno di uno speciale follicolo pilifero, nel quale si aprono i dotti delle vicine ghiandole sebacee. Le loro secrezioni lubrificano la pelle e i capelli, rendendoli elastici e non bagnati dall'acqua.
La pelle della maggior parte degli animali contiene anche ghiandole sudoripare. Il sudore evapora dalla superficie del corpo, raffreddandolo. Insieme al sudore vengono rimossi dal corpo anche il sale in eccesso e l'urea; quindi, le ghiandole sudoripare svolgono il ruolo di ulteriori organi escretori 121 .
Un cane ha poche ghiandole sudoripare e il raffreddamento del corpo si ottiene aumentando la respirazione.
All'estremità delle dita dei mammiferi ci sono artigli, unghie o zoccoli cornuti. Talvolta si sviluppano formazioni cornee anche sulla testa (corna nei rinoceronti, nelle antilopi, nei bovini, ecc.) o sulla coda (ad esempio, scaglie cornee nei ratti).
Lo scheletro dei mammiferi è costituito dalle stesse parti di quelli degli altri vertebrati. 122 . Il cranio degli animali si distingue per un cranio più grande, che è associato alle grandi dimensioni del cervello 123 . È tipico che i mammiferi abbiano 7 vertebre cervicali.


Sia le giraffe dal collo lungo che le balene hanno lo stesso numero di vertebre cervicali. Le vertebre toraciche (di solito 12-15) insieme alle costole e allo sterno formano un torace forte. Le massicce vertebre della regione lombare sono articolate in modo mobile tra loro. In questa sezione, il busto può piegarsi e distendersi. Il numero di vertebre lombari varia a seconda della specie (2-9), il cane ne ha 6. La colonna sacrale (3-4 vertebre) si fonde con le ossa pelviche. Il numero di vertebre nella regione caudale (da tre a diverse dozzine) dipende dalla lunghezza della coda.
La cintura degli arti anteriori dei mammiferi è costituita da due scapole su cui sono attaccate ossa di corvo e due clavicole. Le clavicole del cane non sono sviluppate. La cintura degli arti posteriori - il bacino - è formata da tre paia di ossa pelviche. Scheletri di arti in diverse specie di mammiferi e rettili sono simili, ma i dettagli della loro struttura sono diversi nelle diverse specie e dipendono dalle condizioni di vita dell'animale.
Muscoli.
La maggior parte dei mammiferi, compresi i cani, hanno muscoli particolarmente sviluppati nella schiena, negli arti e nei cingoli. Il cane può correre con ampi balzi, piegandosi e raddrizzando il corpo, spingendosi da terra alternativamente con le zampe anteriori e posteriori. Muscoli forti muovono la mascella inferiore 124 . - Stringendo le mascelle, armato di denti, il cane trattiene saldamente la sua preda.
1. Indicare le somiglianze e le differenze nella struttura esterna di rettili e mammiferi (ad eslucertole
e cani).
2. Qual è il vantaggio della disposizione degli arti dei mammiferi rispetto ai rettili?
3. Secondo il disegno 121
Raccontaci la struttura del tegumento di un cane e il suo significato.
4. Assegna un nome alle ghiandole cutanee di un cane (Fig. 121
)
5. Qual è il significato dei capelli? Perché non è sviluppato nelle balene e nei delfini?
6. Da quali parti sono costituite la colonna vertebrale, gli arti anteriori e posteriori dei mammiferi? (Per la risposta, utilizzare il diagramma con lo scheletro brulicante di un cane nella figura 122
.)
Osserva i movimenti del cane o del gatto quando corre, salta e mangia il cibo. Quali muscoli sono più sviluppati in un cane? Perché?
Biologia: Animali: libro di testo. per la 7a elementare. media scuola / B. E. Bykhovsky, E. V. Kozlova, A. S. Monchadsky e altri; Sotto. ed. M. A. Kozlova. - 23a ed. - M.: Educazione, 2003. - 256 p.: ill.
Calendario e pianificazione tematica in biologia, video in biologia online, download di biologia a scuola
Contenuto della lezione appunti di lezione metodi di accelerazione della presentazione delle lezioni con frame di supporto tecnologie interattive Pratica compiti ed esercizi autotest workshop, corsi di formazione, casi, ricerche compiti a casa domande di discussione domande retoriche degli studenti Illustrazioni audio, video clip e contenuti multimediali fotografie, immagini, grafica, tabelle, diagrammi, umorismo, aneddoti, barzellette, fumetti, parabole, detti, cruciverba, citazioni Componenti aggiuntivi abstract articoli trucchi per i curiosi presepi libri di testo dizionario base e aggiuntivo dei termini altro Miglioramento di libri di testo e lezionicorreggere gli errori nel libro di testo aggiornamento di un frammento in un libro di testo, elementi di innovazione nella lezione, sostituzione di conoscenze obsolete con nuove Solo per insegnanti lezioni perfette piano di calendario per l'anno; raccomandazioni metodologiche; programmi di discussione Lezioni integrateI cani sono mammiferi, quindi il loro scheletro è tipico dei mammiferi ed è costituito dalle stesse sezioni.
I mammiferi hanno un cranio più grande rispetto, ad esempio, ai rettili.
I mammiferi sono caratterizzati dalla presenza 7 vertebre cervicali. Sia le giraffe, che hanno un collo molto lungo, sia le balene, che non ne hanno affatto, hanno lo stesso numero di vertebre cervicali. Le vertebre toraciche (di solito 12-15) insieme alle costole e allo sterno formano il torace.
La colonna lombare è formata da vertebre massicce e articolate in modo mobile che forniscono flessione ed estensione in questa sezione della colonna vertebrale. In questo modo il busto può piegarsi e distendersi. Il numero di vertebre lombari nelle diverse specie di mammiferi può variare da 2 a 9, nel cane ce ne sono 6. La colonna sacrale è composta da 3-4 vertebre, che sono collegate alle ossa pelviche.
Il numero di vertebre nella regione caudale nei cani può variare da 3 a diverse dozzine, il che determina la lunghezza della coda.
La cintura degli arti anteriori dei mammiferi è costituita da due scapole, ossa di corvo fuse con esse e un paio di clavicole sottosviluppate.
La cintura degli arti posteriori - il bacino - nel cane è formata da 3 paia di ossa pelviche. La maggior parte dei mammiferi, compresi i cani, hanno muscoli particolarmente sviluppati nella schiena e negli arti.
La bocca del cane, come quella degli altri mammiferi, contiene la lingua e i denti. La lingua viene utilizzata per determinare il gusto del cibo: la sua superficie è ricoperta da numerose papille, che contengono le terminazioni dei nervi del gusto. La lingua mobile muove il cibo intorno alla bocca, il che aiuta a bagnarlo con la saliva secreta dalle ghiandole salivari. I denti dei mammiferi hanno radici con le quali si rafforzano nelle cavità delle mascelle. Ogni dente è costituito da dentina ed è ricoperto esternamente da smalto resistente. Nei mammiferi, i denti hanno strutture diverse associate a uno scopo specifico. Nella parte anteriore delle mascelle del cane ci sono degli incisivi, su entrambi i lati dei quali ci sono le zanne. Nella profondità della bocca ci sono i molari.
Molto sviluppati sono anche i muscoli della mascella inferiore, grazie ai quali il cane è in grado di trattenere saldamente la preda
Scheletro di un cane: 1 – mascella superiore; 2 – mascella inferiore; 3 – cranio; 4 – osso parietale; 5 – protuberanza occipitale; 6 – vertebre cervicali; 7 – vertebra toracica; 8 – vertebre lombari; 9 – vertebre caudali; 10 – scapole; 11 – omero; 12 – ossa dell'avambraccio; 13 – ossa carpali; 14 – metacarpo; 15 – falangi delle dita; 16 – costole; 17 – cartilagini costali; 18 – sterno; 19 – osso pelvico; 20 – articolazione dell'anca; 21 – femore; 22 – articolazione del ginocchio; 23 – tibia; 24 – perone; 25 – calcagno; 26 – garretto; 27 – tarso; 28 – metatarso; 29 – dita
I cuccioli sviluppano prima i denti da latte, che poi cadono e vengono sostituiti dai denti permanenti.
Tutti i denti di un cane hanno uno scopo. Usa i suoi molari per strappare grossi pezzi di carne.
I molari esterni hanno punte smussate che aiutano a masticare la materia vegetale. Gli incisivi sono progettati per separare la carne dalle ossa.
Lo stomaco del cane, come quello della maggior parte dei mammiferi, è a camera unica; l'intestino è costituito da piccolo, grande e retto. Nell'intestino, il cibo viene digerito sotto l'influenza delle secrezioni delle ghiandole digestive dell'intestino, nonché dei succhi del fegato e del pancreas.
Nel cane, come negli altri mammiferi, la cavità toracica è separata dal setto muscolare addominale - il diaframma, che sporge nella cavità toracica ed è adiacente ai polmoni. Quando i muscoli intercostali e il diaframma si contraggono, il volume del torace aumenta, le costole si spostano in avanti e lateralmente e il diaframma da convesso diventa piatto. In questo momento, la forza della pressione atmosferica spinge l'aria nei polmoni: avviene l'inalazione. Quando le costole scendono, il torace si restringe e l'aria viene espulsa dai polmoni: avviene l'espirazione.

Organi interni del cane: 1 – cavità nasale; 2 – cavità orale; 3 – trachea; 4 – esofago; 5 – polmoni; 6 – cuore; 7 – fegato; 8 – milza; 9 – reni; 10 – intestino tenue; 11 – intestino crasso; 12 – ano; 13 – ghiandole anali; 14 – vescica; 15, 16 – genitali; 16 – cervello; 17 – cervelletto; 18 – midollo spinale
Il cuore del cane ha quattro camere ed è composto da 2 atri e 2 ventricoli. Il movimento del sangue viene effettuato in 2 circoli di circolazione sanguigna: grande e piccolo.
L'urina viene escreta attraverso i reni, un organo accoppiato situato nella cavità addominale ai lati delle vertebre lombari. L'urina risultante scorre attraverso 2 ureteri nella vescica e da lì viene periodicamente scaricata attraverso l'uretra.
Il metabolismo nei mammiferi, a causa dell'elevato sviluppo dei sistemi respiratorio e circolatorio, avviene ad alta velocità. La temperatura corporea dei mammiferi è costante.
Il cervello dei cani, come gli altri mammiferi, è composto da 2 emisferi. Gli emisferi cerebrali hanno uno strato di cellule nervose che formano la corteccia cerebrale.
In molti mammiferi, compresi i cani, la corteccia cerebrale è così ingrandita da formare pieghe-giri, e maggiori sono le convoluzioni, migliore è la corteccia cerebrale sviluppata e più cellule nervose contiene. Il cervelletto è ben sviluppato e, come gli emisferi cerebrali, presenta molte circonvoluzioni. Questa parte del cervello coordina i movimenti complessi dei mammiferi.
La temperatura corporea normale di un cane è di 37–38 °C; i cuccioli di età inferiore a 6 mesi hanno una temperatura media di 0,5 °C superiore a quella dei cani adulti.
I cani hanno 5 sensi: olfatto, udito, vista, tatto e gusto, ma non sono ugualmente sviluppati.
I cani, come la maggior parte dei mammiferi terrestri, hanno un buon senso dell'olfatto, che li aiuta a rintracciare la preda o a individuare un altro cane dall'odore, anche a notevole distanza. Anche l'udito della maggior parte dei cani è ben sviluppato, ciò è facilitato dalle orecchie mobili che catturano il suono.
Gli organi del tatto nei cani sono speciali peli lunghi e rigidi, le cosiddette vibrisse, la maggior parte dei quali si trovano vicino al naso e agli occhi.
Avvicinando la testa a qualsiasi oggetto, i mammiferi lo annusano, lo esaminano e lo toccano contemporaneamente. Il comportamento dei cani, insieme agli istinti complessi, è in gran parte determinato da un'attività nervosa superiore basata su riflessi condizionati.
Subito dopo la nascita, la cerchia sociale del cucciolo è limitata alla madre e agli altri cuccioli, tra i quali acquisisce le prime capacità di comunicare con il mondo esterno. Man mano che i cuccioli crescono, la loro esperienza personale con l’ambiente aumenta continuamente.
I cambiamenti nell'ambiente fanno sì che i cani sviluppino costantemente nuovi riflessi condizionati e quelli che non sono rinforzati dagli stimoli scompaiono. Questa capacità consente ai cani di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali.
I giochi per cuccioli (lotta, inseguimento, salto, corsa) servono come buon addestramento e contribuiscono allo sviluppo delle tecniche di attacco e difesa individuali.
| |
Una conoscenza generale dell'anatomia del corpo di un cane è molto importante per qualsiasi proprietario di cane: un allevatore, un allevatore o un semplice allevatore. L'anatomia studia la struttura esterna ed interna del corpo di un cane. La struttura interna è costituita dal sistema scheletrico e dagli organi interni. È questa conoscenza, combinata con la fisiologia, che può aiutare, ad esempio, a fornire il primo soccorso tempestivo a un animale domestico o a valutare correttamente l’aspetto esteriore di un cane.
Parti anatomiche del corpo di un cane
Le caratteristiche della posizione delle varie parti del corpo, del fisico e dell'aspetto generale del cane in conformità con le caratteristiche della razza sono chiamate esterne. Da valutare l'esterno Anatomicamente, ci sono diverse parti del corpo di un cane:
- Testa. Vengono valutati il cranio e il muso, gli occhi, le orecchie e il sistema dentale.
- Torso. Lungo la linea superiore osservare il garrese, il dorso, il lombo, la groppa e la coda. Il torace e l'addome vengono valutati lungo la linea di fondo.
- Arti. Presentato fronte e retro.
La conoscenza delle caratteristiche esterne è particolarmente necessaria per i proprietari di cani di razza. Aiuta a controllare, preservare e sviluppare le razze canine.
Sistema scheletrico
Lo studio dell'anatomia è necessario iniziamo considerando il sistema scheletrico. Lo scheletro è la base ossea del corpo di un cane. Lo sviluppo e la produttività del corpo del cane nel suo insieme dipendono dalle sue condizioni. Il sistema scheletrico, insieme alle articolazioni, ai legamenti, ai muscoli e ai tendini, costituisce il sistema muscolo-scheletrico. Ci sono sezioni assiali e periferiche del sistema scheletrico.
Sezione assiale del sistema
La struttura dello scheletro assile comprende:
- Scull.
- Colonna vertebrale.
- Petto con costole.
 I crani sono dolicocefali (lunghi) o brachicefali (corti). I primi sono tipici delle razze di cani da pastore, doberman, collie, il secondo tipo di cranio è per pechinese, carlino e bulldog. Cranio di cane ha una parte craniale e facciale (muso). Le ossa del cranio, ad eccezione della mascella inferiore, sono collegate in modo fisso. La mobilità della mascella inferiore è dovuta alla necessità di afferrare, trattenere e masticare il cibo. Il sistema dentale partecipa attivamente a questo processo. I cani adulti hanno 42 denti, i cuccioli 28. Ci sono incisivi, canini, premolari e molari. Ai cuccioli mancano i molari e un premolare.
I crani sono dolicocefali (lunghi) o brachicefali (corti). I primi sono tipici delle razze di cani da pastore, doberman, collie, il secondo tipo di cranio è per pechinese, carlino e bulldog. Cranio di cane ha una parte craniale e facciale (muso). Le ossa del cranio, ad eccezione della mascella inferiore, sono collegate in modo fisso. La mobilità della mascella inferiore è dovuta alla necessità di afferrare, trattenere e masticare il cibo. Il sistema dentale partecipa attivamente a questo processo. I cani adulti hanno 42 denti, i cuccioli 28. Ci sono incisivi, canini, premolari e molari. Ai cuccioli mancano i molari e un premolare.
A seconda delle caratteristiche della razza Quando i denti anteriori (incisivi) si occludono, formano un morso definito. Il taglio più preferito e spesso obbligatorio per la maggior parte delle razze è il taglio a forbice, in cui gli incisivi superiori si adattano strettamente dietro quelli inferiori. Nel morso dritto, accettabile per alcuni gruppi di razza, le superfici degli incisivi sono unite dai bordi taglienti. Il morso inferiore si manifesta con una forte sporgenza della mascella superiore davanti alla mascella inferiore, in modo che tra loro si formi un ampio spazio. Il morso inferiore è caratterizzato dalla sporgenza della mascella inferiore, che fa sporgere gli incisivi inferiori davanti a quelli superiori ed è una caratteristica delle razze con muso corto.
La colonna vertebrale di un cane è composta da sette vertebre cervicali, tredici toraciche, sette lombari, tre sacrali e diverse caudali.
La regione cervicale è costituita da sette vertebre cervicali, che iniziano con la prima, l'atlante, e la seconda, l'epistrofea. Il teschio è attaccato a loro e consentono alla testa del cane di muoversi in diverse direzioni.
La regione toracica è rappresentata da tredici vertebre, alle quali sono attaccate costole ricurve di varia lunghezza. Le prime quattro paia di costole si chiudono nell'arco costale, le restanti nove paia si accorciano verso la regione lombare e si piegano liberamente. Le costole servono da protezione per gli organi interni del cane e sono coinvolte nel processo di respirazione.
 La regione lombare è composta da sette segmenti. Il lombo non dovrebbe essere lungo: questo è considerato un grosso inconveniente. Idealmente, è desiderabile che sia corto, convesso e largo, che colleghi in modo affidabile la colonna vertebrale toracica e pelvica e che sia in grado di agire come una molla. Un lombo lungo influenza notevolmente i movimenti del cane, l’andatura diventa fiacca e il posteriore inizia a scodinzolare.
La regione lombare è composta da sette segmenti. Il lombo non dovrebbe essere lungo: questo è considerato un grosso inconveniente. Idealmente, è desiderabile che sia corto, convesso e largo, che colleghi in modo affidabile la colonna vertebrale toracica e pelvica e che sia in grado di agire come una molla. Un lombo lungo influenza notevolmente i movimenti del cane, l’andatura diventa fiacca e il posteriore inizia a scodinzolare.
Tipicamente, i cani hanno 20-23 vertebre caudali. Ci sono anche numeri più piccoli. Per soddisfare lo standard, in alcune razze le vertebre della coda vengono tagliate (ritagliate), lasciando diversi segmenti.
Sistema scheletrico periferico
La sezione è rappresentata dagli arti anteriori e posteriori del cane.
L'arto anteriore è costituito da una scapola, preferibilmente disposta obliquamente, alla quale è attaccato l'omero attraverso l'articolazione gleno-omerale. La spalla è collegata attraverso l'articolazione del gomito alle ossa dell'avambraccio, costituite da due ossa: l'ulna e il radio. Per la maggior parte delle razze, è altamente auspicabile che il punto più basso dell’arco costale raggiunga o sia al di sotto dell’articolazione del gomito . Profondità del torace- uno dei parametri importanti dell'esterno. Un torace abbastanza profondo, di larghezza moderata, crea le basi per un buon sviluppo degli organi toracici interni: cuore, polmoni, vasi sanguigni.
L'articolazione del polso è composta da sette ossa che collegano le ossa dell'avambraccio alle cinque ossa del metacarpo. Gli arti anteriori terminano con le dita, ciascuna di esse è dotata all'estremità di un duro artiglio che non può retrarsi. Quattro dita hanno tre falangi e una ne ha solo due.
L'arto anteriore è attaccato allo scheletro vertebrale tramite muscoli della spalla molto forti. La sporgenza della scapola obliqua, che sale sopra le vertebre toraciche, crea un garrese prominente. Misure dal punto più alto l'altezza al garrese di un cane in posizione tranquilla è un parametro esterno molto importante e per la valutazione viene chiamato “altezza al garrese”. A seconda dello standard di razza accettato, l'altezza al garrese ha un significato diverso. La fluttuazione dell'altezza al garrese in varie razze a volte stupisce semplicemente l'immaginazione con le meraviglie del lavoro di selezione di allevatori e allevatori. La differenza di altezza tra un cagnolino in miniatura e i giganti del mondo canino, alani e levrieri è così grande: da 6,5 cm a 111,8 cm di altezza al garrese.
 La cintura degli arti posteriori inizia dall'articolazione dell'anca, che articola l'intero arto posteriore con l'osso pelvico della colonna vertebrale del cane. L'arto posteriore è costituito dal femore, che tramite l'articolazione del ginocchio è collegato a due ossa della parte inferiore della gamba: la tibia e la tibia.
La cintura degli arti posteriori inizia dall'articolazione dell'anca, che articola l'intero arto posteriore con l'osso pelvico della colonna vertebrale del cane. L'arto posteriore è costituito dal femore, che tramite l'articolazione del ginocchio è collegato a due ossa della parte inferiore della gamba: la tibia e la tibia.
L'articolazione del ginocchio, solitamente impercettibile, svolge una funzione importante nel sistema muscolo-scheletrico del cane. . Raddrizzandosi, dà il via alla spinta y, che produce l'arto posteriore. Questa spinta termina con l'estensione dell'articolazione del garretto (tarso), che collega gli stinchi al metatarso. Il grande osso del tallone è chiaramente visibile sull'articolazione del garretto. Quattro ossa metacarpali, occasionalmente cinque, si trasformano in tre dita falangee, che terminano con forti artigli.
A volte i cuccioli nascono con un quinto dito sull'arto posteriore. Questi speroni sono spesso feriti, quindi vengono rimossi, come prescritto dagli standard di razza. Nelle razze rare, gli speroni vengono lasciati indietro. Tra i Beauceron(Pastore Francese) dovranno essere doppi, la loro assenza comporterà la squalifica del cane. Nel Mastino Tibetano e nel Pointer Italiano gli speroni vengono lasciati su richiesta dell'allevatore o del proprietario.
Struttura interna del corpo di un cane
Il sistema degli organi interni è costituito dai sistemi digestivo, respiratorio, escretore e riproduttivo.
Digestivo
Il suo scopo principale è il consumo, promozione, digestione, assorbimento di cibo e acqua. Partendo dalla bocca con i denti, passa nell'esofago, che è adiacente allo stomaco. Nello stomaco il cibo e l'acqua si mescolano e, con l'aiuto dell'acido cloridrico rilasciato, vengono scomposti in sostanze nutritive (processo di digestione). Andando oltre, il bolo alimentare entra nel duodeno dell'intestino.
L'intestino è l'organo principale per l'ulteriore digestione e l'assorbimento delle particelle scomposte: i nutrienti. Le secrezioni pancreatiche e la bile, il pancreas e rispettivamente il fegato e la cistifellea aprono in esso i loro condotti e secernono le sostanze necessarie alla digestione. Il tratto intestinale è molto lungo, la sua lunghezza va dai due metri e mezzo ai sette metri. L'intestino è diviso in intestino tenue e crasso, che termina nell'ano.
Respiratorio
 Il sistema respiratorio è progettato per lo scambio di gas nei polmoni. L'ossigeno entra nel sangue dall'aria e l'anidride carbonica viene rimossa. Contraendosi e rilassandosi, i muscoli delle costole fanno sì che i polmoni si contraggano per rimuovere l’anidride carbonica e si gonfino per aspirare ossigeno. L'apparato respiratorio è costituito da dalle cavità nasali e orali, dalla laringe, dalla trachea e dai polmoni.
Il sistema respiratorio è progettato per lo scambio di gas nei polmoni. L'ossigeno entra nel sangue dall'aria e l'anidride carbonica viene rimossa. Contraendosi e rilassandosi, i muscoli delle costole fanno sì che i polmoni si contraggano per rimuovere l’anidride carbonica e si gonfino per aspirare ossigeno. L'apparato respiratorio è costituito da dalle cavità nasali e orali, dalla laringe, dalla trachea e dai polmoni.
escretore
Il sistema è rappresentato da due reni con uretere, vescica e uretra. I prodotti finali del metabolismo del sangue nei reni passano attraverso la filtrazione nell'urina, che viene raccolta nella vescica attraverso gli ureteri e periodicamente rimossa dal corpo attraverso l'uretra.
Sistema riproduttivo
Gli organi del sistema riproduttivo servono alla procreazione. La loro struttura è diversa nei diversi sessi. Nei maschi comprende i testicoli situati nello scroto, i vasi deferenti, il pene, ricoperti dal prepuzio . Le femmine hanno un sistema di organi riproduttivi ha una sede interna nel corpo ed è costituito dalle ovaie, dalle tube di Falloppio, dall'utero, dalla vagina e dai genitali esterni.
Gestione dell'intero organismo nel suo complesso
Per controllare tutti i sistemi del corpo vengono utilizzati i sistemi nervoso, circolatorio, immunitario, linfatico, ormonale, cutaneo e sensoriale.
Nervoso
Il sistema è diviso in centrale e vegetativo. È costituito da fibre nervose. Grazie al suo elevato sviluppo, i cani hanno sensi potenziati come l'olfatto, la vista e l'udito. Il sistema nervoso centrale, insieme alla corteccia cerebrale, attraverso riflessi congeniti e acquisiti durante la vita, regola tutti i sistemi del corpo del cane.
Sangue
Il sistema cardiovascolare comprende il cuore e i vasi sanguigni: arterioso, proveniente dal cuore, e venoso, proveniente da questo organo. Il vaso arterioso principale è chiamato aorta. Il sistema cardiovascolare progettato per fornire a tutti gli organi e le cellule del corpo ossigeno e sostanze nutritive e rimuovere i prodotti finali del metabolismo. La posizione del cuore è il petto. Si trova sul lato sinistro di esso.
Organi di senso e pelle
 Le influenze esterne ed interne vengono percepite e analizzate dai sensi. Un cane ha cinque sensi: visivo, uditivo, olfattivo, gustativo e tattile. L'occhio ottico è costituito dall'occhio con la pupilla, i muscoli oculari e i nervi.
Le influenze esterne ed interne vengono percepite e analizzate dai sensi. Un cane ha cinque sensi: visivo, uditivo, olfattivo, gustativo e tattile. L'occhio ottico è costituito dall'occhio con la pupilla, i muscoli oculari e i nervi.
Analizzatore dell'udito include l'orecchio, la cui struttura è tale da non solo percepire le vibrazioni delle onde sonore, trasformandole in suono, ma ha anche la funzione di corretto orientamento nello spazio - equilibrio. L'olfatto nei cani è molto sviluppato, la sua acutezza dipende dalle caratteristiche individuali e dall'addestramento. Le papille gustative si trovano sulla lingua del cane e servono ad analizzare la composizione e la qualità delle sostanze che entrano in bocca.
L’organo cutaneo del tatto rappresenta innanzitutto una barriera tra l’ambiente esterno e il sistema interno del corpo del cane. La funzione tattile protegge gli organi dagli effetti avversi. Composizione della pelle:
- Tessuto sottocutaneo.
- Epidermide.
- La lana è un derivato della pelle.
Conoscenza dell'anatomia del corpo del cane Ci permette di comprendere meglio le ragioni che spingono i nostri animali domestici a comportarsi in un modo o nell'altro.