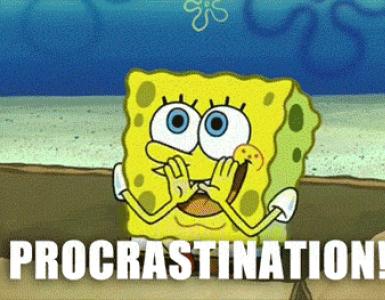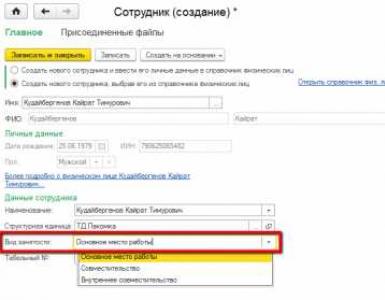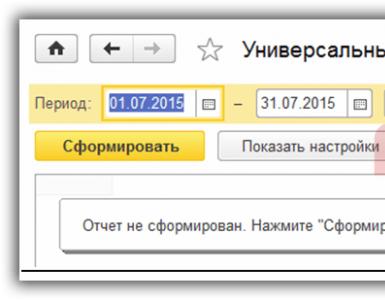Che cos'è l'emolisi del sangue e perché si verifica? Sangue lacca Il sangue lacca si osserva quando la membrana si rompe.
Esce da loro nell'ambiente. Il sangue o una sospensione di globuli rossi si trasforma in un liquido rosso limpido (sangue laccato). L'emolisi può verificarsi nel sangue (emolisi intravascolare) o nelle cellule del sistema reticoloistiocitario (emolisi intracellulare). Normalmente si osserva emolisi intracellulare: alcuni globuli rossi vengono distrutti quotidianamente, principalmente nella milza, e l'emoglobina rilasciata viene convertita in. Con l'emolisi patologica, aumenta la disgregazione degli eritrociti, aumenta la produzione di bilirubina e il suo rilascio, nonché il rilascio di corpi di urobilina e l'urina. Se viene rilasciata molta emoglobina e il sistema reticoloistiocitario non è in grado di far fronte alla sua elaborazione, e. La degradazione dei globuli rossi nel flusso sanguigno avviene in due fasi: cromolisi - rilascio di emoglobina e stromolisi - distruzione. La conseguenza immediata dell'emolisi è.
L'emolisi è la distruzione della membrana dei globuli rossi, accompagnata dal rilascio di emoglobina nel plasma sanguigno, che diventa rosso e diventa trasparente (“sangue lacca”). Lo stroma dei globuli rossi distrutti e privati dell'emoglobina forma le cosiddette “ombre dei globuli rossi”.
La distruzione dei globuli rossi può avvenire nel corpo e all'esterno di esso - in vitro - a seconda di una serie di motivi. Se i globuli rossi si trovano in una soluzione ipotonica, la pressione osmotica al loro interno è maggiore rispetto alla soluzione circostante e l'acqua della soluzione entra nei globuli rossi, provocando un aumento del loro volume e una rottura della membrana. Questa cosiddetta emolisi osmotica avviene quando la pressione osmotica della soluzione che circonda i globuli rossi si riduce della metà rispetto al normale. Con una leggera ipotensione della soluzione salina in cui si trovano i globuli rossi, questi non vengono distrutti, ma si gonfiano e aumentano leggermente di dimensioni.
La concentrazione di NaCl nella soluzione che circonda la cellula, a partire dalla quale inizia l'emolisi, è una misura della cosiddetta stabilità osmotica (resistenza) dei globuli rossi. Nell'uomo, l'emolisi inizia in una soluzione di NaCl allo 0,4% e in una soluzione allo 0,34% tutti i globuli rossi vengono distrutti. In varie condizioni patologiche, la stabilità osmotica degli eritrociti può essere ridotta e può verificarsi un'emolisi completa anche ad elevate concentrazioni di NaCl in soluzione.
L'emolisi può verificarsi anche sotto l'influenza di alcuni composti chimici. Pertanto, è causato da solventi lipidici: etere, cloroformio, benzene, alcool, che distruggono (ad alte concentrazioni) la membrana degli eritrociti. L'emolisi è causata anche da acidi biliari, saponina, pirogallolo e alcune altre sostanze.
La distruzione dei globuli rossi può avvenire all'esterno del corpo sotto l'influenza di forti influenze meccaniche, ad esempio a seguito dell'agitazione di una fiala di sangue. L'emolisi è causata anche dal congelamento e dallo scongelamento ripetuto del sangue.
L'emolisi può verificarsi nel corpo sotto l'influenza del veleno di alcuni serpenti, nonché sotto l'azione di sostanze speciali: le emolisine, formate nel plasma a seguito di ripetute iniezioni di globuli rossi di altri animali nel sangue dell'animale. Le emolisine differiscono nella specificità della specie; agiscono sui globuli rossi solo della specie animale il cui sangue è stato introdotto nell'organismo. Pertanto, il siero del sangue di un coniglio normale emolizza debolmente gli eritrociti di pecora. Dopo diverse iniezioni di eritrociti di pecora nel sangue di coniglio, il siero del sangue di coniglio, quando diluito, emolizza questi eritrociti anche decine di volte.
L'articolo di oggi sarà dedicato a un argomento controverso come l'emolisi. Che cos'è, quali sono i suoi tipi e cosa lo causa: puoi trovare una risposta chiara e informativa a queste domande.
In generale, l'emolisi è un processo durante il quale viene distrutta la membrana dei globuli rossi, che consente all'emoglobina di entrare nel plasma sanguigno. L'emolisi si verifica regolarmente nel nostro corpo e per questo esiste una spiegazione assolutamente naturale. Tutte le strutture del sangue hanno le proprie funzioni che svolgono continuamente. Hanno anche un proprio periodo di “vita”; per i globuli rossi dura fino a 4 mesi. Una volta completati, viaggiano verso la milza, il fegato o il midollo osseo, dove vengono distrutti. Di conseguenza rimangono emoglobina libera e residui di cellule morte, che vengono eliminati dai macrofagi che li utilizzano. Vengono sostituiti da globuli rossi nuovi, giovani e capaci.
Ma a volte, sotto l'influenza di fattori sfavorevoli, i globuli rossi possono morire prima del tempo assegnato, questa condizione sarà chiamata emolisi patologica. Funziona tutto più o meno così:
- In presenza di una sostanza irritante, i globuli rossi aumentano di dimensioni;
- La membrana cellulare non è in grado di allungarsi, poiché questo non rientra nelle sue capacità;
- Si rompe direttamente nel flusso sanguigno e il suo contenuto penetra liberamente nel sangue.
L'emolisi patologica (se esacerbata) può essere vista anche ad occhio nudo. Il pigmento rosso sangue, una volta nel plasma, gli conferisce una tonalità innaturale. Gli esperti caratterizzano questo stato di emolisi come “sangue lacca”, poiché il siero del sangue diventa rosso brillante.
Oltre ai risultati dell'analisi, l'emolisi viene rilevata anche dal quadro clinico caratteristico. Con una forma lieve di emolisi, è poco espressa e presenta i seguenti sintomi:
Con l'aumentare dell'emolisi, dopo otto ore, i segni di debolezza si intensificano, sono possibili forti mal di testa e vomito. Si verificano sintomi come forti dolori al petto, all'addome e soprattutto nella parte bassa della schiena. L'urina diventa rosso scuro. In assenza di cure mediche o trattamento per l’emolisi:
- La temperatura corporea del paziente aumenta fino a 39 gradi;
- Il fegato cambia di dimensioni, cresce, a causa del quale le sue funzioni vengono interrotte, con conseguente insufficienza epatica;
- I reni sono sovraccarichi di prodotti di degradazione dell'emoglobina in arrivo, che minacciano l'insufficienza renale;
- Il volume dell'urina diminuisce drasticamente e presto la sua escrezione si interrompe del tutto.
Tutto ciò comporta anuria con uremia e, come risultato dell'avvelenamento del corpo, la morte del paziente.
Emolisi: tipologie
Come abbiamo già scoperto, la morte dei globuli rossi può essere naturale o patologica.
Se le cellule del sangue sono in qualche modo influenzate dal loro ambiente, rappresentato dal sangue circolante, allora è opportuno supporre che si tratti di emolisi intravascolare. Stiamo parlando della distruzione dei globuli rossi direttamente nel flusso sanguigno. Questo è tipico:
Quando la morte cellulare avviene negli organi ematopoietici: nella milza, nel fegato o nel midollo osseo, si tratta già di emolisi intracellulare. Questo è tipico:
- Microsferocitosi ereditaria;
- Talassemia;
- Anemia di tipo autoimmune.
Nucleopro-Inorganico. Lipidi (ca.
Teid e nuk-subst. (1%)lo H, org. sost. leoalbumina) (circa H, _^"T"~-- org. sottotitoli.) ^^ ~\> Colesterolo Lecy-Cerebrintin e altri sono stati poco studiati. I lipidi G. possono formarsi come risultato dell'effetto sia sulla parte lipidica che su quella proteica dello stroma degli eritrociti. Gli acidi biliari dissolvono i globuli rossi a causa della dissoluzione di lecitina nell'involucro di quest'ultimo; la saponina agisce emoliticamente per la sua forte affinità per il colesterolo (Ransom); etere, cloroformio e farmaci simili sono emolitici per l'affinità degli elementi rossi del sangue per la lecitina (il loro effetto è rilevabile solo in vitro, poiché praticamente queste sostanze non entrano nel sangue in una concentrazione tale da portare a fenomeni emolitici). Anche l'emolisina, prodotta dal bacillo del tetano, distrugge apparentemente la sostanza lecitina dello stroma eritrocitario. Negli esperimenti di Pascucci, le membrane preparate artificialmente impregnate di lecitina, sotto l'influenza dell'emolisina indicata, passavano una soluzione di emoglobina molto più velocemente delle membrane con colesterolo. Secondo Bajardi, l'azione dell'emolisina stafilococcica è associata alla proteolisi e si basa sulla degradazione delle proteine della membrana dei globuli rossi. Emolisine. Le emolisine sono prodotti di origine animale o vegetale che hanno la capacità di dissolvere i globuli rossi di una o più specie animali. Ehrlich divide le emolisina in 1) emolisina vegetale, 2) tossine batteriche, 3) secrezioni velenose di animali (veleno di serpente, veleno di scorpione, api, ecc.) ed emolisina dal siero di animali superiori. interessanti sono le saponine, che rilevano proprietà emolitiche in concentrazioni molto piccole. Agiscono più vigorosamente sui globuli rossi lavati dal siero, poiché il siero neutralizza l'effetto della saponina a causa della presenza di colesterolo in esso, che forma composti insolubili con la saponina. Grazie a questa proprietà del colesterolo, l'aggiunta di quest'ultimo al siero può proteggere gli eritrociti dall'effetto emolitico del colesterolo. Ponina. Altre emolisine di origine vegetale includono abrina, crotina, fallina, ricina e pettirosso. Le emolisine batteriche sono un prodotto secretorio dei microbi, vengono separate dai batteri mediante filtrazione e sono un tipo di esotossina. Alcuni ricercatori le chiamano “emotossine”. Sono sensibili al calore e agli influssi chimici. agenti e, una volta introdotti nel corpo dell'animale, portano alla formazione di anticorpi specifici che neutralizzano l'effetto delle emolisine. Il siero sanguigno di animali normali possiede anche alcune proprietà antiemolitiche minori, che dovrebbero essere attribuite al colesterolo sierico (Noguchi). Le emolisine sono prodotte da stafilococchi patogeni, streptococchi, bacillo del tetano, molti vibrioni, microbi dell'antrace, Vas. subtilis, tu. megaterio, tu. proteus, ecc. Il meccanismo d'azione delle emolisina batterica non può essere considerato lo stesso: la tetanolisina agisce sulla parte lecitina della membrana eritrocitaria, l'emolisina stafilococcica avviene nelle proteine dello stroma; in relazione agli effetti dei tuoi prodotti. mesenterico, Vas. prodigioso, Vibr. Metschnikow suggerisce la presenza in essi di un enzima che dissolve la lecitina. Il riscaldamento (a 55-60° per 20-30 minuti) distrugge l'attività della maggior parte delle emolisine batteriche, ad eccezione di alcune più stabili. Una possibilità interessante è quella di aumentare più volte l'attività dell'emolisina (200-250) aggiungendo peptone al filtrato. Secondo Pfibram, questo effetto si verifica a causa di cambiamenti nella distribuzione dell'emolisina tra i globuli rossi e l'ambiente. L'aggiunta di peptone riduce la solubilità dell'emolisina nella soluzione circostante e ne modifica il coefficiente. distribuzione verso i globuli rossi. la vivo, anche le emolisine batteriche hanno un effetto emolitico. Quando somministrate per via endovenosa a un animale, le emolisine causano la distruzione dei globuli rossi, accompagnata da emoglobinuria e sviluppo di anemia. L'effetto delle emolisine batteriche dovrebbe essere avvertito anche nel corso di malattie infettive causate da microbi che producono veleni emolitici. Per rilevare un effetto anemia non sono necessarie elevate concentrazioni di emolisina. Quando iniettato in un coniglio del peso di 1 kg solo 2 cubo cm emolisina stafilococcica (due gocce della quale possono causare G. 5 cubo mangiare sospensione di eritrociti al 5%) dopo 5-6 giorni si sviluppa anemia, spiegata dal fatto che sebbene una tale quantità di emolisina non sia in grado di provocare l'emolisi completa di un numero notevole di eritrociti, tuttavia l'emolisina, distribuita uniformemente su un gran numero di eritrociti , non si dissolve, li danneggia talmente che vanno incontro a fagocitosi e distruzione nel finale. apparato. Non si può escludere la possibilità di tali effetti emolitici anemici da parte della microflora intestinale. Le emolisine di origine animale possono in alcuni casi manifestare anche un effetto anemico sull'intestino. Tra questi dovrebbero rientrare i veleni emolitici degli elminti, soprattutto di Bothriocephalus, la cui presenza nell'intestino, come è noto, è associata da alcuni ricercatori (Tallquist, Faust) all'anemia perniciosa.Il veleno di insetti (api, ragni, scorpioni) e i serpenti contengono anche sostanze emolitiche Il veleno di Cobra contiene emolisina, che scioglie i globuli rossi solo in presenza di siero, il cui effetto di attivazione del veleno dipende dalla presenza in esso di lecitina (Kyes, Noguchi), che svolge il ruolo di complemento (vedi sotto). Va notato che la velenosità dei serpenti non si limita alla secrezione delle loro ghiandole velenose; il loro sangue, quando somministrato per via parenterale ad altri animali, presenta un effetto altamente tossico. La tossicità di sieri eterogenei, sebbene ad un livello In misura molto minore, è caratteristico anche dei mammiferi, e tale effetto viene rilevato quando somministrato non solo per via ematica, ma anche per via sottocutanea e intraperitoneale (Uhlenhuth). Uhlenhuth e Pfeiffer associano l'effetto tossico dei sieri alla loro azione emolitica. proprietà. In effetti, sono pochi i sieri che non possiedono queste proprietà, almeno in termini relativi. ai globuli rossi umani (vale a dire siero di cavallo, asino, capra e pecora). La maggior parte dei sieri sono emolitici in un modo o nell'altro per gli eritrociti di una specie estranea. Le emolisine provenienti da sieri estranei (animali normali, non immunizzati) sono chiamate “emolisine normali”. I fenomeni di G. però non esauriscono ancora l'effetto tossico del siero estraneo, risp. sangue. È necessario tenere conto della formazione di sostanze simili agli enzimi durante la coagulazione del sangue, dell'azione dell'enzima fibrina e dei cambiamenti nei colloidi del corpo dovuti all'introduzione di sostanze colloidali estranee (per maggiori dettagli vedere. malattia da siero). In numerosi sieri di varie specie di mammiferi, i sieri di gatto e bovino sono al primo posto in termini di tossicità; I sieri di maiale, pecora e cavallo sono significativamente meno tossici (Weiss). Hanno un effetto letale sui conigli se somministrati per via endovenosa kg:Siero sanguigno Anguilla.............. 0,02-0,05 cubo cm Gatti.................. 8.0" "Toro.............. 9.0" Umani......... ..10.0-27.0 " " Pecore..............12.0-20.0 "" Cavalli..............44, 0-50.0 "" Quando gli animali sono immunizzati con eritrociti di altro tipo, il siero acquista spiccate proprietà emolitiche nei confronti degli eritrociti utilizzati per l'immunizzazione a causa della formazione di emolisine specifiche, o immunoemolisine (Bog-det).Ad esempio, quando ad un coniglio vengono somministrati per via parenterale eritrociti di pecora, si ottengono emolisine , sciogliendo gli elementi rossi del sangue delle pecore, ma non degli altri animali.Quando il siero emolitico viene riscaldato per mezz'ora a 55° o quando viene conservato, le proprietà litiche scompaiono, il siero diventa inattivo; ma si riattiva aggiungendo siero da un animale normale, i bordi di per sé non hanno proprietà emolitiche, da qui la conclusione che le emolisine sono costituite da 2 elementi: uno che si distrugge facilmente, in particolare per l'azione della t° (termolabile), e un altro, più resistente (termostabile) . Quest'ultima sostanza, presente nel siero immune (e in piccole quantità in alcuni sieri normali - "emolisina normale"), era chiamata "sensibilizzante" (Bordet), "fissatore" (Metchnikov) o "ambocettore" (Ehrlich). La distribuzione di queste sostanze nel siero normale e immune è la seguente: Siero amboceptor + + Complemento Immune fresco...... » riscaldato...... Normale fresco..... + + La sostanza termolabile trovata rCctK nel siero immune fresco e nel siero normale è chiamata “alexina” (Buchner), “citasi” (Metchnikov), “complemento” (Ehrlich). Affinché il siero sanguigno di un animale immunizzato acquisisca proprietà emolitiche, è sufficiente una dose minima di eritrociti estranei (1,0-1,5 zhg Sospensione al 5% di globuli rossi in fisiolo. soluzione). Ricerche precise rivelano che l'azione delle immunoemolisine, come di altri immunocorpi, non è strettamente specifica. Il siero ottenuto mediante immunizzazione con eritrociti umani agisce anche sulle scimmie; Il siero contro i globuli rossi del pollo dissolve anche i globuli rossi del piccione. Questi cosiddetti Le “emolisine di gruppo” agiscono solitamente sull'antigene di gruppo in misura più debole rispetto a quello utilizzato per l'immunizzazione. In alcuni casi, l'antigene delle emolisine potrebbe non essere eritrociti, ma organi, e l'antigene è eterogeneo in relazione alle emolisine risultanti (“emolisine eterogenee”). Quando un coniglio viene immunizzato con organi di cavia, compaiono le emolisine che dissolvono i globuli rossi del sangue di pecora (Forssman, Krichevskij, ecc.). Oltre alla cavia, negli organi di alcuni altri animali (cavallo, asino, cane, gatto) è presente un antigene che, quando immunizzato con esso, provoca emolisina per gli eritrociti di pecora. Questi animali “tipo cavia” si contrappongono al “tipo coniglio”, che comprende coniglio, uomo, ratto, bue, maiale e che non possiede questo antigene eterogeneo. L'antigene Forsman è presente solo negli organi, mentre è assente negli eritrociti. La spiegazione di questi fenomeni va ricercata nel fatto che diverse specie animali presentano nei loro tessuti proteine che contengono identici radicali complessi aventi le stesse proprietà antigeniche. La relazione tra antigene (eritrociti), ambocettore e complemento è illustrata dal seguente esperimento. Dopo il contatto del complemento (siero brillante) per un'ora con gli eritrociti, questi ultimi vengono separati mediante centrifugazione e ad essi viene aggiunto un amboceptor (siero immune riscaldato per 1/2 ora a 55°) - non si verifica emolisi. Se al contrario si aggiunge prima un ambocettore agli eritrociti e poi, dopo la centrifugazione, lo si sostituisce con il complemento, si verificherà l'emolisi. Pertanto, il complemento non può agire direttamente sugli eritrociti; provoca l'emolisi solo attraverso l'ambocettore fissato sugli eritrociti. Secondo Ehrlich l'ambocettore, che appartiene ai recettori del terzo ordine, ha due gruppi aptofori: uno per il legame con l'antigene, l'altro con il complemento (per questo è chiamato anche corpo intermedio). Anche il complemento ha due gruppi, uno dei quali (aptoforo) si collega all'ambocettore e l'altro (zimoforo) produce un effetto litico. Nonostante l'ampia letteratura dedicata al problema delle emolisine, né l'ambocettore né il complemento hanno ricevuto alcuna caratterizzazione chimica sufficiente. Gli ambocettori, a quanto pare, dovrebbero essere classificati come sostanze proteiche-pseudoglobuline; il complemento, secondo gli studi della maggior parte degli autori, è una sostanza vicina ai lipidi ed è probabilmente un composto proteico-lipidico (Landsteiner). Il ruolo dei colloidi e dei lipidi nei fenomeni di G. è abbastanza dimostrativo negli esperimenti di Landsteiner, il quale riuscì a stabilire che G. in una miscela di biossido di silicio + lecitina procede in modo del tutto simile al sistema: ambocettore + complemento . Secondo Liebermann, l'acido oleico stesso non è quasi emolitico; anche le soluzioni di sapone proteico non emolizzano, ma quando vengono combinate insieme, si ottiene una forte emolisi dei globuli rossi a causa del rilascio di saponi che hanno la capacità di dissolvere il sangue rosso cellule. Una miscela di acido oleico e composti proteici-saponi si comporta in modo simile alle emolisine; a 55° viene inattivata e può essere riattivata aggiungendo una piccola quantità di composto proteico-sapone. Attualmente sta diventando sempre più importante la teoria dell'adsorbimento dell'azione delle emolisine, espressa per primo da Bord, secondo la quale il sensibilizzatore (ambocettore) è considerato come un mordente, grazie al quale il globulo rosso viene preparato per l'induzione di G. azione dell'alexina (complemento) - Secondo le ricerche di Rohner i fenomeni gassosi quando quantificati seguono le leggi del cosiddetto. isoterma di adsorbimento. Secondo alcuni autori (Barykin, Zilber), nei fenomeni di G. non sono sostanze speciali - amboceptor e complemento - che reagiscono, ma appaiono differenze nelle funzioni e nelle norme del sistema immunitario. sieri associati allo stato noto dei loro colloidi. (Per la formazione delle immunoemolisine, cfr Immunità.) e.Tatarshuv. Emolisi in vivo. * In condizioni normali nel corpo animale, costantemente * Mentre la chimica biologica usa il termine “emolisi” per indicare il rilascio di Hb dallo stroma, la patologia e i medici usano questo termine per riferirsi all’intero processo di distruzione dei globuli rossi nel corpo. È in quest’ultimo senso che in questa sezione verrà utilizzata la parola “emolisi”. si verifica una nuova formazione e distruzione dei globuli rossi; questo processo può essere chiamato metabolismo del sangue. Secondo dati più vecchi, ogni eritrocita umano vive circa 30 giorni (Quincke, Eppinger), in un cane 20-30 giorni, secondo dati più recenti, molto più a lungo: in una persona - 100-150, in un cane circa 80 giorni (McMaster ed Ellmann, Lichtenstein e Terven, Adler e Bressel). In condizioni normali, sono soggetti a distruzione quegli eritrociti che, avendo vissuto il loro termine, sono maturi per la distruzione, cioè hanno cambiato fisico-chimica nella misura appropriata e nel rapporto appropriato. In quali organi, in quali tessuti e come si presenta questo G. normale? Nei mammiferi superiori, G. apparentemente si trova nelle cellule reticolari ed endoteliali della milza, del fegato, del midollo osseo e delle ghiandole linfatiche (sistema terminale). Ma tra questi organi un posto particolare occupa la milza rispetto a G., poiché sulla base di numerosi dati è necessario supporre che essa abbia la funzione di accelerare quelli fisico-chimici. cambiamenti nei globuli rossi, che portano alla loro distruzione. Questi dati sono i seguenti: 1) ridotta resistenza osmotica degli eritrociti nel sangue della milza e della vena splenica rispetto al sangue arterioso e venoso di altre aree (Bolt and Heres, Orahowats, Dreisbach, ecc.); 2) aumento della resistenza osmotica degli eritrociti dopo splenectomia (Eppinger, Austin e Krumb-Laar, Istomanova, Myasnikov e Svyatskaya, ecc.); 3) una diminuzione del rilascio di bilirubina (un prodotto della conversione dei globuli rossi distrutti dall'Hb da parte del fegato) dopo splenectomia (Banti, Pugliese, Pchelina, Sagia e Hizai); 4) un effetto più debole di alcuni veleni emolitici, ad esempio la toluene diammina, dopo splenectomia (Banti, Eppinger, Myasnikov, Istomanova e Svyatskaya) e 5) risultati favorevoli generalmente riconosciuti della splenectomia per l'ittero emolitico. Una diminuzione della resistenza osmotica degli eritrociti con la loro età (Brinckmann, Snapper, Aschner, Simmel, Istomanova e Myasnikov, ecc.) e la diminuzione più significativa della resistenza osmotica degli eritrociti nella forma familiare di ittero emolitico, cioè nella malattia in cui si osserva l'aumento più drammatico della pressione sanguigna, e non a causa dell'aumento della capacità emolitica della milza in questa malattia, ma a causa di un'anomalia congenita degli eritrociti - questi due fatti danno senza dubbio il diritto di credere che una diminuzione nella resistenza osmotica degli eritrociti è una delle manifestazioni di quelle fisiche. -chimica. cambiamenti che si verificano nei globuli rossi quando maturano per morte naturale da parte di G. Sulla base di tutti questi dati, si deve riconoscere che i globuli rossi nella milza sono esposti, grazie alla quale la loro maturazione in G. viene accelerata (“Andauung” Eppinger"a Questa funzione della milza è compatibile con la sua funzione di serbatoio (Bar-croft) senza pericolo di danni alla composizione del sangue, poiché questi cambiamenti si verificano nei globuli rossi immediatamente non appena entrano nella milza, ma con rimanendovi dentro non progrediscono più (Orahowats , Wicklein).Quali sono i cambiamenti che subiscono i globuli rossi nella milza? Secondo i lavori di Snapper e Brinkman, la stabilità osmotica dei globuli rossi dipende dal rapporto tra colesterolo e fosfatidi (lecitina) sulla loro superficie o nel loro guscio, con l'aumento dei primi e la riduzione della resistenza osmotica degli eritrociti con i secondi. Un cambiamento nel rapporto di queste sostanze sulla superficie degli eritrociti può anche essere associato ad altri cambiamenti nell'aspetto fisico- proprietà chimiche. proprietà dei globuli rossi che maturano fino all'emolisi, ad esempio una maggiore tendenza ad aderire (vedi sotto). Se la milza, modificando questa funzione, possa regolare G., cioè rafforzarla o indebolirla, questa questione non è stata ancora risolta. Globuli rossi, sottoposti ad alcune attività fisico-chimiche nella milza. i cambiamenti, in parte qui nella milza, subiscono fagocitosi dall'estremità ritirata. cellule. Con ogni probabilità, gli eritrociti che vengono fagocitati qui sono quelli che entrano nella milza già in un'età in cui l'influenza indicata della milza è sufficiente perché subiscano la fagocitosi. La fagocitosi degli eritrociti preparati dalla milza continua nelle cellule di Kupffer del fegato, dove entrano per primi gli eritrociti della milza. La direzione del flusso sanguigno dalla milza al fegato crea un'idea della cooperazione di questi organi in relazione a G. Globuli rossi che sono maturi per la distruzione, ma non catturati dai fagociti della milza e del fegato, entrano nella circolazione generale e, tra l'altro, nei vasi del midollo osseo e della linfa., risp. . ghiandole emolinfatiche. Rit.-fine. le cellule di questi organi, senza dubbio, fagocitano anche gli eritrociti e quindi svolgono anche il ruolo di organi di G. Perché solo gli eritrociti maturi per G. sono esposti alla fagocitosi, o, più precisamente, in che modo avviene la ret? .-FINE. le cellule catturano proprio questi, i globuli rossi più vecchi, e non altri? Ovviamente ciò avviene per ragioni fisico-chimiche stesse. cambiamenti caratteristici dei globuli rossi maturati in G., forse a causa di una maggiore tendenza ad aderire o aderire. Il lento flusso del sangue in tutti quegli organi dove si manifesta l’epatite (seni splenici e simili formazioni midollari, capillari epatici) dovrebbe favorire l’adesione di questi globuli rossi alle cosiddette cellule “shore” (Uferzellen), cioè endoteliali e retico. cellule. La funzione eritrofagocitaria di queste cellule può variare quantitativamente entro ampi limiti, a seconda della necessità di distruggere la presenza di globuli rossi nel sangue. Mentre prima tra questi organi il fegato e la milza avevano la massima importanza come organi di G., oggi si ritiene che anche il midollo osseo abbia una parte importante in G. (Mann e Magath, Askanazy, Peabody e Braun, Doan). Quella fagocitosi dei globuli rossi interi da parte delle cellule terminali della rigenerazione. è l’unico modo normale per distruggere i globuli rossi nel corpo e non è riconosciuto da tutti. Rou, Robertson, Doan e Sabin affermano che il modo normale e principale di distruzione dei globuli rossi è la frammentazione che avviene nel sangue stesso, cioè la rottura dei globuli rossi in piccoli pezzi (frammenti) intrecciando piccole particelle. Il lento processo di frammentazione si manifesta con poichilocitosi, i cosiddetti frammenti di eritrociti. schistociti descritti da Ehrlich. I frammenti vengono fagocitati dalle stesse cellule che, secondo la teoria prevalente, fagocitano gli eritrociti interi, cioè le cellule ret.-end. sistemi. Il metodo di distruzione dei globuli rossi mediante frammentazione non può ancora essere considerato provato. Infine, Fahraeus descrive le formazioni sferiche, incolori e trasparenti nei prodotti sanguigni freschi come una costante morfologica. elemento del sangue normale. Considera queste formazioni come lo stroma dei globuli rossi e suggerisce che indichino il normale modo di distruzione dei globuli rossi che si verifica costantemente nel sangue. Questa ipotesi è contraddetta dal fatto che normalmente l'Hb viene rilevata nel sangue solo in tracce insignificanti. Fareus ritiene che l'Hb venga assorbito molto rapidamente dal ret-end. cellule. Comunque sia, sembra che nelle cellule terminali si verifichino ulteriori stadi di emolisi. sistemi. Quali prodotti si ottengono e quale è il loro destino futuro? Il destino delle parti costitutive dello stroma, in particolare dei suoi lipidi, ci è completamente sconosciuto. L'Hb si decompone nel pigmento ematina contenente ferro e nella sostanza proteica ■ globina. Anche l'ulteriore destino di quest'ultimo ci è sconosciuto. L'ematina si scompone in una particella di pigmento e in alcuni composti di ferro, proteine apparentemente deboli o composti lipidici del ferro colloidale, risp. ossidi di ferro, chiamati emosiderina, perché la loro presenza è determinata da reazioni microscopiche al ferro. Questi composti di ferro si accumulano nel residuo. cellule in generale e del fegato e della milza in particolare (emosiderosi, cfr emosiderina) e lì, a quanto pare, vengono trasformati secondo necessità in altri composti, sotto forma dei quali il ferro viene trasferito al tessuto eritroblastico (in condizioni normali, al midollo osseo) e lì utilizzato per la produzione di nuova Hb. Ancora controverso è il ruolo particolare che la milza svolge nell'accumulo del ferro e in generale nella regolazione del suo metabolismo (Asher). L'ematina, la particella del pigmento, viene convertita in bilirubina. La questione della localizzazione di questa trasformazione è ora risolta nel senso che nelle cellule dell'estremità ret si forma la bilirubina. sistemi nella milza, nel fegato e nel midollo osseo, possibilmente nella linfa., resp. ghiandole emolinfatiche (Aschoff, Mann-Magath). La questione se la maggior parte della bilirubina si formi nel fegato o nel midollo osseo non è ancora stata risolta (Rosenthal, Mann-Magath). Perché la bilirubina si forma nelle cellule ret.-end. e in essi si deposita anche ferro a seguito della scomposizione dell'Hb, è molto probabile che la scomposizione dell'Hb degli eritrociti fagocitati in globina ed ematina, nonché il distacco del Fe dalla particella del pigmento e la conversione del quest'ultimo nella bilirubina si verifica nelle cellule dell'estremità ritirata. sistemi di fegato, milza e midollo osseo. Dalle cellule ret.-end. sistemi del midollo osseo e della milza, la bilirubina entra nel sangue della circolazione generale o del sistema portale e viene secreta dal fegato nella bile. La bilirubina, prodotta dalle cellule di Kupffer, viene anche secreta dalle cellule del fegato nella bile, ma non è chiaro come venga loro trasmessa - attraverso la linfa, il sangue o attraverso processi speciali delle cellule di Kupffer gettate sulla superficie delle cellule del fegato (Roessle, Rosenthal e Holzer).L'influenza di vari fattori fisiologici su G. non è stata ancora sufficientemente studiata; ci sono indicazioni che il cibo a base di carne aumenti G. (Morawitz e Kuehl, Adler e Sachs).Anche il lavoro fisico ha un effetto potenziante su G. se è stato preceduto da un lungo periodo di riposo, ma il lavoro fisico prolungato provoca iperplasia del midollo osseo e aumento dell'eritropoiesi, che più che compensano l'aumento di G. Non è noto anche come sia regolato G. nel corpo. La composizione del sangue ha senza dubbio un influenza su di esso nel senso che l'anemizzazione provoca una diminuzione riflessiva di G. (Belonogova) e la policitemia è la sua intensificazione (Krumbhaar e Chanutin). Con l'intensificazione patologica dell'emolisi, si verifica principalmente un aumento della quantità di bilirubina nella bile ( pleiocromia) e, di conseguenza, aumento dell'urobilinogeno nelle feci; l'urobilina nelle urine aumenta solo con un aumento molto netto di G., e quindi principalmente quando la corrispondente funzionalità epatica è compromessa; poi, man mano che G. si intensifica. , iperbilirubinemia e ittero compaiono quando il fegato non è più in grado di secernere l'acido prodotto in eccesso. bilirubina. L'iperbilirubinemia dovuta all'aumento di G. di solito differisce in quanto la bilirubina nel siero dà il cosiddetto. Reazione indiretta di Hymans van den Bergh: l'ittero dovuto all'aumento di G. non è accompagnato da prurito cutaneo e la quantità di colesterolo nel siero e degli acidi biliari nelle urine non aumenta (vedi. ittero emolitico). Con una maggiore emolisi, sotto l'influenza di emolitici specifici e di molti veleni emolitici, l'emolisi avviene nel sangue stesso, come evidenziato dall'emoglobinemia osservata. Se l'emoglobinemia dovuta a tale G. patologico non è particolarmente forte, allora lo è moglobinuria(vedi) non è accompagnato, poiché l'Hb viene rapidamente assorbita dal sangue dalle cellule terminali. sistemi. Solo in caso di emoglobinemia significativa si verifica emoglobinuria, come nel caso dell'emoglobinuria parossistica. Con l'aumento dell'epatite, l'ematina e altri prodotti della trasformazione dell'Hb compaiono talvolta nel plasma contemporaneamente all'Hb. L'emosidorosi è considerata una manifestazione istologica di aumento dell'emolisi, sebbene non vi sia una relazione costante tra loro; d'altro canto, l'accumulo di ferro di conseguenza. organi (principalmente fegato e milza) possono dipendere anche da altri motivi, come è il caso, ad esempio, emocromatosi(vedi) - G. patologicamente e anatomicamente potenziato si manifesta con iperemia e ingrossamento della milza, in parte del fegato, iperplasia dell'estremità ret. cellule degli stessi organi con aumento dell'eritrofagocitosi in essi, così come nel midollo osseo (Askanazy, Peabody e Braun, Doan). Con l'emolisi grave, che a volte si sviluppa nei casi settici acuti, la sua manifestazione morfologica può essere l'imbibizione dell'intima dei vasi sanguigni e dell'endocardio da parte del pigmento del sangue, che avviene molto rapidamente dopo la morte. Tra le malattie, è caratteristica la G. più acutamente aumentata ittero emolitico(vedi) e, in misura minore, anemia maligna (cosiddetta criptogenetica e Bothriocefalica). Come già accennato, l'aumento di G. nell'ittero emolitico è una conseguenza di un'anomalia congenita degli eritrociti. Secondo gli ultimi dati (Morawitz e Belonogova), e nell'anemia maligna, il rafforzamento di G. è un fenomeno secondario, causato anche dalla patologia. la struttura degli eritrociti come conseguenza dell'eritropoiesi primaria alterata. Le malattie infettive con un pronunciato aumento di G. includono la malaria e la sprue, la natura dell'anemia che l'accompagna ricorda l'anemia perniciosa. Tra le intossicazioni professionali, il saturnismo è apparentemente accompagnato da un aumento dell'emolisi (Berezin, Fischer e Nikulina) (vedi. Veleni emolitici). Tra le sostanze utilizzate per scopi medicinali, salvarsan (Belonogova, Kasatkin) causa un marcato aumento dell'emolisi; l'arsenico ha questa proprietà in misura molto minore. Il ferro, al contrario, è invisibile; riduce leggermente l'emolisi (Belogova). Infine, l'emolisi si osserva spesso in alcune infezioni settiche, soprattutto in quelle cosiddette “biliari” (ad esempio febbre ricorrente, polmonite lobare). In un esperimento l'idea più corretta di G. si ottiene determinando la quantità di bilirubina nella bile secreta attraverso una fistola del dotto biliare comune (McMaster); ma con la perdita prolungata di tutta la bile, i cani sviluppano anemia, che a sua volta può colpire G. (McMaster, Seyderhelm). In clinica, l'aumento di G. è spesso giudicato dall'aumento della bilirubinemia e dell'urobilinuria, ma entrambi questi metodi sono errati, poiché l'iperbilirubinemia e l'urobilinuria, in misura maggiore dell'emolisi, sono determinate dallo stato delle condizioni corrispondenti. funzionalità epatica. In ogni caso, non è accurato determinare la patogenesi dell'iperbilirubinemia in base alla natura della reazione di Hymans van den Berg. La proposta di Eppinger di determinare i calcoli biliari umani in base alla quantità di bilirubina nel contenuto duodenale non è fattibile a causa della variabilità del contenuto della bile in essa contenuta e della variabilità della sua composizione nel senso della partecipazione di "bile vescicale" concentrata e non concentrata “bile di fegato” in esso. Dati più accurati si ottengono determinando G. in base alla quantità di urobilinogeno nelle feci, ma questo metodo è tutt'altro che impeccabile, poiché non tutta l'Hb o, più precisamente, non l'intera massa della particella di pigmento degli eritrociti distrutti appare nelle feci. Una parte di essa, forse, viene utilizzata ancor prima di essere convertita in bilirubina per la costruzione di nuova Hb. Quindi una parte significativa (fino a x/z- a/a) l'urobilinogeno (in cui tutta la bilirubina viene convertita nell'intestino) viene assorbito dall'intestino ed entra nel fegato con il sangue portale. L'ulteriore destino di questa parte dell'urobilinogeno non è chiaro; una parte significativa, a quanto pare, viene riconvertita dal fegato in bilirubina e nuovamente secreta nella bile; l'altra parte passa dal fegato nella circolazione generale ed in parte viene escreta dai reni, ed in parte, forse, viene utilizzata per costruire nuova Hb. Inoltre, è possibile che una parte dell'urobilinogeno venga distrutta nell'intestino o nel fegato. Pertanto, il calcolo diretto del numero di globuli rossi sottoposti a emolisi al giorno o della loro aspettativa di vita in base alla quantità di urobilinogeno nelle feci è completamente impreciso. Con la stitichezza, la quantità di urobilinogeno escreto nelle feci diminuisce e con la diarrea aumenta. Se c'è un'urobilinuria significativa (a causa di insufficienza epatica), per determinare il grado di G. è necessario determinare la quantità di urobilinogeno nelle feci e nelle urine. Date le notevoli fluttuazioni della quantità di urobilinogeno nelle feci, è necessario per una corretta valutazione di G. prelevare sempre dalle sue determinazioni la quantità media giornaliera di urobilinogeno, almeno per 4-5 giorni. Il metodo più idoneo per la determinazione quantitativa dell'urobilinogeno nelle urine e nelle feci è il metodo Terven. G. viene solitamente giudicato dalla quantità media giornaliera di urobilinogeno nelle feci e nelle urine; Normalmente varia da 50 a 193 mg, l'importo medio giornaliero corrisponde a circa 120 mg.È più corretto determinare G. in base alla quantità di urobilinogeno secreto pro die ogni 100 G NH. Con questo calcolo il numero medio di norme è 30 mg. Con l'ittero emolitico, la quantità giornaliera di urobilinogeno raggiunge 1.500 mg, per l'anemia maligna-500 mg, con l'anemia secondaria diminuisce a 25 mg. Lang. Illuminato.: Zlatogorov S., La dottrina dell'infezione e dell'immunità, Kharkov, 1928; Rosenthal L., Immunità, M.-L., 1925; Gamaleya N., Fondamenti di immunologia, M.-L., 1928; Kasatkin V., Sulla questione del metabolismo dei pigmenti del sangue, Ter. Arco.", vol. V, n. 5, 1927; N b b e r R., Physikalische Chemie der Zelle u. D. Gewebe, Lpz., 1926; Blumenthal C, Hamolyse (Hndb. der Biochemie des Menschen u. der Tiere, hrsg. v. C Oppenheirner, B. Ill, Jena, 1925); Scegli U.E. Silberstein F., Biocnemie der Antigene u. Antikorper (Hndb. der patogen Mikro-organismen, hrsg. v. W. Kolle, R. Kraus u. P. Uhlen-huth, B. II, Jena-B - Wien, 1928, lett.); Pf ibram E., Hamotoxine u. Antiamomotossina (ibid.); Sachs H., Hamolysine (ibid., stampato); Morawitz P., Messung des Blutumsatzes (Hndb. der normalen u. patho-logischen Physiolosie, hrsg. v. A. Bethe, G. Bergmann u. a., B. VI, Halite i, T. 1, V., 1928, lett. ); Brink-m a n n R., Die Hamolyse (ibid.); Laud a E., Problem der Milzhamolyse, Erg. der inneren Med. tu. der Kindcrheilkunde, B. XXXIV, 1928; Sachs H. u. Klopstock A., Die Hamolyseforschung, B. - Vienna, 1928 (lett.); Robertson O. e Rons P., Il normale destino degli eritrociti, - Distruzione del sangue. negli animali pletorici e negli animali affetti da anemia semplice, Journal of sperimentale medicina, v. XXV; 191-7.
L'emolisi degli eritrociti (ematolisi sin., eritrocitolisi) è la distruzione delle cellule, che spesso riflette un processo del tutto naturale del loro invecchiamento. Tuttavia, la loro distruzione può derivare dall'influenza di fattori patologici. Da un punto di vista fisiologico, il fenomeno si verifica in ogni persona.
Questa condizione ha le sue manifestazioni cliniche, ma non sono specifiche e spesso sono nascoste dietro i sintomi della malattia di base. I sintomi principali sono pallore, nausea e vomito, dolore addominale, febbre e vertigini.
La base per diagnosticare la distruzione dei globuli rossi sono gli esami del sangue di laboratorio. Tuttavia, per identificare la causa principale dell'anomalia, è necessario un esame completo del corpo.
Il trattamento viene effettuato utilizzando metodi conservativi: sono indicate trasfusioni di sangue e farmaci che alleviano i sintomi. Lo schema per eliminare il fattore eziologico è selezionato su base individuale.
L'emolisi dei globuli rossi avviene regolarmente in ogni organismo vivente. Normalmente i globuli rossi vivono circa 120 giorni, dopodiché inizia la loro graduale distruzione. La membrana si rompe e viene rilasciata emoglobina. In condizioni fisiologiche, tali processi avvengono nella milza con l'aiuto delle cellule del sistema immunitario.
I globuli rossi possono morire nel letto vascolare. In questi casi, l'emoglobina interagisce con una proteina specifica presente nel plasma sanguigno ed entra nel fegato. Successivamente, avviene un'intera catena di trasformazioni complesse, dopo di che la proteina contenente ferro diventa bilirubina e viene escreta dal corpo insieme alla bile. Tutto ciò costituisce un'emolisi patologica.

Emolisi dei globuli rossi
Le cause dell'emolisi possono essere molto diverse, ma sono spesso associate al decorso di una malattia. Pertanto, i seguenti possono fungere da provocatori:
Una predisposizione genetica può contribuire al fatto che i globuli rossi sono difettosi (emolisi osmotica).
In base alla natura della formazione dell'emolisi dei globuli rossi, si verifica una condizione simile:
- fisiologico;
- patologico.
A seconda di dove vengono distrutti i globuli rossi, ci sono:
- emolisi intracellulare: la distruzione avviene nella milza;
- emolisi intravascolare: il processo si sviluppa nel letto vascolare.
Esistono 2 tipi di eritrocitolisi:
- ereditario: esiste una struttura anormale dei globuli rossi, una disfunzione del sistema enzimatico o una composizione difettosa dei globuli rossi;
- acquisita.
Se la distruzione dei globuli rossi avviene a causa del decorso di una malattia o di un processo patologico, in base al meccanismo di sviluppo, viene rilasciato:
- emolisi osmotica: si sviluppa in condizioni di laboratorio;
- emolisi biologica - il risultato della trasfusione di componenti del sangue incompatibili, viremia;
- l'eritrocitolisi della temperatura è una conseguenza dell'ingresso dei globuli rossi in un ambiente specifico (durante i test di laboratorio si trovano in una soluzione ipotonica);
- emolisi meccanica - osservata in persone con una valvola cardiaca artificiale, si verifica a causa della circolazione artificiale;
- emolisi naturale.

Tipi di emolisi dei globuli rossi
L'emolisi si distingue in vitro: i globuli rossi vengono distrutti all'esterno del corpo umano e quando il materiale biologico viene raccolto per le successive ricerche di laboratorio. Di conseguenza, l'analisi darà un risultato falso o fallirà del tutto. In tali situazioni, le ragioni sono:
- tecnica di raccolta del sangue errata;
- provetta contaminata;
- stoccaggio improprio del liquido sequestrato;
- congelamento o scongelamento ripetuto del sangue;
- agitare vigorosamente la provetta.
In questo contesto, è necessario ripetere l'analisi, il che è indesiderabile, soprattutto per i bambini.
L'emolisi degli eritrociti presenta numerose manifestazioni cliniche, ma possono passare inosservate al paziente: tali sintomi non sono specifici e sono caratteristici di un gran numero di malattie. Potrebbero nascondersi dietro la clinica del disturbo di fondo, che viene alla ribalta.
Sintomi:
- pallore o giallo della pelle;
- aumento della temperatura a 38–39 gradi;
- dolore localizzato nella parte superiore dell'addome;
- disturbo del ritmo cardiaco;
- vertigini;
- dolori muscolari e articolari;
- debolezza generale e malessere;
- dispnea;
- ematosplenomegalia;
- nausea e vomito;
- cambiamento nel colore delle urine;
- diffusione del dolore alla regione lombare;
- diminuzione dei valori del tono sanguigno;
- arrossamento doloroso della pelle del viso;
- aumento dell'ansia;
- problemi con lo svuotamento della vescica e dell'intestino;
- forti mal di testa.
Per quanto riguarda i neonati, mostrano segni di malattia emolitica del neonato.
Il principale test diagnostico che indica la distruzione dei globuli rossi è un esame del sangue clinico generale. Il materiale biologico viene prelevato da un dito, meno spesso è richiesto il sangue venoso.
Le manifestazioni di laboratorio di tale deviazione sono:
- aumento della stercobilina;
- aumento dell'urobilina;
- un cambiamento verso l'alto nella concentrazione della bilirubina non coniugata;
- emoglobinemia;
- emosiderinuria.

Diagnosi di emolisi dei globuli rossi
Tuttavia, tali risultati non sono sufficienti per identificare il fattore provocante, è necessario un esame completo del corpo, che inizia con le misure eseguite dal medico curante:
- studiare la storia medica - per rilevare la fonte patologica;
- familiarizzazione con la storia familiare;
- raccolta e analisi della storia della vita del paziente: vengono prese in considerazione le informazioni sull'assunzione di eventuali farmaci, possibili punture di insetti o consumo di funghi velenosi;
- misurazione dei valori di pressione sanguigna e temperatura;
- valutazione dell'aspetto della pelle;
- palpazione della parete anteriore della cavità addominale - per rilevare un aumento del volume del fegato o della milza;
- è necessaria un'indagine dettagliata del paziente per compilare un quadro sintomatico completo.
Uno schema diagnostico aggiuntivo - procedure strumentali, test di laboratorio e consultazioni con altri specialisti - viene selezionato individualmente.
I principi del trattamento dell'emolisi eritrocitaria saranno comuni a tutti i fattori eziologici. Prima di tutto, è necessario fermare completamente l'ingresso della fonte velenosa nel corpo umano. Puoi accelerarne l'eliminazione:
- diuresi forzata;
- clisteri purificanti;
- lavanda gastrica;
- emodialisi;
- emoassorbimento.
La terapia sarà mirata a:
- trasfusione di sangue o globuli rossi;
- fototerapia;
- assumere glucocorticoidi e farmaci che alleviano i sintomi, come antipiretici o antidolorifici;
- terapia trasfusionale;
- uso del bicarbonato di sodio.
Se i metodi conservativi sono inefficaci, si ricorre alla rimozione chirurgica della milza.
È possibile prevenire il verificarsi di un problema come l'emolisi patologica o acquisita dei globuli rossi osservando le seguenti regole preventive:
- completa rinuncia alle dipendenze;
- assumere solo i farmaci prescritti dal medico;
- consumo di alimenti di qualità;
- uso di dispositivi di protezione individuale quando si lavora con prodotti chimici e veleni;
- trattamento tempestivo delle malattie che possono portare a problemi;
- sottoporsi regolarmente a un esame preventivo completo presso un istituto medico - oltre alle procedure strumentali, ciò include la donazione di sangue per test di laboratorio.
La prognosi dipende dalla causa sottostante, poiché ogni fattore eziologico con base patologica ha una serie di complicazioni che spesso portano alla morte.
Pubblicazione principale
L'emolisi (sinonimo: ematolisi, eritrocitolisi) è il processo di danneggiamento dei globuli rossi, in cui l'emoglobina viene rilasciata da essi nell'ambiente. Il sangue o una sospensione di globuli rossi si trasforma in un liquido rosso limpido (sangue laccato). L'emolisi può verificarsi nel sangue (emolisi intravascolare) o nelle cellule del sistema reticoloistiocitario (emolisi intracellulare). Normalmente si osserva emolisi intracellulare: alcuni globuli rossi vengono distrutti quotidianamente, principalmente nella milza, e l'emoglobina rilasciata viene convertita in bilirubina. Con l'emolisi patologica, aumenta la disgregazione dei globuli rossi, aumenta la produzione di bilirubina e la sua escrezione nella bile, nonché il rilascio di corpi di urobilina nelle feci e nelle urine. Se viene rilasciata molta emoglobina e il sistema reticoloistiocitario non riesce a far fronte alla sua elaborazione, si verificano emoglobinemia ed emoglobinuria. La degradazione dei globuli rossi nel sangue avviene in due fasi: cromolisi - rilascio di emoglobina e stromolisi - distruzione dello stroma.
3. Emolisi e sue tipologie
La conseguenza immediata dell'emolisi è l'anemia.
L'emolisi è la distruzione della membrana dei globuli rossi, accompagnata dal rilascio di emoglobina nel plasma sanguigno, che diventa rosso e diventa trasparente (“sangue lacca”). Lo stroma dei globuli rossi distrutti e privati dell'emoglobina forma le cosiddette “ombre dei globuli rossi”.
La distruzione dei globuli rossi può avvenire nel corpo e all'esterno di esso - in vitro - a seconda di una serie di motivi. Se i globuli rossi si trovano in una soluzione ipotonica, la pressione osmotica al loro interno è maggiore rispetto alla soluzione circostante e l'acqua della soluzione entra nei globuli rossi, provocando un aumento del loro volume e una rottura della membrana. Questa cosiddetta emolisi osmotica avviene quando la pressione osmotica della soluzione che circonda i globuli rossi si riduce della metà rispetto al normale. Con una leggera ipotensione della soluzione salina in cui si trovano i globuli rossi, questi non vengono distrutti, ma si gonfiano e aumentano leggermente di dimensioni.
La concentrazione di NaCl nella soluzione che circonda la cellula, a partire dalla quale inizia l'emolisi, è una misura della cosiddetta stabilità osmotica (resistenza) dei globuli rossi. Nell'uomo, l'emolisi inizia in una soluzione di NaCl allo 0,4% e in una soluzione allo 0,34% tutti i globuli rossi vengono distrutti. In varie condizioni patologiche, la stabilità osmotica degli eritrociti può essere ridotta e può verificarsi un'emolisi completa anche ad elevate concentrazioni di NaCl in soluzione.
L'emolisi può verificarsi anche sotto l'influenza di alcuni composti chimici. Pertanto, è causato da solventi lipidici: etere, cloroformio, benzene, alcool, che distruggono (ad alte concentrazioni) la membrana degli eritrociti.
L'emolisi è causata anche da acidi biliari, saponina, pirogallolo e alcune altre sostanze.
La distruzione dei globuli rossi può avvenire all'esterno del corpo sotto l'influenza di forti influenze meccaniche, ad esempio a seguito dell'agitazione di una fiala di sangue. L'emolisi è causata anche dal congelamento e dallo scongelamento ripetuto del sangue.
L'emolisi può verificarsi nel corpo sotto l'influenza del veleno di alcuni serpenti, nonché sotto l'azione di sostanze speciali: le emolisine, formate nel plasma a seguito di ripetute iniezioni di globuli rossi di altri animali nel sangue dell'animale. Le emolisine differiscono nella specificità della specie; agiscono sui globuli rossi solo della specie animale il cui sangue è stato introdotto nell'organismo. Pertanto, il siero del sangue di un coniglio normale emolizza debolmente gli eritrociti di pecora. Dopo diverse iniezioni di eritrociti di pecora nel sangue di coniglio, il siero del sangue di coniglio, quando diluito, emolizza questi eritrociti anche decine di volte.
 L'emolisi del sangue è la rottura dei globuli rossi - eritrociti, che sulla loro superficie trasportano ossigeno agli organi e ai tessuti, quindi quando vengono distrutti, l'ossigeno entra nello spazio intercellulare. Normalmente, i globuli rossi muoiono continuamente in piccole quantità, la loro durata di vita è di 4 mesi.
L'emolisi del sangue è la rottura dei globuli rossi - eritrociti, che sulla loro superficie trasportano ossigeno agli organi e ai tessuti, quindi quando vengono distrutti, l'ossigeno entra nello spazio intercellulare. Normalmente, i globuli rossi muoiono continuamente in piccole quantità, la loro durata di vita è di 4 mesi.
Esistono emolisi intravascolare, che si verifica nel flusso sanguigno, ed emolisi intracellulare, quando la distruzione dei globuli rossi avviene nelle cellule del fegato, della milza e del midollo osseo.
Cause dell'emolisi del sangue.
Qualsiasi sostanza che abbia un effetto tossico sul corpo.
Agenti causali di malattie infettive, ad esempio streptococco, virus.
Sostanze medicinali, ad esempio sulfamidici.
Morsi di insetti o serpenti velenosi.
Mancato rispetto delle regole per la trasfusione di sangue.
Conflitto di compatibilità dei gruppi sanguigni tra madre e feto.
A volte, a causa del decorso patologico della gravidanza di una donna, il feto sviluppa una malattia autoimmune del sangue quando il sistema immunitario percepisce i suoi globuli rossi come un oggetto estraneo. In questo caso, l'emolisi avviene in modo accelerato, i globuli rossi si disintegrano nella milza e nel fegato e si verifica l'ipertrofia di questi organi.
C'è l'emolisi, che si verifica all'esterno del corpo, in particolare durante il prelievo di sangue. Se non vengono seguite le regole per la raccolta o la conservazione del sangue, o se viene scongelato o congelato ripetutamente, i globuli rossi vengono distrutti. I risultati dell'analisi saranno inaffidabili e dovranno essere ripetuti.
Segni che indicano emolisi del sangue.
Prima di tutto, questa è una debolezza irragionevole che sta gradualmente crescendo. Possono verificarsi brividi e nausea.
Poiché l’emolisi si verifica principalmente nel fegato, il dolore si manifesta nella parte destra, irradiandosi all’epigastrio o alla parte bassa della schiena.
Può verificarsi anche ematuria persistente, in cui l'urina assume un colore rosso sporco.
A poco a poco i sintomi aumentano e il corpo inizia a reagire. La temperatura corporea sale a livelli piretici, le funzioni epatiche vengono interrotte, appare il giallo della sclera, della mucosa orale, dei genitali e della pelle.
Sintomi di emolisi dei globuli rossi
I reni smettono di funzionare normalmente, la quantità di urina, il suo colore e la sua densità cambiano e può verificarsi un'insufficienza renale.
Il sangue non si coagula bene e anche un piccolo taglio provoca un sanguinamento abbondante. L’emolisi è una chiara controindicazione a qualsiasi intervento chirurgico addominale, nonché alle procedure dentistiche che comportano l’impianto di impianti dentali e la dissezione del tessuto gengivale.
I prodotti della carie non vengono eliminati autonomamente dall'organismo e provocano convulsioni e svenimenti. L'attività del cuore viene interrotta, le aritmie diventano più frequenti.
Diagnosi di emolisi del sangue.
La diagnosi viene fatta, prima di tutto, dopo un esame del sangue generale e biochimico, che rivelerà un basso contenuto di emoglobina, piastrine, globuli rossi e un aumento del livello di bilirubina. Un esame generale delle urine conterrà globuli rossi, che normalmente non dovrebbero essere presenti, e urobilina. L'ecografia e la tomografia computerizzata degli organi addominali mostreranno cambiamenti nel fegato e nella milza - la loro ipertrofia. La patologia renale può essere diagnosticata solo quando il processo è avanzato.
Trattamento dell'emolisi del sangue.
Se il livello di calo dell'emoglobina ha raggiunto livelli critici, viene eseguita una trasfusione di sangue di globuli rossi.
Vengono prescritti anche glucocorticoidi e immunosoppressori per fermare il processo autoimmune.
Se vi è una distruzione significativa del tessuto della milza, è indicata la rimozione chirurgica.
L'emodialisi è prescritta per rimuovere le sostanze tossiche dal flusso sanguigno.
A volte i farmaci ormonali sono indicati come terapia complessa.
Per normalizzare le condizioni generali, vengono prescritte terapia vitaminica, una dieta ricca di minerali e cibi facilmente digeribili e un'attività fisica moderata.
Il trattamento dell'emolisi viene effettuato da un ematologo.
L'emolisi del sangue è una malattia che risponde bene alla terapia. Se si consulta tempestivamente uno specialista e si seguono tutte le raccomandazioni, la malattia non causa complicazioni e, nel tempo, si verifica la remissione completa.
Emolisi dei globuli rossi
Emolisi e suoi tipi.
Emolisi chiamato distruzione dei globuli rossi con rilascio di emoglobina nell'ambiente circostante i globuli rossi. L'emolisi può essere osservata sia nel letto vascolare che all'esterno del corpo.
Al di fuori del corpo, l'emolisi può essere causata da soluzioni ipotoniche. Questo tipo di emolisi è chiamato osmotica . Il forte scuotimento del sangue o la sua miscelazione porta alla distruzione della membrana dei globuli rossi - emolisi meccanica . Alcune sostanze chimiche (acidi, alcali, etere, cloroformio, alcol) causano la coagulazione (denaturazione) delle proteine e l'interruzione dell'integrità della membrana dei globuli rossi, che è accompagnata dal rilascio di emoglobina da essi - emolisi chimica . Sotto l'influenza si osserva anche un cambiamento nella membrana degli eritrociti con il successivo rilascio di emoglobina da essi fattori fisici . In particolare, se esposto ad alte temperature, avviene la coagulazione delle proteine. Il congelamento del sangue è accompagnato dalla distruzione dei globuli rossi.
Si verifica costantemente nel corpo in piccole quantità emolisi quando i vecchi globuli rossi muoiono. Normalmente, si verifica solo nel fegato, nella milza e nel midollo osseo rosso. L'emoglobina viene “assorbita” dalle cellule di questi organi ed è assente dal plasma sanguigno circolante. In alcune condizioni e malattie del corpo, l'emolisi è accompagnata dalla comparsa di emoglobina nel plasma sanguigno circolante ( emoglobinemia) e la sua escrezione nelle urine ( emoglobinuria). Ciò si osserva, ad esempio, nel morso di serpenti velenosi, scorpioni, punture multiple di api, malaria e trasfusione di sangue di gruppi incompatibili.
Composti dell'emoglobina. L'emoglobina, che ha aggiunto ossigeno a se stessa, si trasforma in ossiemoglobina(HbO2).
Tipi di emolisi dei globuli rossi
L'ossigeno forma un composto debole con l'emoglobina, in cui il ferro rimane bivalente. Si chiama emoglobina che cede l'ossigeno restaurato, O ridotto, emoglobina (Hb). Viene chiamata l'emoglobina combinata con una molecola di anidride carbonica carboemoglobina(HbCO2). Anche l'anidride carbonica con la componente proteica dell'emoglobina forma un composto facilmente disintegrabile.
Viene chiamata la combinazione di emoglobina con monossido di carbonio carbossiemoglobina(HbCO). La carbossiemoglobina è un composto forte e, di conseguenza, l'avvelenamento da monossido di carbonio è molto pericoloso per la vita.
In alcune condizioni patologiche, ad esempio, in caso di avvelenamento fenacetina, nitriti di amile e propile, ecc., nel sangue appare una forte connessione tra l'emoglobina e l'ossigeno - metaemoglobina, in questo composto, una molecola di ossigeno si lega al ferro eme, lo ossida e il ferro diventa trivalente. Nei casi in cui nel sangue si accumula una grande quantità di metaemoglobina, il trasporto di ossigeno ai tessuti diventa impossibile e la persona muore.
L'emolisi del sangue, da un lato, è la ragione del fallimento dell'analisi, dall'altro è il principale sintomo patogenetico dell'anemia emolitica che richiede diagnosi e trattamento. Si distingue anche l'emolisi fisiologica.
Vita e morte di un globulo rosso
L'emolisi dei globuli rossi si verifica costantemente nel corpo degli esseri viventi. Normalmente i globuli rossi vivono circa 120 giorni. Quando viene distrutta, la membrana degli eritrociti si rompe e l'emoglobina fuoriesce. Questo processo, in condizioni fisiologiche, avviene nella milza con l'aiuto delle cellule del sistema immunitario, i macrofagi. Questa è la cosiddetta emolisi intracellulare.
Se la morte di un eritrocita avviene nel letto vascolare, si tratta di emolisi intravascolare. L'emoglobina si lega a una proteina speciale nel plasma e viene trasportata al fegato. Dopo una catena di reazioni complesse, si trasforma in bilirubina, che viene escreta dal corpo con la bile. Ci sono molti fattori che portano all'emolisi patologica.
Cosa causa l'emolisi nel corpo
Le cause dell'emolisi dei globuli rossi nel sangue sono varie:
L'emolisi causata da questi fattori è alla base delle anemie emolitiche acquisite.
Esistono anche anemie congenite, in cui la durata della vita dei globuli rossi è significativamente ridotta. Ciò accade a causa del sottosviluppo e della maggiore fragilità della membrana o della presenza nel corpo di fattori aggressivi contro i propri globuli rossi. Tutto ciò porta anche all'emolisi, intracellulare, nel fegato e nella milza. In questo caso, si osserva un aumento di questi organi, una diminuzione del contenuto dei globuli rossi.
Emolisi in vitro
Durante l'emolisi, il plasma sanguigno diventa scarlatto dopo che viene rilasciata una grande quantità di emoglobina. Questo tipo di sangue è chiamato “lacca”
L'emolisi dei globuli rossi può verificarsi all'esterno del corpo umano durante un esame del sangue. Di conseguenza, l’analisi sarà inaffidabile o fallirà del tutto. La ragione di ciò potrebbe essere una violazione della tecnica di prelievo del sangue, una provetta contaminata, una conservazione impropria del sangue raccolto, ripetuti congelamenti e scongelamenti del sangue. Anche un forte scuotimento della provetta può causare emolisi nel sangue. Di conseguenza, il test dovrà essere ripetuto, il che è particolarmente indesiderabile nei bambini. Pertanto, è importante che il personale medico rispetti tutte le regole per la raccolta e la conservazione del sangue.
Principali sintomi
Nei casi lievi, sintomi come debolezza, nausea e brividi sono preoccupanti. Potrebbe esserci un ittero della sclera.
Con l'emolisi massiccia, è caratteristico un periodo di latenza, fino a otto ore dall'inizio della malattia. Quindi aumentano la debolezza e il mal di testa. Possibile vomito. Sono preoccupato per il dolore all'ipocondrio destro, all'epigastrio e alla parte bassa della schiena. Spesso il sintomo iniziale è l'emoglobinuria, in cui l'urina diventa rosso scuro.
Successivamente, a causa della rottura dei globuli rossi, aumenta l'eritropenia. Nel sangue c'è una reticolocitosi pronunciata. La temperatura sale a 38-39 gradi. Successivamente, il fegato si ingrandisce con l'interruzione delle sue funzioni, fino allo sviluppo dell'insufficienza epatica. Dopo alcuni giorni appare l'ittero. La bilirubina nel sangue aumenta.
A causa del blocco dei tubuli renali da parte dei prodotti di degradazione dell'emoglobina, si sviluppa insufficienza renale con oliguria, fino all'anuria.
I principali segni di laboratorio dell'emolisi sono l'emoglobinemia, l'emoglobinuria e la bilirubinemia.

Un segno di bilirubinemia è l'ittero della sclera e l'ittero
Trattamento
I principi del trattamento dell'emolisi acuta dei globuli rossi, indipendentemente dal fattore che l'ha causata, sono simili. Prima di tutto, fermare l'ingresso del fattore che colpisce i globuli rossi nel corpo. Accelerarne l'eliminazione (diuresi forzata, clisteri depurativi, lavanda gastrica, emosorbimento ed emodialisi). Terapia intensiva delle complicanze potenzialmente letali. Terapia sintomatica. Trattamento dell'insufficienza epatico-renale.
Per quanto riguarda il trattamento delle anemie emolitiche ereditarie, sono difficili da trattare. In alcuni casi, con frequenti crisi emolitiche, viene asportata la milza. Per alcuni tipi di anemia è stata utilizzata con successo la terapia ormonale. Ebbene, in generale, sono indicati la terapia trasfusionale, il trattamento e la prevenzione delle complicanze e la stimolazione dell'eritropoiesi.
L'emolisi acuta degli eritrociti è una malattia grave che richiede cure intensive immediate, poiché le complicanze sono fatali per il corpo.
L'anemia emolitica congenita richiede un monitoraggio e un trattamento costanti sotto la supervisione di personale medico.