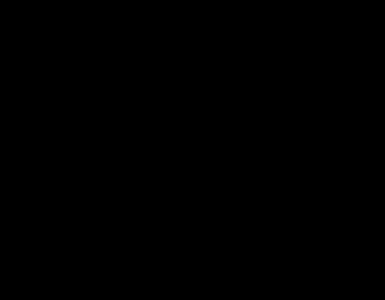Cellule del sistema fagocitario mononucleare. Fagociti mononucleari e immunoterapia Il ruolo del sistema dei fagociti mononucleari nei processi fisiologici e patologici
Sono rappresentati dal midollo osseo, precursori di fagociti, monociti e macrofagi tissutali.
A seconda della località hanno il nome corrispondente, la struttura e le funzioni sono le stesse.
Funzioni:
1. Cellule effettrici chiave del sistema immunitario innato (insieme a NK-L e neutrofili).
2. Essendo una delle forme di APC, partecipano alla formazione dell'immunità adattativa (insieme alle cellule dendritiche e V-L).
3. Attivate durante il processo di endocitosi, le particelle estranee secernono prodotti solubili di varie attività: lisozima, proteasi, collagenasi, elastasi, attivatore del plasminogeno, citochine, componenti del sistema del complemento, prostanoidi, fibronectina, fattori della coagulazione del sangue, ecc.
4. Alcuni sono chemioattraenti, reclutando diversi tipi istologici di cellule, principalmente della serie mieloide, nel sito dell'infiammazione.
5. Alcuni hanno un effetto microbicida dovuto ai prodotti lisosomiali secreti durante l'esocitosi.
6. Alcuni dei loro prodotti hanno proprietà curative delle ferite.
7. Endocitosi delle cellule obsolete e distrutte del proprio corpo.
8. Molte delle loro citochine promuovono le interazioni intercellulari, presentano proprietà infiammatorie, sviluppano attività regolatoria in relazione alle cellule del sistema immunitario e promuovono la distruzione dei tumori.
Monociti(3-11% nel sangue) – promonociti, monoblasti, cellule staminali mieloidi si formano nel midollo osseo sotto l’influenza di citochine e entro 24 ore vengono espulsi nel flusso sanguigno, dove rimangono fino a 2 giorni. (12-32 ore). Sono divisi in 2 gruppi: circolanti e parietali - in stretto contatto con le cellule endoteliali e pronti per la migrazione interendoteliale nei tessuti, dove si trasformano in macrofagi. Può differenziarsi in cellule dendritiche mieloidi. Rimane nei tessuti fino a 30 giorni. I lisosomi dei monociti contengono un gran numero di enzimi (lisozima, lattoferrina, peptidi antibiotici, idrolasi acide - proteasi, nucleasi, ecc.). Sulla membrana sono espresse molte strutture molecolari, inclusi antigeni di istocompatibilità, recettori per componenti del sistema del complemento, citochine, chemochine, ecc. Funzioni protettive– reclutano cellule infiammatorie nel focolaio infiammatorio, svolgono funzioni effettrici su cellule bersaglio geneticamente estranee (citotossicità cellulare anticorpo-dipendente), secernono prodotti battericidi, assorbono l'antigene e ne assicurano la frammentazione (1 monocita fagocita circa 100 batteri (neutrofili - 5-25)) , precursore dei macrofagi
Macrofagi– sono i primi a incontrare l’antigene nel tessuto da esso danneggiato (insieme ai neutrofili). La produzione di citochine dovuta alla loro attivazione costituisce un importante stimolo inducente per il coinvolgimento dei neutrofili e di altri leucociti, compresi i monociti, che formano una nuova ondata di macrofagi, nella formazione di un focolaio infiammatorio. È anche la base per creare la massa quantitativa di cellule necessaria per la completa frammentazione dell'antigene e il completamento dell'infiammazione. Le cellule a vita lunga vivono nei tessuti per mesi o anni.
Migrazione diretta dei macrofagi Sotto l'influenza è assicurata (chemiotassi) all'antigene e al sito di sviluppo dell'infiammazione chemiotassine o chemioattraenti. Le molecole chemiotattiche dei microbi hanno le proprietà dei chemioattraenti; citotassine prodotte dai fagociti e da altre cellule. sotto l'influenza di endotossine batteriche; Prodotti per la distruzione dei tessuti; secrezioni di cellule attivate nel fuoco infiammatorio: interleuchina, chemochine, istamina, leucotrieni, ecc.; componenti formati durante l'attivazione del sistema del complemento, ecc. Limitano la chemiotassi: un numero di prodotti batterici, alcuni ormoni, a2-macroglobulina, ecc. La membrana ha strutture recettoriali corrispondenti, l'interazione dei ligandi con cui forma un segnale specifico, il passaggio di cui lungo le vie di segnalazione intracellulare determina la direzione del funzionamento dei fagociti, in particolare il movimento diretto. La sua base è la reazione delle proteine del citoscheletro (actina), che cambia la forma della cellula da rotonda a triangolare con pseudopodi.
Viene chiamato il movimento delle gabbie in mancanza di una pendenza di sostanze chemiotattiche migrazione spontanea dei fagociti, aumento indiretto della motilità cellulare sotto l’influenza di sostanze chimiche – chemocinesi.
La chemiotassi dei macrofagi indotta dai chemoattraenti è accompagnata dalla loro interazione con l'antigene, dal suo assorbimento e frammentazione; questo processo comprende le fasi di interazione dei recettori con i ligandi.
I recettori che forniscono il riconoscimento dell'ipertensione negli stadi primari dell'infiammazione pre-immune sono chiamati recettori PRR (Pattern Recognition Receptors), cioè riconoscere l'immagine generale dell'ipertensione o la sua tipologia non dettagliata.
La struttura dell'immagine generale dell'ipertensione infettiva è designata come un mosaico molecolare dell'agente patogeno - PAMP (Pathogen-Associated Molecular Pattern) - queste sono le strutture di batteri, virus, protozoi, funghi, componenti normalmente assenti nel corpo.
In base alla loro attività funzionale, i recettori PRR si dividono in riconoscendo Antigene PAMP e promuovendone l'endocitosi e la frammentazione e segnale – attivando i geni delle citochine per formare una risposta immunitaria.
Un altro tipo di recettori per molecole di origine endogena: per IgG e IgE, per componenti del complemento, alcune citochine, proteine di adesione, ecc. Un ruolo importante è svolto dagli antigeni di istocompatibilità delle classi I e II situati sulla loro membrana, che sono di grande importanza negli stadi tardivi dell’infiammazione preimmune.
Viene chiamata fagocitosi mediata attraverso recettori per molecole di origine sierica che opsonizzano la cellula microbica - proteina C-reattiva, proteine del sistema del complemento, pentraxine, ficoline, collezionine, anticorpi IgG, ecc. indiretto, e il PAMP mediato attraverso le strutture molecolari è diretto.
Il gruppo dei recettori PAMP comprende le seguenti famiglie:
1. Recettori Toll-like (11 classi) - TLR (Toll-Like Receptors) - sulla superficie cellulare, riconoscono vari componenti di microrganismi patogeni;
2. Recettori che legano siti nucleotidici arricchiti con ripetizioni di leucina (20+14) - NBS-LRR (Sito di legame dei nucleotidi - Recettori ricchi di leucina) - intracellulari, riconoscono componenti di microrganismi che sono entrati nel citoplasma della cellula.;
3. Recettori “per la raccolta dei rifiuti” (6) - SR (Scavenger Receptors) - sulla superficie cellulare, legano lipoproteine modificate a bassa densità, subiscono endocitosi (differenza da altri recettori) e frammentazione.
4. Recettori della polilectina - MLRF (Multilectin Receptors Family) - riconoscono i carboidrati e si legano in modo proteina-carboidrato, ecc.
Granulociti
Il loro citoplasma contiene granuli. A seconda della colorazione dei granuli, questi si dividono in basofili (colorati con coloranti basici), eosinofili (coloranti acidi) e neutrofili (non colorati). Si formano nel midollo osseo da un comune precursore mieloide, subiscono diversi stadi di maturazione e nell'ultimo stadio di differenziazione vengono rilasciati nel sangue. Dopo una breve circolazione nel sangue (ore), entrano nei tessuti, dove muoiono attraverso il meccanismo dell'apoptosi.
1) Neutrofili(granulociti neutrofili) – leucociti polimorfonucleati, divisi in giovani (metamielociti, nucleo a forma di fagiolo), bastoncelli (nucleo a ferro di cavallo) e segmentati (nucleo di 2-5 segmenti). Maturano nel midollo osseo da 7 a 14 giorni. ad una velocità di 8 milioni di cellule/ora. sotto l'influenza delle citochine.
Durante il processo di maturazione si forma nel citoplasma 2 tipi di granuli contenente più di 20 enzimi proteolitici, ecc.:
1. Primario O azzurrofilo(allo stadio di promielociti);
2. Secondario O specifica(mielociti) – 80%.
Vengono espulsi dal midollo osseo entro 24 ore dalla maturazione, la popolazione più numerosa (60-75% - carnivori, 50% - cavalli, 20-30% - ruminanti, 40-70% - esseri umani).
Nel sangue formano 2 pozze - circolante(nel sangue 6-14 ore) e marginale o parietale(nel tratto gastrointestinale, fegato, polmoni, fino a 7 giorni), muoiono per apoptosi e vengono fagocitati dai macrofagi.
Sotto l'influenza di stimoli chemiotattici (prodotti microbici, tessuti danneggiati, ecc.), migrano per primi nel sito dell'infiammazione (calore, arrossamento, gonfiore, dolore, diminuzione della funzionalità), assorbono e digeriscono gli antigeni.
3) Basofili o granulociti basofili– 0,5-1%, vivono nei tessuti per diversi giorni, nel sangue – 4-8 ore, secernono citochine ed esprimono recettori. I granuli primari contengono enzimi idrolitici, i granuli secondari contengono istamina, eparina, anafilaxina, fattori chemiotattici dei neutrofili e degli eosinofili. Sotto l'influenza dell'allergene, si verifica la degranulazione e il rilascio di queste sostanze. Di conseguenza, si forma un complesso di reazioni protettive, causate dalla contrazione della muscolatura liscia, broncospasmo, vasodilatazione, aumento della permeabilità vascolare, attrazione di altri tipi di cellule nella zona - cellule mononucleate, neutrofili, eosinofili, stimolazione dell'aggregazione piastrinica, ecc. .
Mastociti
Sono cellule residenti del tessuto connettivo, presenti principalmente nella pelle, negli organi respiratori e nel tratto gastrointestinale. Allo stato libero - nelle mucose, nel lume bronchiale, nel tessuto connettivo lungo le fibre nervose e nei vasi sanguigni. In base alla localizzazione e ai prodotti granulari si dividono in connettivo e mucoso (o atipico). Contengono molti grandi granuli metacromatici, che sono lisosomi modificati. Sintetizzano fattori di chemiotassi di neutrofili ed eosinofili, citochine, fattore di aggregazione piastrinica, mediatori del danno tissutale e di riparazione - chimasi, triptasi, acido ialuronico, istamina, serotonina, eparina, leucotrieni, prostaglandine, ecc. Dopo l'attivazione, si verifica la denaturazione dei prodotti granulari vengono rilasciati nello spazio extracellulare e mostrano vari effetti, a seconda della necessità: contrazione della muscolatura liscia, azione chemiotattica, enzimatica o vasoattiva, stimolazione delle terminazioni nervose periferiche, ecc. In termini di funzione, sono analoghi dei basofili, ma di diversa origine precursori.
Piastrine
Strutture postcellulari prive di nucleo di megacariociti maturi, frammenti del loro citoplasma. Megacarioblasti Þ promegacariociti Þ megacariociti-vivere 10 giorni. e ciascuno produce 2-5mila. piastrine- vivono 8-11 giorni, esprimono recettori, hanno isoantigeni dei gruppi sanguigni Rh e A, B, 0.
2 tipi di granuli, compresi i fattori della coagulazione del sangue: 1) a-granuli– enzimi (glucuronidasi, fosfatasi, trombochinasi, ecc.) e 2) corpi densi– composti (fibrinogeno, serotonina, ADP, ATP, ecc.). Quando la parete del vaso è danneggiata, il tessuto danneggiato secerne fattore estrinseco della coagulazione, determinare l'adesione delle piastrine alla superficie danneggiata. In questo caso, contengono granuli densi fattore intrinseco della coagulazione. Induce l'aggregazione piastrinica, che trombizza il vaso.
Entrambi i fattori attivano la protrombina (proteina plasmatica) in trombina sotto l'influenza del cofattore tromboplastina tissutale, che viene attivata quando il tessuto è danneggiato. Sotto l'influenza della trombina, il fibrinogeno forma fili di fibrina, che assicurano la coagulazione (coagulazione) del sangue. Attaccandosi ai fili di fibrina, le piastrine aiutano a compattare il coagulo, che diminuisce di dimensioni a causa del trascinamento dei fili di fibrina nel coagulo. La trombosi dei vasi sanguigni impedisce anche la diffusione dei microbi attraverso il flusso sanguigno in tutto il corpo.
Le piastrine attivate rilasciano sostanze coinvolte nell'infiammazione (idrolasi, lipidi vasoattivi, ecc.).
Si ritiene che abbiano un effetto citotossico sui trematodi.
Cellule endoteliali
Nel tessuto a riposo, le cellule endoteliali dei piccoli vasi regolano i processi di stravaso fisiologico di macromolecole e leucociti dai vasi sanguigni nei tessuti che mantengono la costanza genetica dell'ambiente interno del corpo.
Sotto l'influenza di microrganismi, i prodotti del tessuto danneggiato o le citochine prodotte da fagociti mononucleati, granulociti, mastociti, piastrine, linfociti, cellule endoteliali squamose vengono attivati e trasformati in cellule endoteliali alte (cuboidali) che rivestono venule postcapillari.
Questa è una delle fasi iniziali più importanti dello sviluppo dell'infiammazione, che influenza in modo significativo le fasi successive. Porta allo sviluppo di processi che attirano le cellule del sistema immunitario verso il focolaio emergente dell’infiammazione: la produzione di citochine e, soprattutto, di a-chemochine (neutrofili) e b-chemochine (mnociti e linfociti), che sono le principali chemiotattici che attivano l'emigrazione dei leucociti dal sangue nei tessuti. L'espressione delle molecole di adesione sulle cellule endoteliali e sui leucociti aumenta in modo significativo, questi ultimi vengono trattenuti e fissati sulla superficie dei primi, favorendo la diapedesi dei leucociti attraverso la parete vascolare.
Altri processi dopo l'attivazione sono un aumento della resistenza apoptotica delle cellule, l'attività battericida dell'endotelio (NO), l'attivazione piastrinica, la sintesi delle prostaglandine, il dolore, la vasodilatazione, l'aumento della permeabilità vascolare e la soppressione dell'aggregazione piastrinica.
Lezione 6
1. Antigeni
1. Antigeni e condizioni che ne determinano l'immunogenicità
Antigeni O immunogeni sono sostanze di natura biologica o chimica strutturalmente diverse dalle molecole del proprio organismo, riconosciute dal sistema immunitario come geneticamente estranee e capaci di provocare una risposta immunitaria specifica quando entrano nell'organismo, finalizzata alla loro distruzione ed eliminazione.
AG è suddiviso in 3 gruppi principali :
1. Esogeno
2. Endogeni – autoantigeni
3. Allergeni
Gli Ag presentano differenze strutturali che ne determinano la specificità.
Le condizioni per indurre una risposta immunitaria dipendono dalla struttura dell'Ag e dal genotipo dell'individuo immunizzato.
Gli AG sono proteine, polipeptidi, polisaccaridi, lipopolisaccaridi, lipoproteine, singoli composti sintetici ad alto peso molecolare, virus, batteri, protozoi, funghi, elminti, vari tipi di cellule e loro componenti, ecc.
La formazione di una risposta immunitaria è determinata dall’assunzione dell’antigene e dal suo riconoscimento da parte dell’apparato recettoriale della cellula. Non viene riconosciuta l'intera molecola AG, ma i suoi piccoli gruppi chimici... epitopi O determinanti antigenici.
L'organismo produce tanti tipi di anticorpi quanti sono i determinanti delle diverse strutture negli anticorpi che possono essere riconosciuti dai recettori di riconoscimento dell'antigene delle cellule linfoidi, ad es. Per ogni epitopo si forma un AT complementare ad esso, che interagisce specificatamente solo con questo epitopo o ne ha la stessa struttura.
Volume dell'epitopo - 2-3 nm 3, lunghezza - 2,4 nm (7-15 residui di aminoacidi o 6 monosaccaridi), peso molecolare 0,6-1,0 kJ.
Queste molecole determinano specificità dell'ipertensione– lineari o globulari, diversi dagli altri Ag, interagiscono con i recettori di riconoscimento dell’antigene dei linfociti e con gli anticorpi contro uno specifico Ag.
Le strutture molecolari di dimensioni più piccole non hanno proprietà antigeniche.
Il numero di epitopi nei diversi Ags varia: albumina d’uovo – 5, tossina difterica – 8, virus del mosaico del tabacco – 650, linfociti – 1000.
Caratterizza il numero di epitopi che legano il numero massimo di molecole AT valenza antigenica.
Tipicamente, la valenza aumenta con l'aumentare del peso molecolare dell'AG. Ma non è un criterio accurato per il numero di epitoises. Il numero di epitopi in un antigene può essere maggiore a causa delle aree all'interno del globulo che sono inaccessibili all'antigene.

Pertanto, l’ipertensione è caratterizzata da un alto grado di specificità. L'eccezione è antigeni che reagiscono in modo crociato , compresi epitopi di struttura simile (esempio: reazione di eritrociti di pecora con antisiero di coniglio, organi di cavia immunizzati con antigene (fegato, reni, ecc.) - antisiero di Forsman).
Il processo opposto – effetto di competizione antigenica , cioè l'assenza di una reazione immunologica o la sua notevole diminuzione ad un antigene o determinante antigenico quando un altro antigene o determinante viene introdotto nel corpo.
Distinguere 3 forme di competizione AG :
1. Intermolecolare – Ag o determinanti concorrenti sono localizzati su una molecola di Ag.
2. Intermolecolare – epitopi concorrenti degli antigeni sono localizzati su molecole diverse.
3. Sequenziale – un tipo di intermolecolare, si verifica durante l’immunizzazione sequenziale con diversi antigeni.
Viene chiamato antigene che induce la soppressione della risposta immunitaria verso altri antigeni ipertensione dominante .
Epitopi immunodominanti causare la maggiore stimolazione della risposta immunitaria.
La capacità dell'AG di creare immunità li caratterizza immunogenicità .
Antigenicità AG è la capacità qualitativa di indurre una risposta immunitaria di una grandezza o di un'altra.
Vengono chiamati gruppi di epitopi che determinano la specificità immunologica degli antigeni gruppi determinanti .
Vengono chiamati Ags che causano lo sviluppo di una risposta immunitaria e reagiscono con gli anticorpi formati contro di loro ipertensione totale .
Vengono chiamati Ags che non sono capaci di una risposta immunitaria e di produzione di anticorpi, ma capaci di reagire con anticorpi ipertensione incompleta O apte (lipidi, acidi nucleici, carboidrati, farmaci, ecc.).
Una risposta immunitaria contro gli apteni si sviluppa solo quando questi sono combinati con Ag ad alto peso molecolare.
Viene chiamata la combinazione di una proteina con un aptene o un altro antigene, formando una nuova specificità immunologica antigene coniugato.
Viene chiamata la proteina contenuta nell'antigene coniugato vettore .
Dall’antigene coniugato si producono 3 tipi di anticorpi:
1) contro il vettore (riconoscere T-L),
2) contro aptene (V-L),
3) contro la porzione trasformata della molecola a seguito della coniugazione del trasportatore e dell'aptene (T-L).
Gli antigeni propri dell'organismo sono in grado di provocare una risposta immunitaria: in seguito al superamento delle formazioni di barriera (ad es. sangue-cervello) e all'immunizzazione dei tessuti barriera con antigeni o in seguito a mutazioni o cambiamenti nella struttura a seguito di diversi influssi (ad es. proteine denaturazione), quando diventano estranei al corpo, mentre si sviluppano lesioni autoimmuni.
L'antigenicità delle proteine aumenta con l'aumentare delle differenze filogenetiche tra il donatore di AG e il ricevente e dipende anche dalle funzioni (proprietà), dal peso molecolare, dalla rigidità strutturale, dall'isometria della molecola, dalla dose di AG, ecc.
A seconda della partecipazione dei linfociti T al processo di induzione della risposta immunitaria, in particolare alla produzione di AT, AG diviso in dipendente dal timo E timo indipendente .
Questi ultimi si dividono in 2 tipologie: Classe AG timo-indipendente I – attiva V-Li maturo e immaturo Ipertensione timo-indipendente di classe II – attiva solo V-L matura.
Non esiste una classificazione univoca dell’ipertensione. Per solubilità – solubile e corpuscolare (insolubile); per origine: leucocitario, linfocitario, piastrinico, eritrocitario, cellulare, siero, microbico, batterico, canceroso-embrionale, ecc.; a seconda delle procedure utilizzate - trapianto, a seconda delle strutture genetiche codificanti - antigeni del complesso maggiore di istocompatibilità, ecc.
Gli allergeni si dividono in microbici, insetti, domestici, industriali, alimentari, ecc. Microbico – batterico, virale, ecc.
Isolato da diversi organi - organo-specifico, tessuti - tessuto-specifico, diversi stadi di sviluppo nell'embriogenesi - stadio-specifico; diversi tipi di animali - specie-specifici; individui e gruppi all'interno di una specie – isoantigeni, gruppo-specifici; i componenti distintivi dei diversi microbi della stessa specie sono specifici del tipo.
Artificiale O sintetico – AG ottenuti come risultato della sintesi chimica di strutture basate sul principio degli analoghi naturali o non naturali.
1218 0
Macrofagi e monociti appartengono alle cosiddette cellule professionali presentanti l'antigene e, secondo i concetti moderni, sono uniti in un sistema di fagociti mononucleari, che comprende anche monoblasti e promonociti.
Come i neutrofili, sono coinvolti nel fornire la prima linea di difesa contro varie influenze estranee.
Oltre alle loro funzioni principali - presentazione dell'antigene, fagocitosi e citotossicità - queste cellule svolgono anche diverse influenze regolatorie. Le idee moderne sui fagociti mononucleari indicano la loro partecipazione all'immunità sia innata che acquisita.
A differenza di altre cellule con una spiccata capacità di fagocitosi (neutrofili, mastociti, basofili, eosinofili), sia i monociti del sangue periferico che i macrofagi tissutali sono oggetto di studi intensivi, che si riflettono in molte pubblicazioni. Non è stato lasciato da parte lo studio del ruolo dei fagociti mononucleati nel processo tumorale, il che ha contribuito all'accumulo di molti dati che ampliano le informazioni su questo tema.
Caratteristiche dei macrofagi
Oggi è noto che il ruolo dei fagociti mononucleati si manifesta non solo nella fagocitosi e nella presentazione dell'antigene - funzioni che sono state maggiormente studiate, ma anche nelle influenze regolatrici che hanno sulle funzioni di altre cellule, che generalmente determina la forma versatile di partecipazione di monociti e macrofagi al mantenimento dell'omeostasi sia immunologica che tissutale.Le caratteristiche dei fagociti mononucleati come cellule presentanti l'antigene sono state descritte nella prima parte della monografia. A questo proposito, ci sembra opportuno limitare la presentazione dei dati in questo capitolo, in primo luogo, alle informazioni che si riflettono nella letteratura degli ultimi anni e, in secondo luogo, a quelle che possono essere importanti per comprendere il loro ruolo nel tumore. processi.
Macrofagi- una popolazione di cellule longeve, il loro numero massimo si trova nei tessuti connettivi e linfoidi, soprattutto quelli associati alla mucosa. Come è noto, una sorta di analogo dei macrofagi nel fegato sono le cellule di Kupffer, che fagocitano, elaborano e presentano vari antigeni, e nel cervello - cellule microgliali e astrociti.
Il controllo della maturazione dei monociti nel midollo osseo è effettuato da citochine come IL-3, GM-CSF, M-CSF, IFNa/b; L'M-CSF è un fattore di crescita selettivo per i fagociti mononucleati.
È noto che la monocitopoiesi è potenziata dalle citochine proinfiammatorie dei macrofagi secondo il principio del feedback: dopo la differenziazione dei monociti in macrofagi, questi ultimi iniziano a produrre citochine che, a loro volta, potenziano la monocitopoiesi.
Nelle sue varie fasi, il ruolo predominante appartiene a varie citochine, ma alla fine le principali in questo processo sono IL-3, GM-CSF, M-CSF, IL-9, IL-11, IFNy, IL-4. I monociti possono essere precursori diretti delle cellule dendritiche in vivo, che sono diventate note come CD8a+ cellule dendritiche (DC) e può presentare in modo crociato l'antigene ai linfociti T CD8+.
La membrana superficiale dei macrofagi è altamente mosaicata, poiché è formata da un gran numero di composti diversi (proteine, carboidrati, lipidi), le sue superfici esterne ed interne sono collegate e sono caratterizzate dalla capacità di sintetizzare rapidamente e costantemente le sostanze che formano esso, che garantisce l'implementazione affidabile delle loro funzioni più importanti da parte dei fagociti mononucleari (fagocitosi, citotossicità, ecc.). Questa mobilità è ovviamente il risultato di un complesso percorso evolutivo che hanno subito le cellule fagocitiche.
La superficie della membrana dei fagociti mononucleari è ricca di vari recettori, di cui i più ampiamente studiati sono gli FcR per le immunoglobuline, nonché i recettori per le citochine, gli ormoni e varie frazioni del complemento. L'interesse per lo studio del recettore per il frammento Fc dell'immunoglobulina è dovuto al fatto che questi recettori svolgono un ruolo importante nello svolgimento di quasi tutte le funzioni delle cellule fagocitiche.
Esistono tre tipi noti di recettori immunoglobulinici identificati negli studi sui macrofagi dei topi:
1) recettore ad alta affinità per IgG - FcyRI (CD64), che ha la capacità di legarsi alle IgG aggregate monomeriche e fa anche parte degli immunocomplessi; espresso esclusivamente su macrofagi e neutrofili e media la fagocitosi e la citotossicità anticorpo-dipendente;
2) recettore a bassa affinità per IgG - FcyRII (CD32);
3) FcyRIII (CD16), che lega le IgG solo come parte degli immunocomplessi ed è espresso da macrofagi, neutrofili, mastociti e cellule natural killer.
Alcuni FcyR hanno una maggiore affinità per alcune sottoclassi di IgG (IgGp IgG2a, IgG3, IgG4). Gli FcR possono anche legarsi alle immunoglobuline di altri isotipi (M, A, E). In particolare, il legame con le IgM è particolarmente caratteristico dei macrofagi peritoneali di ratto, delle IgA - monociti umani e delle IgE - macrofagi alveolari e peritoneali dei ratti, monociti umani. Il recettore Fc a bassa affinità si lega alle IgE (FceR), che è accompagnato da un aumento della trascrizione dei geni TNFa e IL-ip con un forte aumento della produzione di queste citochine da parte dei macrofagi.
FcRI può essere espresso sia dai macrofagi a riposo che dall'IFNy attivato. Quasi tutte le cellule presentanti l'antigene, compresi i macrofagi, sono in grado di esprimere alti livelli di FcRI in parallelo con l'espressione degli antigeni di classe II complesso maggiore di istocompatibilità (MHC), CD40, CD88. Un nuovo sguardo alle cellule presentanti l'antigene ci consente di considerare la FcRI come un collegamento tra l'immunità innata e quella adottiva come risultato dell'assorbimento degli immunocomplessi, che successivamente è importante per l'induzione di una risposta T-dipendente.
Una delle caratteristiche importanti degli FcR, che garantisce la loro rapida risposta a vari influssi, è la capacità di ridistribuirsi sulla membrana e di interagire con le integrine β2 (le basi molecolari di questa interazione rimangono sconosciute).
Insieme ai recettori Fc coinvolti nell'attivazione dei macrofagi, ne è stato descritto un altro - FcRIIb - un recettore inibitorio unico che inibisce i segnali intracellulari quando interagisce con complessi immunitari contenenti IgG.
Grazie allo studio di questo recettore sono stati ottenuti nuovi e molto importanti dati secondo i quali l'antigene è in grado di interagire con i recettori Fc attivatori e inibitori sia dei macrofagi del midollo osseo che delle cellule di Langerhans e delle cellule dendritiche, cosa che potenzia le cellule T proliferazione e induzione dell’immunità umorale.
Questi dati indicano che FcRIIb, nonostante sia un recettore inibitorio, è anche in grado di regolare positivamente la presentazione degli immunocomplessi, tra cui le IgG, cosa già confermata nello studio delle cellule dendritiche.
Solo i fagociti mononucleari esprimono la proteina transmembrana CD163, che è un membro della famiglia dei recettori scavenger, e la sua espressione è regolata da mediatori antinfiammatori.
L'interesse per lo studio del ruolo di questo recettore è recentemente aumentato a causa dell'evidenza della sua partecipazione a vari processi patologici e della sua capacità di legarsi al sistema aptoglobina-emoglobina (Hb-Hp), che ha causato l'attivazione della produzione di IL-10 ed è stato inibito da anticorpi anti-CD163. I dati disponibili su questo tema sono giustamente considerati l'identificazione di un nuovo percorso per l'effetto antinfiammatorio protettivo dei monociti e dei macrofagi umani.
Come notato, le cellule killer naturali sono attivate linfociti citotossici (CTL) esprimono i recettori NKG2D. Anche i macrofagi esprimono questo recettore, che è in grado di riconoscere diversi ligandi di superficie associati agli antigeni MHC di classe I.
Tali ligandi sono attivamente espressi dalle cellule in numerosi processi patologici, nonché dalle cellule tumorali, e il legame con essi è accompagnato dall'attivazione dei macrofagi; è possibile che l'espressione di NKG2D e la loro ridistribuzione sulla superficie cellulare svolgano un ruolo nella lisi (naturale) illimitata.
I fagociti mononucleati esprimono anche: antigeni delle classi I e II del complesso maggiore di istocompatibilità; MAS-1; antigeni la; varie molecole di adesione (LFA-1, LFA-3, ICAM-1, ICAM-2, integrine, ecc.); recettori per i componenti del complemento (CR1, CR3, CR4, CR5, CD35, CD88, ecc.); recettori per le citochine (IL-1 - CDwl25, TNF - CD120a/b, IFNy - CDwll9); recettori per chemochine (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8), che si legano a vari chemoattraenti (MIP-1, MIP-la, MIP-1p, MCP, RANTES, ecc.); mannosio, mannosio-fruttosio o molecole recettoriali simili alla lectina, nonché recettori per la fibronectina. La superficie dei macrofagi ha anche recettori TOLL-like - TLR-2 e TLR-4, con la partecipazione dei quali viene effettuato l'effetto protettivo dei macrofagi e l'apoptosi dei macrofagi carichi di batteri.
Insieme all'espressione degli antigeni classici delle classi MHC I e II, gli antigeni HLA-G vengono espressi all'attivazione dei macrofagi. La loro espressione è stata riscontrata sulle cellule infiltranti il carcinoma polmonare e, in misura molto minore, nelle malattie polmonari non maligne.
Si presume che l'espressione di HLA-G possa compromettere la presentazione dell'antigene, il che porta ad un indebolimento della risposta immunologica e quindi favorisce lo sviluppo di processi sia maligni che infiammatori.
Sulla superficie dei macrofagi sono espressi anche recettori per vari ormoni (insulina, tireotropina, β-adrenergici, estrogeni, glucocorticoidi, somatostatina, gonadotropina, ecc.), che consente loro di partecipare all'interazione con il sistema nervoso ed endocrino , così come nei processi riproduttivi. Pertanto, gli estrogeni mostrano un effetto protettivo contro la neurodegenerazione nel danno cerebrale acuto e cronico, e sono i macrofagi cerebrali ad essere coinvolti negli effetti del 17b-estradiolo (E2) sui neuroni.
Oltre a ciò, dati recenti mostrano che i macrofagi e i monociti sono coinvolti nella patogenesi di vari processi neuroinfiammatori (sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, ischemia cerebrale), che è associato al rilascio di varie citochine, metalloproteinasi, all'espressione di CD40 e al suo legame con il loro ligando CD40L.
I macrofagi esprimono molecole costimolatorie (CD80, CD86, ecc.), che, di regola, sono combinate con l'induzione di una risposta dei linfociti Th2. Le cellule di Kupffer esprimono anche molecole costimolatorie simili.
Caratteristica dei fagociti mononucleari è l'espressione del recettore della transferrina, che si lega attivamente alla transferrina sierica (il sito di legame si trova all'interno dei macrofagi). Si presume che l'aspetto di questo recettore corrisponda allo stadio di attivazione dei macrofagi e ai cambiamenti di membrana caratteristici dell'attivazione.
L'istamina svolge anche un ruolo significativo nel funzionamento dei macrofagi, i cui recettori sono espressi dai fagociti mononucleati. Sotto questo aspetto, i più studiati sono i monociti del sangue periferico, che sono eterogenei nella loro capacità di esprimere questi recettori.
Uno studio su cellule simil-macrofagiche della linea P38821 ha dimostrato che l'aggiunta di istamina al terreno di coltura aumenta la quantità di calcio intracellulare e guanosina monofosfato ciclico(cGMP). Questi effetti si realizzano attraverso i recettori H1 - prova che è attraverso questi recettori che viene effettuata la modulazione di alcune funzioni biologiche dei macrofagi e Ca2+ e cGMP agiscono come messaggeri secondari.
L'istamina e la serotonina attivano i macrofagi alveolari e peritoneali. Più recentemente è stato dimostrato che i macrofagi assorbono l’istamina e sono quindi coinvolti nella neutralizzazione dei suoi effetti negativi nelle aree infiammate. L'istamina, insieme alla PGE-2 (vasaprostan) e alle catecolamine, regola l'immunità innata e acquisita, migliorando l'interazione tra monociti e altre cellule.
Funzioni dei macrofagi
Nell'implementazione di una serie di funzioni dei macrofagi, i recettori della lattoferina, una proteina legante il ferro, che è presente in varie secrezioni e, insieme alle proprietà battericide, ha effetti immunomodulatori, inibendo la produzione di IL-2, IL-1, TNFa, aumentando la citotossicità dei monociti e delle cellule natural killer.Quasi tutte le cellule che presentano l'antigene hanno un recettore per gp96, una proteina da shock termico. Questo recettore, l'α2-macroglobulina (CD91), si trova a livello intracellulare e viene rilasciato solo durante la morte necrotica, ma non apoptotica, il che suggerisce il suo coinvolgimento come sensore della morte cellulare necrotica.
Sui macrofagi epatici è stato identificato il recettore M-4, che è un recettore per gli antigeni carcinoembrionali. È stato stabilito che anche le cellule tumorali del colon MIP101 esprimono questo recettore, che esiste in varie isoforme ed è regolato tessuto-specificamente.
Inoltre, macrofagi e monociti esprimono il recettore della melanocortina (MC-1R) e come risultato dell'interazione di questo recettore con l'ormone stimolante i melanociti, che funziona come mediatore dell'immunità e dell'infiammazione, la produzione di IL-1, IL-2 , IL-6, IL-13 diminuiscono.IL-24, TNFa, IFNy e IL-10 aumentano.
In termini di numero di prodotti sintetizzati e secreti dai macrofagi, occupano uno dei primi posti rispetto ad altre cellule del sistema immunitario e i loro concorrenti possono essere solo mastociti e neutrofili.
I fagociti mononucleati esprimono Fas e FasL, che possono causare apoptosi spontanea, effettuata sia attraverso vie autocrine che paracrine. Quando attivati, i monociti rilasciano rapidamente una forma solubile di FasL, indicando la loro capacità di rispondere ai cambiamenti ambientali.
L'espressione di Fas e il legame a FasL da parte dei fagociti mononucleati induce segnali di attivazione, facendo sì che sia i monociti che i macrofagi rilascino TNFa e IL-8, e il terreno di coltura di queste cellule contiene fattori che stimolano la migrazione dei neutrofili.
Tuttavia, si osservano alcune differenze nei processi indotti dalla legatura di Fas nei monociti e nei macrofagi. Queste differenze si manifestano nel fatto che la produzione di queste citochine da parte dei monociti è accompagnata da successiva apoptosi ed è bloccata da un inibitore della caspasi, mentre la risposta citochinica dei macrofagi avviene in assenza di apoptosi ed è indipendente dalla caspasi.
Questi dati dimostrano abbastanza chiaramente che la legatura di Fas da parte dei monociti può indurre una risposta proinfiammatoria, portando ad infiammazione acuta e danno tissutale. Anche i neutrofili preapoptotici mostrano questa risposta proinfiammatoria, suggerendo una serie di manifestazioni comuni di legatura di Fas da parte di varie cellule fagocitiche.
I macrofagi producono IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, TNFa, IFNa, IFNp, MCP-1, TGFP, fattore di crescita dei fibroblasti (FGF), fattore di crescita piastrinico-dipendente (PDGF), ecc. Recentemente, è stato scoperto che i macrofagi producono MIF (fattore inibitorio della migrazione dei macrofagi) - una citochina che è stata inizialmente identificata come citochina delle cellule T; Il MIF è considerato una citochina proinfiammatoria candidata attiva coinvolta nella regolazione ormonale e nell'infiammazione.
N Insieme a queste e ad altre citochine, i macrofagi contengono e in determinate condizioni possono secernere:
1) enzimi lisosomiali (proteinasi, desossiribonucleasi, lipasi, lisozima, collagenasi, elastasi, mieloperossidasi, ecc.);
2) radicali dell'ossigeno (H2O2, superossido, nitroossido, ecc.);
3) ormoni ( ormone antidiuretico (ADCH), timosina, androfina);
4) componenti del complemento (C1, C2, C3, C4, C5); così come vitamina D3, prostaglandine, leucotrieni, fattori B e D, correttadina, fibronectina, condroitin solfato, transferrina, avidina, amiloproteina E, ecc.
Di grande importanza per comprendere il funzionamento dei macrofagi sono i nuovi dati emergenti secondo cui il gene che controlla p53 è coinvolto nella regolazione dell'aumentata differenziazione dei macrofagi; la presenza di mutazioni nel gene specificato lo priva di questa capacità. Questo fatto è di particolare interesse nello sviluppo di neoplasie maligne, caratterizzate dalla comparsa di mutazioni nel gene p53, che lo priva della capacità di migliorare la differenziazione dei macrofagi.
Quando si discute dell'importanza dei macrofagi nel mantenimento dell'omeostasi immunologica e tissutale, non si può ignorare un'altra questione, apparentemente molto importante. Il punto è che i macrofagi hanno la capacità di differenziare e fagocitare corpi apoptotici e particelle necrotiche.
Sebbene anche altre cellule abbiano questa capacità, essa è più pronunciata nei macrofagi. Questa linea di ricerca è stata sviluppata attivamente da V. Fadok e coautori, a seguito della quale i meccanismi e le condizioni per la fagocitosi dei corpi apoptotici sono ora diventati noti. I macrofagi emergono e riconoscono i corpi apoptotici utilizzando vari meccanismi, tra cui integrine, fosfatidilserina (PS)-3, lectine e altri.
I macrofagi monociti-dipendenti e alveolari dell'uomo, i macrofagi del midollo osseo dei topi riconoscono e fagocitano i corpi apoptotici attraverso il sistema integrinico vb3, che sui macrofagi umani è associato alla superfamiglia dei recettori scavenger CD36 - SR-B; i suoi ligandi: collagene I, IV, V, trombospondina, fosfolipidi, acidi grassi a lunga catena.
Il gene che codifica per questo recettore è stato clonato ed è stato dimostrato che durante l'apoptosi dei macrofagi si verifica un'asimmetria nella disposizione dei fosfolipidi di membrana, che è particolarmente pronunciata quando i macrofagi esprimono fosfatidilserina.
Studiando i macrofagi alveolari, si è scoperto che l'espressione del recettore scavenger e del CD14 è regolata da IL-6 e IL-10. Tuttavia, esiste una diversa natura delle influenze regolatorie di queste citochine su questi recettori: IL-6 aumenta l'espressione di CD14 e sopprime l'espressione dell'mRNA del recettore scavenger; al contrario, IL-10 diminuisce l’espressione del CD14 e aumenta l’espressione del recettore scavenger (tutti gli effetti sono dose-dipendenti e determinati dal tempo di coltura).
I macrofagi umani monociti-dipendenti, quando fagocitano i corpi apoptotici, utilizzano CD14, un recettore lipopolisaccaridico, la cui funzione non è completamente compresa.
Il processo di legame e fagocitosi dei corpi apoptotici è accompagnato da un effetto antinfiammatorio, che avviene con la partecipazione di meccanismi autocrini e/o paracrini, che includono TGF|3, PGE-2 e il fattore di attivazione piastrinica (PAF). Durante la fagocitosi dei corpi apoptotici da parte dei macrofagi umani, viene inibita la produzione di IL-4, IL-8, IL-10, GM-CSF, TNFa, leucotriene C-4 e trombossano B-2; parallelamente a ciò aumenta la produzione di TGFpi, PGE-2 e PAF.
Va sottolineato che molti dei recettori necessari per il riconoscimento dei corpi apoptotici sono molto importanti anche per l'immunità innata. Questi recettori includono le integrine, i recettori scavenger di classe A e B, il recettore ossidato simile alla lectina LOX1, alcuni recettori del complemento e CD14.
In modo piuttosto sorprendente, e forse anche paradossale, quando questi recettori si legano ai microrganismi o ai loro prodotti, in molti casi si sviluppa una risposta proinfiammatoria e si osserva la stimolazione dell'immunità acquisita. Al contrario, l’assorbimento dei corpi apoptotici non è associato all’infiammazione e l’immunità acquisita non viene attivata. A questo proposito, è necessario spiegare un processo così diametralmente opposto che si verifica quando vengono attivati gli stessi recettori.
Questi dati, indipendentemente dall'interpretazione che verrà data loro in futuro, sono estremamente importanti e interessanti, poiché rivelano forme precedentemente sconosciute di partecipazione dei macrofagi all'infiammazione e all'immunità acquisita.
Inoltre, in esperimenti condotti su macrofagi del midollo osseo, è stato dimostrato che dopo l'ingestione di neutrofili necrotici, questi stimolavano la proliferazione dei linfociti T in vitro, aumentavano l'espressione di CD40 e tali macrofagi contenevano alti livelli di TGFP, ma bassi TNFa; effetti simili non sono stati osservati durante la fagocitosi dei neutrofili apoptotici.
Alti livelli di TGFP nei macrofagi durante la fagocitosi dei corpi apoptotici sono considerati una protezione contro le citochine proinfiammatorie; questo processo avviene con la partecipazione di p38, chinasi attivante il mitogeno (MARS) e NF-kappaB.
Prove sempre più numerose suggeriscono che il fagocimento e la digestione delle cellule necrotiche o lisate induce una risposta immunologica e un'infiammazione che non si verifica quando si verifica la fagocitosi dei corpi apoptotici.
A questo proposito, la domanda posta da V. Fadok e coautori nel titolo di uno dei loro articoli è molto legittima: “Il recettore della fosfatidilserina potrebbe essere un interruttore molecolare che determina chi dovrebbe andarsene?” La domanda posta non è priva di carattere discutibile e suggerisce non solo la complessità della risposta, ma anche il difficile percorso che occorre percorrere per ottenerla.
Il profondo significato biologico del fenomeno, che risiede nelle peculiarità della fagocitosi delle cellule necrotiche e apoptotiche, è evidente. L'interruzione dei meccanismi di pulizia del corpo attraverso l'apoptosi può essere la causa della transizione dell'infiammazione acuta in malattie infiammatorie croniche, inclusa la patologia autoimmune.
Purtroppo questa questione estremamente interessante è stata ancora poco studiata nel processo tumorale. Le opere disponibili sono rare. Ad esempio, possiamo citare i dati sulla fagocitosi delle cellule apoptotiche della linea HT-29 del carcinoma del colon umano.
Questi studi mostrano che l'espressione delle molecole di fosfatidilserina e delle catene di carboidrati varia a seconda dello stadio della fagocitosi: l'espressione del galattosio era ugualmente importante per tutti gli stadi dell'apoptosi, l'espressione della fosfatidilserina per gli stadi successivi e tardivi.
Lo studio di questo problema nel processo tumorale può essere interessante per vari motivi. È del tutto realistico supporre che, da un lato, l’assorbimento dei corpi apoptotici in determinate condizioni possa creare un serbatoio di antigeni tumorali nei macrofagi con la loro successiva presentazione; dall’altro, la fagocitosi delle cellule tumorali necrotiche può essere uno dei ragioni degli effetti soppressivi dei macrofagi sulle cellule del sistema immunitario.
Infine, non si può non essere d'accordo con l'ipotesi che il rilascio di citochine soppressive da parte dei macrofagi durante la fagocitosi delle cellule tumorali lisate possa essere uno dei motivi per cui il tumore sfugge al controllo immunologico.
Quando si discute la questione della fagocitosi dei corpi apoptotici e necrotici da parte dei macrofagi, va anche notato che i macrofagi che esprimono FasL sono in grado di fagocitare cellule tumorali apoptotiche che non esprimono questo antigene.
Berezhnaya N.M., Chekhun V.F.
Il sangue circola nel sistema circolatorio, un tessuto liquido che svolge una serie di funzioni fisiologiche. È costituito da plasma e da elementi formati. Questi includono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Vale la pena notare che esistono 5 tipi di leucociti. Questi sono basofili, neutrofili ed eosinofili, nonché cellule del sangue mononucleate chiamate cellule mononucleari, che includono linfociti e monociti.
Cellule mononucleate nel sangue: caratteristiche generali
Come già notato, queste cellule appartengono ai leucociti. Va notato che le cellule mononucleate includono anche le plasmacellule: questi sono i precursori dei linfociti T e B. Le cellule mononucleari non hanno una granularità specifica e contengono un nucleo semplice e non segmentato. Il rapporto tra i diversi tipi di cellule del sangue ci consente di valutare la gravità della malattia o determinare l'efficacia del trattamento.
Linfociti
Se parliamo di linfociti, questi sono gli elementi formati responsabili dell'immunità cellulare. Producono anticorpi che legano sostanze estranee e uccidono le cellule del proprio corpo se vengono infettate da microrganismi. Inoltre, queste cellule mononucleate nel sangue sono in grado di “riconoscere” le cellule tumorali e di distruggerle.

Monociti
Se caratterizziamo i monociti, allora si tratta di cellule leucocitarie responsabili della risposta immunitaria e della formazione di citochine. Inoltre, queste cellule mononucleate del sangue sono in grado di differenziarsi, poiché sono i precursori dei macrofagi. Sono in grado di assorbire microrganismi e vari batteri, cellule e tessuti danneggiati a causa dell'infiammazione.
Cellule mononucleari: normali
Per determinare il livello di linfociti e monociti, viene effettuato un esame del sangue dettagliato per determinare la formula dei leucociti. Normalmente, i linfociti costituiscono il 25-35% e i monociti il 2-6%. Va notato che nei bambini il numero di queste cellule del sangue è leggermente superiore a quello degli adulti. Inoltre, ci sono una serie di patologie che sono anche accompagnate da linfocitosi. Pertanto, con malattie infettive e virali, patologie del sangue, avvelenamento o uso di farmaci, il numero di linfociti può aumentare. Una diminuzione del loro livello si osserva nella tubercolosi miliare, nell'anemia aplastica, nell'insufficienza epatica e anche durante l'assunzione di citostatici. Il numero di monociti varia anche in determinate condizioni patologiche. Pertanto, queste cellule mononucleate nel sangue aumentano durante infezioni acute, collagenosi sistemica, malattie del sangue e avvelenamento. Una diminuzione del livello di queste cellule si osserva durante lo shock, l'assunzione di glucocorticoidi, durante il parto e le infezioni da piogeni.

Cellule mononucleari atipiche nel sangue
Queste cellule sono anche chiamate virociti. Questi sono linfociti peculiari che hanno alcune caratteristiche morfologiche dei monociti. Si ritiene che i virociti siano linfociti T modificati. Di norma, queste cellule si trovano nella mononucleosi infettiva, anche se in alcuni casi compaiono in altre malattie, ma rappresentano non più del 10%. La mononucleosi infettiva è confermata se il numero di cellule mononucleate atipiche nella formula dei leucociti supera il 10%. Va notato che queste cellule vengono rilevate anche in qualsiasi persona sana, ma il loro numero non supera 1/6 del numero di linfociti. Con qualsiasi infezione virale, dopo la vaccinazione, in presenza di tumori o patologie autoimmuni, nonché con l'infezione da HIV, aumenta il livello delle cellule mononucleate atipiche.
Tutti i componenti sono mezzi filogeneticamente più antichi per proteggere il corpo (rispetto al sistema immunitario) che, senza la partecipazione di linfociti e anticorpi, possono agire su una vasta gamma di agenti infettivi.
Il sistema di resistenza viene attivato dagli induttori dell'infiammazione e soppresso dai suoi inibitori. Rispetto all’immunità, il sistema di resistenza aspecifica varia significativamente a seconda delle differenze temporali e individuali. La sintesi di tutti i componenti è determinata geneticamente e sono presenti nell'organismo al momento della nascita. Grazie all'equilibrio del sistema immunitario e al sistema di resistenza non specifica, viene preservata l'integrità individuale di un organismo altamente sviluppato. D'altra parte, difetti parziali e disturbi nei meccanismi regolatori portano a numerose malattie.
Sistema fagocitico. La fagocitosi si riferisce all'assorbimento attivo di materiale solido da parte delle cellule. Negli organismi unicellulari, questo processo serve principalmente per la nutrizione. In molti organismi multicellulari, compreso l’uomo, la fagocitosi funge da fondamentale meccanismo di difesa anti-infettiva. I fagociti sono cellule con una capacità particolarmente pronunciata di fagocitosi. Morfologicamente e funzionalmente si distinguono componenti monociti (macrofagi) e granulocitici (granulociti e microfagi) del sistema fagocitico. Tutti i fagociti hanno le seguenti funzioni:
- migrazione e chemiotassi;
- adesione e fagocitosi;
- citotossicità;
- secrezione di idrolasi e altre sostanze biologicamente attive.
I fagociti mononucleati sono capaci di una proliferazione limitata al di fuori del midollo osseo, della sintesi e della secrezione di numerose proteine e partecipano ai processi di differenziazione e maturazione dei tessuti. Inoltre, i macrofagi sono cellule presentanti l’antigene, cioè elaborano e presentano l’antigene per il riconoscimento da parte delle cellule del sistema immunitario e quindi innescano il meccanismo di risposta immunitaria.
Sistema di fagocitosi dei granulociti . I granulociti vengono generati attraverso il processo di granulopoiesi nel midollo osseo. Sono caratterizzati da un gran numero di granuli nel citoplasma, in base alla loro capacità di colorazione si distinguono granulociti basofili, eosinofili e neutrofili. Dal punto di vista della valutazione del sistema di resistenza umana, i neutrofili polimorfonucleari (PMN) sono di grande importanza, ciò è determinato sia dal loro numero che dalla loro funzione. Il tempo di maturazione dei PMN nel midollo osseo varia da 8 a 14 giorni. Entrano quindi nel sangue come cellule mature, non in divisione, con un diametro di 10-12 micron con un nucleo segmentato complesso. Molte cellule contengono quantità notevoli di granuli citoplasmatici debolmente azzurrofili e una membrana ripiegata. Dopo alcune ore, i neutrofili polimorfonucleati lasciano il flusso sanguigno nello spazio interstiziale e muoiono dopo 1-2 giorni. Diversi tipi di granulociti sono coinvolti in tutte le forme di infiammazione e svolgono un ruolo di primo piano. Viene rivelata una stretta relazione tra macrofagi e neutrofili polimorfonucleati, nonché granulociti eosinofili e basofili. I neutrofili polimorfonucleati sono il componente principale dei leucociti del sangue umano. Ogni giorno molti neutrofili polimorfonucleati vengono rilasciati dal midollo osseo nel sangue e durante le infezioni acute questo numero può aumentare di 10-20 volte, mentre nel sangue compaiono anche forme immature (spostamento dell'emocromo a sinistra). La dimensione della mielopoiesi è determinata e regolata da specifici fattori di crescita dei granulociti prodotti dai granulociti periferici e dai macrofagi. L'uscita dal midollo osseo e l'accumulo di cellule nel sito dell'infiammazione sono regolati da fattori chemiotassi. I PMN svolgono un ruolo decisivo nella difesa antinfettiva, che viene svolta continuamente nell'organismo, pertanto l'agranulocitosi permanente non è compatibile con il concetto di organismo vivente e funzionante. L'attività del PMN è strettamente correlata ai granuli, il cui contenuto sono enzimi e altre sostanze biologicamente attive. Allo stadio promielocitario, nel citoplasma della cellula compaiono granuli azzurrofili primari; nel mielocita si rilevano anche i cosiddetti granuli secondari (specifici). Queste forme possono essere distinte mediante microscopia elettronica e separate mediante frazionamento delle strutture subcellulari. L'ultracentrifugazione preparativa ha permesso inoltre di identificare una frazione di piccoli granuli corrispondenti ai lisosomi dei neutrofili polimorfonucleari. Indipendentemente dal tipo, i granuli sono strutture cellulari contenenti enzimi o proteine idrolitiche. Sono circondati da un guscio lipoproteico che, una volta attivato, è in grado di fondersi con strutture subcellulari simili e con la membrana citoplasmatica.
L'attività funzionale dei neutrofili polimorfonucleari è regolata da un gran numero di recettori di membrana, attivatori solubili e corpuscolari. Ci sono neutrofili polimorfonucleari riposanti e attivati. I primi hanno forma rotonda, circolano nel flusso sanguigno e in altri fluidi biologici dell'organismo e sono caratterizzati dalla natura ossidativa del metabolismo. L'adesione ad altre cellule, i fattori chemiotattici e la fagocitosi portano all'attivazione dei neutrofili polimorfonucleati, che è determinata dall'aumento dell'assorbimento di ossigeno e glucosio, nonché dal rilascio di anidride carbonica da parte delle cellule. Durante la fagocitosi o l'azione massiccia dei fattori chemiotattici, aumenta la richiesta di energia delle cellule, che si ottiene attraverso uno shunt del monofosfato. In condizioni ipossiche è possibile ottenere in breve tempo un apporto sufficiente di ATP utilizzando la glicolisi. Le risposte successive dei neutrofili polimorfonucleari attivati dipendono dal tipo di stimolazione. I prodotti di sintesi sono limitati ai metaboliti dell'acido arachidonico e ad altri fattori lipidici.
Sistema fagocitico mononucleare. Le cellule dominanti del sistema fagocitico mononucleare sono i macrofagi. Le forme di manifestazione della loro attività sono estremamente eterogenee. L'origine generale delle cellule dipende dalla monocitopoiesi del midollo osseo, da dove i monociti entrano nel sangue, dove circolano fino a tre giorni, per poi migrare nei tessuti adiacenti. Qui avviene la maturazione finale dei monociti, o in istiociti mobili (macrofagi tissutali) o in macrofagi tessuto-specifici altamente differenziati (macrofagi alveolari polmonari, cellule di Kupffer del fegato). L'eterogeneità morfologica delle cellule corrisponde alla diversità funzionale del sistema mononucleare. L'istiocita ha spiccate capacità di fagocitosi, secrezione e sintesi. D'altra parte, le cellule dendritiche dei linfonodi e della milza, così come le cellule di Langerhans della pelle, sono più specializzate nell'elaborazione e nella presentazione dell'antigene. Le cellule del sistema fagocitico mononucleare possono vivere da diverse settimane a diversi mesi, il loro diametro è di 15-25 micron, il nucleo è ovale o a forma di rene. Nei promonociti e nei monociti vengono rilevati granuli azzurrofili e nei macrofagi maturi, simili alle cellule della serie granulocitica. Contengono numerosi enzimi idrolitici, altri principi attivi e solo tracce di mieloperossidasi e lattoferrina. La monocitopoiesi del midollo osseo può essere aumentata solo 2-4 volte. Le cellule del sistema fagocitico mononucleare proliferano in modo estremamente limitato al di fuori del midollo osseo. La sostituzione delle cellule del sistema fagocitico mononucleare nei tessuti viene effettuata dai monociti del sangue. È necessario distinguere tra macrofagi a riposo e attivati e l'attivazione può influenzare un'ampia varietà di funzioni cellulari. I macrofagi svolgono tutte le funzioni delle cellule del sistema fagocitico mononucleare; inoltre, sintetizzano e secernono un gran numero di proteine nell'ambiente extracellulare. Le idrolasi vengono sintetizzate dai macrofagi in grandi quantità e si accumulano nei lisosomi o vengono immediatamente secrete. Il lisozima viene prodotto continuamente nelle cellule e viene anche secreto; sotto l'influenza di attivatori, il suo livello nel sangue aumenta, il che consente di giudicare lo stato di attività del sistema fagocitico mononucleare. Il metabolismo nei macrofagi può procedere sia attraverso la via ossidativa che quella glicolitica. All'attivazione si osserva anche una “esplosione di ossigeno”, realizzata attraverso lo shunt dell'esoso monofosfato e manifestata nella formazione di specie reattive dell'ossigeno.
Funzioni specifiche dei fagociti. La fagocitosi è una funzione caratteristica dei fagociti; può verificarsi in vari modi ed essere combinata con altre manifestazioni di attività funzionale:
- riconoscimento dei segnali chemiotattici;
- chemiotassi;
- fissaggio su supporto solido (adesione);
- endocitosi;
- reazione agli aggregati non fagocitati (a causa delle dimensioni);
- secrezione di idrolasi e altre sostanze;
- rottura intracellulare delle particelle;
- rimozione dei prodotti di decadimento dalla cellula.
Meccanismi citotossici e infiammatori. I fagociti attivati sono cellule citotossiche altamente efficienti. In questo caso occorre suddividere i seguenti meccanismi:
1) citolisi intracellulare e attività battericida dopo fagocitosi;
2) citotossicità extracellulare:
- citotossicità da contatto (fagocito e cellula bersaglio sono associati tra loro per almeno un breve periodo);
- citotossicità a distanza (il fagocito e la cellula bersaglio sono adiacenti l'uno all'altro, ma non sono in contatto diretto).
I tipi di citotossicità intracellulare e da contatto possono essere causati immunologicamente (mediati da anticorpi) o avere una natura non specifica. La citotossicità a distanza è sempre non specifica, cioè è indotta da enzimi tossici e specie reattive dell'ossigeno provenienti da macrofagi attivati. Questa categoria comprende gli effetti citotossici sulle cellule tumorali mediati dal fattore di necrosi tumorale e dall'interferone alfa.
Nell'ambito della protezione antinfettiva, grande importanza è attribuita alla capacità battericida dei fagociti, che si manifesta a livello intracellulare dopo la fagocitosi dei microrganismi. Quando la microscopia della fagocitosi dei granulociti neutrofili si osserva una degranulazione cellulare più o meno pronunciata. Si tratta della fusione di granuli specifici ed azzurofili con il fagosoma e la membrana citoplasmatica. Gli enzimi lisosomiali e le sostanze biologicamente attive vengono secreti sia nel fagosoma che nell'ambiente. In questo caso si attivano le idrolasi che agiscono all'esterno della cellula come fattori che promuovono l'infiammazione e mediano la citotossicità a distanza. La loro massima concentrazione si osserva nel fagolisosoma, con conseguente rapida degradazione di proteine, lipidi e polisaccaridi. Va notato che i microrganismi hanno una membrana relativamente resistente all'azione degli enzimi lisosomiali, ma nel fagolisosoma deve essere distrutta. Esistono meccanismi O2-dipendenti e O2-indipendenti di citotossicità e attività battericida dei fagociti.
Citotossicità ossigeno-indipendente. Nelle aree di infiammazione con microcircolazione compromessa, ipossia e anossia, i fagociti sono caratterizzati da vitalità e attività limitate a causa del metabolismo glicolitico. L'attività battericida dei fagolisosomi è determinata dai valori di pH acido, dal contenuto di numerose proteine cationiche tossiche, idrolasi acide e lisozima. I PMN e i macrofagi attivati sono anche capaci di citotossicità da contatto indipendente. Può essere causato dall'ADCC o da altri meccanismi non specifici mirati, ad esempio, alle cellule tumorali. Le basi biochimiche di questo fenomeno non sono ancora note. La citotossicità dipendente e indipendente si manifesta prevalentemente in totale, tuttavia numerose idrolasi lisosomiali vengono inattivate dai radicali liberi. L'influenza reciproca di varie idrolasi lisosomiali, proteinasi, lipasi, da un lato, e proteine cationiche insieme agli inibitori enzimatici, dall'altro, è impossibile da coprire completamente.
I meccanismi dell'attività battericida dei granulociti e dei macrofagi sono simili. A seconda della loro posizione, i macrofagi possono agire sia come antinfiammatorio che come causa di infiammazioni. Questi effetti sono dovuti ai processi di secrezione e sintesi.
Funzioni di secrezione e sintesi dei fagociti. Insieme alla chemiotassi e alla fagocitosi, la secrezione è una delle funzioni fondamentali dei fagociti. Tutte e 3 le funzioni sono strettamente correlate tra loro, la sintesi e la secrezione sono necessarie per la cooperazione dei leucociti con le cellule endoteliali, l'attivazione piastrinica, la regolazione delle ghiandole endocrine e l'ematopoiesi. Inoltre, la sintesi proteica nei macrofagi e la loro secrezione sono importanti per il sistema di coagulazione del sangue, il sistema del complemento e il sistema delle chinine. Vanno evidenziati diversi processi:
1) svuotamento di granuli o lisosomi di macrofagi e granulociti;
2) sintesi e secrezione di lipidi attivi;
3) sintesi e secrezione di numerose proteine nei macrofagi.
I macrofagi sintetizzano una serie di fattori del sistema del complemento e trasportano essi stessi recettori per alcuni prodotti di attivazione di questo sistema. Di particolare importanza per il sistema immunitario è la sintesi dell'interleuchina-1 da parte delle cellule del sistema macrofagico, che da un lato induce la proliferazione dei linfociti, dall'altro attiva la sintesi delle proteine della fase acuta nel fegato e favorisce l'aumento della temperatura corporea (pirogeni endogeni).
Attraverso la sintesi dell'interferone, i macrofagi regolano la resistenza dell'organismo alle infezioni virali. Un ruolo significativo nella regolazione della resistenza effettuata dai macrofagi è svolto dalla sintesi da parte di queste cellule dei fattori stimolanti le colonie G-CSF, GM-CSF) della mielo- e monocitopoiesi del midollo osseo. L'ampia gamma di funzioni svolte dai macrofagi consente di valutare il loro ruolo nella patogenesi delle malattie che si verificano sia con che senza manifestazioni infiammatorie. Il confronto dei dati sulle proprietà dei macrofagi con le informazioni su altre cellule del sistema di resistenza e del sistema immunitario ci consente di concludere che le nostre conoscenze sono piuttosto limitate. L'uso di metodi di biologia molecolare e di ingegneria genetica consente di ottenere prodotti di sintesi dei macrofagi in forma purificata e in quantità significative. I fattori macrofagici conosciuti più interessanti includono il fattore di necrosi tumorale e l'interferone. Per le sue proprietà, il sistema dei macrofagi occupa un posto centrale nella difesa contro le malattie batteriche, virali e tumorali.
Sistema dei fagociti mononucleari(Greco monox uno + lat. nucleos nucleo: greco fago divoratore, assorbente + histol. cellula sutus; sinonimo: sistema macrofagico, sistema monociti-macrofagi) - un sistema protettivo fisiologico delle cellule con la capacità di assorbire e digerire materiale estraneo. Le cellule che compongono questo sistema hanno un'origine comune, sono caratterizzate da somiglianza morfologica e funzionale e sono presenti in tutti i tessuti del corpo.
La base dell'idea moderna di S. m. f. è la teoria dei fagociti sviluppata da I.I. Mechnikov alla fine del XIX secolo, e l’insegnamento del patologo tedesco Aschoff (K. A. L. Aschoff) sul sistema reticoloendoteliale (RES). Inizialmente, il RES è stato identificato morfologicamente come un sistema di cellule del corpo in grado di accumulare il colorante vitale carminio. Secondo questo criterio, gli istiociti del tessuto connettivo, i monociti del sangue, le cellule di Kupffer del fegato, nonché le cellule reticolari degli organi emopoietici, le cellule endoteliali dei capillari, i seni del midollo osseo e i linfonodi sono stati classificati come RES. Con l'accumulo di nuove conoscenze e il miglioramento dei metodi di ricerca morfologica, è diventato chiaro che le idee sul sistema reticoloendoteliale sono vaghe, non specifiche e in un certo numero di posizioni sono semplicemente errate. Ad esempio, alle cellule reticolari e all'endotelio dei seni del midollo osseo e dei linfonodi è stato assegnato per lungo tempo il ruolo di fonte di cellule fagocitiche, cosa che si è rivelata errata. È ormai accertato che i fagociti mononucleati originano dai monociti circolanti nel sangue. I monociti maturano nel midollo osseo, quindi entrano nel flusso sanguigno, da dove migrano nei tessuti e nelle cavità sierose, diventando macrofagi. Le cellule reticolari svolgono una funzione di supporto e creano il cosiddetto microambiente per le cellule ematopoietiche e linfoidi. Le cellule endoteliali trasportano le sostanze attraverso le pareti dei capillari. Le cellule reticolari e l'endotelio vascolare non sono direttamente correlati al sistema protettivo delle cellule. Nel 1969, in una conferenza a Leida dedicata al problema delle RES, il concetto di “sistema reticoloendoteliale” fu considerato obsoleto. È stato invece adottato il concetto di “sistema fagocitico mononucleare”. Questo sistema comprende istiociti del tessuto connettivo, cellule di Kupffer del fegato (reticoloendoteliociti stellati), macrofagi alveolari dei polmoni, macrofagi dei linfonodi, milza, midollo osseo, macrofagi pleurici e peritoneali, osteoclasti del tessuto osseo, microglia del tessuto nervoso, sinoviociti del tessuto sinoviale. membrane, cellule di Langergais della pelle, dendrociti granulari privi di pigmento. Ce ne sono di gratuiti, ad es. muovendosi attraverso i tessuti e macrofagi fissi (residenti), avendo un posto relativamente costante.
I macrofagi dei tessuti e delle cavità sierose, secondo la microscopia elettronica a scansione, hanno una forma quasi sferica, con una superficie piegata irregolare formata dalla membrana plasmatica (citolemma).
In condizioni di coltivazione, i macrofagi si estendono sulla superficie del substrato e acquisiscono una forma appiattita e, quando si muovono, formano molteplici pseudopodi polimorfici. Una caratteristica ultrastrutturale di un macrofago è la presenza nel suo citoplasma di numerosi lisosomi e fagolisosomi, o vacuoli digestivi ( riso. 1 ). I lisosomi contengono vari enzimi idrolitici che assicurano la digestione del materiale assorbito. I macrofagi sono cellule secretorie attive che rilasciano enzimi, inibitori e componenti del complemento nell'ambiente. Il principale prodotto secretorio dei macrofagi è il lisozima. I macrofagi attivati secernono proteinasi neutre (elastasi, collagenasi), attivatori del plasminogeno, fattori del complemento come C2, C3, C4, C5 e interferone.Celle S. m. f. hanno una serie di funzioni, che si basano sulla loro capacità di endocitosi, cioè assorbimento e digestione di particelle estranee e liquidi colloidali. Grazie a questa capacità svolgono una funzione protettiva. Attraverso la chemiotassi, i macrofagi migrano verso focolai di infezione e infiammazione, dove effettuano la fagocitosi dei microrganismi, uccidendoli e digerendoli. In condizioni di infiammazione cronica, possono comparire forme speciali di fagociti: cellule epitelioidi (ad esempio, in un granuloma infettivo), cellule multinucleate giganti del tipo cellulare Pirogov-Langhans e il tipo di cellule di corpo estraneo. che si formano dalla fusione dei singoli fagociti in un policarione, una cellula multinucleata ( riso. 2 ). Nei granulomi, i macrofagi producono la glicoproteina fibronectina, che attira i fibroblasti e favorisce lo sviluppo di a.
Celle S. m. f. prendere parte ai processi immunitari. Pertanto, un prerequisito per lo sviluppo di una risposta immunitaria diretta è l'interazione primaria del macrofago con l'antigene. In questo caso, l'antigene viene assorbito e trasformato dai macrofagi in una forma immunogenica. La stimolazione immunitaria dei linfociti avviene attraverso il contatto diretto con un macrofago che trasporta un antigene convertito. La risposta immunitaria nel suo insieme viene effettuata come una complessa interazione a più stadi dei linfociti G e B con i macrofagi.
I macrofagi hanno attività antitumorale e mostrano proprietà citotossiche contro le cellule tumorali. Questa attività è particolarmente pronunciata nei cosiddetti macrofagi immunitari, che lisano le cellule tumorali bersaglio a contatto con linfociti T sensibilizzati che trasportano anticorpi citofili (linfochine).
Celle S. m. f. partecipano alla regolazione dell’ematopoiesi mieloide e linfoide. Pertanto, le isole ematopoietiche nel midollo osseo rosso, nella milza, nel fegato e nel sacco vitellino dell'embrione si formano attorno a una cellula speciale: il macrofago centrale, che organizza l'eritropoiesi dell'isola eritroblastica. Le cellule di Kupffer del fegato sono coinvolte nella regolazione dell'ematopoiesi producendo eritropoietina.