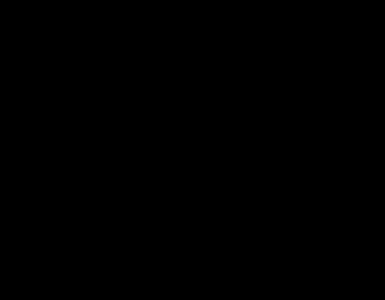Panoramica del sottofilo dei vertebrati. Atmosfera e respirazione della natura vivente Meccanismo della respirazione esterna
Tuttavia, la quota di partecipazione della pelle alla respirazione umana è trascurabile rispetto a quella dei polmoni, poiché la superficie totale del corpo è inferiore a 2 m2 e non supera il 3% della superficie totale degli alveoli polmonari.
I componenti principali del sistema respiratorio sono le vie aeree, i polmoni e i muscoli respiratori, compreso il diaframma. L'aria atmosferica che entra nei polmoni umani è una miscela di gas: azoto, ossigeno, anidride carbonica e alcuni altri (Fig. 2).
Riso. 2. Valori medi della pressione parziale dei gas (mm Hg) a secco
nell'aria inspirata, negli alveoli, nell'aria espirata e nel sangue durante il riposo muscolare (parte centrale della figura). Pressione parziale dei gas nel sangue venoso che scorre dai reni e dai muscoli (parte inferiore della figura)
La pressione parziale di un gas in una miscela di gas è la pressione che questo gas creerebbe in assenza di altri componenti della miscela. Dipende dalla percentuale di gas presente nella miscela: più è alta, maggiore è la pressione parziale di questo gas. La pressione parziale dell'ossigeno* nell'aria alveolare è 105 mm Hg. Art., e nel sangue venoso – 40 mm Hg. Art., quindi l'ossigeno si diffonde dagli alveoli nel sangue. Quasi tutto l’ossigeno nel sangue è legato chimicamente all’emoglobina. La pressione parziale dell'ossigeno nei tessuti è relativamente bassa, quindi si diffonde dai capillari sanguigni nel tessuto, fornendo processi di respirazione tissutale e di conversione dell'energia.
Il trasporto dell'anidride carbonica, uno dei prodotti finali del metabolismo, avviene in modo simile nella direzione opposta. L'anidride carbonica viene rilasciata dal corpo attraverso i polmoni. L'azoto non viene utilizzato nel corpo. La pressione parziale di ossigeno, anidride carbonica e azoto nell'aria atmosferica e ai diversi livelli dello schema di trasporto dell'ossigeno è presentata in Fig. 2.

UN– cilindro esterno, B– finestra in vetro per le letture, V– cilindro interno, G– un cilindro pneumatico per bilanciare il cilindro interno, D- acqua
Grazie alla diffusione, la composizione dell'aria alveolare cambia continuamente: la concentrazione di ossigeno in essa diminuisce e aumenta la concentrazione di anidride carbonica. Per mantenere il processo respiratorio, la composizione dei gas nei polmoni deve essere costantemente aggiornata. Ciò si verifica durante la ventilazione dei polmoni, ad es. respirare nel senso comune del termine. Quando inspiriamo, il volume dei polmoni aumenta e l'aria entra dall'atmosfera. Allo stesso tempo, gli alveoli si espandono. A riposo, ad ogni respiro entrano nei polmoni circa 500 ml di aria. Questo volume d'aria si chiama volume corrente. I polmoni umani hanno una certa riserva di capacità che può essere utilizzata durante la respirazione intensa. Dopo un'inalazione calma, una persona può inalare circa 1500 ml di aria. Questo volume si chiama volume di riserva inspiratoria. Dopo un'espirazione calma, puoi, facendo uno sforzo, espirare circa 1500 ml di aria. Questo volume di riserva espiratoria. Il volume corrente e i volumi di riserva inspiratorio ed espiratorio si sommano a capacità vitale(VEL). In questo caso è pari a 3500 ml (500 + 1500 + 1500). Per misurare la capacità vitale, fai un respiro particolarmente profondo e poi espira il più possibile nel tubo di un dispositivo speciale: uno spirometro. Le misurazioni vengono effettuate in posizione eretta a riposo (Fig. 3). Il valore della capacità vitale dipende dal sesso, dall’età, dalla corporatura e dalla forma fisica. Questa cifra varia ampiamente, con una media di 2,5–4 litri nelle donne e 3,5–5 litri negli uomini. In alcuni casi, nelle persone molto alte, ad esempio nei giocatori di basket, la capacità vitale può raggiungere i 9 litri. Sotto l'influenza dell'allenamento, ad esempio, quando si eseguono speciali esercizi di respirazione, la capacità vitale aumenta (a volte anche del 30%).

Riso. 4. Nomogramma di Miller per determinare la corretta capacità vitale dei polmoni
La capacità vitale può essere determinata utilizzando il nomogramma di Miller (Fig. 4). Per fare ciò, devi trovare la tua altezza sulla scala e collegarla con una linea retta alla tua età (separatamente per donne e uomini). Questa linea retta intersecherà la scala della capacità vitale. Un indicatore importante nella ricerca sulle prestazioni fisiche è volume minuto di respirazione, O ventilazione. La ventilazione è la quantità effettiva di aria che, in diverse condizioni, passa attraverso i polmoni entro 1 minuto. A riposo, la ventilazione polmonare è di 5–8 l/min.
Una persona è in grado di controllare la propria respirazione. Puoi ritardarlo per un po’ o intensificarlo. La capacità di aumentare la respirazione è misurata dal valore massima ventilazione polmonare(MLW). Questo valore, come la capacità vitale, dipende dal grado di sviluppo dei muscoli respiratori. Durante il lavoro fisico la ventilazione polmonare aumenta e raggiunge i 150–180 l/min. Più il lavoro è duro, maggiore è la ventilazione polmonare.
L'elasticità del polmone dipende in gran parte dalle forze di tensione superficiale del liquido che bagna la superficie interna degli alveoli (s = 5 x 10–2 n/m). La natura stessa si è occupata di facilitare la respirazione e ha creato sostanze che abbassano la tensione superficiale. Sono sintetizzati da cellule speciali situate nelle pareti degli alveoli. La sintesi di questi tensioattivi continua per tutta la vita di una persona.
In quei rari casi in cui un neonato non ha cellule produttrici di tensioattivi nei polmoni, non riesce a fare il primo respiro da solo e muore. A causa della mancanza o assenza di tensioattivi negli alveoli, circa mezzo milione di neonati nel mondo muoiono ogni anno senza emettere il primo respiro.
Tuttavia, alcuni animali che respirano polmoni possono fare a meno dei tensioattivi. Prima di tutto, questo vale per gli animali a sangue freddo: rane, serpenti, coccodrilli. Poiché questi animali non hanno bisogno di spendere energia per stare al caldo, il loro fabbisogno di ossigeno non è elevato come quello degli animali a sangue caldo e quindi hanno una superficie polmonare inferiore. Se nei polmoni di una persona la superficie di contatto tra 1 cm 3 di aria e vasi sanguigni è di circa 300 cm 2, in una rana è di soli 20 cm 2.
La relativa diminuzione dell'area polmonare per unità di volume negli animali a sangue freddo è dovuta al fatto che il diametro dei loro alveoli è circa 10 volte maggiore rispetto agli animali a sangue caldo. E dalla legge di Laplace ( P= 4a/R) ne consegue che la pressione addizionale che deve essere vinta durante l'inspirazione è inversamente proporzionale al raggio degli alveoli. L'ampio raggio degli alveoli negli animali a sangue freddo consente loro di inalare facilmente anche senza ridurre le dimensioni P a causa dei tensioattivi.
Non ci sono tensioattivi nei polmoni degli uccelli. Gli uccelli sono animali a sangue caldo e conducono uno stile di vita attivo. A riposo, il bisogno di ossigeno degli uccelli è superiore a quello di altri vertebrati, compresi i mammiferi, e durante il volo aumenta molte volte. Il sistema respiratorio degli uccelli è in grado di saturare il sangue con ossigeno anche quando volano ad alta quota, dove la sua concentrazione è molto inferiore rispetto al livello del mare. Tutti i mammiferi (compresi gli esseri umani), una volta a tale altezza, iniziano a sperimentare la carenza di ossigeno, riducono drasticamente la loro attività motoria e talvolta cadono addirittura in uno stato di semi-svenimento. Come possono i polmoni degli uccelli, in assenza di tensioattivi, far fronte a questo difficile compito?
Oltre ai polmoni normali, gli uccelli hanno un sistema aggiuntivo costituito da cinque o più paia di sacche d'aria a pareti sottili collegate ai polmoni. Le cavità di queste borse si ramificano ampiamente nel corpo e si estendono in alcune ossa, talvolta anche nelle piccole ossa delle falangi delle dita. Di conseguenza, il sistema respiratorio, ad esempio nelle anatre, occupa circa il 20% del volume corporeo (2% polmoni e 18% sacche aeree), mentre nell'uomo è solo il 5%. Le pareti delle sacche d'aria sono povere di vasi sanguigni e non partecipano allo scambio di gas. Gli airbag non solo aiutano a soffiare aria attraverso i polmoni in una direzione, ma riducono anche la densità del corpo, l'attrito tra le sue singole parti e contribuiscono a un raffreddamento efficace del corpo.
Il polmone dell'uccello è costituito da sottili tubi collegati in parallelo, aperti su entrambi i lati, circondati da vasi sanguigni - capillari aerei, che si estendono dai parabronchi. Durante l'inspirazione aumentano i volumi delle sacche d'aria anteriori e posteriori. L'aria dalla trachea entra direttamente nelle sacche posteriori. Le sacche anteriori non comunicano con il bronco principale e sono piene di aria che lascia i polmoni (Fig. 5, UN).

Riso. 5 . Movimento dell'aria nel sistema respiratorio di un uccello: UN- inspira, B– espirare
(K1 e K2 sono valvole che modificano il movimento dell'aria)
Quando espiri, la comunicazione tra le sacche anteriori e il bronco principale viene ripristinata e la comunicazione tra le sacche posteriori viene interrotta. Di conseguenza, durante l’espirazione, l’aria fluisce attraverso i polmoni dell’uccello nella stessa direzione che durante l’inspirazione (Fig. 5, B). Durante la respirazione cambia solo il volume delle sacche d'aria e il volume del polmone rimane quasi costante. Diventa chiaro il motivo per cui non ci sono tensioattivi nei polmoni degli uccelli: lì semplicemente non servono, perché non è necessario gonfiare i polmoni.
Alcuni organismi usano l'aria per qualcosa di più della semplice respirazione. Il corpo del pesce palla, che vive nell'Oceano Indiano e nel Mar Mediterraneo, è costellato di numerose scaglie modificate con aghi. In uno stato calmo, gli aghi si adattano più o meno strettamente al corpo. In pericolo, il pesce palla si precipita sulla superficie dell'acqua e, prendendo aria nell'intestino, si trasforma in una palla gonfiata. In questo caso, gli aghi si alzano e sporgono in tutte le direzioni. Il pesce sta vicino alla superficie dell'acqua, con la pancia capovolta e parte del corpo sporge sopra l'acqua. In questa posizione il pesce palla è protetto dai predatori sia dal basso che dall'alto. Quando il pericolo è passato, il pesce palla rilascia aria e il suo corpo assume le dimensioni normali.
Il guscio d'aria della Terra (atmosfera) è trattenuto vicino alla Terra a causa delle forze di gravità ed esercita una pressione su tutti i corpi con cui entra in contatto. Il corpo umano è adattato alla pressione atmosferica e non tollera bene la sua diminuzione. Quando si scalano le montagne (4mila metri, e talvolta anche meno), molte persone non si sentono bene e hanno attacchi di "mal di montagna": diventa difficile respirare, spesso il sangue sanguina dalle orecchie e dal naso ed è possibile la perdita di coscienza. Poiché le superfici articolari si adattano strettamente l'una all'altra (nella capsula articolare che copre le articolazioni, la pressione è ridotta) a causa della pressione atmosferica, in alta montagna, dove la pressione atmosferica è notevolmente ridotta, l'azione delle articolazioni viene interrotta, il le braccia e le gambe non “ascoltano” bene, si verificano facilmente lussazioni. Scalatori e piloti, quando salgono a grandi altezze, portano con sé l'attrezzatura per l'ossigeno e si allenano appositamente prima della salita.
Lo speciale programma di addestramento per gli astronauti prevede l'addestramento obbligatorio in una camera a pressione, ovvero una camera d'acciaio ermeticamente sigillata collegata a una potente pompa che crea al suo interno alta o bassa pressione. Nella medicina moderna, le camere a pressione vengono utilizzate per trattare molte malattie. Alla camera viene fornito ossigeno puro e viene creata un'alta pressione. A causa della diffusione dell'ossigeno attraverso la pelle e i polmoni, la sua tensione nei tessuti aumenta notevolmente. Questo metodo di trattamento è molto efficace, ad esempio, per le infezioni delle ferite (cancrena gassosa) causate da microrganismi anaerobici per i quali l'ossigeno è un forte veleno.
Alle altitudini in cui volano le moderne astronavi, non c'è praticamente aria, quindi le cabine delle navi sono sigillate ermeticamente e al loro interno vengono create e mantenute la normale pressione e composizione dell'aria, umidità e temperatura. La violazione del sigillo della cabina porta a conseguenze tragiche.
La navicella spaziale Soyuz-11 con tre cosmonauti a bordo (G. Dobrovolsky, V. Volkov, V. Patsayev) fu lanciata nell'orbita terrestre bassa il 6 giugno 1971 e il 30 giugno, al ritorno sulla Terra, l'equipaggio morì come conseguenza della depressurizzazione del modulo di discesa dopo la separazione dei compartimenti ad un'altitudine di 150 km.
Alcune informazioni sulla respirazione
La persona respira ritmicamente. Un neonato fa movimenti respiratori 60 volte in 1 minuto, un bambino di cinque anni - 25 volte in 1 minuto, a 15-16 anni la frequenza respiratoria diminuisce a 16-18 in 1 minuto e rimane tale fino alla vecchiaia, quando tornerà ad essere più frequente.
Alcuni animali hanno una frequenza respiratoria molto più bassa: il condor fa un movimento respiratorio ogni 10 secondi e il camaleonte ogni 30 minuti. I polmoni del camaleonte sono collegati da sacche speciali nelle quali aspira aria e allo stesso tempo si gonfia notevolmente. La bassa frequenza respiratoria consente al camaleonte di non rilevare la sua presenza per molto tempo.
A riposo e a temperatura normale, una persona consuma circa 250 ml di ossigeno al minuto, 15 litri all'ora, 360 litri al giorno. La quantità di ossigeno consumata a riposo non è costante: è maggiore durante il giorno che durante la notte, anche se una persona dorme durante il giorno. Questa è probabilmente una manifestazione dei ritmi circadiani nella vita del corpo. Una persona sdraiata consuma circa 15 litri di ossigeno in 1 ora, in piedi - 20 litri, camminando tranquillamente - 50 litri, camminando a una velocità di 5 km/h - 150 litri.
A pressione atmosferica, una persona può respirare ossigeno puro per circa un giorno, dopodiché si verifica la polmonite, che termina con la morte. A una pressione di 2-3 atm, una persona può respirare ossigeno puro per non più di 2 ore, quindi si verifica una violazione della coordinazione dei movimenti, dell'attenzione e della memoria.
In 1 minuto, normalmente attraverso i polmoni passano 7-9 litri di aria, ma per un corridore allenato - circa 200 litri.
Durante il lavoro intenso, gli organi interni necessitano di un maggiore apporto di ossigeno. Durante un'attività intensa, il consumo di ossigeno da parte del cuore aumenta di 2 volte, del fegato di 4 volte e dei reni di 10 volte.
Ad ogni inspirazione, una persona esegue un lavoro sufficiente per sollevare un carico del peso di 1 kg ad un'altezza di 8 cm. Utilizzando il lavoro svolto entro 1 ora, sarebbe possibile sollevare questo carico ad un'altezza di 86 m e durante la notte - a 690 M.
È noto che il centro respiratorio si eccita quando aumenta la concentrazione di anidride carbonica nel sangue. Se la concentrazione di anidride carbonica nel sangue si riduce, una persona potrebbe non respirare per un periodo di tempo più lungo del solito. Ciò può essere ottenuto con una respirazione rapida. I subacquei utilizzano una tecnica simile e i pescatori di perle esperti possono rimanere sott'acqua per 5-7 minuti.
La polvere è ovunque. Anche in vetta alle Alpi 1 ml di aria contiene circa 200 particelle di polvere. Lo stesso volume di aria urbana contiene più di 500mila particelle di polvere. Il vento trasporta la polvere su distanze molto lunghe: ad esempio, in Norvegia è stata scoperta la polvere del Sahara e in Europa è stata trovata polvere vulcanica delle isole dell'Indonesia. Le particelle di polvere vengono trattenute nel sistema respiratorio e possono causare varie malattie.
A Tokyo, dove ogni residente ha 40 cm2 di superficie stradale, gli agenti di polizia indossano maschere di ossigeno. A Parigi sono state installate cabine per l'aria pulita per i passanti. I patologi riconoscono i parigini durante le autopsie dai loro polmoni neri. A Los Angeles vengono installate palme di plastica sulle strade perché quelle viventi muoiono a causa dell’elevato inquinamento atmosferico.
Continua
* Si riferisce alla pressione parziale dell'ossigeno nell'aria alla quale è in equilibrio con l'ossigeno disciolto nel sangue o in un altro mezzo, chiamata anche tensione dell'ossigeno in questo mezzo.
Test
706-01. I vertebrati con un cuore a tre camere, la cui riproduzione è strettamente legata all'acqua, sono raggruppati in questa classe
A) Pesci ossei
B) Mammiferi
B) Rettili
D) Anfibi
Risposta
706-02. A quale classe appartengono gli animali, il cui diagramma della struttura del cuore è mostrato nella figura?
A) Insetti
B) Pesci cartilaginei
B) Anfibi
D) Uccelli
Risposta
706-03. La caratteristica che distingue gli anfibi dai pesci è
A) sangue freddo
B) struttura del cuore
B) sviluppo in acqua
D) sistema circolatorio chiuso
Risposta
706-04. Gli anfibi differiscono dai pesci nell'avere
Un cervello
B) sistema circolatorio chiuso
B) polmoni accoppiati negli adulti
D) organi di senso
Risposta
706-05. Quale caratteristica tra quelle elencate distingue la maggior parte degli animali della classe Anfibi dai Mammiferi?
B) fecondazione esterna
B) riproduzione sessuale
D) utilizzo dell'ambiente acquatico come habitat
Risposta
706-06. Nel processo di evoluzione, i rettili acquisirono, a differenza degli anfibi,
A) sistema circolatorio chiuso
B) elevata fertilità
B) un grande uovo con membrane embrionali
D) cuore a tre camere
Risposta
706-07. Se, nel processo di evoluzione, un animale ha formato il cuore mostrato in figura, allora gli organi respiratori dell'animale dovrebbero essere 
A) polmoni
B) pelle
B) sacche polmonari
D) branchie
Risposta
706-08. In quale gruppo di animali la riproduzione non coinvolge l'acqua?
A) senza cranio (lancette)
B) pesci ossei
B) anfibi
D) rettili
Risposta
706-09. In quali animali l'embrione si sviluppa completamente all'interno dell'uovo?
A) pesci ossei
B) anfibi dalla coda
B) anfibi senza coda
D) rettili
Risposta
706-10. I vertebrati con un cuore a tre camere, la cui riproduzione non è associata all'acqua, sono raggruppati in questa classe
A) Pesci ossei
B) Mammiferi
B) Rettili
D) Anfibi
Risposta
706-11. I vertebrati con temperatura corporea instabile, respirazione polmonare, cuore a tre camere con setto incompleto nel ventricolo sono classificati come
A) pesci ossei
B) anfibi
B) rettili
D) pesci cartilaginei
Risposta
706-12. I rettili, a differenza degli anfibi, tendono a farlo
A) fecondazione esterna
B) fecondazione interna
B) sviluppo con formazione di una larva
D) divisione del corpo in testa, busto e coda
Risposta
706-13. Quale dei seguenti animali è a sangue freddo?
A) lucertola veloce
B) Tigre dell'Amur
B) volpe delle steppe
D) lupo comune
Risposta
706-14. Quale classe comprende animali che hanno la pelle secca con scaglie cornee e un cuore a tre camere con un setto incompleto?
A) Rettili
B) Mammiferi
B) Anfibi
D) Uccelli
Risposta
706-15. Gli uccelli differiscono dai rettili per l'avere
A) fecondazione interna
B) sistema nervoso centrale
B) due cerchi di circolazione sanguigna
D) temperatura corporea costante
Risposta
706-15. Quale caratteristica strutturale è simile nei rettili e negli uccelli moderni?
A) ossa piene d'aria
B) pelle secca, priva di ghiandole
B) regione caudale della colonna vertebrale
D) piccoli denti nelle mascelle
Risposta
706-16. In quale animale lo scambio gassoso tra l'aria atmosferica e il sangue avviene attraverso la pelle?
A) orca assassina
B) tritone
B) coccodrillo
D) rosa salmone
Risposta
706-17. Quale gruppo di animali ha un cuore formato da due camere?
Un pesce
B) anfibi
B) rettili
D) mammiferi
Risposta
706-18. Lo sviluppo del bambino nell'utero avviene a
A) uccelli rapaci
B) rettili
B) anfibi
D) mammiferi
Risposta
706-19. Rappresentanti di quale classe di cordati sono caratterizzati dalla respirazione cutanea?
A) Anfibi
B) Rettili
B) Uccelli
D) Mammiferi
Risposta
706-20. Il segno della classe degli anfibi è
A) copertura chitinosa
B) pelle nuda
B) nati vivi
D) arti accoppiati
Risposta
706-21. Per quali caratteristiche i rappresentanti della classe degli anfibi differiscono dagli altri vertebrati?
A) colonna vertebrale e arti liberi
B) respirazione polmonare e presenza di una cloaca
B) pelle nuda delle mucose e fecondazione esterna
D) sistema circolatorio chiuso e cuore a due camere
Risposta
706-22. Quale caratteristica tra quelle elencate distingue gli animali della classe Rettili dagli animali della classe Mammiferi?
A) sistema circolatorio chiuso
B) temperatura corporea instabile
C) sviluppo senza trasformazione
D) utilizzo dell'ambiente suolo-aria come habitat
Fisiologia della respirazione 1.
1. L'essenza della respirazione. Il meccanismo di inspirazione ed espirazione.
2. L'emergere di pressione negativa nello spazio peripolmonare. Pneumotorace, atelettasia.
3. Tipi di respirazione.
4. Capacità vitale dei polmoni e loro ventilazione.
N 1. L'essenza della respirazione. Il meccanismo di inspirazione ed espirazione.
n L’insieme dei processi che assicurano lo scambio di ossigeno e anidride carbonica tra l’ambiente esterno ed i tessuti dell’organismo è denominato respirazione , e l'insieme degli organi che forniscono la respirazione è sistema respiratorio.
N Tipi di respirazione:
n Cellulare - negli organismi unicellulari su tutta la superficie della cellula.
n Cutanea – negli organismi multicellulari (vermi) su tutta la superficie del corpo.
n Tracheale - negli insetti attraverso trachee speciali che corrono lungo la superficie laterale del corpo.
n Gill - nel pesce attraverso le branchie.
n Polmonare: negli anfibi attraverso i polmoni.
n Nei mammiferi, attraverso organi respiratori specializzati: rinofaringe, laringe, trachea, bronchi, polmoni, e anche il torace, il diaframma e il gruppo muscolare: inspiratori ed espiratori.
n Polmoni (0,6-1,4% del peso corporeo) - organi accoppiati, hanno lobi (destra - 3, sinistra - 2), divisi in lobuli (ciascuno con 12-20 acini), i bronchi si ramificano in bronchioli, terminando in alveoli .
n Unità morfologica e funzionale del polmone - acini (lat. acinus - acino d'uva)- ramificazione del bronchiolo respiratorio in dotti alveolari che terminano con 400-600 sacchi alveolari.
n Gli alveoli sono pieni d'aria e non collassano per la presenza di tensioattivi sulle loro pareti - tensioattivi (fosfolipoproteine o lipopolisaccaridi).
N Fasi della respirazione:
n a) ventilazione polmonare - scambio di gas tra i polmoni e l'ambiente esterno;
n b) scambio di gas nei polmoni tra aria alveolare e capillari della circolazione polmonare;
n c) trasporto di O2 e CO2 attraverso il sangue;
n d) scambio di gas tra il sangue dei capillari della circolazione sistemica e il fluido tessutale;
n e) la respirazione intracellulare è un processo enzimatico a più stadi di ossidazione dei substrati nelle cellule.
n Il principale processo fisico che garantisce il movimento dell'O2 dall'ambiente esterno alle cellule e della CO2 nella direzione opposta è diffusione , cioè il movimento di un gas come sostanza disciolta lungo gradienti di concentrazione.
N Inalazione - ispirazione .
n Il movimento dell'aria dentro e fuori i polmoni nell'ambiente è causato dai cambiamenti di pressione all'interno dei polmoni. Quando i polmoni si espandono, la pressione al loro interno diventa inferiore a quella atmosferica (di 5-8 mm Hg) e l'aria viene aspirata nei polmoni. I polmoni stessi non hanno tessuto muscolare. La variazione del volume polmonare dipende dalla variazione del volume del torace, ad es. i polmoni seguono passivamente i cambiamenti nel torace. Durante l'inspirazione, il torace si espande in direzione verticale, sagittale e frontale. Quando i muscoli inspiratori (inspiratori) - i muscoli intercostali esterni e il diaframma - si contraggono, le costole si sollevano verso l'alto e il torace si espande. Il diaframma assume una forma conica. Tutto ciò aiuta a ridurre la pressione nei polmoni e ad aspirare aria. Lo spessore degli alveoli è piccolo, quindi i gas si diffondono facilmente attraverso la parete degli alveoli.
N Espirazione - scadenza .
n Quando espiri, i muscoli inspiratori si rilassano e il torace, a causa della pesantezza e dell'elasticità delle cartilagini costali, ritorna nella sua posizione originale. Il diaframma si rilassa e diventa a forma di cupola. Pertanto, a riposo, l'espirazione avviene passivamente, a causa della fine dell'inspirazione.
n Con la respirazione forzata, l'espirazione diventa attiva - è potenziata dalla contrazione dei muscoli espiratori (esalatori) - muscoli intercostali interni, muscoli addominali - esalatore obliquo esterno ed interno, addominale trasversale e dritto, esalatore dentato dorsale. Aumenta la pressione nella cavità addominale, che spinge il diaframma nella cavità toracica, le costole scendono e si avvicinano l'una all'altra, riducendo il volume del torace.
n Quando i polmoni collassano, l'aria viene espulsa, la pressione al loro interno diventa superiore a quella atmosferica (di 3-4 mm Hg).
N 2. L'emergere di pressione negativa nello spazio peripolmonare. Pneumotorace, atelettasia
n I polmoni nel torace sono separati da strati pleurici: viscerale - adiacente ai polmoni, parietale - che riveste il torace dall'interno. Tra le foglie c'è la cavità pleurica. È pieno di liquido pleurico. La pressione nella cavità pleurica è sempre inferiore di 4-10 mm Hg rispetto alla pressione atmosferica. Arte. (nei polmoni 760 mm Hg). Ciò è dovuto a: 1) crescita più rapida del torace rispetto ai polmoni nell'ontogenesi postnatale; 2) trazione elastica(tensione elastica) dei polmoni, cioè una forza che si oppone al loro allungamento provocato dall'aria. La cavità pleurica è sigillata dall'ambiente.
n Quando l'aria entra nella cavità pleurica (ad esempio durante un infortunio), la pressione nella cavità pleurica equivale alla pressione atmosferica - pneumotorace , mentre il polmone collassa - atelettasia e la respirazione potrebbe fermarsi.
n La pressione negativa della cavità pleurica si forma alla nascita. Durante la prima inspirazione, il torace si espande, i polmoni si espandono, perché sono ermeticamente separati: nella cavità pleurica si forma una pressione negativa. Nel feto, i polmoni sono in uno stato collassato, il torace è appiattito, la testa delle costole è all'esterno della fossa glenoidea. Alla nascita, nel sangue del feto si accumula anidride carbonica che stimola il centro respiratorio. Da qui gli impulsi arrivano ai muscoli inspiratori, che si contraggono, le teste delle costole entrano nelle fosse articolari. Il torace aumenta di volume, i polmoni si espandono.
n La relazione tra volume toracico e volume polmonare durante la respirazione viene solitamente illustrata utilizzando metodi fisici Modelli Donders:
n 1. Copertura in vetro,
n 2. In alto c'è un tappo con un foro,
n 3. Fondo – pellicola elastica con anello,
n 4. All'interno del cappuccio ci sono i polmoni di un coniglio.
n Quando il volume all'interno del tappo aumenta a causa dello stiramento della pellicola elastica, la pressione nella cavità del tappo diminuisce, l'aria entra nei polmoni attraverso il foro del tappo, questi si espandono e viceversa.
N 3. Tipi di respirazione.
N 1. Toracico o costale – la variazione del volume del torace avviene principalmente a causa dei muscoli intercostali (espiratori e inspiratori). Caratteristica dei cani e delle donne.
N 2. Addominale o diaframmatico – la variazione del volume del torace avviene principalmente a causa del diaframma e dei muscoli addominali. Caratteristico per gli uomini.
N 3. Misto o toracoaddominale – le variazioni del volume del torace avvengono in egual misura con la contrazione dei muscoli intercostali, del diaframma e dei muscoli addominali. Caratteristica degli animali da fattoria.
n I tipi di respirazione hanno significato diagnostico: se gli organi della cavità addominale o toracica sono danneggiati, cambiano.
N 4. Capacità vitale dei polmoni e loro ventilazione.
N Capacità vitale dei polmoni (VC) è costituito da 3 volumi d'aria che entrano ed escono dai polmoni durante la respirazione:
N 1. Respiratorio - volume d'aria durante l'inspirazione e l'espirazione tranquille. Per animali di piccola taglia (cani, piccoli animali) - 0,3-0,5 l, per animali di grossa taglia (bovini, cavalli) - 5-6 l.
N 2. Volume inspiratorio aggiuntivo o di riserva– il volume d'aria che entra nei polmoni durante l'inspirazione massima dopo un'inspirazione tranquilla. 0,5-1 e 5-15 l.
N 3. Volume di riserva espiratoria– il volume d'aria alla massima espirazione dopo un'espirazione tranquilla. 0,5-1 e 5-15 l.
n La capacità vitale viene determinata misurando il volume di espirazione massima dopo la precedente inspirazione massima mediante spirometria. Negli animali viene determinato inalando una miscela di gas ad alto contenuto di anidride carbonica.
N Volume residuo - il volume d'aria che rimane nei polmoni anche dopo la massima espirazione.
N Aria di spazio “dannoso” o “morto”. - il volume d'aria che non partecipa allo scambio di gas e si trova nella parte superiore dell'apparato respiratorio - cavità nasale, faringe, trachea (20-30%).
N Il significato di spazio “dannoso”.:
n 1) l'aria si riscalda (abbondante apporto di vasi sanguigni), che impedisce l'ipotermia dei polmoni;
n 2) l'aria è purificata e umidificata (macrofagi alveolari, molte ghiandole mucose);
n 3) quando le ciglia dell'epitelio ciliato sono irritate, si verifica lo starnuto - una rimozione riflessa di sostanze nocive;
n 4) recettori dell'analizzatore olfattivo (“labirinto olfattivo”);
n 5) regolazione del volume dell'aria inalata.
n Il processo di aggiornamento della composizione del gas dell’aria alveolare durante l’inspirazione e l’espirazione – ventilazione .
n L'intensità della ventilazione è determinata dalla profondità dell'ispirazione e dalla frequenza dei movimenti respiratori.
N Profondità di inspirazione determinato dall'ampiezza dei movimenti del torace, nonché misurando i volumi polmonari.
N Frequenza respiratoria conteggiato in base al numero di escursioni del torace in un determinato periodo di tempo (4-5 volte inferiore alla frequenza cardiaca).
n Cavallo (al minuto) – 8-16; Bovini – 12-25; SIGNORA – 12-16; maiale – 10-18; cane – 14-24; coniglio – 15-30; pelliccia - 18-40.
N Volume respiratorio minuto è il prodotto del volume corrente dell'aria e della frequenza respiratoria al minuto.
n Esempio: cavallo: 5 l x 8 = 40 l
N Metodi per studiare la respirazione:
n1. Pneumografia– registrazione dei movimenti respiratori mediante pneumografo.
n2. Spirometria– misurazione dei volumi correnti mediante spirometri.
Lezione 25.
Fisiologia della respirazione 2.
1. Scambio di gas tra gli alveoli e il sangue. Stato dei gas nel sangue.
2. Trasporto dei gas e fattori che lo determinano. Respirazione dei tessuti.
3. Funzioni polmonari non correlate allo scambio di gas.
4. Regolazione della respirazione, centro respiratorio e sue proprietà.
5. Peculiarità della respirazione negli uccelli.
Scambio gassoso tra gli alveoli e il sangue. Stato dei gas nel sangue.
Negli alveoli dei polmoni avviene lo scambio di O2 e CO2 tra l'aria e il sangue dei capillari della circolazione polmonare.
L'aria espirata contiene più O2 e meno CO2 dell'aria alveolare, perché ad esso si mescola l'aria dello spazio nocivo (7,1).
La quantità di diffusione del gas tra gli alveoli e il sangue è determinata da leggi puramente fisiche operanti nel sistema gas-liquido separato da una membrana semipermeabile.
Il fattore principale che determina la diffusione dei gas dagli alveoli dell'aria al sangue e dal sangue agli alveoli è la differenza di pressione parziale, o gradiente di pressione parziale. La diffusione avviene da un'area di pressione parziale maggiore a un'area di pressione minore.
Composizione gassosa dell'aria
Pressione parziale(lat. parziale – parziale) - è la pressione che un gas, in una miscela di gas, eserciterebbe alla stessa temperatura, occupando l'intero volume
P = RA x a/100,
dove P è la pressione parziale del gas, PA è la pressione atmosferica, ed è il volume di gas contenuto nella miscela in %, 100 –%.
P O2 inalazione = 760 x 21 / 100 = 159,5 mm Hg. Arte.
P Inalazione di CO2. = 760 x 0,03 / 100 = 0,23 mmHg. Arte.
P N2 inalare. = 760 x 79/100 = 600,7 mmHg. Arte.
L'uguaglianza P O2 o P CO2 non si verifica mai nei mezzi interagenti. Nei polmoni c'è un flusso costante di aria fresca dovuto ai movimenti respiratori del torace, mentre nei tessuti la differenza di tensione dei gas è mantenuta dai processi di ossidazione.
La differenza tra la pressione parziale dell'O2 nell'aria alveolare e quella del sangue venoso dei polmoni è: 100 - 40 = 60 mmHg, che provoca la diffusione dell'O2 nel sangue. Quando la differenza di tensione O2 è 1 mmHg. Arte. In una mucca, 100-200 ml di O2 passano nel sangue al minuto. Il fabbisogno medio di O2 di un animale a riposo è di 2000 ml per 1 minuto. Differenze di pressione di 60 ml Hg. Arte. più che sufficiente per saturare il sangue con O2 sia a riposo che durante l'esercizio.
60mmHg x 100-200 ml = 6000-12000 ml O2 al minuto
LEZIONE N. 15. Fisiologia della respirazione.
1.
2. Respirazione esterna (ventilazione polmonare).
3.
4. Trasporto di gas (O2, CO2) attraverso il sangue.
5. Scambio di gas tra sangue e fluido tissutale. Respirazione dei tessuti.
6. Regolazione della respirazione.
1. L'essenza del respiro. Sistema respiratorio.
La respirazione è una funzione fisiologica che garantisce lo scambio gassoso tra il corpo e l'ambiente esterno e l'insieme degli organi coinvolti nello scambio gassoso è l'apparato respiratorio.
Evoluzione del sistema respiratorio.
1.Negli organismi unicellulari la respirazione avviene attraverso la superficie (membrana) della cellula.
2.Negli animali multicellulari inferiori lo scambio di gas avviene attraverso l'intera superficie delle cellule esterne ed interne (intestinali) del corpo.
3.Negli insetti il corpo è ricoperto da una cuticola e quindi compaiono speciali tubi respiratori (trachee) che penetrano in tutto il corpo.
4.Nel pesce Gli organi respiratori sono branchie: numerose foglie con capillari.
5.Negli anfibi compaiono sacche d'aria (polmoni), in cui l'aria viene rinnovata con l'aiuto dei movimenti respiratori. Tuttavia, il principale scambio di gas avviene attraverso la superficie della pelle e rappresenta i 2/3 del volume totale.
6.Nei rettili, negli uccelli e nei mammiferi i polmoni sono già ben sviluppati e la pelle diventa un rivestimento protettivo e lo scambio di gas attraverso di essa non supera l'1%. Nei cavalli sottoposti ad elevata attività fisica, la respirazione attraverso la pelle aumenta all'8%.
Sistema respiratorio.
L'apparato respiratorio dei mammiferi è un insieme di organi che svolgono funzioni di conduzione dell'aria e di scambio di gas.
Vie aeree superiori: cavità nasale, bocca, rinofaringe, laringe.
Vie aeree inferiori: trachea, bronchi, bronchioli.
Funzione di scambio di gas eseguito dal tessuto poroso respiratorio - parenchima polmonare. La struttura di questo tessuto comprende vescicole polmonari - alveoli.
ha la parete delle vie aeree scheletro cartilagineo e il loro lume non si abbassa mai. La mucosa del tubo respiratorio è rivestita epitelio ciliato con ciglia. Trachea prima dell'ingresso nei polmoni dicotomicamenteè diviso in due bronchi principali (sinistro e destro), che si dividono e si formano ulteriormente albero bronchiale. La divisione termina con finito bronchioli (terminali) (diametro fino a 0,5-0,7 mm).
Polmoni situati nella cavità toracica e hanno forma di tronco di cono. La base del polmone è rivolta all'indietro ed è adiacente al diaframma. L'esterno dei polmoni è ricoperto da una membrana sierosa - pleura viscerale. Pleura parietale (osso) delimita la cavità toracica e si fonde strettamente con la parete costale. Tra questi strati di pleura c'è uno spazio a fessura (5-10 micron) - cavità pleurica pieno di liquido sieroso. Viene chiamato lo spazio tra i polmoni destro e sinistro mediastino. Qui si trovano il cuore, la trachea, i vasi sanguigni e i nervi. I polmoni sono divisi in lobi, segmenti e lobuli. Il grado di gravità di questa divisione varia tra i diversi animali.
L'unità morfologica e funzionale del polmone è acinus (lat. acinus - acino d'uva). Acino include bronchioli respiratori (respiratori) e dotti alveolari, quale fine sacchi alveolari. Un acino contiene 400-600 alveoli; 12-20 acini formano il lobo polmonare.
Alveoli – Queste sono vescicole, la cui superficie interna è rivestita da epitelio squamoso monostrato. Tra le cellule epiteliali ci sono : alveolociti del 1° ordine, che, insieme all'endotelio dei capillari polmonari, si formano barriera aria-sangue E alveciti del 2° ordine svolgere una funzione secretoria, liberando la sostanza biologicamente attiva surfattano. Surfattano (fosfolipoproteine - tensioattivo) riveste la superficie interna degli alveoli, aumenta la tensione superficiale e previene il collasso degli alveoli.
Funzioni delle vie aeree.
Vie aeree(al loro interno viene trattenuto fino al 30% dell'aria inspirata) non partecipano allo scambio gassoso e sono chiamati spazio "dannoso". Tuttavia, le vie aeree superiori e inferiori svolgono un ruolo importante nella vita del corpo.
Qui l'aria inspirata viene riscaldata, umidificata e purificata. Ciò è possibile grazie alla mucosa ben sviluppata delle vie respiratorie, che è abbondante vascolarizzato, contiene cellule caliciformi, ghiandole mucose e un gran numero di ciglia dell'epitelio ciliato. Inoltre, ci sono recettori per l'analizzatore olfattivo, recettori per i riflessi protettivi di tosse, starnuti, sbuffo e recettori irritanti. Si trovano nei bronchioli e reagiscono alle particelle di polvere, al muco e ai vapori caustici. Quando i recettori irritanti sono irritati, si verifica una sensazione di bruciore, dolore, appare una tosse e la respirazione accelera.
Lo scambio di gas tra il corpo e l'ambiente esterno è assicurato da una serie di processi strettamente coordinati che fanno parte della struttura respiratoria degli animali superiori.
2. Respirazione esterna (ventilazione polmonare) un processo costante di aggiornamento della composizione gassosa dell'aria alveolare, che viene effettuato quando inspirazione ed espirazione.
Il tessuto polmonare non presenta elementi muscolari attivi e pertanto il suo aumento o diminuzione di volume avviene passivamente in sincronia con i movimenti del torace (inspirazione, espirazione). Ciò è dovuto pressione intrapleurica negativa(sotto l'atmosfera: durante l'inalazione di 15-30 mmHg. Arte., durante l'espirazione di 4-6 mmHg. Arte.) in una cavità toracica ermeticamente chiusa.
Il meccanismo della respirazione esterna.
L'atto dell'inspirazione (lat. ispirazione - ispirazione) effettuato aumentando il volume del torace. I muscoli inspiratori (respiratori) partecipano a questo: muscoli intercostali esterni e diaframma. Durante la respirazione forzata vengono attivati i seguenti muscoli: costole dell'elevatore, scaleno sopracostale, dentato dorsale. Il volume del torace aumenta in tre direzioni: verticale, sagittale (antero-posteriore) e frontale.
L'atto dell'espirazione (lat. scadenza - scadenza) in uno stato di riposo fisiologico è prevalentemente di natura passiva. Non appena i muscoli inspiratori si rilassano, il torace, a causa della sua pesantezza e dell'elasticità delle cartilagini costali, ritorna nella sua posizione originale. Il diaframma si rilassa e la sua cupola diventa nuovamente convessa.
Durante la respirazione forzata, l'atto di espirazione è facilitato dai muscoli espiratori: muscoli intercostali interni, obliqui esterni ed interni, muscoli addominali trasversali e retti e esalatore del dentato dorsale.
Tipi di respirazione.
A seconda della trasformazione di alcuni muscoli coinvolti nei movimenti respiratori, esistono tre tipi di respirazione:
1 - tipo di respirazione toracica (costale). effettuato dalla contrazione dei muscoli intercostali esterni e dei muscoli del cingolo pettorale;
2 – tipo di respirazione addominale (diaframmatica).– predominano le contrazioni del diaframma e dei muscoli addominali;
3 – tipo di respirazione mista (costo-addominale). più comune negli animali da fattoria.
Con varie malattie, il tipo di respirazione può cambiare. Nelle malattie degli organi toracici predomina il tipo di respirazione diaframmatica e nelle malattie degli organi addominali prevale il tipo di respirazione costale.
Frequenza respiratoria.
La frequenza respiratoria si riferisce al numero di cicli respiratori (inspirazione-espirazione) al minuto.
Cavallo 8 - 12 Cane 10 - 30
Groppa corno. bovini 10 - 30 Conigli 50 - 60
Pecore 8 - 20 Polli 20 - 40
Maiale 8 - 18 Anatre 50 - 75
Persona 10 - 18 Topo 200
Si prega di notare che la tabella mostra i valori medi. La frequenza dei movimenti respiratori dipende dal tipo di animale, razza, produttività, stato funzionale, ora del giorno, età, temperatura ambiente, ecc.
Volumi polmonari.
Esiste una distinzione tra capacità polmonare totale e vitale. La capacità vitale dei polmoni (VC) è composta da tre volumi: volumi respiratori e di riserva di inspirazione ed espirazione.
1.Volume corrente- questo è il volume d'aria che può essere inalato ed espirato con calma e senza sforzo.
2.Volume di riserva inspiratoria – Questa è l'aria che può essere ulteriormente inalata dopo un'inspirazione calma.
3.Volume di riserva espiratoria- questo è il volume d'aria che può essere espirato il più possibile dopo un'espirazione silenziosa.
Dopo un'espirazione completa e massimamente profonda, nei polmoni rimane dell'aria – volume residuo. La somma del fluido vitale e del volume d'aria residua è capacità polmonare totale.
Viene chiamata la somma del volume residuo d'aria e del volume di riserva espiratoria aria alveolare (capacità funzionale residua).
Volumi polmonari (in litri).
L'uomo cavallo
1. V respiratoria 5-6 0,5
2. Riserva V inalazione 12 1.5
3. Espirazione di riserva V 12 1.5
4. V 10 residuo 1
Ventilazione- Questo è il rinnovamento della composizione gassosa dell'aria alveolare durante l'inspirazione e l'espirazione. Quando si valuta l'intensità della ventilazione polmonare, utilizzare volume minuto di respirazione(la quantità di aria che passa attraverso i polmoni in 1 minuto), che dipende dalla profondità e dalla frequenza dei movimenti respiratori.
Il volume corrente del cavallo a riposo 5-6 litri , frequenza respiratoria 12 movimenti respiratori per 1 minuto.
Quindi: 5 l.*12=60 litri volume minuto di respirazione. per lavori leggeri è uguale a 150-200 litri, durante il duro lavoro 400-500 litri.
Durante la respirazione, le singole parti dei polmoni non sono tutte ventilate e con intensità diverse. Quindi calcolano coefficiente di ventilazione alveolare è il rapporto tra l'aria inalata e il volume alveolare. Bisogna tenere conto che quando un cavallo inala 5 litri, il 30% dell'aria rimane nello “spazio nocivo” delle vie aeree.
Pertanto, 3,5 litri di aria inalata raggiungono gli alveoli (70% di 5 litri di volume corrente). Pertanto il coefficiente di ventilazione alveolare è 3,5 l.:22 l. o 1:6. Cioè, con ogni respiro tranquillo, 1/6 degli alveoli vengono ventilati.
3. Diffusione dei gas (scambio di gas tra aria alveolare e sangue nei capillari della circolazione polmonare).
Lo scambio di gas nei polmoni avviene a seguito della diffusione l'anidride carbonica (CO 2) dal sangue negli alveoli polmonari e l'ossigeno (O 2) dagli alveoli al sangue venoso dei capillari della circolazione polmonare. È stato calcolato che circa il 5% dell'ossigeno contenuto nell'aria inalata rimane nel corpo e circa il 4% dell'anidride carbonica viene rilasciata dal corpo. L'azoto non prende parte allo scambio di gas.
Il movimento dei gas è determinato puramente leggi fisiche (osmosi e diffusione), operanti in un sistema gas-liquido separato da una membrana semipermeabile. Queste leggi si basano sulla differenza di pressione parziale o sul gradiente di pressione parziale dei gas.
Pressione parziale (lat. partialis - parziale)è la pressione di un gas contenuto nella miscela di gas.
La diffusione dei gas avviene da un'area a pressione maggiore a un'area a pressione minore.
Pressione parziale dell'ossigeno nell'aria alveolare 102 mmrt. Art., anidride carbonica 40 mm Hg. Arte. Tensione nel sangue venoso dei capillari dei polmoni O2 =40mmHg. Art., CO2=46 mmHg. Arte.
Pertanto la differenza di pressione parziale è:
ossigeno (O2) 102 – 40 = 62 mmHg. Arte.;
diossido di carbonio (CO2) 46 – 40 = 6 mmHg. Arte.
L'ossigeno entra rapidamente attraverso le membrane polmonari e si combina completamente con l'emoglobina e il sangue diventa arterioso. L'anidride carbonica, nonostante la leggera differenza di pressione parziale, sì tasso di diffusione più elevato (25 volte) dal sangue venoso agli alveoli polmonari.
4. Trasporto di gas (O 2, CO 2) attraverso il sangue.
L'ossigeno, passando dagli alveoli al sangue, è in due forme: circa 3% disciolto nel plasma e a proposito di Il 97% dei globuli rossi si combina con l'emoglobina (ossiemoglobina). Si chiama la saturazione del sangue con l'ossigeno ossigenazione.
Ci sono 4 atomi di ferro in una molecola di emoglobina, quindi 1 molecola di emoglobina può collegare 4 molecole di ossigeno.
NNB+ 4О 2 ↔ ННB(O2) 4
Ossiemoglobina (HHb (O 2) 4) - mostra la proprietà acido debole e facilmente dissociabile.
Viene chiamata la quantità di ossigeno presente in 100 mm di sangue quando l'emoglobina è completamente convertita in ossiemoglobina capacità di ossigeno del sangue.È stato stabilito che 1 g di emoglobina può, in media, legarsi 1,34 mmossigeno. Conoscere la concentrazione di emoglobina nel sangue e la sua media 15 g. /100ml, Puoi calcolare la capacità di ossigeno del sangue.
15 * 1,34 = 20,4 vol.% (percentuale in volume).
Trasporto dell'anidride carbonica nel sangue.
Il trasporto dell'anidride carbonica nel sangue è un processo complesso che coinvolge globuli rossi (emoglobina, enzima anidrasi carbonica) e sistemi tampone del sangue.
L'anidride carbonica si trova nel sangue in tre forme: 5% - in forma fisicamente disciolta; 10% - sotto forma di carboemoglobina; 85% - sotto forma di bicarbonati di potassio negli eritrociti e bicarbonati di sodio nel plasma.
La CO 2 che entra nel plasma sanguigno dal tessuto si diffonde immediatamente nei globuli rossi, dove avviene una reazione di idratazione con la formazione di acido carbonico (H 2 CO 3) e la sua dissociazione. Entrambe le reazioni sono catalizzate dall'enzima anidrasi carbonica, che è contenuto nei globuli rossi.
H2O+CO2 → H2CO3
anidrasi carbonica
↓
H2CO3 → H+ + HCO3 -
All'aumentare della concentrazione di ioni bicarbonato (NSO3-) nei globuli rossi, una parte di essi si diffonde nel plasma sanguigno e si combina con i sistemi tampone formando bicarbonato di sodio (NaHCO3). L'altra parte di HCO 3 rimane nei globuli rossi e si combina con emoglobina (carboemoglobina) e con cationi di potassio - bicarbonato di potassio (KHCO 3).
Nei capillari degli alveoli, l'emoglobina si combina con l'ossigeno (ossiemoglobina): questo è un acido più forte che sposta l'acido carbonico da tutti i composti. Sotto l'influenza dell'anidrasi carbonica, si verifica la sua disidratazione.
H2CO3 → H2O + CO2
Pertanto, l'anidride carbonica disciolta e rilasciata durante la dissociazione della carboemoglobina si diffonde nell'aria alveolare.
5. Scambio di gas tra sangue e fluido tissutale. Respirazione dei tessuti.
Lo scambio di gas tra sangue e tessuti avviene allo stesso modo a causa della differenza nella pressione parziale dei gas (secondo le leggi dell'osmosi e della diffusione). Il sangue arterioso che entra qui è saturo di ossigeno, la sua tensione lo è 100 mmrt. Arte. Nel fluido tissutale, la tensione dell'ossigeno è 20 - 40 mmHg. Arte., e nelle cellule il suo livello scende a 0.
Rispettivamente: O2 100 – 40 = 60 mmHg. Arte.
60 – 0 = 60 mmHg. Arte.
Pertanto, l'ossiemoglobina cattura l'ossigeno, che passa rapidamente nel fluido tissutale e quindi nelle cellule dei tessuti.
Respirazione dei tessuti è un processo di ossidazione biologica nelle cellule e nei tessuti. L'ossigeno che entra nei tessuti è influenzato dall'ossidazione di grassi, carboidrati e proteine. L'energia rilasciata in questo caso si accumula nella forma legami macroergici - ATP. Oltre alla fosforilazione ossidativa, viene utilizzato anche l'ossigeno durante l'ossidazione microsomiale - nei microsomi del reticolo endoplasmatico delle cellule. In questo caso, i prodotti finali delle reazioni ossidative diventano acqua e anidride carbonica.
L'anidride carbonica, dissolvendosi nel fluido tissutale, crea tensione lì 60-70 mmHg. Arte., che è più alto che nel sangue (40mmHg).
CO2 70 - 40 = 30 mm Hg. Arte.
Pertanto, l'elevato gradiente di tensione dell'ossigeno e la differenza nella pressione parziale dell'anidride carbonica nel fluido tissutale e nel sangue provocano la sua diffusione dal fluido tissutale nel sangue.
6. Regolazione della respirazione.
Centro respiratorio – si tratta di un insieme di neuroni dislocati in tutte le parti del sistema nervoso centrale e coinvolti nella regolazione della respirazione.
La parte principale del "nucleo" del centro respiratorio Mislavsky situato nel midollo allungato, nella regione della formazione reticolare nella parte inferiore del quarto ventricolo cerebrale. Tra i neuroni di questo centro esiste una rigorosa specializzazione (distribuzione delle funzioni). Alcuni neuroni regolano l'atto dell'inspirazione, altri l'atto dell'espirazione.
Vie respiratorie bulbari tra ha una caratteristica unica - automatico, che persiste anche con la sua completa deafferentazione (dopo la cessazione dell'influenza di vari recettori e nervi).
In zona ponte situato "Centro pneumotassico". Non ha automatismo, ma influenza l'attività dei neuroni del centro respiratorio Mislavsky, stimolando alternativamente l'attività dei neuroni per l'atto di inspirazione ed espirazione.
Gli impulsi nervosi vanno dal centro respiratorio ai motoneuroni nuclei del nervo toracoventrale(3-4 vertebre cervicali - il centro dei muscoli diaframmatici) e ai motoneuroni situati in corni laterali del midollo spinale toracico(innerva i muscoli intercostali esterni ed interni).
Nei polmoni (tra la muscolatura liscia delle vie aeree e attorno ai capillari della circolazione polmonare) sono presenti tre gruppi di recettori: distorsioni e collassi, irritante, iuxtacapillare. Le informazioni provenienti da questi recettori sullo stato dei polmoni (stiramento, collasso), sul loro riempimento d'aria, sull'ingresso di sostanze irritanti nel tratto respiratorio (gas, polvere), sui cambiamenti della pressione sanguigna nei vasi polmonari, viaggiano attraverso i nervi afferenti fino a il centro respiratorio. Ciò influenza la frequenza e la profondità dei movimenti respiratori, la manifestazione dei riflessi protettivi di tosse e starnuti.
Di grande importanza sono nella regolazione della respirazione fattori umorali. I vasi vascolari reagiscono ai cambiamenti nella composizione dei gas nel sangue zone riflessogene del seno carotideo, dell'aorta e del midollo allungato.
Un aumento della concentrazione di anidride carbonica nel sangue porta alla stimolazione del centro respiratorio. Di conseguenza, la respirazione diventa più veloce - dispnea (mancanza di respiro). La diminuzione dei livelli di anidride carbonica nel sangue rallenta il ritmo della respirazione -apnea.
Cos'è lo scambio di gas? Quasi nessuna creatura vivente può farne a meno. Lo scambio di gas nei polmoni e nei tessuti, così come nel sangue, aiuta a fornire sostanze nutritive alle cellule. Grazie a lui riceviamo energia e vitalità.
Cos'è lo scambio di gas?
Gli organismi viventi hanno bisogno dell'aria per esistere. È una miscela di molti gas, le cui quote principali sono ossigeno e azoto. Entrambi questi gas sono componenti essenziali per garantire il normale funzionamento degli organismi.
Nel corso dell'evoluzione, diverse specie hanno sviluppato i propri adattamenti per ottenerli: alcune hanno sviluppato i polmoni, altre hanno le branchie e altre ancora utilizzano solo la pelle. Con l'aiuto di questi organi avviene lo scambio di gas.
Cos'è lo scambio di gas? Si tratta di un processo di interazione tra l'ambiente esterno e le cellule viventi, durante il quale vengono scambiati ossigeno e anidride carbonica. Durante la respirazione, l'ossigeno entra nel corpo insieme all'aria. Saturando tutte le cellule e i tessuti, partecipa alla reazione ossidativa, trasformandosi in anidride carbonica, che viene escreta dal corpo insieme ad altri prodotti metabolici.
Scambio di gas nei polmoni
Ogni giorno inaliamo più di 12 chilogrammi di aria. I polmoni ci aiutano in questo. Sono l'organo più voluminoso, capace di trattenere fino a 3 litri di aria in un respiro completo e profondo. Lo scambio di gas nei polmoni avviene con l'aiuto degli alveoli: numerose bolle intrecciate con i vasi sanguigni.

L'aria entra in loro attraverso il tratto respiratorio superiore, passando attraverso la trachea e i bronchi. I capillari collegati agli alveoli aspirano l'aria e la distribuiscono in tutto il sistema circolatorio. Allo stesso tempo rilasciano anidride carbonica agli alveoli, che lascia il corpo insieme all'espirazione.
Il processo di scambio tra alveoli e vasi sanguigni è chiamato diffusione bilaterale. Avviene in pochi secondi e viene effettuato grazie alla differenza di pressione. L'aria atmosferica satura di ossigeno ha più ossigeno, quindi si precipita nei capillari. L'anidride carbonica ha una pressione inferiore, motivo per cui viene spinta negli alveoli.
Circolazione
Senza il sistema circolatorio, lo scambio di gas nei polmoni e nei tessuti sarebbe impossibile. Il nostro corpo è penetrato da numerosi vasi sanguigni di varia lunghezza e diametro. Sono rappresentati da arterie, vene, capillari, venule, ecc. Il sangue circola continuamente nei vasi, facilitando lo scambio di gas e sostanze.
Lo scambio di gas nel sangue avviene attraverso due circuiti circolatori. Durante la respirazione, l'aria inizia a muoversi in un ampio cerchio. Viene trasportato nel sangue legandosi a una proteina speciale chiamata emoglobina, che si trova nei globuli rossi.

Dagli alveoli l'aria entra nei capillari e poi nelle arterie, dirigendosi dritta al cuore. Nel nostro corpo svolge il ruolo di una potente pompa, che pompa il sangue ossigenato ai tessuti e alle cellule. Questi, a loro volta, rilasciano sangue pieno di anidride carbonica, inviandolo attraverso venule e vene al cuore.
Passando attraverso l'atrio destro, il sangue venoso completa un ampio cerchio. Inizia nel ventricolo destro, attraverso il quale viene pompato il sangue, si muove attraverso le arterie, le arteriole e i capillari, dove scambia aria con gli alveoli per ricominciare il ciclo.
Scambio nei tessuti
Quindi, sappiamo cos'è lo scambio di gas tra i polmoni e il sangue. Entrambi i sistemi trasportano e scambiano gas. Ma il ruolo chiave spetta ai tessuti. In essi avvengono i principali processi che modificano la composizione chimica dell’aria.
Satura le cellule con l'ossigeno, che innesca in esse una serie di reazioni redox. In biologia sono chiamati ciclo di Krebs. Per la loro implementazione sono necessari enzimi, che arrivano anche con il sangue.
Nel processo si formano acidi citrico, acetico e altri, prodotti per l'ossidazione di grassi, aminoacidi e glucosio. Questa è una delle fasi più importanti che accompagna lo scambio di gas nei tessuti. Durante il suo decorso viene rilasciata l'energia necessaria per il funzionamento di tutti gli organi e sistemi del corpo.
L'ossigeno viene utilizzato attivamente per eseguire la reazione. Si ossida gradualmente, trasformandosi in anidride carbonica - CO 2, che viene rilasciata dalle cellule e dai tessuti nel sangue, quindi nei polmoni e nell'atmosfera.
Scambio di gas negli animali
La struttura del corpo e dei sistemi di organi di molti animali varia in modo significativo. I mammiferi sono i più simili agli esseri umani. I piccoli animali, come le planarie, non hanno sistemi metabolici complessi. Usano i loro rivestimenti esterni per respirare.
Gli anfibi usano la pelle, la bocca e i polmoni per respirare. Nella maggior parte degli animali che vivono nell'acqua, lo scambio di gas viene effettuato utilizzando le branchie. Sono piastre sottili collegate ai capillari e trasportano l'ossigeno dall'acqua al loro interno.

Gli artropodi, come millepiedi, onischi, ragni e insetti, non hanno polmoni. Hanno trachee su tutta la superficie del corpo, che dirigono l'aria direttamente alle cellule. Questo sistema consente loro di muoversi rapidamente senza avvertire mancanza di respiro e affaticamento, perché il processo di formazione dell'energia avviene più velocemente.
Scambio di gas nelle piante
A differenza degli animali, lo scambio di gas nei tessuti delle piante prevede il consumo sia di ossigeno che di anidride carbonica. Consumano ossigeno durante la respirazione. Le piante non hanno organi speciali per questo, quindi l'aria entra in loro attraverso tutte le parti del corpo.
Di norma, le foglie hanno l'area più grande e la maggior parte dell'aria cade su di esse. L'ossigeno vi entra attraverso piccole aperture tra le cellule, chiamate stomi, viene elaborato ed espulso sotto forma di anidride carbonica, come negli animali.

Una caratteristica distintiva delle piante è la loro capacità di fotosintesi. Pertanto, possono convertire i componenti inorganici in organici con l'aiuto della luce e degli enzimi. Durante la fotosintesi viene assorbita anidride carbonica e viene prodotto ossigeno, quindi le piante sono vere e proprie “fabbriche” di arricchimento dell’aria.
Peculiarità
Lo scambio di gas è una delle funzioni più importanti di qualsiasi organismo vivente. Si effettua attraverso la respirazione e la circolazione sanguigna, favorendo il rilascio di energia e il metabolismo. La particolarità dello scambio di gas è che non avviene sempre allo stesso modo.
Prima di tutto, è impossibile senza respirare; fermarlo per 4 minuti può portare a disturbi nel funzionamento delle cellule cerebrali. Di conseguenza, il corpo muore. Esistono molte malattie in cui lo scambio di gas è compromesso. I tessuti non ricevono abbastanza ossigeno, il che rallenta il loro sviluppo e il loro funzionamento.

Lo scambio di gas irregolare si osserva anche nelle persone sane. Aumenta in modo significativo con l'aumento del lavoro muscolare. In soli sei minuti raggiunge la massima potenza e la mantiene. Tuttavia, con l’aumento del carico, la quantità di ossigeno può iniziare ad aumentare, il che avrà anche un effetto spiacevole sul benessere del corpo.