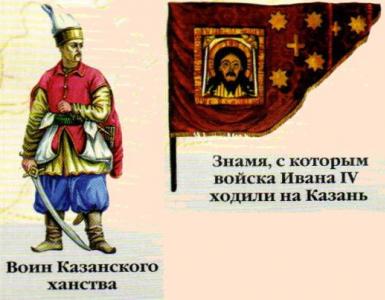Metodi psicologici. Emozioni ed emozioni fondamentali. Workaholism: definizione, struttura, analisi
Se ti ritrovi con la testa tra le nuvole così spesso da interferire con le tue attività quotidiane, forse hai bisogno di lavorare sulla tua concentrazione e abbandonare i sogni ad occhi aperti per la notte. Per ridurre il sogno ad occhi aperti, dovresti prima comprendere la causa e la portata di questa caratteristica. Puoi quindi utilizzare tecniche per combattere i sogni ad occhi aperti eccessivi, rafforzare la tua capacità di concentrazione e impegnarti in attività che mantengano la tua attenzione.
Passi
Analizza i tuoi modelli di fantasia
- Fai un elenco delle tue fantasie e delle funzioni che ritieni servano. Ad esempio, potresti notare che fantastici costantemente sulle conversazioni con gli amici, il che ti aiuta a prevedere cosa accadrà e come dovresti reagire. Un altro esempio potrebbe essere fantasticare sull'acquisto di una casa: forse ti aiuta a pensare a un giorno più luminoso e a sperare nel futuro.
- Chiediti: "Qual è lo scopo delle mie fantasie in generale?" Sogni costantemente ad occhi aperti per sfuggire alla realtà, distrarti, migliorare la tua condizione o ammazzare il tempo?
-
Evidenzia i modelli della tua fantasia. Comprendendo i modelli di fantasia, puoi aiutare te stesso a sviluppare un modo per affrontare ogni tipo di fantasia. Sogni ad occhi aperti per lo più a scuola o al lavoro? Ci sono alcune situazioni che “scatenano” le tue fantasie?
- Determina quanto spesso sogni ad occhi aperti. Imposta la sveglia per un'ora. Tieni traccia di quante volte sogni ad occhi aperti durante quell'ora. Ad esempio, nel momento in cui noti che inizi a sognare ad occhi aperti, prendi nota su un pezzo di carta. Questo ti aiuterà a capire quanto spesso sei distratto dalle fantasie. A volte potrebbero volerci alcuni minuti per realizzare che stai sognando ad occhi aperti, e va bene, notalo ogni volta che lo noti.
-
Evidenzia le conseguenze negative. Se la tua fantasia porta a difficoltà nel tuo Vita di ogni giorno Ad esempio, se sei distratto dalla scuola o dal lavoro, dalle relazioni interpersonali o dalle responsabilità personali, i tuoi sogni ad occhi aperti potrebbero essere considerati eccessivi e persino dannosi. Sfortunatamente, la tua tendenza ad avere pensieri vaganti può renderti infelice.
- Elenca le conseguenze negative associate alla tua ricca immaginazione. L'elenco potrebbe includere: trascorrere meno tempo con la famiglia e gli amici, restare indietro a scuola perché non riesci a concentrarti, non portare a termine tutto il tuo lavoro perché sei distratto dai sogni ad occhi aperti e la tua famiglia e i tuoi amici si sentono come se non fossi loro ... ascolti perché hai la testa tra le nuvole.
Usa le tecniche per sognare meno ad occhi aperti
-
Aumenta la tua consapevolezza. Per iniziare a cambiare la tua abitudine di avere la testa tra le nuvole, devi prima renderti conto che stai fantasticando troppo. Una volta compreso lo scopo delle tue fantasie, nonché gli schemi e le conseguenze, sarà più facile per te notare i momenti specifici in cui indulgi nei sogni ad occhi aperti.
- I segni che hai la testa tra le nuvole includono: perdere il contatto visivo con qualcuno durante una conversazione, difficoltà a concentrarsi sul compito da svolgere, avere pensieri non correlati alla situazione attuale e immaginare conversazioni con persone o eventi immaginari.
-
Tieni un diario fantasy. Quando ti rendi conto che stai sognando ad occhi aperti frequentemente, fermati immediatamente e scrivi cosa stavi sognando ad occhi aperti, così come l'ora del giorno, la situazione o il luogo in cui ti trovavi e per quanto tempo sei rimasto tra le nuvole. Questo ti aiuterà a diventare consapevole di quando stai fantasticando e capirai anche i tuoi modelli di comportamento.
- Metti in dubbio l'utilità della fantasia. Chiediti se la tua fantasia ti sta aiutando in qualche modo.
-
Delinea i principi e i confini della fantasia. Alcuni tipi di fantasticare possono portare a conseguenze negative. Ad esempio, sognare ad occhi aperti persone che non conosci bene può portare ad una maggiore solitudine. Tuttavia, quando presenti le persone a te vicine, rafforzi il legame tra te e il tuo livello generale di soddisfazione per la vita.
- Determina i confini, oltrepassando i quali dovresti smettere di fantasticare. Alcuni di questi possono includere intimità, spendere molti soldi o violenza.
- A volte, quando sei perso nei tuoi sogni e sprechi il tuo tempo, guarda l'orologio. Un orologio può ricordarci che ogni momento è molto prezioso, scorre via velocemente e non tornerà più.
-
Metti a fuoco la tua immaginazione. La fantasia può essere usata per pensare e lavorare verso obiettivi personali. Le tecniche di immaginazione e visualizzazione sono spesso utilizzate in terapia, soprattutto nel trattamento dell'ansia e della depressione. Utilizzando le tecniche di visualizzazione, puoi indirizzare la tua immaginazione verso ciò che ti sarà utile e ti aiuterà a rilassarti.
Inizia a muoverti. Quando noti che inizi a sognare ad occhi aperti, alzati e fai qualcosa di attivo. Ciò libererà la tua energia fisica, che a sua volta può aiutare i tuoi pensieri a concentrarsi e a smettere di essere tra le nuvole.
- Allunga un po'. Raggiungi il più in alto possibile. Quindi allarga le gambe ai lati in posizione eretta e allunga le mani a terra (piegati il più in basso possibile).
- Puoi fare salti "gambe unite, gambe divaricate", correre sul posto o scuotere le braccia. Impegnati in qualsiasi attività fisica purché sia sicura e appropriata per la situazione o il luogo in cui ti trovi.
-
Premiati per essere concentrato. Ogni volta che completi un compito senza sognare ad occhi aperti, premiati. Questa idea si basa sul rinforzo positivo, una componente della psicoterapia riabilitativa; gli studi hanno dimostrato che questo metodo migliora gli stati positivi (ad esempio, l'attenzione sostenuta a lungo termine). Questo metodo ti darà anche dei limiti personali (che non farai nulla di divertente finché non avrai completato l'attività) e ti darà qualcosa da aspettarti (ricompense).
- Concediti qualcosa che ti piace, ad esempio qualcosa di delizioso.
- Puoi anche concederti una pausa di 5 minuti come ricompensa. Fare pause adeguate aumenta anche la produttività. Durante questo periodo, fai qualcosa che ti piace davvero, come giocare o mandare messaggi a un amico.
-
Considera il trattamento. Sognare ad occhi aperti può essere un problema se causa problemi nella tua vita, come difficoltà nelle relazioni, a scuola, nel poter lavorare o in altre attività quotidiane. Se sei arrivato a questo punto, dovresti cercare aiuto.
- Consulta uno psicologo, un terapista familiare o uno psichiatra.
Aumenta la tua attenzione e concentrazione
-
Prova a fare esercizi di coinvolgimento mentale. Se hai la testa tra le nuvole, significa che sei concentrato su fantasie o sui tuoi pensieri che non sono necessariamente legati a ciò che accade intorno a te. Il coinvolgimento mentale è la capacità di essere presenti nel momento presente.
-
Usa la tecnica del “grounding”. Questa tecnica ti permetterà di isolarti dal dolore emotivo; È particolarmente utile se stai affrontando una situazione o un'emozione difficile e può servire come un sano e utile sostituto per sognare ad occhi aperti e avere la testa tra le nuvole. La tecnica del “radicamento” può essere utilizzata in qualsiasi situazione e in qualsiasi momento ti aiuterà a centrare la tua mente. Dopo tale esercizio, dovresti tornare a completare l'attività originale. Dopo questa tecnica vedrai che potrai concentrarti meglio.
- Nomina diversi oggetti nella stanza e i loro diversi usi.
- Puoi anche nominare colori o animali.
- Ricorda che non vuoi spendere troppo tempo usando la tecnica del radicamento, altrimenti la userai semplicemente come un'altra forma di fantasia. Limitati a circa un minuto e poi torna all'attività originale.
-
Dormire a sufficienza. Di bassa qualità il sonno è spesso associato ad un crescente desiderio di sognare ad occhi aperti. Se non lasci riposare la mente durante la notte, può diventare iperattiva durante il giorno. Le persone con problemi di sonno tendono ad essere più inclini alla depressione, all’ansia e ad altre malattie.
- Crea un programma del sonno (ora di andare a dormire e di sveglia) e dormi almeno 8 ore a notte.
- Usa tecniche di rilassamento e respirazione per aiutarti ad addormentarti la notte.
Affronta il motivo che ti fa andare con la testa tra le nuvole. Sapere perché tendi a sognare ad occhi aperti è fondamentale se vuoi cambiare la situazione. Se non sai perché sta succedendo qualcosa (la radice del problema), sarà difficile arrivare a una soluzione. A volte le persone possono sognare ad occhi aperti per evitare stress o emozioni negative. Questo mondo immaginario consente loro di evitare di affrontare le emozioni negative. Sognare ad occhi aperti può anche essere un modo per calmarsi, immaginando che i propri desideri siano già stati soddisfatti. Inoltre, fantasticare può essere associato alla necessità di dimenticare alcune informazioni (traumi, esperienze dolorose, ecc.). Il risultato della fantasia può essere l'oblio di determinate informazioni e ricordi.
I concetti di mentalizzazione, consapevolezza affettiva (emotiva) e coinvolgimento mentale vengono sempre più enfatizzati come chiave nella psicoterapia in varie direzioni. Sono stati sviluppati vari metodi per valutare questi concetti, ma si sa poco sulle loro relazioni. Discutiamo le somiglianze e le differenze concettuali tra questi tre concetti e presentiamo i risultati di una ricerca empirica preliminare sulla loro valutazione. Per esaminare le relazioni tra questi concetti, sono stati utilizzati i dati di uno studio su un gruppo di 46 studenti di psicoterapia. La mentalizzazione, coniato il termine Funzionamento Riflessivo (RF), è stata valutata trascrivendo una versione breve dell'intervista focalizzata sull'attaccamento dell'adulto, il questionario a 5 dimensioni. coinvolgimento mentale(FFMQ) è stato utilizzato per valutare l'impegno mentale e l'Affettive Mindfulness Interview, Self/Other-version (ACI-S|O) è stato utilizzato per valutare la consapevolezza affettiva. È stata riscontrata un'associazione piccola ma statisticamente significativa tra RF e FFMQ, ma sorprendentemente nessuna associazione tra ACI-S|O e RF o FFMQ. Analisi successive hanno mostrato una relazione tra la consapevolezza degli affetti (emozioni) degli altri e una versione abbreviata della scala RF. I risultati hanno mostrato che la mentalizzazione e l’impegno mentale condividevano alcuni cambiamenti comuni, ma contrariamente alle aspettative, la consapevolezza affettiva sembrava differire dalla RF e dall’impegno mentale più del previsto. Una possibile spiegazione per questa constatazione paradossale di una mancanza di associazione tra RF e consapevolezza affettiva è
p.27
è che le divisioni superiori della scala della consapevolezza affettiva valutano la capacità matura di mentalizzare l'affettività, mentre la RF è in gran parte una difesa contro lesioni e problemi. Poche o nessuna scoperta (conclusioni, dati) sul FFMQ sono spiegate maggiormente da varie deviazioni (errori) nella metodologia di ricerca.
Parole chiave: mentalizzazione, funzionamento riflessivo, consapevolezza affettiva, integrazione affettiva, mentalizzazione, affettività (emotività), coinvolgimento mentale.
Capacità di autoconsapevolezza e comprensione stati mentali come emozioni, pensieri, intenzioni e così via, vengono sempre più enfatizzati come importanti salute psicologica e il funzionamento interpersonale adattivo in varie teorie tradizionali della psicoterapia (Fonagy, Gergely, Jurist e Target, 2002; Hayes, Follette e Linehan, 2004; Hayes, Strosahl e Wilson, 1999; Linehan, 1993; Liotti & Gilbert, 2011; Segal, Williams e Teasdale, 2002). Nonostante la sua lunga esistenza nei concetti clinici della psicoanalisi (ad esempio, Bion, 1962, 1970; Freud, 1900/1953, 1937; Sterba, 1934), è solo di recente che la valutazione di questa capacità è diventata veramente possibile. Questo studio è un tentativo di confrontare concetti correlati utilizzando vari dati teorici e tecniche di valutazione (ricerca).
La teoria della mentalizzazione (Allen, Fonagy, & Bateman, 2008; Bateman & Fonagy, 2006, 2012; Fonagy et al., 2002; Fonagy & Target, 1996, 2000; Target & Fonagy, 1996) è un'estensione della teoria psicoanalitica combinata con la teoria e ricerca sull'attaccamento (Main, 1991; Main, Hesse e Goldwyn, 2008; Main, Kaplan e Cassidy, 1985), filosofia della mente (Dennett, 1987) e teoria e ricerca sulla coscienza (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985). Il concetto di mentalizzazione è definito come la capacità di comprendere il comportamento umano come il risultato di stati mentali, come pensieri, sentimenti, desideri, bisogni, ecc. (Fonagy, Target, Steele e Steele, 1998). Il termine si riferisce sia all'autoriflessione che alla riflessione del comportamento di altre persone nel senso di stati mentali.
Teoricamente, si ipotizza che la mentalizzazione derivi dall'integrazione dei primi stati di coscienza durante lo sviluppo della personalità, in particolare la cosiddetta equivalenza mentale e la "modalità gioco/finzione" (lo stato delle rappresentazioni) (Fonagy & Target, 1996; Target & Fonagy, 1996). L'equivalenza mentale significa che il mondo interno ed esterno sono visti come la stessa cosa, e si ritiene che questo causi paure (esperienze legate alla paura) quando le fantasie vengono vissute come reali esteriormente. L’opposto dell’equivalenza mentale è uno stato tardivo delle idee (“modalità di gioco/modalità di fantasia”) nel processo di sviluppo della personalità, in cui l’interno e l’esterno vengono vissuti in modo completamente separato l’uno dall’altro. Ciò significa che non esiste alcuna esperienza che colleghi le esperienze interne con il mondo esterno. In questo stato, le fantasie sono meno spaventose, ma lato posteriore le medaglie sono una sensazione di isolamento e alienazione. È importante che in nessuna di queste modalità vi sia alcuna possibilità di introspezione. Solo nella modalità integrata di mentalizzazione in una fase avanzata del processo di sviluppo della personalità è possibile osservare le esperienze interne come consapevolezza che sono separate e allo stesso tempo connesse con la realtà esterna.
Influenzato dalla teoria degli affetti di Tomkins (ad esempio, 1962, 1991) e dalla teoria della psicologia del sé della psicoanalisi (ad esempio, Stolorow, Brandchaft e Atwood, 1987), Monsen (Monsen, Eilertsen, Melg;rd, & ;deg;rd , 1996; Monsen & Monsen, 1999) hanno sviluppato la teoria dell'integrazione affettiva e della consapevolezza affettiva. Il termine consapevolezza affettiva (AC) si riferisce a "la relazione appropriata tra l'eccitazione delle esperienze emotive (affettive) di base e la capacità dell'individuo di percepire consapevolmente, tollerare, riflettere ed esprimere queste esperienze. "(Solbakken, Hansen e Monsen, 2011, p. 5), si ritiene anche che questo processo sia alla base dell'integrazione degli affetti nella cognizione, nella motivazione e nel comportamento. In questo quadro concettuale, viene considerato l’affetto
p.28
come i principali forze motrici, insieme agli impulsi, ai processi omeostatici di supporto vitale e al dolore.
Secondo Tomkins (1962, 1991), esiste un numero limitato di affetti universali innati e questo garantisce la diffusione della funzione ad altri sistemi (cognitivo, motorio, percettivo, memoria, ecc.). Gli affetti forniscono informazioni sullo stato del sé e sui suoi stati connessione con il mondo esterno stabilendo connessioni prevedibili tra interno ed esterno. Pertanto, integrare la funzione di segnalazione degli affetti con altri sistemi è vitale per la coerenza delle esperienze di un individuo (Solbakken, Hansen, Havik e Monsen, 2011). La consapevolezza affettiva, per definizione, riflette la capacità di accedere (accedere) ed elaborare (utilizzare) le proprietà adattive degli affetti per la regolazione personale (autoregolazione) - ciò che viene chiamato elaborazione emotiva (utilizzo) (Izard, Stark, Trentacosta e Schultz , 2008). Include anche la capacità di base di tollerare e regolare l’eccitazione affettiva, più comunemente definita regolazione delle emozioni. (Gross & Thompson, 2007; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011). È stato dimostrato che l'AC è sistematicamente associata a varie valutazioni della psicopatologia come disagio sintomatico, problemi interpersonali, autostima, problemi di personalità e funzionamento in generale (Lech, Andersson e Holmqvist, 2008; Solbakken, Hansen, Havik, et al ., 2011). Sebbene l’AS, come definito da Monsen e colleghi, si concentri sugli affetti vissuti dal sé, recentemente la teoria e la valutazione dell’AS si sono evolute per includere la consapevolezza degli affetti come oggetto di osservazione negli altri (Lech et al., 2008).
Sia la teoria della mentalizzazione che la teoria dell’AS forniscono spiegazioni clinicamente ed empiricamente supportate della relazione tra il mondo interno ed esterno. Un terzo concetto, che ha un'origine completamente diversa ma che sottolinea ugualmente il valore della capacità di introspezione, è il coinvolgimento psichico. L'impegno mentale è definito come dirigere intenzionalmente l'attenzione al momento presente con un atteggiamento di accettazione (Kabat-Zinn, 1990, 1996), un termine che ha le sue origini nelle tradizioni meditative buddiste (Nyanaponika, 1962). L'introspezione consapevole è caratterizzata da un tentativo consapevole di escludere l'elaborazione mentale delle informazioni (escludere l'attività cognitiva) al fine di osservare attentamente le cose così come sono, senza tenere conto di un'opinione precedentemente formata (giudizio). È importante che l'osservazione consapevole sia caratterizzata da un sentimento di benevola accettazione di tutto ciò che è oggetto di osservazione. Secondo gli autori buddisti, la pratica ripetuta della consapevolezza porta alla comprensione delle caratteristiche dell'essere (vita, esistenza), in definitiva l'essenza (natura) di breve durata, altruista e insoddisfacente di tutti i fenomeni, che a sua volta genera compassione per tutti gli esseri viventi. (ad esempio, Falkenstr;m, 2003; Korn;eld, 1993; Nyanaponika, 1962). Sebbene il coinvolgimento mentale sia chiaramente incluso nella terapia cognitivo comportamentale, sono diversi gli autori che ne hanno studiato l’importanza nella terapia psicodinamica e nella teoria generale della psicoanalisi (Epstein, 1995; Falkenstr;m, 2003, 2007; Safran, 2003; Safran & Muran , 2000). Il coinvolgimento mentale è stato paragonato a concetti fondamentali della psicoanalisi come la libera associazione (Epstein, 1995), l'attenzione sospesa, ecc. (Rubin, 1985), sia con l’idea di liberazione dalla memoria, dai desideri e dalla comprensione (concettualizzazione) (Bion, 1970).
Differenti sotto diversi aspetti, sia la mentalizzazione, l’AS e l’impegno mentale si concentrano sulla regolazione degli affetti, che implica prestare attenzione ai pensieri e ai sentimenti nel momento presente con curiosità e desiderio di trovare nuove prospettive su di essi. Inoltre, tutti e tre si concentrano più sul processo di osservazione che sui contenuti specifici della coscienza. Choi-Kain e Gunderson (2008) hanno confrontato questi concetti lungo tre dimensioni: implicito/esplicito, focus su sé/altro e focus cognitivo/affettivo. (Link in fondo alla pagina: Più recentemente, Fonagy e Luyten (2009) hanno aggiunto una quarta dimensione: la mentalizzazione, basata sulle caratteristiche interne ed esterne di sé e degli altri. Tuttavia, questo aspetto non sembra significativo se si confronta il concetto di mentalizzazione con consapevolezza affettiva e coinvolgimento mentale) Sebbene sia la mentalizzazione che
pag.29
AS ha componenti implicite ed esplicite; lo studio è limitato alla parte esplicita. Il coinvolgimento mentale differisce sotto questi aspetti perché è per definizione cosciente e quindi esplicito.
Tutti e tre i concetti si concentrano sul sé, sebbene la mentalizzazione abbia un uguale focus sugli altri (cioè si presume che i processi comuni siano alla base della mentalizzazione di sé e degli altri). AS è originariamente un concetto focalizzato su sé stessi, ma, come accennato in precedenza, l'espansione della teoria ha introdotto il concetto di consapevolezza affettiva focalizzata sull'altro (Lech et al., 2008). Empiricamente, come si può vedere da numerosi studi condotti fino ad oggi, la consapevolezza affettiva autodiretta e la consapevolezza affettiva diretta verso gli altri sono strettamente correlate tra loro (Lech et al., 2008; Lech, Holmqvist e Andersson, 2012). Sebbene la consapevolezza sia più spesso intesa come attenzione introspettiva a pensieri, sentimenti, sensazioni fisiche, ecc. dentro di sé, a volte viene utilizzata anche per osservare (prestare attenzione) la realtà esterna come suoni, immagini. In linea di principio, la consapevolezza potrebbe essere utilizzata anche per osservare gli stati interni di altre persone, sebbene tali applicazioni siano raramente descritte nella letteratura sulla consapevolezza. Forse perché gli stati interni degli altri non possono essere osservati direttamente, è necessario fare inferenze attraverso operazioni figurativo-cognitive, e a questo scopo la posizione osservativa di coinvolgimento mentale diventa estremamente difficile.
La dimensione cognitivo/affettiva di Choi-Kain e Gunderson (2008) può essere ulteriormente suddivisa nel processo e nel contenuto dell'osservazione (vedi anche Gullestad & Wilberg, 2011). L'AS è il più limitato in termini di contenuto dell'osservazione, che include solo la consapevolezza degli affetti, mentre il coinvolgimento mentale è il più ampio, includendo qualsiasi esperienza del momento presente come il vero (effettivo) contenuto dell'osservazione. In questo modo è possibile osservare consapevolmente non solo pensieri e sentimenti, ma anche qualsiasi impressione sensoriale strocettiva (ad esempio immagini, suoni, ecc.) o introcettiva (cioè sensazioni all'interno del corpo). La mentalizzazione si trova nel mezzo; il suo contenuto può contenere qualsiasi stato mentale, questi sono pensieri, sentimenti, intenzioni, desideri, ecc., ma non stati puramente fisici o impressioni sensoriali "grezze" (non elaborate) come nel coinvolgimento mentale.
Da un lato, la mentalizzazione è probabilmente il processo cognitivamente più ricco dei tre tipi di osservazione grazie alla sua enfasi sulla comprensione e sul “gioco” con gli stati mentali (Fonagy & Target, 1996, 2000; Target & Fonagy, 1996). Il mero riconoscimento (identificazione) degli stati mentali non è considerato vera (genuina) mentalizzazione. (Fonagy et al., 1998) Il coinvolgimento mentale, invece, è in questo senso il suo opposto, poiché pone l'accento sull'attenzione pura, ottenuta inibendo ogni tentativo di comprensione. Naturalmente, il coinvolgimento mentale, una concettualizzazione buddista alle sue origini, può essere visto come un processo quasi interamente non verbale (di sola attenzione), sebbene alcuni sviluppi teorici nella psicologia occidentale includano componenti verbali (denominazione) dei sentimenti all'interno del concetto di mentale. coinvolgimento. (Falkenstr;m, 2010) Infine, AS assume una posizione intermedia tra questi due estremi, enfatizzando sia la consapevolezza (comprensione) e la tolleranza, che sembrano più “orientate alla consapevolezza”, sia l’espressività (espressione), che richiede una certa comprensione verbale. Inoltre, sembrerebbe che la consapevolezza degli affetti altrui dovrebbe richiedere più lavoro cognitivo, poiché richiede più inferenze (assunzioni, ipotesi, conclusioni) e immaginazione.
Passando alla metodologia di valutazione, lo strumento iniziale per valutare la mentalizzazione è la scala del funzionamento riflessivo (RF) (Fonagy et al., 1998) applicata alle trascrizioni letterali (stampando ogni parola e suono con audio) di un'intervista focalizzata sull'attaccamento adulto (AAI; George, Kaplan e Main, 1985). L'AAI è un'intervista semistrutturata in cui all'intervistato vengono poste domande riguardanti esempi delle sue esperienze della prima infanzia e la loro analisi (valutazione). Per contrassegnare la scala RF, vengono studiate in particolare le domande più determinanti (valutative), le cosiddette "domande chiave" (traduzione letterale - domande sui requisiti). I segni di RF possono essere sistematizzati in quattro diverse aree: comprensione della natura degli stati mentali, sforzi espliciti (tentativi) di selezionare (isolare) gli stati mentali alla base del comportamento, riconoscimento degli aspetti degli stati mentali associati allo sviluppo della personalità
p.30
e dimostrare una comprensione degli stati mentali in relazione all'intervistatore (la persona che fa l'intervista). Numerosi studi supportano l’affidabilità di una scala (cioè la probabilità che una misura sia esente da errori casuali e produca un risultato coerente, cioè ci si possa aspettare lo stesso risultato in altri momenti) (Fonagy et al., 1998; Taubner, Kessler , Buchheim, K;chele, & Staun, 2011), e la validità di costrutto è stata dimostrata dai punteggi RF sull'AAI dei genitori in attesa che prevedono l'attaccamento sicuro del bambino valutato mediante la Strange Situations Procedure a 12-18 mesi di età (Fonagy, Steele, Steele, & Moran, 1991) e differenze nella RF tra gruppi di studio clinici e non clinici (Fonagy et al., 1996). Tuttavia, è ancora necessario studiare ulteriormente l’affidabilità di costrutto della scala RF.
L'AS viene valutata utilizzando l'intervista sulla consapevolezza affettiva (ACI; Monsen et al., 1996; Monsen & Monsen, 1999). In questa intervista, all'intervistato viene chiesto di fornire esempi di situazioni in cui sente un affetto particolare. Nella versione originale, ci sono 11 affetti distinti, e ciascuno di essi viene valutato in base al suo livello di adattabilità in quattro aspetti (aree): consapevolezza, tolleranza, espressione non verbale e verbale. I test empirici hanno dimostrato una struttura fattoriale affidabile e teoricamente logica che rivela importanti relazioni con diversi tipi di funzionamento interpersonale (Lech et al., 2008; Solbakken, Hansen, Havik, et al., 2011).
Mentre la mentalizzazione e l’AS vengono valutate al meglio mediante tecniche di valutazione consolidate (testate), l’unico strumento ad oggi per valutare il coinvolgimento mentale è la valutazione self-report. Ciò non sorprende, poiché lo stato di coscienza difficilmente può essere osservato da qualcuno dall'esterno (eccetto dall'individuo stesso). Sono stati sviluppati diversi questionari sul coinvolgimento mentale (per idea generale vedere Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006), sebbene il Five Facets of Engagement Questionnaire (FFMQ; Baer et al., 2008) sembri essere il più espansivo in termini di fattibilità della ricerca, poiché è stato sviluppato come analisi fattoriale di diversi altri strumenti di ricerca. Questo strumento valuta l’impegno mentale su cinque sottoscale: non reattività alle esperienze interne, osservare/presenziare/monitorare pensieri, sentimenti, sensazioni, agire con consapevolezza, descrizione/etichettatura verbale e non giudizio. È stato dimostrato che tutte le sottoscale (con la parziale eccezione della scala di osservazione) fanno parte del concetto di coinvolgimento mentale nella sua interezza e dimostrano relazioni previste con altri concetti.
In conclusione, questi tre concetti, sebbene fondamentalmente diversi, condividono caratteristiche comuni e ci si può aspettare che le loro valutazioni si sovrappongano. Poiché finora nessuno studio empirico ha esaminato la loro relazione, non disponiamo di molte informazioni su cui basare un'ipotesi specifica. Ma abbiamo scelto un ampio focus di ricerca. Possiamo però fare un paio di previsioni leggermente più specifiche.
Innanzitutto, Bouchard et al. (2008) hanno confrontato la RF con i punteggi di mentalizzazione ottenuti dalla stessa AAI e dallo strumento di valutazione degli Stati Mentali e dell'Elaborazione degli Affetti Verbali. Gli stati mentali sono una valutazione (tecnica di valutazione) basata su formulazioni psicoanalitiche dell'Io-psicologico e relazionale oggettuale della relazione dell'Io con le esperienze emotive. Anche l'elaborazione degli affetti verbali si basa sulla teoria psicoanalitica e valuta il grado in cui un soggetto riesce ad associare parole e immagini con l'eccitazione fisica grezza. Si presume che ciò, a sua volta, contribuisca ad un aumento della tolleranza affettiva. I risultati hanno mostrato che la RF era associata all’elaborazione verbale degli affetti negativi negli altri, ma non nel sé. Sebbene la misurazione dell’elaborazione affettiva verbale si basi su una teoria diversa da quella alla base della scala della consapevolezza affettiva, è probabile che la somiglianza sia sufficiente per farci prevedere una relazione più forte tra RF e AC negli altri che AC in se stessi. Tuttavia, come notato in letteratura, la scala RF viene utilizzata principalmente per valutare i fattori cognitivi, con gli aspetti affettivi rappresentati meno chiaramente (ad esempio, Choi-Kain & Gunderson, 2008; Solbakken, Hansen e Monsen, 2011). Si prevede che la relazione tra i due concetti, come ora esplorata, sarà piuttosto modesta. In secondo luogo, poiché il coinvolgimento mentale viene valutato esclusivamente su se stessi concetto orientato, si prevede che sarà più strettamente correlato alla consapevolezza degli affetti in se stessi,
p.31
che negli altri (questo è il caso se c'è una differenza tra la consapevolezza degli affetti in se stessi e negli altri).
Metodologia di ricerca
Partecipanti
I partecipanti erano studenti di sei diversi corsi di formazione in psicoterapia presso l’Università di Linköping tra il 2006 e il 2011. Tre dei corsi erano corsi triennali per psicologi, assistenti sociali e altre professioni legate alla salute mentale, in cui è richiesto il diploma di psicoterapeuta. Due corsi avevano un focus psicodinamico/relazionale, mentre il terzo era cognitivo. Gli altri due erano corsi biennali di psicoterapia abbreviata (Psicoterapia Interpersonale e Relazionale Abbreviata). I partecipanti erano volontari e la metà ha accettato di completare le interviste AAI, ACI e FFMQ. L'età media dei partecipanti era di 48 anni (SD=79 DS) e l'83% erano donne.
Studio
Funzionamento riflessivo (Fonagy et al., 1998)
Abbiamo valutato la RF utilizzando trascrizioni letterali di un'intervista ad adulti relativa al tema dell'attaccamento (George et al., 1985). L'AAI è un'intervista semi-strutturata focalizzata principalmente sulla memoria dei bambini legata alle relazioni di attaccamento. La scala RF ha valutato la presenza di mentalizzazione esplicita nell'AAI, che si ipotizza rifletta la tendenza di una persona a pensare alla propria relazione con la figura di attaccamento in termini di stati mentali. La scala ha divisioni da -1 (evitamento attivo della mentalizzazione) a 9 (mentalizzazione esclusiva), dove 5 si propone di essere considerato un livello “normale” di mentalizzazione. Poiché l’AAI richiede molto tempo per essere condotta, abbiamo deciso di provare una versione abbreviata dell’intervista. Questa versione comprende la prima parte dell'AAI fino alla domanda 10 inclusa; "In generale, pensi che tutta la tua esperienza con i tuoi genitori ti abbia influenzato da adulto?" (10 bis); e "Ci sono aspetti delle tue prime esperienze che ritieni ti abbiano ostacolato nel tuo sviluppo?" (10b). La versione abbreviata include 4 “domande chiave” che sono sufficientemente ponderate per valutare la RF (M. Target, comunicazione personale, 27 luglio 2007). Questa versione abbreviata non è stata testata in studi pubblicati in precedenza.
RF è caratterizzato da estratti di interviste che dimostrano una mentalizzazione esplicita. I passaggi che rivelano con particolare chiarezza la RF, proposta come ipotesi di lavoro, sono forse spiegazioni del comportamento in termini di stati mentali. Per quanto riguarda i voti, per ottenere il punteggio medio della scala (5), è sufficiente dimostrare un esempio semplice ma chiaro di RF, mentre gli indicatori più alti (7-9) sono dedicati (dedicati) a spiegazioni più complesse e sofisticate , ad esempio: dimostrazione di un numero di stati mentali casuali all'interno di un individuo o tra più persone. Le quattro categorie generali di risposta valutate dalla RF comprendono la natura degli stati mentali (ad esempio, la comprensione che gli stati mentali sono difficili da comprendere o che possono essere mascherati o utilizzati a scopo difensivo), gli sforzi espliciti per isolare gli stati mentali, il comportamento sottostante (ad esempio, un spiegazione plausibile del comportamento in termini di stati mentali o comprensione di più di una prospettiva o tra o all'interno delle persone), riconoscimento degli aspetti evolutivi degli stati mentali (ad esempio, spiegazione intergenerazionale degli stati mentali o riconoscimento dei cambiamenti negli stati mentali legati allo sviluppo della personalità), e stati mentali in relazione all'intervistatore (ad esempio, comprendere che l'intervistatore non ha automaticamente accesso alle stesse conoscenze dell'intervistato o essere in sintonia con le reazioni emotive dell'intervistatore durante l'intervista).
P.32
Questionario sulle cinque dimensioni del coinvolgimento mentale (Baer et al., 2006)
Il FFMQ è stato sviluppato come risultato dell'analisi fattoriale di diversi questionari preesistenti sul coinvolgimento mentale. L'analisi fattoriale ha rivelato cinque aspetti che sono considerati come parte dell'indicatore del coinvolgimento mentale nell'intero ambito del concetto. Il FFMQ è composto da 39 item valutati su una scala Likert a cinque punti che va da 1 (mai o molto raramente vero) a 5 (sempre o quasi sempre vero). Gli item sono combinati in cinque sottoscale. Il valore alfa di Cronbach è tratto da un campione normativo svedese (Lilja et al., 2011):
1. Non reattività alle esperienze esterne, ad esempio: "Di solito, quando ho pensieri e immagini inquietanti, riesco semplicemente a non notarli senza reagire (non reagire ad essi)" (alfa = .75)
2. Osservare/prestare attenzione/monitorare sensazioni/pensieri/sentimenti, ad esempio: “Quando cammino, presto intenzionalmente attenzione alle sensazioni del mio corpo mentre si muove” (alfa=.83)
3. Agire con consapevolezza/con il pilota automatico/con concentrazione/senza distrazione, ad esempio: "Mi sembra di agire automaticamente senza molta consapevolezza di ciò che sto facendo" (alfa = .87)
4. Descrizione/etichettatura verbale, ad esempio: "Di solito riesco a descrivere ciò che provo in modo significativo" (alfa = .91)
5. Esperienza non giudicante, ad esempio: "Penso che alcune delle mie emozioni siano cattive o inappropriate e non dovrei provarle" (alfa = .87)
Alcuni degli item del FFMQ sono presi da strumenti di valutazione sviluppati per lo studio del coinvolgimento mentale nella terapia comportamentale dialettica (Linehan, 1993), e quindi differiscono in qualche modo dal concetto buddista originale di coinvolgimento mentale. Il punto principale è che il concetto buddista di coinvolgimento mentale è prevalentemente un concetto non verbale, e quindi la sottoscala 4 da questo punto di vista non può essere considerata una parte importante del concetto buddista originale di consapevolezza.
Intervista sulla consapevolezza affettiva, versione Sé/Altro (ACI-S/O; Lech et al., 2008;
Monsen et al., 1996)
L'ACI-S/O chiede all'intervistato di identificare le situazioni in cui ha avvertito uno dei 7 affetti: interesse/eccitazione, piacere/gioia, paura/panico, rabbia/rabbia, umiliazione/vergogna, tristezza/disperazione e senso di colpa/ rimorso (Nota a piè di pagina - La scala AC originale ha 11 affetti, ma a causa della stretta interconnessione delle scale e al fine di ridurre il carico sull'intervistato, abbiamo ridotto il numero di affetti in questo studio). Ciascuno di questi affetti viene valutato lungo 4 dimensioni: consapevolezza, tolleranza, espressione emotiva (non verbale) ed espressione concettuale (verbale), e ciascuna di queste quattro dimensioni valuta la consapevolezza degli affetti in se stessi e negli altri. Per ciascuna di queste aree, ci sono domande standardizzate che vengono definite manualmente nell'intervista e all'intervistato viene chiesto di rispondere nel modo più informativo possibile. L'intervistatore è libero di porre domande di follow-up per garantire che la risposta possa essere valutata. Le risposte sono state videoregistrate e valutate direttamente dalla videocassetta, una procedura che è stata testata e ritenuta affidabile in studi precedenti.
p.33
Procedura
Gli studenti di psicoterapia sono stati intervistati da studenti di psicologia formati in AAI e ACI-S/O sotto la direzione degli autori. Tutte le interviste sono state videoregistrate e tutte le interviste AAI sono state trascritte parola per parola e valutate dalle trascrizioni. Le interviste ACI-S/O sono state realizzate direttamente dalla registrazione video.
Il primo autore (Frederic Falkenstr;m) ha segnato tutte le interviste AAI per RF. FF è stato coinvolto in passato con gli sviluppatori della scala RF per dimostrarne l'affidabilità presso l'Anna Freud Centre di Londra, e ha ricevuto il permesso di insegnare la RF in Svezia. Le prime 15 interviste sono state valutate anche da un terzo autore (Clara Müller), anch'egli coinvolto con gli sviluppatori della scala nella convalida della sua affidabilità al fine di stabilire l'affidabilità interosservatore dei punteggi delle interviste in questo particolare studio. Un secondo autore (Ole Andr; Solbakken) ha segnato tutte le interviste ACI-S/O. Ole André; Solbakken è un esperto valutatore di AS ed è stato anche coinvolto nel dimostrare l'affidabilità della scala AS in diversi studi. Nel presente studio, non avevamo un secondo valutatore per la scala AC, quindi l'affidabilità è stata calcolata come coerenza interna (valore alfa del coefficiente).
analisi statistica
Un'analisi della potenza utilizzando G-power 3.1 (Faul, Erdfelder, Lang e Buchner, 2007) ha indicato che erano necessari 46 partecipanti per una potenza dell'80% per rilevare correlazioni bivariate con un valore del coefficiente di .40 (che è risultato ragionevole dai risultati dello studio precedente) con un valore alfa di 0,5 (a due code). A causa delle numerose possibili intercorrelazioni (relazioni), se le sottoscale non fossero utilizzate per l'analisi primaria, di conseguenza rischio aumentato Errori di tipo I, abbiamo deciso di utilizzare scale combinate per la nostra analisi primaria. Tuttavia, a causa della natura esplorativa del nostro studio, non abbiamo utilizzato alcun calcolo del coefficiente alfa per test con struttura complessa. (Nota a piè di pagina - Il calcolo del valore del coefficiente alfa come mezzo di controllo degli errori di tipo I è stato messo in discussione, vedere O'Keefe (2003)). Sono state condotte anche analisi di test secondari sulle sottoscale.
Combinazione di scale
È stato dimostrato che la FFMQ è in grado di prevedere più piuttosto che meno la psicopatologia nei campioni non meditativi, forse perché in questi campioni la scala valuta la ruminazione ossessiva e i tentativi di controllare le esperienze interne piuttosto che la consapevolezza (Baer et al., 2006, 2008). ; Lilja et al ., 2011; Lilja,
Lundh, Josefsson e Falkenstr;m, 2012). Pertanto, abbiamo combinato le altre quattro scale, lasciando la sottoscala di osservazione senza l’analisi primaria.
risultati
Statistiche descrittive
La tabella 1 mostra le medie, le deviazioni standard (deviazioni) e il coefficiente di affidabilità per le variabili (valori) principali (primarie). In termini di coerenza interna, il FFMQ ha un livello di affidabilità tra buono ed eccellente (.86). Il coefficiente di correlazione intraclasse (misto a due vie) per le valutazioni RF tra i due valutatori per le prime 15 interviste era buono (0,80). Il punteggio medio RF era 5,05 (deviazione standard = 1,42), quasi quello che ci si aspetterebbe nel gruppo normale (non clinico) dello studio (Fonagy et al., 1998). Per l'ACI-S/O, la coerenza interna era elevata (0,93) e il livello medio di consapevolezza affettiva era 4,73 (deviazione standard = 0,73), che corrispondeva a quanto ci si aspetterebbe nella popolazione dello studio non clinico (campione). La consapevolezza dei propri affetti e di quelli degli altri è strettamente correlata (intercorrelata) (r=.84, p< .001)
Tabella 1
Media, deviazioni standard (deviazioni) e coefficiente di affidabilità per le variabili principali (primarie) (valori)
Relazioni tra funzionamento riflessivo, consapevolezza affettiva e impegno mentale
La tabella 2 mostra le correlazioni (connessioni) tra le variabili (valori) principali (primarie). Come si può vedere nella tabella, esiste una correlazione piccola (debole) ma statisticamente significativa (significativa) tra la mentalizzazione valutata dalla scala RF e il coinvolgimento mentale valutato dalla FFMQ (r = .31, p = .04), maggiore è maggiore è il livello di mentalizzazione, maggiore è il coinvolgimento mentale. L'ACI-S/O non è associato né al punteggio RF né al punteggio FFMQ.
Controllo di previsioni specifiche
La relazione tra RF e ACI-S/O non era significativa sia per l'affetto in sé (r = .05, ns) che negli altri (r = .18, ns). Poiché la letteratura è contrastante riguardo alla relazione tra alti livelli di RF e salute emotiva, abbiamo calcolato un valore RF alternativo in cui il massimo è limitato a 5 (tutti i valori superiori a 5 sono stati arrotondati a 5). La ragione di ciò è il fatto che 5 dovrebbe essere il livello RF "normale" (Fonagy
et al., 1998) e si pensava che livelli più elevati di RF avessero relazioni complesse con la salute mentale (Target, 2008). Poiché è ovvio che questi valori non sono stati classificati (distribuiti) adeguatamente (poiché abbiamo tagliato parte della classificazione accorciando le interviste), abbiamo utilizzato la correlazione di Spearman. Si è scoperto che questa dimensione RF è fortemente associata alla consapevolezza affettiva negli altri (p = .30, p = .05) ma non in se stessi (p = .15 ns).
L'impegno mentale non era significativamente correlato alla consapevolezza affettiva in sé (r = 0,05 ns) o negli altri (r = 0,15 ns).
Analisi delle sottoscale
Nessuna delle sottoscale FFMQ era significativamente associata alla RF se analizzata separatamente. La consapevolezza degli affetti negli altri era fortemente associata alla sottoscala FFMQ “non giudizio delle esperienze interne” (r = .35, p = .02).
Discussione
Abbiamo esaminato le relazioni concettuali ed empiriche tra mentalizzazione, consapevolezza affettiva e impegno mentale. Lo studio dovrebbe essere prezioso nel contesto della quantità limitata di ricerche precedenti su questo tema, nonostante la significativa attenzione clinica ad esso e l’uso di concetti come mentalizzazione, consapevolezza affettiva e coinvolgimento mentale nella letteratura clinica negli ultimi anni.
L'analisi primaria ha mostrato una relazione significativa tra mentalizzazione e coinvolgimento mentale, come previsto sulla base delle somiglianze teoriche esistenti di questi concetti. Per la mentalizzazione è ovviamente necessario un certo grado di coinvolgimento mentale, poiché affinché la mentalizzazione sia possibile è prima necessaria l'attenzione agli stati mentali (devono essere notati - letteralmente). Tuttavia, la mentalizzazione implica qualcosa di più della semplice attenzione agli stati mentali; richiede un’elaborazione cognitiva che è esclusa dal coinvolgimento mentale. Inoltre, il coinvolgimento mentale include l'attenzione a una gamma più ampia di fenomeni oltre ai soli stati mentali (ad esempio, qualsiasi impressione sensoriale).
Replicando i risultati precedenti di Lech et al. (2008), abbiamo scoperto che la consapevolezza dei propri affetti è strettamente correlata alla consapevolezza degli affetti degli altri. Ciò significa che è probabile che la consapevolezza degli affetti in se stessi e la consapevolezza degli affetti negli altri si basino su processi comuni. Sorprendentemente, non siamo riusciti a trovare alcuna relazione tra mentalizzazione e consapevolezza affettiva, anche quando focalizzata sugli affetti degli altri. Ciò è in contrasto con i risultati di Bouchard et al. (2008), che hanno trovato una relazione tra RF ed elaborazione degli affetti verbali valutata con l'AAI. Usare la stessa intervista per valutare l'elaborazione affettiva e la RF può in parte spiegare questa discrepanza nei risultati (vedi sotto), ma potrebbe anche essere che il concetto di AS sia più diverso dalla RF rispetto all'elaborazione affettiva verbale.
L'analisi di potenza per questo studio presupponeva un coefficiente di correlazione di 0,40. Ciò significa che se esiste una vera correlazione tra punteggi il cui valore è inferiore a questo, allora il rischio di un errore di tipo II è elevato (cioè di non rilevare una relazione quando effettivamente esiste). Considerati i risultati della nostra analisi, dovremmo concludere che la relazione tra AC e RF e tra AC e FFMQ è piccola o trascurabile. Ciò significa che sebbene questi concetti siano teoricamente simili, potrebbero essere più diversi tra loro di quanto previsto.
Possiamo discutere con Choi-Kain e Gunderson (2008) e Solbakken, Hansen e Monsen (2011), sebbene l'area di contenuto rappresentata dalla RF sia multidimensionale, in pratica tende ancora maggiormente verso l'aspetto cognitivo. La nostra impressione dal punteggio RF è che vi sia una consapevolezza rudimentale degli stati mentali (punteggi più bassi), mentre i punteggi più alti sono caratterizzati da una comprensione cognitiva più avanzata degli stati mentali in relazione a sé e agli altri nel tempo. Pertanto, punteggi RF più elevati svolgono un ruolo maggiore nel processo di emergenza (sviluppo della personalità) rispetto all’elaborazione affettiva. A questo proposito, ricerche recenti sottolineano la necessità di una valutazione più equilibrata della RF che includa la distinzione tra aspetti affettivi e cognitivi della mentalizzazione (Fonagy & Luyten, 2009). Può anche darsi che il FFMQ, in termini di applicazione pratica, si limiti alla dimensione cognitiva più di quanto comunemente si creda. La nostra scoperta che l’AS negli altri è strettamente correlata alla sottoscala FFMQ “non giudizio delle esperienze interne” fornisce una buona base concettuale, poiché il grado di accettazione e riconoscimento di vari aspetti vita emotivaè una componente centrale nella valutazione dell’AS. Tuttavia, questa conclusione deve essere affrontata con cautela, poiché dei numerosi test statistici (test) condotti, solo uno conferma questa affermazione.
Forse per far luce sui nostri risultati è necessario utilizzare il concetto di affettività mentalizzante (Fonagy et al., 2002; Jurist, 2005). Questo concetto è definito come “la capacità matura di regolazione affettiva in cui una persona è consapevole dei propri affetti pur rimanendo all'interno di uno stato emotivo (Fonagy et al., 2002, p. 96). Sottolineando che si tratta di un'abilità matura, questi autori indicano l'affettività mentalizzante come una conquista di un periodo successivo di sviluppo della personalità rispetto a qualcosa di più concetto ampio mentalizzazione. In un recente articolo di Solbakken, Hansen e Monsen
(2011) hanno discusso questioni concettuali e di valutazione riguardanti la mentalizzazione e l’affettività mentalizzante, sostenendo che l’affettività mentalizzante non è ben misurata dalla scala RF ma è ben adatta agli strumenti di valutazione AS. Si presuppone che il sistema di valutazione AS sia una valutazione abbastanza diretta del livello di affettività mentalizzante, cioè il livello di capacità matura di mentalizzazione dell’affettività che un individuo ha raggiunto.
Potrebbe non essere solo il caso che l’affettività mentalizzante sia un risultato successivo e più avanzato (avanzato) di un periodo successivo di sviluppo della personalità rispetto alla mentalizzazione in generale, ma anche che punteggi RF più alti aiutano ad affrontare i problemi potrebbero non essere particolarmente necessari nella vita normale. . sviluppo della personalità. Si ipotizza infatti che la RF funzioni come difesa contro eventi traumatici e lo sviluppo di psicopatologie. Nell’originale London Parent-Child Project, la RF era fortemente associata all’attaccamento sicuro del bambino solo in un gruppo di genitori (un sottocampione) che avevano avuto esperienze infantili particolarmente avverse. In assenza di avversità, la RF non era fortemente associata alla sicurezza psicologica del bambino ( Obiettivo, 2008). Inoltre, uno studio di Fonagy et al. (1996) hanno dimostrato che l'associazione tra RF basso e disturbo borderline di personalità era più forte se il paziente aveva subito un trauma grave.
Secondo Target (2008), le persone con livelli più elevati di RF non sono quelle che hanno vissuto le condizioni infantili più favorevoli. Condividiamo questo punto di vista dopo aver valutato un gran numero di AAI per la scala RF. AAI di persone che hanno descritto in modo plausibile sicuro e infanzia felice, di solito non presentavano livelli RF elevati. Quelli con livelli più elevati di RF hanno sperimentato difficoltà significative nella loro vita, ma sono stati in grado di superarle e raggiungere un attaccamento adulto sicuro nonostante queste difficoltà (la cosiddetta sicurezza acquisita o guadagnata; Main, Goldwyn e Hesse, 2003). Inoltre, mentre alti livelli di RF indicano la capacità di elaborare (superare) le difficoltà passate, forse anche fornendo uno strumento per affrontare futuri problemi relazionali, le persone con livelli di RF superiori al normale, secondo Target, spesso sperimentano affetti depressivi residui e sintomi di ansia.
Se le divisioni superiori della scala AC valutano le capacità utili anche in assenza di problemi nello sviluppo della personalità, possiamo supporre che l’AC sia una misura della salute mentale migliore rispetto alla scala RF. Il nostro test di follow-up utilizzando una versione abbreviata della scala RF ha supportato l’idea che le associazioni tra RF e AC possono essere diverse a diversi livelli di scala, sebbene questo risultato richieda un riesame in un gruppo di studio indipendente (campione) prima di trarre conclusioni definitive.
Questo studio ha confrontato le valutazioni da diverse prospettive di osservazione, vale a dire dal punto di vista di osservatori addestrati e dal punto di vista delle auto-valutazioni individuali. Inoltre, due osservatori valutatori hanno somministrato due diversi tipi di interviste. Queste interviste avevano focus diversi: l'AAI chiedeva di più sull'attaccamento infantile, mentre l'ACI-S/O aveva un focus più ampio e includeva le relazioni adulte, siano esse relazioni di attaccamento o meno. Il FFMQ era strettamente focalizzato sull'esperienza di sé (esperienze personali) nel qui e ora e non poneva alcuna domanda sulle relazioni. È noto da tempo che i bias nelle tecniche di valutazione tendono a gonfiare i risultati basati su tecniche di valutazione comuni (Campbell & Fiske,
1959). Un classico esempio di ciò sono gli effetti alone (la tendenza di un valutatore ad assegnare punteggi elevati a un individuo) di Thorndike (1920). L'effetto alone influenza le valutazioni espresse dalla stessa persona, come è comune negli studi che confrontano diverse valutazioni self-report.
p.37
Nel presente studio, abbiamo avuto tre valutatori diversi per i tre diversi metodi di valutazione utilizzati nel nostro studio: un'autovalutazione e due valutatori indipendenti per le valutazioni dell'osservatore. Ciò significa che il confronto di queste stime è stato molto rigoroso.
A causa della loro facilità di amministrazione e punteggio, molti studi psicologici utilizzano strumenti di autovalutazione. Sembrerebbe che, in base all'essenza del coinvolgimento mentale, sia difficile trovare un altro strumento di valutazione diverso dall'autovalutazione. Tuttavia, soprattutto quando si tratta di valutare concetti complessi come mentalizzazione, consapevolezza affettiva, empatia, insight, ecc., l’affidabilità dell’autovalutazione come strumento di valutazione è altamente discutibile. Questi fenomeni dovrebbero essere valutati utilizzando test piuttosto che auto-report (Lundh, Johnsson, Sundqvist e Olsson, 2002). Ad esempio, confronta i test di intelligenza, in cui molti ricercatori non riconoscono l’autovalutazione come uno strumento di valutazione affidabile.
Vale la pena sottolineare il fatto che abbiamo stabilito un’importante relazione tra l’impegno mentale auto-riferito e la mentalizzazione valutata dall’osservatore. È possibile che la relazione stabilita tra questi due valori sia esagerata a causa di errori nella metodologia di ricerca e possa essere sottostimata. Tuttavia, è necessario prestare attenzione nel trarre conclusioni riguardo alla relazione tra RF e impegno mentale, poiché non è stata trovata alcuna correlazione a livello di sottoscala. Pertanto, la sovrapposizione tra questi due concetti è, nella migliore delle ipotesi, modesta. Inoltre, la valutazione da parte dell'osservatore di scale come RF e ACI-S/O richiede molto tempo, quindi se fosse possibile trovare strumenti più semplici, ma approssimativamente simili a quelli utilizzati, per valutare questi concetti, ciò semplificherebbe notevolmente lo studio.
Limitazioni e suggerimenti per la ricerca futura
Come accennato, la potenza statistica era troppo bassa per essere affidabile nel rilevare piccole (deboli) correlazioni. Il gran numero di test nelle analisi di sottoscala rende i risultati vulnerabili al cosiddetto errore di tipo II (vale a dire, aumenta il rischio di trovare correlazioni spurie quando si conducono un gran numero di test. L’uso di interviste AAI precedentemente non testate è una limitazione, sebbene l’affidabilità tra osservatori era buono. Inoltre, avremmo potuto avere più fiducia nelle conclusioni se avessimo più di un valutatore per l'AS, sebbene l'uso di una popolazione normale piuttosto che di uno studio clinico possa sottostimare le associazioni tra AS e RF. Entrambi questi concetti erano sviluppate da una prospettiva clinica e sono quindi destinate principalmente a identificare i processi psicopatologici piuttosto che lo sviluppo normale. La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sull'affidabilità correlata ai criteri di queste tecniche di valutazione confrontando il potere predittivo basato su criteri esterni teoricamente rilevanti. L'obiettivo della ricerca futura dovrebbe avere un potere statistico adeguato per rilevare associazioni a livello di sottoscala più coerenti sia per l’AS che per il coinvolgimento mentale. Poiché il punteggio globale di entrambi i concetti è un aggregato non lineare (cioè una media multidimensionale), la convergenza e l’affidabilità discriminante possono essere oscurate da relazioni non sistematiche a livello di sottoscala. (Cronbach e Shavelson, 2004;
Shavelson & Webb, 1991) Per quanto riguarda la scala RF, i nostri risultati indicano la necessità di sviluppare procedure di valutazione differenziate per valutare la mentalizzazione nella ricerca futura.
L'articolo presenta un'analisi dei principali approcci alla comprensione stato attuale problemi dei fenomeni di coinvolgimento nel lavoro e maniaco del lavoro, ragioni soggettive e oggettive per il loro sviluppo e modi possibili diagnostica Il coinvolgimento nel lavoro è caratterizzato da una serie di caratteristiche che distinguono questo fenomeno dal fenomeno del maniaco del lavoro. Le conseguenze di un eccessivo coinvolgimento nel lavoro attraverso meccanismi di accumulo di effetti negativi vissuti dal dipendente delle FS possono trasformarsi nello sviluppo del fenomeno del workaholism. SU palcoscenico moderno sviluppo della scienza e della società, c'è una mancanza di conoscenza del fenomeno del maniaco del lavoro, tuttavia, senza dubbio, questo problema è rilevante in tutte le aree della scienza psicologica a causa del fatto che la concettualizzazione scientifica e l'operazionalizzazione del fenomeno del maniaco del lavoro è iniziata relativamente di recente - negli anni '70 del secolo scorso (Oates, 1968; Clark, 2014). La principale difficoltà nello studio di questo fenomeno è (1) la difficoltà di distinguerlo da un modello favorevole di comportamento lavorativo, chiamato “coinvolgimento nel lavoro” (Schaufelli, 2012), e (2) l’ambiguità dell’atteggiamento formato nella società nei confronti del lavoro. fenomeno stesso del maniaco del lavoro: con evidenti conseguenze negative per benessere psicologico e la salute professionale del dipendente, non si possono non notare le tradizionali conseguenze socialmente approvate del maniaco del lavoro sotto forma di straordinari volontari e regolari per i dipendenti inclini al maniaco del lavoro a beneficio dell'organizzazione. L'analisi della ricerca sul problema del maniaco del lavoro e del coinvolgimento lavorativo ci consente di affermare che non esiste ancora un'unica visione accettata nella scienza psicologica sull'essenza di questi fenomeni, sulle cause e sui meccanismi del loro sviluppo, o sullo sviluppo di un sistema generalizzato di diagnosi, prevenzione e correzione, manifestazioni e conseguenze del maniaco del lavoro e sistemi per diagnosticare e mantenere il coinvolgimento nel lavoro dei dipendenti delle organizzazioni.
Nella società moderna, uno stereotipo di comportamento abituale e socialmente approvato è il desiderio di trascorrere lunghi periodi di tempo al lavoro, superando significativamente la durata della giornata lavorativa. Cause comportamento simile può essere diverso: la cultura organizzativa impone la necessità di straordinari (Bakker et al, 2010a), il dipendente fa una scelta personale a favore di trascorrere del tempo al lavoro a causa della mancanza di compiti personali non lavorativi (Hakanen, Schaufeli, 2012), l'attività di sostituzione del dipendente, progettata per aiutarlo a allontanarsi dal problema per andare al lavoro (Sulea et al., 2012), ecc. Nonostante l'importanza e il significato del lavoro nella vita di ogni specialista, il compito prioritario di ogni dipendente dovrebbe essere mantenere un equilibrio nel sistema “lavoro-vita” e “lavoro-famiglia” (Jones, Burke & Westman, 2005). La moderna scienza psicologica non ha ancora trovato una ricetta per la combinazione ideale di lavoro e tempo libero, il che ci spinge a condurre uno studio teorico di idee su concetti importanti come il coinvolgimento nel lavoro e il maniaco del lavoro. Nonostante tutte le somiglianze esterne di entrambi i fenomeni, esistono una serie di differenze fondamentali che sono fondamentali nello sviluppo di programmi preventivi e correttivi volti a prevenire lo sviluppo di deformazioni professionali.
L'impegno lavorativo: definizione, struttura, analisi
Il concetto di impegno lavorativo è stato definito per la prima volta da Kahn (1990). Questo fenomeno si riferisce alla “partecipazione diretta e organizzata; Quando i dipendenti sono coinvolti nel processo lavorativo, iniziano ad esprimersi fisicamente, cognitivamente, emotivamente e mentalmente” (Bakker et al, 2010b). Se il coinvolgimento lavorativo agisce spesso come un modello positivo di comportamento lavorativo, allora il suo antagonista, il burnout, è negativo (Schaufeli, 2013). Ad esempio, Schaufeli e i suoi colleghi vedono l’impegno lavorativo come l’antitesi del burnout (Schaufeli & Bakker, 2004). Secondo Maslach (Maslach et al, 2001), energia, coinvolgimento ed efficacia sono le componenti principali dell'impegno, che sono l'opposto del burnout. Il burnout è la principale fonte di interruzione dell’impegno lavorativo, trasformando il vigore in esaurimento, l’impegno in cinismo e l’efficacia in inefficacia.
Nel 2001 Schaufeli ha fornito una definizione chiara in cui ha caratterizzato l'impegno lavorativo come uno stato positivo, affettivo-motivazionale, associato alla prestazione lavorativa, che può essere considerato l'opposto del burnout (Schaufeli & Bakker, 2004). Il fenomeno del coinvolgimento lavorativo contiene tre componenti: energia, inclusione ed efficacia professionale. L'energia presuppone determinazione e stabilità psicologica nel processo di esecuzione del lavoro, manifestazione di perseveranza, nonostante le difficoltà incontrate. L’efficacia professionale si riferisce al senso di autostima, entusiasmo e orgoglio (Bakker et al, 2010b). Il coinvolgimento nel lavoro è caratterizzato da qualità come la completa concentrazione sull'attività svolta, per cui il tempo passa rapidamente e inosservato, e alla fine del lavoro lo specialista può incontrare difficoltà in relazione alla cessazione dell'attività, che è spiegato dal fenomeno chiamato “flusso”. Questo concetto è stato introdotto da Csikszentmihalyi (1990).
Il “coinvolgimento lavorativo” sta diventando uno dei concetti caratterizzanti i processi motivazionali nell’attività lavorativa (Bakker et al, 2010a). L'energia, come parte integrante del fenomeno dell'engagement, garantisce che il dipendente sia dell'umore giusto per raggiungere con successo il suo obiettivo, supportando il suo desiderio di ottenere risultati.
Mackey e Schneider (2008) hanno identificato diversi tipi di impegno lavorativo: impegno personale, impegno situazionale e impegno comportamentale. Il coinvolgimento situazionale è assicurato dalla motivazione individuale della persona al lavoro, dal suo entusiasmo personale, dalla perseveranza e dalla volontà di superare qualsiasi difficoltà, che mantengono un elevato livello di coinvolgimento nel lavoro. La formazione di questo tipo di coinvolgimento nel lavoro può essere facilitata dalla soddisfazione per le proprie attività professionali, che portano emozioni positive. Lo sviluppo del coinvolgimento personale di una persona è facilitato da tratti individuali come la coscienziosità, l'esperienza lavorativa personale positiva accumulata e l'emotività. Il coinvolgimento comportamentale è generato dalle condizioni lavorative in cui il dipendente svolge la propria attività professionale e dal suo abituale ruolo sociale. I tipi identificati di coinvolgimento nel lavoro differiscono nel grado di natura situazionale della formazione di questo modello di comportamento positivo. Se, nel caso del coinvolgimento comportamentale, una tendenza positiva nel comportamento lavorativo si basa su caratteristiche puramente esterne che cambiano facilmente con un cambio di lavoro, allora il coinvolgimento personale garantirà l'interesse e il coinvolgimento stabili del dipendente, il suo amore per la propria attività, e non , ad esempio, il solito spazio ufficio. Pertanto, il concetto stesso di “impegno lavorativo” è un concetto psicologico abbastanza specifico, ben definito e ampiamente utilizzato, aperto non solo allo studio teorico, ma anche empirico.
Abbastanza comune nella moderna ricerca psicologica (Bakker et al, 2010a) è spiegare il fenomeno dell’impegno lavorativo utilizzando il modello “richieste di lavoro-risorse” (Fig. 1). In questo modello, il coinvolgimento lavorativo e il burnout sono considerati come due costrutti completamente indipendenti, uniti dal concetto di intendere l'efficacia di una persona che lavora come un sistema che soddisfa le esigenze dell'ambiente e delle condizioni di lavoro con le risorse disponibili. In sostanza, l'impegno lavorativo è visto come il risultato finale del processo di svolgimento di un'attività, che ha natura motivazionale. In base a questo punto di vista si è soliti distinguere tra due tipologie di risorse: 1) lavorative e 2) risorse personali. Per risorse lavorative si intende la corrispondenza tra le esigenze lavorative e le capacità della persona che lavora, ciò include, tra le altre cose, l'adempimento produttivo delle mansioni lavorative, il desiderio di crescita professionale, lo stress organizzativo e la minaccia di licenziamento sul lavoro. Le risorse personali di solito includono l’autoefficacia, il perfezionismo, la capacità di rifiutarsi prontamente di adempiere alle responsabilità lavorative di qualcun altro, la stabilità emotiva e l’ottimismo. Con un'interazione positiva tra risorse personali e lavorative, a condizione che le risorse del dipendente soddisfino i requisiti del lavoro, questi sarà coinvolto nel lavoro. Con un'interazione negativa o una mancata corrispondenza tra risorse e requisiti, una persona sviluppa deformazioni professionali, forma tipica che è il burnout. La produttività dell'attività professionale di un dipendente dipende dal grado di coinvolgimento nel lavoro e dalla conformità delle risorse disponibili ai requisiti di questo lavoro.
Riso. 1. Modello “Fabbisogni-risorse lavorative”.
È necessario tenere conto del fatto che le risorse lavorative svolgono un importante ruolo motivazionale interno per lo sviluppo dei dipendenti e un ruolo motivazionale esterno per il raggiungimento degli obiettivi. Le risorse lavorative vengono gradualmente accumulate e attivate quando un dipendente affronta crescenti richieste nell’ambiente di lavoro (Bakker & Demerouti, 2007). A. Bakker et al (Bakker, Hakanen, Demerouti, Xanthopoulou, 2007, studiando il livello di impegno lavorativo tra gli insegnanti finlandesi, hanno concluso che le risorse lavorative influenzano l’impegno lavorativo quando gli insegnanti si trovano ad affrontare bassi livelli di disciplina tra gli studenti.
Il coinvolgimento nel lavoro agisce tradizionalmente come un fenomeno positivo che caratterizza un modello di comportamento lavorativo “corretto” (Fig. 2). Ma non si può negare che un tratto di coinvolgimento come il completo assorbimento nelle attività professionali possa diventare un presagio dello sviluppo di una deformazione professionale distruttiva: il maniaco del lavoro. Nonostante tutta la somiglianza esterna di questi fenomeni, ci sono una serie di differenze che rappresentano caratteristiche invarianti di ciascuno di essi. Il maniaco del lavoro, prima di tutto, si distingue per un desiderio ossessivo, che è la caratteristica principale di ogni dipendenza, ed è assente nelle persone coinvolte nel lavoro. I maniaci del lavoro non sperimentano emozioni positive dal proprio lavoro, mentre i dipendenti impegnati provano gioia, che successivamente li porta ad essere soddisfatti del proprio lavoro e della propria vita. Il senso acquisito di soddisfazione lavorativa consente al dipendente impegnato di trovare un equilibrio tra lavoro e altre attività. Un dipendente coinvolto nel lavoro ha un elevato livello di comfort soggettivo e benessere psicologico. Non sperimenta conseguenze o esperienze distruttive a cui portano le deformazioni professionali, in particolare il maniaco del lavoro.
Riso. 2. Sistema di lavoro dipendente dallo Stato (Russel, 1980; Schaufeli, 2013)
Workaholism: definizione, struttura, analisi
Il concetto di maniaco del lavoro, nonostante la sua apparente scarsa prevalenza e la quantità relativamente piccola di ricerche, risale alla fine del 19° secolo. Nel 1852, uno dei più grandi scrittori francesi del XIX secolo, G. Flaubert, descrisse il maniaco del lavoro come un desiderio doloroso, quasi perverso, di lavorare. Nel 1919, lo psicoanalista S. Ferenczi (Mental Disorders..., 2006) descrive il maniaco del lavoro come una malattia e diagnostica ai suoi pazienti la “nevrosi della domenica” (esaurimento dovuto al fatto di settimana di lavoro termina e il recupero il lunedì quando si va al lavoro e si continua l'attività professionale). I pazienti hanno manifestato sintomi simili all’astinenza da farmaci, come instabilità emotiva, umore arrabbiato e cupo. Anthony Kepinski ha descritto un fenomeno simile, chiamandolo “nevrosi manageriale”, che appare principalmente nei manager che sono in costante tumulto, gravati da un numero immenso di responsabilità e grandi responsabilità (Szpitalak, 2014).
Il termine maniaco del lavoro stesso è stato introdotto dallo psicologo americano W. Oates (Oats, 1968), che ha unito le due parole "lavoro" e "alcolizzato" in una sola, poiché lui stesso ha sperimentato approssimativamente la stessa dipendenza dal lavoro degli alcolisti dall'alcol. Fu allora che fu pubblicato il suo primo libro, intitolato "Confessione di un maniaco del lavoro", e già nel 1983 fu creata la prima comunità di maniaci del lavoro anonimi. Il maniaco del lavoro sta rapidamente diventando un problema riconosciuto ed è spesso discusso nella letteratura popolare. Nonostante ciò, e forse proprio per questo, finora è stato pubblicato relativamente poco. lavori scientifici, dedicato al tema del maniaco del lavoro.
Nel 1991, lo psicologo canadese B. Killinger (Killinger, 1991) ha pubblicato una guida classica per chiunque si trovi ad affrontare il problema del maniaco del lavoro: "Workaholics, Respectable Addicts". Secondo Killinger, i professionisti ossessionati dal lavoro come unico modo per ottenere riconoscimento e successo spesso entrano in conflitto, diventano crudeli ed egoisti nelle relazioni. Il concetto stesso di maniaco del lavoro è visto come un processo negativo e complesso (Killinger, 1991) che in definitiva influisce sulla capacità di un individuo di funzionare correttamente.
Studi successivi rivelano alcune differenze e contraddizioni nelle opinioni sul maniaco del lavoro. Ad esempio, la dipendenza dal lavoro è vista come una dipendenza (McMillan & O'Driscoll, 2006), come un tratto caratteristico della personalità (Scotte, Moore & Miceli, 1997), come un'attitudine verso il lavoro (Spence & Robbins, 1992), come una sindrome caratterizzazione dello squilibrio lavoro-lavoro. vita" (Aziz & Zickar, 2006).
Uno dei motivi di questa controversia è che il maniaco del lavoro è un costrutto complesso e multidimensionale (Clark, Lelchook e Taylor, 2010). Ovviamente, le persone possono lavorare troppo per molte ragioni: problemi finanziari, un cattivo matrimonio, pressioni da parte dei superiori, l’insieme di valori accettati o condivisi dai membri del team (“cultura organizzativa”), crescita professionale (fanatici, entusiasti) e molto altro ancora. (Sussmann, 2012).
Secondo i risultati della ricerca di K. Scott e dei suoi colleghi (Scott, Moore Miceli, 1997), sono state identificate tre caratteristiche principali del maniaco del lavoro:
i maniaci del lavoro trascorrono la maggior parte del loro tempo lavorando, anche quando hanno libertà di azione;
i maniaci del lavoro sono riluttanti a finire la giornata lavorativa, pensano costantemente al lavoro e ne sono ossessionati;
i maniaci del lavoro lavorano non solo sul posto di lavoro, ma anche a casa, in vacanza, ovunque si trovino.
Il maniaco del lavoro in questo concetto è inteso come la tendenza a lavorare troppo duramente ( segno comportamentale) in combinazione con l'ossessione di una persona per il lavoro (segno cognitivo). La definizione di Scott et al. è coerente con la posizione del fondatore del termine "workaholism" Oates, il quale credeva che il workaholism fosse un desiderio obbligatorio (auto) e incontrollabile di lavorare senza interruzione (Oates, 1968). È interessante notare che nel concetto in esame, la componente centrale è il presupposto che lo sviluppo del maniaco del lavoro si basi su un tipo di personalità individuale, o più precisamente, sui seguenti tratti della personalità: orientamento al successo, perfezionismo (esigenze elevate) e diligenza. Pertanto, Scott e i suoi colleghi predeterminano effettivamente lo sviluppo di una forma di comportamento professionale così distruttiva come il maniaco del lavoro in un individuo con l'insieme di tratti corrispondente.
D. Spence ed E. Robbins (Spence & Robbins, 1992) hanno dato un contributo significativo alla comprensione del workaholism sviluppando la “triade del workaholism”, che includeva “coinvolgimento lavorativo”, “motivazione” e “soddisfazione lavorativa”. Varie combinazioni Questi componenti possono formare sei diversi tipi di comportamento lavorativo, due dei quali sono caratteristici dei maniaci del lavoro. Gli autori sottolineano che il maniaco del lavoro “stereotipato” è caratterizzato da un elevato coinvolgimento nel lavoro e dall'attrazione interna per il lavoro, e il “maniaco del lavoro-appassionato” (gran lavoratore) non solo è coinvolto e costretto internamente a lavorare, ma riceve anche soddisfazione dal lavoro. Secondo la classificazione presentata, una persona laboriosa (appassionata di lavoro) differisce da un maniaco del lavoro per avere un basso desiderio di lavoro, con cui è difficile essere d'accordo.
Molto popolare è la teoria del workaholism, basata su una valutazione oggettiva del tempo dedicato al lavoro (Peiperl & Jones, 2001). A differenza di tutti gli altri concetti, questo è senza dubbio attraente per la presenza di un chiaro criterio oggettivo che ci consente di giudicare la gravità del maniaco del lavoro come un tipo di comportamento distruttivo di un dipendente. Al giorno d'oggi, il primo posto nel mondo in termini di numero di ore lavorative è occupato dai giapponesi (47,6 ore settimanali) e l'ultimo dai residenti nei Paesi Bassi (39,7 ore settimanali). Per la maggior parte dei giapponesi, il lavoro è di fondamentale importanza nella vita (Kanai & Wakabayashi, 2001, 2004). Nel complesso, i dipendenti giapponesi lavorano 400 ore in più all’anno rispetto a coloro che svolgono le stesse occupazioni nei Paesi Bassi. Il 12% dei dipendenti di varie aziende in Giappone lavora più di 60 ore settimanali (Iwasaki, Takahashi e Nakata, 2006). In Giappone esiste il termine “karoshi” (lavoro fino alla morte) e “karojisatu” (suicidio dovuto a sovraccarico di lavoro) (Kanai, 2006). Tuttavia, tenendo conto di tutti questi dati, non si può negare che la conoscenza della quantità di tempo lavorato da un dipendente non dà un'idea dell'effettiva qualità delle sindromi di maniaco del lavoro sperimentato.
Pertanto, riassumendo le opinioni sul fenomeno del maniaco del lavoro, possiamo presentarle nella forma seguente (vedi Tabella 1).
Tabella 1. Idee sul fenomeno del workaholism in una prospettiva storica
Cercando di trovare le cause e i fattori scatenanti per lo sviluppo del maniaco del lavoro, L. McMillan e i suoi colleghi, basandosi sul concetto di tre tipi di apprendimento, evidenziano l'apprendimento operante come il più applicabile per spiegare il maniaco del lavoro. Il maniaco del lavoro è un fenomeno relativamente immutabile determinato strumentalmente, la cui insorgenza dipende dal rafforzamento di questo tipo di comportamento. In questa forma, il maniaco del lavoro viene interpretato come un eccessivo coinvolgimento nel lavoro, determinato da rinforzi positivi, come il profitto, l'approvazione sociale e un elevato status sociale. Anche le relazioni familiari infruttuose, i conflitti costanti con i propri cari e i valori materiali influenzano il desiderio di lavorare e di trascorrere una certa quantità di tempo al lavoro. Il maniaco del lavoro in questo caso può essere interpretato come un tentativo di compensare la bassa autostima, che potrebbe essere stata generata dalle eccessive richieste dei genitori nei confronti del bambino durante l'infanzia, dalle aspettative ingiustificate dei genitori, quando al bambino è stato insegnato che l'amore può essere solo guadagnato. I ricercatori hanno chiesto ai dipendenti di rispondere alla domanda su chi sia un maniaco del lavoro e quali indicatori possano fungere da sue caratteristiche. Dopo l'analisi del contenuto, le due risposte più comuni identificate sono state “tempo trascorso al lavoro o pensando al lavoro” (39%) e “desiderio personale ossessivo di lavorare” (22%) (McMillan & O'Driscoll, 2005). Dopo aver analizzato le opinioni sull'essenza del fenomeno del maniaco del lavoro presentate nella Tabella 1, si può notare che alcuni autori descrivono il maniaco del lavoro come un comportamento caratteristico di una persona sana e psicologicamente prospera. Ad esempio, secondo V. Schaufeli, il maniaco del lavoro è caratterizzato da un'irresistibile attrazione interna verso superlavoro(Shaufeli et al.,2007). Scott e i suoi colleghi (Scott, Moore e Miceli, 1997) consideravano i maniaci del lavoro semplicemente come dipendenti eccessivamente esecutivi, mentre Buelens e Poelmans (2004) descrivevano i maniaci del lavoro come “dipendenti felici e laboriosi”.
Tuttavia, alcuni autori sono propensi al punto di vista che attribuisce il maniaco del lavoro a un effetto distruttivo e distruttivo sulla psiche e sul comportamento di una persona (Zijlstra et al, 2006). Comprendono il maniaco del lavoro come una delle dipendenze più comuni, che causa all'individuo non meno danni delle dipendenze chimiche: tossicodipendenza e alcolismo (Asmakovets, 2014). La dipendenza emotiva dei maniaci del lavoro deforma il loro mondo interiore, lasciando un'impronta nel loro pensiero, intelletto, memoria, azioni e personalità. Ts.P. Korolenko ha suggerito che il maniaco del lavoro, come ogni dipendenza, è una fuga dalla realtà attraverso il cambiamento del proprio stato emotivo, in in questo caso raggiunto attraverso la fissazione sul lavoro (Ilyin, 2011).
La maggior parte dei capi incoraggia la dipendenza dal lavoro dei dipendenti, identificando questo concetto con il duro lavoro. Tuttavia, molti non sono d'accordo con questo punto di vista e credono che il maniaco del lavoro e il duro lavoro siano fenomeni psicologici diversi. Se il primo va represso, il secondo va incoraggiato. I grandi lavoratori, o “lavoratori positivamente impegnati” come vengono chiamati (Aziz & Zickar, 2006), amano il proprio lavoro e sono perfettamente in grado di evitare conflitti sul lavoro e in famiglia (Buelens & Poelmans, 2004).
Un gran lavoratore è una persona che si realizza e, idealmente, una persona attraente, integra e illuminata (vedi Tabella 2). Un dipendente che lavora non per approvazione, status e ricompense, ma perché ama lavorare, può svilupparsi attraverso il lavoro. Mentre un maniaco del lavoro è una persona che dedica la sua vita al lavoro, ma lo fa senza alcun desiderio (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2005: 1497), può successivamente degradarsi come persona. Cioè, il maniaco del lavoro è inteso come una dipendenza mentale abbastanza grave dal lavoro.
Tavolo 2. Caratteristiche del duro lavoro e del maniaco del lavoro
Il confine tra duro lavoro utile e dipendenza distruttiva passa laddove il lavoro si trasforma da mezzo in fine (Ilyin, 2011). La sensazione che il lavoro sia l’unico valore nella vita è un segno distintivo del maniaco del lavoro. Ad esempio, le persone laboriose possono sedersi sul posto di lavoro e pensare al mare, alla stazione sciistica. I maniaci del lavoro, al contrario, mentre nuotano nel mare, penseranno al lavoro. I grandi lavoratori lavorano per vivere e i maniaci del lavoro vivono per lavorare. Di conseguenza, sia i grandi lavoratori che i maniaci del lavoro possono lavorare instancabilmente, ma è la motivazione che apporta cambiamenti fondamentali nell’essenza interna del loro lavoro (Bamber, 2006).
Ragioni per lo sviluppo del maniaco del lavoro
Molti presumono che il maniaco del lavoro sia una certa tendenza, altri credono che il maniaco del lavoro sia una conseguenza dell'educazione della società e della famiglia, dove il ruolo principale della famiglia è quello principale. Machlowitz (1960) ritiene che le cause del maniaco del lavoro affondino le loro radici in un lontano passato, o più precisamente, nell'infanzia. Molti genitori cercano di instillare nei propri figli che la lode e l'amore devono essere guadagnati attraverso un buon comportamento, ottimi voti, ecc. L'autostima di molti bambini diminuisce se non soddisfano le aspettative dei genitori e dicono a se stessi: "Dimostrerò che sono il migliore in tutto". Il figlio maggiore o unico della famiglia corre il rischio maggiore di diventare un maniaco del lavoro, poiché il maggiore viene portato ad esempio e all'unico viene detto che i suoi genitori lo hanno solo e che ogni speranza risiede in lui (Ilyin, 2011) .
Il maniaco del lavoro in adolescenza viene spesso definito “nerdismo” (Russel & Kon, 2013). Questo fenomeno è causato dalle stesse ragioni del maniaco del lavoro “adulto”: ad esempio, il desiderio inconscio di evitare determinati problemi, predisposizione personale, desiderio di “accontentare” l’insegnante, ecc.
Il maniaco del lavoro può anche essere associato alla proprietà di dipendenza dell'organizzazione, che è un sistema chiuso che sopprime la capacità dei suoi dipendenti di pensare in modo indipendente. Secondo la famosa legge di Pareto, il 20% dei dipendenti svolge l'80% del lavoro (Koch, 1998), quindi, quando un dipendente efficace si unisce al gruppo di lavoro, il datore di lavoro lo percepisce come una manna dal cielo. Lo sviluppo del maniaco del lavoro è facilitato anche dal costante meschino controllo da parte dei superiori, poiché tali controlli si basano sulla sfiducia nei confronti di una persona, sulla mancanza di rispetto per la sua personalità e sulla possibilità di autorealizzazione. In contrasto con l’opinione diffusa sull’utilità del maniaco del lavoro in un’organizzazione, lo psicologo americano D. Island ha identificato le ragioni principali per cui i maniaci del lavoro sono spesso cattivi dipendenti (Andreassen, 2014). I maniaci del lavoro, a suo avviso, non sanno come lavorare in squadra; credono che faranno questo o quel lavoro meglio dei loro colleghi; i maniaci del lavoro sono arroganti e non ascoltano i loro colleghi. Queste persone spesso hanno un pensiero ristretto, tendono a perdere lampi di creatività, sono ossessionate dai piccoli dettagli e non vedono il quadro generale, motivo per cui trascorrono più tempo a lavorare. I maniaci del lavoro non possono lavorare senza una supervisione costante; le loro attività portano a un sovraccarico mentale e, di conseguenza, a errori; usano certe abilità stereotipate, ma non si sviluppano nella loro professione.
Robinson (2000) ha descritto il maniaco del lavoro come una situazione in cui una persona preferisce lavorare per sfuggire alle preoccupazioni relative ai problemi nella sua vita personale, e il lavoro crea l’impressione di bisogno e coinvolgimento. Un maniaco del lavoro fugge costantemente da alcuni dei suoi problemi, molto spesso si tratta di paura o incapacità di comunicare con le persone, bassa autostima. A volte il maniaco del lavoro è un tentativo di compensare la perdita di una persona cara o il desiderio di nascondersi dalla propria malattia, da alcuni problemi nella vita familiare o un modo per evitare altre questioni. La ragione del maniaco del lavoro può essere il desiderio e la necessità di essere riconosciuti da altre persone, ad esempio dal collettivo di lavoro.
Ancora uno causa probabile Lo sviluppo del maniaco del lavoro è chiamato elevato bisogno innato di attività intellettuale e/o fisica. Come è stato mostrato da Yu.N. Chusov e V.A. Skovorodko (1976), con un alto bisogno di attività, ci sono più maschi che femmine, questo spiega il fatto che ci sono più maniaci del lavoro maschi.
Pertanto, analizzando tutte le ragioni descritte per la formazione e lo sviluppo del maniaco del lavoro, possiamo confermare ancora una volta l'ambiguità di questo fenomeno, la cui natura e meccanismi di sviluppo sono ancora oggetto di ricerca.
Un'analisi dei principali concetti teorici sui fenomeni del maniaco del lavoro e del coinvolgimento lavorativo, accettati nella psicologia moderna, ci consente di trarre le seguenti conclusioni:
Il coinvolgimento nel lavoro è un fenomeno positivo, affettivo-motivazionale, caratterizzato da un completo assorbimento nelle attività professionali, che, a sua volta, può diventare la causa principale dello sviluppo di una deformazione professionale distruttiva: il maniaco del lavoro.
Il fenomeno del maniaco del lavoro è un complesso costrutto multidimensionale, le cui cause non sono state ancora chiaramente stabilite. Al momento, sembrano altrettanto preziosi concetti che spiegano il maniaco del lavoro in base allo stile di istruzione e alle caratteristiche dell'apprendimento durante l'infanzia, nonché le teorie secondo cui questo fenomeno è generato dai requisiti dettati al dipendente dalla cultura organizzativa dell'azienda.
Non esiste una comprensione comune dei criteri per identificare il maniaco del lavoro come una forma distruttiva di comportamento dei dipendenti. Per lo più, i ricercatori suggeriscono di fare affidamento sulle caratteristiche soggettive di una persona che lavora (la presenza di un desiderio ossessivo di lavorare), o di cercare correlati oggettivi della presenza di segni di comportamento come il maniaco del lavoro: tempo trascorso al lavoro e al lavoro.
Lo stato attuale della ricerca sul problema del maniaco del lavoro e del coinvolgimento lavorativo indica che la scienza psicologica non ha ancora sviluppato un consenso sull'essenza di questi fenomeni, sulle loro cause e sui meccanismi di sviluppo. Non sono stati sviluppati né un sistema generalizzato per diagnosticare, prevenire e correggere le manifestazioni e le conseguenze del maniaco del lavoro, né un sistema per diagnosticare e mantenere il coinvolgimento lavorativo.
Bibliografia:
Asmakovets E.S. Suicidio e attività professionale /E.S. Asmakovets // Giornale psichiatrico di Omsk. - 2014. - N. 1.
Ilyin E.P. Lavoro e personalità: maniaco del lavoro, perfezionismo e pigrizia/ EP Ilin. - San Pietroburgo: Pietro, 2011.
Andreassen C.S. Maniaco del lavoro: una panoramica e lo stato attuale della ricerca// Giornale delle dipendenze comportamentali. - 2014. - 3(1). - P. 1-11.
Bakker A.B., Leiter M.P. Impegno lavorativo: un manuale di teoria e ricerca essenziali.- Stampa psicologica, 2010a.
Bakker AB, Bal PM Impegno e prestazioni lavorative settimanali: uno studio tra gli insegnanti principianti// Giornale di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. -2010 a.C. - 83. - pag. 189-206.
Bamber M.R. La CBT per lo stress lavorativo negli operatori sanitari// Biblioteca elettronica Taylor & Francis. - 2006. - Capitolo 12.15.
Cherrington DJ L'etica del lavoro.- New York: Associazione americana di gestione, 1980.
Clark M., Lelchook A. & Taylor M. Oltre i Big Five: come il narcisismo, il perfezionismo e l'affetto disposizionale si collegano al maniaco del lavoro.- 2010. Csikszentmihalyi M. Flow: La psicologia dell'esperienza ottimale. -New York: Harper, 1990.
Hakanen J.J., Schaufeli W.B. Il burnout e l’impegno lavorativo predicono i sintomi depressivi e la soddisfazione della vita? Uno studio prospettico di sette anni in tre ondate// Giornale dei disturbi affettivi. - 2012. - 141. - pag. 415-424.
Iwasaki K., Takahashi M., Nakata A. Problemi di salute dovuti al lungo orario di lavoro in Giappone: orario di lavoro, compensazione dei lavoratori (Karoshi) e misure preventive// Salute industriale. - 2006. -Vol. 44. - No. 4 - Pag. 537-540.
Jones F., Byrke R. & Westman M. Equilibrio tra lavoro e vita privata: una prospettiva psicologica.- Hove, Regno Unito: Psychology Press, 2005.
Kahn W.A.Condizioni psicologiche di impegno e disimpegno personale nel lavoro// Rivista dell'Accademia di Management. -1990. - 33. - 692-724.
Kanai A, Wakabayashi M. Effetti dei cambiamenti ambientali economici sulle richieste di lavoro e sul maniaco del lavoro in Giappone// Giornale di gestione del cambiamento organizzativo. - 2004. -Vol. 17. - Iss: 5. - pp.537-548.
Killinger B. Workaholics: i rispettabili tossicodipendenti.-New York: Simon & Schuster, 1991.
Koch R. Il principio 80/20: il segreto per ottenere di più con meno. Catalogazione della Biblioteca del Congresso nei dati di pubblicazione, 1998.
Maslach C., Schaufeli W.B. & Leiter MP Burnout lavorativo// Rassegna annuale di psicologia. - 2001. Praeger 52. - 397-422.
Maccey W.H. &Schneider B. Il significato del coinvolgimento dei dipendenti// Psicologia industriale e organizzativa. - 2008. - 1. - 3-30.
I disturbi mentali del nuovo millennio/a cura di Tommaso G. Plante.- Praeger Londra, 2006. Volume 2. - p. 171-181.
Oates W.E. Essere un "maniaco del lavoro"// Psicologia pastorale. - 1968. - 19. - pag. 16-20.
Oates W.E. Confessioni di un maniaco del lavoro.-New York: Abingdon, 1971.
Peiperl M., Jones B. Maniaci del lavoro e superlavoratori: produttività o patologia? Gestione di gruppi e organizzazioni, 2001. - 369-393.
Russell J.A. Un modello circocomplesso dell’affetto// Giornale di personalità e psicologia sociale. - 1980. - 39. - 1161-78.
Russell J., Cohn R. Maniaco del lavoro.-VSD, 2013.
Szpitalak M. Approccio comportamentale al maniaco del lavoro. Problemi di approccio comportamentale al maniaco del lavoro, 2014.
Schaufeli W.B. Cos'è il fidanzamento?// In C. Truss, K. Alfes, R. Delbridge, A. Shantz ed E. Soane (a cura di), Employee Engagement in Theory and Practice. - Londra: Routledge, capitolo 1, 2013.
Schaufeli W.B., Bakker A.B. Richieste lavorative, risorse lavorative e loro relazione con burnout e coinvolgimento: uno studio multicampione// Giornale del comportamento organizzativo. - 2004. - 25. - Numero 3. - p. 293-315.
Schaufeli W.B., Taris T.W., van Rhenen Willem.Workaholism, Burnout e Work engagement: tre tipologie diverse di benessere dei dipendenti?// Psicologia applicata: una revisione internazionale. - 2008. - 57(2). - 173-203.
Snir R., Harpaz I.Oltre il maniaco del lavoro: verso un modello di investimento nel lavoro pesante// Revisione della gestione delle risorse umane. - 2012. - 22. - pag. 232-243.
Spence JT, Robbins A.S.Maniaco del lavoro: definizione, misurazione e risultati preliminari// Giornale dei valutatori della personalità. - 1992. - 58. - pag. 160-178.
Sulea C., Virga D., Maricutoiu L.P., Schaufeli W.B., Zaborila C., Sava F.A. L’engagement lavorativo come mediatore tra caratteristiche lavorative e comportamenti extra-ruolo positivi e negativi// Sviluppo professionale internazionale. 2012. - 17. - pag. 188-207.
Susman S.Maniaco del lavoro: una recensione// J Addict Res Ther; Supplemento - 2012. - 6(1). doi: 10.4172/2155-6105. S6-001.
Yuksel H. Il concetto di maniaco del lavoro rappresenta il punto estremo dell’impegno lavorativo, dei suoi risultati individuali e organizzativi// Giornale internazionale della Facoltà di Economia di Alanya. - 2014. -Vol. 6. - N. 2. - pag. 119-130.
Zijlstra Fred R.H., Sonnentag S. Al termine del lavoro: prospettive psicologiche sul recupero dal lavoro// Rivista europea di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. - 2006. - 15(2). - P. 129-138.
Per citare l'articolo:
Barabanshchikova V.V., Klimova O.A. Concetti di work engagement e workaholism nella ricerca psicologica contemporanea. // Rivista psicologica nazionale. – 2015. – N. 1(17). – P.52-60.
L’abilità che sto imparando a sviluppare è “muoversi dalla testa al corpo”. Aiuta molto nelle situazioni in cui la testa è “gonfia”:
Mi manca davvero l'amore.
- Cosa ti impedisce di ottenerlo?
"Non sono abbastanza bravo, ecco perché tutti mi lasciano."
- Hanno mollato tutti?
- Beh, non tutto... ma quello l'ho lasciato io.
- Quindi, dopo tutto, ci sono persone in natura che possono amarti.
- Non voglio Vasyatka con un telefono cellulare! (c)
- E cosa vuoi?
- Mi manca davvero l'amore.
Chi ha anche il dolore dalla mente sa che è inutile cercare scappatoie per uscire da questi costrutti mentali. La testa presenterà sempre un nuovo ostacolo.
C'è un'esperienza reale, fisica ed emotiva (quando le porte dell'ascensore si chiudono, il mio respiro diventa affannoso, sento tensione nel petto e la sensazione come se volessi saltare fuori dal corpo), e c'è un'interpretazione mentale, che ha anche una “storia” allegata (io soffro di claustrafobia perché mia madre mi ha chiuso in un armadio quando ero bambino).
Pertanto, se sposti la tua attenzione da ciò che sta accadendo nella tua testa a ciò che sta realmente accadendo nel tuo corpo, puoi scoprire qualcosa di interessante.
In primo luogo, può succedere che la fonte dei pensieri e delle sensazioni dolorose non sia affatto ciò che si pensava all'inizio. Potrebbe essere come quella battuta sulla ragazza con un sorriso folle che aveva le trecce strettamente intrecciate. E la storia di un cliente che, entrando nell'ufficio di Tera, ha improvvisamente sentito che le avrebbe fatto del male, anche se avevano già lavorato normalmente insieme per cinque anni (si è scoperto che si trattava del nuovo maglione di Tera, che era simile a un maglione dimenticato da tempo maglione indossato dall'uomo che l'aveva indossata durante l'infanzia violentata).
Di conseguenza, puoi iniziare a risolvere un problema completamente diverso che è la fonte diretta delle tue preoccupazioni. Cioè, la ragazza deve sciogliersi le trecce e non trascinarla da uno psichiatra e sottoporla ad antipsicotici.
In secondo luogo, può accadere che ciò che desideri non sia ciò che è stato interpretato automaticamente dai tuoi sentimenti all'inizio, ma qualcosa di completamente diverso. In climi molto secchi e caldi, ad esempio, i segnali della sete del corpo possono iniziare a somigliare molto ai segnali della fame. Ma non ho voglia di bere. Al primo impulso, senti di voler MANGIARE, e qualcosa di carnoso e grasso. Solo se ascolti il tuo corpo puoi indovinare cosa BERE dopo tutto. Inoltre, i segnali di disidratazione sono simili anche a qualcos'altro. Voglie nello stomaco, per esempio.
Di conseguenza, puoi iniziare a fare non qualcosa che risolverà il problema attuale, ma qualcosa che lo peggiorerà. Cioè, seguendo la percezione automatica dell'impulso, mangia molti cibi grassi, che ti disidratano ancora di più. Tutto quello che devi fare è bere più acqua e continuare a berla regolarmente.
In altre parole, sul percorso in cui i segnali entrano nel cervello, e poi la mente assegna loro immediatamente un'interpretazione, deve essere posizionata una guardia di frontiera per controllare i documenti.
Voglio suicidarmi...
- Perché?
- Perché ho incontrato l'uomo dei miei sogni, ma non possiamo stare insieme! Quella è l'ultima volta...
- In piedi! Cosa ti fa pensare che questo sia l'uomo dei tuoi sogni?
- L'ho sentito subito appena l'ho visto!
- Cosa hai provato esattamente?
- Amore!
- Più specificamente.
- Balin! Il mio petto si è subito sentito più caldo! Questo succede solo per amore... L'ultima volta...
- In piedi! Descrivi in dettaglio cosa stava succedendo in quel momento e quali sensazioni c'erano nel tuo corpo.
- Qual è la differenza?! La mia vita è finita!!!
- Dai, descrivilo.
- OK!!! Allora... ero seduto in un ristorante con un amico... stavamo fumando... era triste... e poi è entrato lui. Un amico dice: guarda questo ragazzo. D'istinto mi sono chinato in avanti... il seno mi è caduto dalla scollatura... è caduto in un piatto di zuppa calda... ho sentito calore nel petto... Oh cavolo... ecco di cosa si tratta!
- Sì.
Dire che tutti i problemi possono essere risolti così facilmente sarebbe nello stile della psicologia pop. È solo che in una situazione di stress acuto o quando "ho la testa gonfia", è più facile dire "alla sua vista il mio petto si è riscaldato" piuttosto che dire "la mia vita è finita".
"Sto camminando per strada in una giornata nuvolosa e fredda, ci sono facce grigie tutt'intorno, sono solo e nessuno mi ama, e non ho futuro" è una costruzione insopportabile. Non ha alcuna soluzione.
"Sto camminando per strada in una giornata nuvolosa e fredda, ho il petto stretto, le spalle curve e i piedi congelati" - insopportabile. Ed è più vicina alla realtà, perché descrive il momento presente, che esiste, e non il futuro, che è completamente sconosciuto. E puoi farci qualcosa, almeno cambiarlo leggermente.
Quando torni a casa, puoi mettere i piedi in una ciotola di acqua tiepida. Questo non risolverà i problemi della vita globale e non porterà felicità immediata, ti scalderà solo le gambe, potrai raddrizzare un po' le spalle, almeno per allungare i muscoli, e poi fare un respiro profondo per raddrizzarli un po' Petto.
Forse questo cambierà un po’ il filo dei pensieri. Il filo del pensiero cambierà e, chissà, potrebbero improvvisamente apparire nuove soluzioni. E se le cose non cambiano, aiuterà l’apsten a superare questa giornata senza un infarto e senza il desiderio di suicidarsi.
1. Il problema dello stato di coinvolgimento nella psicologia domestica e straniera
1.1 Diversi approcci allo stato di ingaggio
Nell'esperienza della cultura mondiale esistono diverse interpretazioni del concetto di coinvolgimento. Ad esempio, N. Berdyaev intendeva il coinvolgimento come un atto creativo; P. Landsberg considerava il coinvolgimento come "un atto di tipo speciale, che attraversa... attraverso l'individuo", e definiva anche la libertà personale come coinvolgimento (la realizzazione del valore dell'individuo attraverso l'attività è vicina nello spirito all'approccio dell'attività in psicologia sovietica)
“Il coinvolgimento è qualcosa di speciale. La tua mente è dedicata al compito con piena attenzione. Le tue emozioni sono intensificate. La tua attenzione è concentrata, ma il tuo comportamento è distribuito."
Nella psicologia moderna, il concetto di coinvolgimento si trova principalmente nel contesto della psicologia manageriale.
Il termine impegno è stato introdotto per la prima volta da K. Thompson e denotava la comprensione e la condivisione dei valori aziendali da parte di un dipendente.
JJ Lambin intende il coinvolgimento come “lo stato di energia (attivazione) vissuto da una persona riguardo alle attività legate al consumo”
Vlasova E.S.: coinvolgimento - il numero di decisioni prese in modo indipendente dai dipendenti; ha uno stato di impegno emotivo e intellettuale nei confronti dell'azienda. Fattori: leadership stimolante, cultura aziendale, politica di sviluppo dei talenti.
Per ottenere il coinvolgimento dei dipendenti nel lavoro, P. Drucker presupponeva che fossero necessarie 3 condizioni (tutte contrassegnate come "soggettive" - cioè dal punto di vista del dipendente): lavoro creativo, rispetto e autostima, remunerazione dignitosa).
Da questo punto di vista il coinvolgimento è strettamente correlato da un lato al concetto di motivazione e dall'altro al concetto di attività. Entrambi questi concetti verranno discussi di seguito, ma per ora ci limiteremo a osservare che tale visione del coinvolgimento, sebbene vicina a quella considerata nel lavoro, non è del tutto identica, poiché la definizione sopra mostra chiaramente l'impronta dell'organizzazione organizzativa attività, cioè ciò che si intende è il coinvolgimento in una causa comune, l'attenzione a un risultato comune, mentre in questo lavoro stiamo parlando sulle attività didattiche e sui risultati individuali. Inoltre, riferendosi alle condizioni di coinvolgimento di cui sopra, si può notare che nelle attività educative, a differenza di quelle organizzative, non vi è alcun rinforzo materiale (monetario).
Anche nella psicologia gestionale esiste una teoria del marketing interattivo (relazionale), uno dei concetti importanti del quale è il coinvolgimento del consumatore.
Un approccio completamente diverso è offerto dai ricercatori americani Douglas e Hargadon nel loro articolo “The Pleasure Principle: Immersion, Engagement, Flow”. Studiando i fattori che influenzano il piacere di leggere libri, identificano 2 aspetti correlati: l'immersione nell '"altra realtà" del libro e il coinvolgimento nel processo di elaborazione e generazione di significato. Concludono che questi due processi si compenetrano a vicenda e insieme consentono a una persona di sperimentare l'esperienza del "flusso" secondo M. Csikszentmihalyi o del jamming secondo Eisenberg.
Pertanto, attraverso il coinvolgimento nella lettura, comprendono il processo di elaborazione attiva delle informazioni. Un posto speciale nel loro articolo è dato ai testi con un sistema di navigazione - la capacità di seguire i collegamenti, cioè di costruire contenuti in modo così visivo, per chiarirne il significato - in altre parole, gli autori evidenziano un posto speciale per l'attività del soggetto nel processo di lettura.
Per quanto riguarda il concetto di jamming (questa parola non è tradotta diversamente in russo; jamming, letteralmente, "interferenza dal funzionamento di altre stazioni", che in modo associativo ci porta all'essenza del concetto, ma non direttamente), allora può essere definito come uno stato mentale che appare nel momento di impegno congiunto in qualsiasi attività creativa (attività in cui c'è spazio per l'improvvisazione) e accompagnato da un forte esperienza emotiva. Proprietà dello stato marmellata: trascendenza (l'esperienza di andare oltre i limiti della propria individualità), solidarietà (unisce persone completamente diverse), instabilità (soggettivamente si verifica inaspettatamente, non può essere causata da uno sforzo volontario), rischio (diversi aspetti: ad esempio , una valutazione errata del proprio stato funzionale o l'eventuale dipendenza psicologica). Tuttavia, nonostante la proprietà dell'instabilità, ci sono le condizioni più favorevoli per il jamming, ce ne sono anche quattro: la presenza di un certo livello di sviluppo delle abilità; presenza di una struttura rigida; sintonizzazione emotiva; “isolamento” dall’ambiente familiare. Eisenberg sottolinea le caratteristiche di questo stato che, a suo avviso, consentono di costruire un ponte tra l'individuo e il collettivo. Eric Eisenberg per primo notò e descrisse questo fenomeno tra i musicisti (jazzisti) e gli atleti (sport di squadra). Ma l'autore suggerisce che questa condizione può apparire completamente vari tipi attività.
Soffermiamoci ora un po' più in dettaglio sul fenomeno descritto da Csikszentmihalyi e chiamato stato di flusso.
“Flow” è un sentimento gioioso di attività quando l'individuo sembra dissolversi completamente nell'argomento con cui ha a che fare, quando l'attenzione è così focalizzata sull'attività da fargli dimenticare il proprio “io”; Il “flusso” è “la sensazione olistica che le persone provano quando sono pienamente impegnate nelle loro attività”.
Quando descrive le sensazioni di una persona in uno stato di flusso, Csikszentmihalyi usa una parola che non ha analoghi nella lingua russa. Godimento - "(piacere, gioia, godimento) differisce da tutti i sinonimi della serie in quanto denota non solo uno stato di piacere (fisico e spirituale), ma anche il processo per ottenerlo" (Dizionario sinonimo inglese-russo)
Il punto iniziale della ricerca di M. Csikszentmihalyi è stato l’osservazione del lavoro di artisti e scultori. Era stupito che l'artista non potesse lasciare il dipinto per giorni interi, esserne completamente assorbito mentre lo dipingeva e poi, una volta finito, abbandonarlo completamente. L'insieme delle esperienze che accompagnano e motivano l'attività, spingendo una persona a riprenderla, indipendentemente dai rinforzi esterni, si chiama esperienza autotelica. Quindi il materiale originale è stato raccolto intervistando persone presumibilmente familiari con l'esperienza autotelica (artisti, compositori, scalatori, musicisti, giocatori di scacchi, ballerini, chirurghi, ecc.). Sono state identificate alcune caratteristiche costanti di quello che molti intervistati chiamano "flusso" (su di loro di seguito ). Successivamente il ricercatore americano ha deciso di scoprire quanto sia diffuso questo fenomeno nella vita di tutti i giorni. Mihaly Csikszentmihalyi ha condotto le sue ricerche utilizzando il metodo del campionamento. Consisteva nel compilare, ogni due ore per una settimana, un libretto in cui indicava cosa stava facendo e cosa sentiva in quel momento. Il segnale di riempimento veniva inviato tramite cercapersone ad intervalli casuali nell'arco di due ore, dal primo mattino alla tarda sera. Dall'analisi dei dati ottenuti è stato scoperto quanto spesso e in quali momenti della vita quotidiana le persone sperimentano uno stato di flusso. La conclusione importante è che tale piacere può essere ottenuto assolutamente da qualsiasi attività, e anche che è familiare ai rappresentanti di culture diverse.
Sulla base dell’analisi delle opere di Csikszentmihalyi è quindi possibile distinguere due interpretazioni dello stato del flusso: in senso ampio e in senso stretto. In senso lato, questa è una gioiosa concentrazione su qualche attività; in senso stretto, è l'esperienza ultima di assorbimento in essa.
Sono state identificate le seguenti caratteristiche del flusso: fusione di azione e consapevolezza, focalizzazione dell'attenzione su un campo limitato di stimoli, perdita dell'ego o trascendenza e senso di potere e competenza. Il ruolo chiave della concentrazione a lungo termine.
Esistono diverse condizioni per l'emergere di uno stato di flusso (caratteristiche dell'attività). Innanzitutto, obiettivi chiari che richiedono una reazione molto specifica, chiare “regole del gioco”. In secondo luogo, risultati immediati, feedback: se una persona ha raggiunto il successo o ha commesso un errore, lo saprà immediatamente. In terzo luogo, il compito non dovrebbe essere né troppo semplice né troppo difficile; dovrebbe essere piuttosto difficile, richiedendo la massima concentrazione e l'applicazione di tutte le abilità, ma pur sempre entro le capacità dell'individuo. (Va però chiarito che affinché si verifichi lo stato di flusso è necessario che il soggetto possieda già un certo livello di competenze, cioè è ancora necessaria una certa preparazione - il che crea una certa eco con la prima condizione per lo stato comparsa di un ingorgo secondo Eisenberg.) Lavorare al limite delle forze e della maestria sviluppa il soggetto; la prossima volta lo stesso compito non richiederà più il suo pieno coinvolgimento. Pertanto, per provare nuovamente il piacere dello stato di flusso, ha bisogno di affrontare compiti ancora più difficili. In questo modo, a una persona viene dato uno slancio per lo sviluppo. Csikszentmihalyi dice addirittura che forse il flusso è una sorta di connessione incorporata nella nostra dall'evoluzione sistema nervoso, la cui funzione è stimolare lo sviluppo dell'organismo nel senso di realizzare le sue capacità.
“Non c’è più spazio nella mente di una persona per pensieri distraenti e sentimenti estranei. L'autoconsapevolezza di una persona scompare quando si sente più forte del solito. Il senso del tempo cambia: le ore sembrano volare come minuti. Quando tutto l'essere di una persona è concentrato sul lavoro completo del corpo e della mente, allora qualunque cosa faccia diventa di per sé preziosa; l'esistenza si giustifica. La combinazione armoniosa di energia fisica e mentale porta al fatto che la vita diventa finalmente vita.
È l’abbandono totale al flusso, non la felicità, che rende la nostra vita meravigliosa”. (M. Csikszentmihalyi)
Lo stato di marmellata di Eisenberg è per molti versi simile allo stato di flusso di Csikszentmihalyi; La differenza principale tra l'inceppamento è che è possibile solo nell'attività collettiva, mentre lo stato di flusso viene raggiunto individualmente.
Analizzando le definizioni di coinvolgimento tratte da vari ambiti del sapere psicologico, si possono evidenziare diversi aspetti: in primo luogo, in tutte le definizioni, in un modo o nell'altro, c'è un'indicazione dell'attività del soggetto; il concetto di attività personale è stato sviluppato abbastanza ampiamente nell'approccio dell'attività domestica, di cui parleremo più in dettaglio, nell'approccio umanistico, esistenziale e nella psicologia positiva - di questo più brevemente. In secondo luogo, ciascuna definizione è strettamente correlata a un'attività specifica, ovvero non esiste una definizione di impegno isolata dal suo oggetto - il che ci porta a considerare le specificità delle attività educative; in terzo luogo, a causa della varietà delle definizioni, sembra necessario introdurre un concetto generico, nell'ambito del quale verranno effettuate ulteriori considerazioni: il concetto di stato mentale.
In futuro, nel nostro lavoro, per impegno intendiamo il fenomeno descritto e studiato da Csikszentmihalyi come uno stato di flusso, nel senso ampio del termine.
Non è facile definire questo concetto. “…gli esseri viventi in generale resistono ostinatamente alla concettualizzazione e a qualsiasi tentativo di definizione univoca. Proprio perché è vivo. Il problema è mantenerlo vivo nella ricerca, nella descrizione, nei modelli, nelle definizioni."
Tuttavia, il coinvolgimento è uno stato mentale che emerge nel processo di un'attività vigorosa ed è caratterizzato da una fusione di azione e consapevolezza, concentrandosi su un campo limitato di stimoli, un senso di competenza e piacere dal processo di attività.
1.2 Il coinvolgimento come stato mentale
ND Levitov: “Uno stato è una caratteristica olistica dell'attività mentale per un certo periodo di tempo; una caratteristica che mostra l’unicità dei processi mentali in corso a seconda degli oggetti e dei fenomeni riflessi della realtà, dello stato precedente e delle proprietà mentali dell’individuo”.
Questa definizione sottolinea in particolare la duplice natura degli stati mentali: la loro connessione con il mondo esterno, oggettivo e mondo interiore soggetto, fino a formazioni stabili come i tratti caratteriali. V.A. Hansen scrive che gli stati mentali sono un anello intermedio di collegamento tra i processi mentali e i tratti della personalità. Inoltre, la connessione tra stati e tratti della personalità, così come tra stati e processi mentali, è bidirezionale, il che è molto importante: ne consegue che correggendo gli stati mentali di una persona, è possibile modificare nel tempo le sue manifestazioni più stabili.
"Uno stato mentale è il riflesso di una persona di una situazione sotto forma di una sindrome integrale stabile (aggregato) nella dinamica dell'attività mentale, espressa nell'unità di comportamento ed esperienza nel continuum del tempo."
Analizzando questa definizione, possiamo quindi evidenziare 2 aspetti importanti nella moderna comprensione degli stati mentali nella psicologia russa: in primo luogo, la connessione inestricabile tra comportamento ed esperienza: la psiche umana è una, e i processi che si verificano all'interno hanno sempre un'espressione esterna. Tuttavia, per trarre una conclusione sullo stato mentale di una persona, non sono sufficienti sia i dati osservabili esternamente che le sole autovalutazioni. In secondo luogo, ciò che segue dalla comprensione della situazione come una combinazione di fattori non solo esterni, ma anche interni, cioè compresi i tratti della personalità, arriviamo alla conclusione che lo stato mentale dipende sia dalle condizioni stabilite dall'esterno che dalle qualità stabili della personalità , il suo sistema di motivazioni, ecc.
Pertanto, per ottenere informazioni sullo stato mentale di una persona, è possibile utilizzare alcuni criteri oggettivi (ad esempio osservando e registrando il comportamento), criteri soggettivi (storie orali o scritte di soggetti sul loro stato) e prodotti dell'attività. Il nostro studio utilizza dati oggettivi e soggettivi per esaminare lo stato dell’impegno.
È interessante notare che gli autori di entrambe le definizioni presentate sopra utilizzano il concetto di integrità nelle loro formulazioni. Ciò ci porta a pensare alla direzione della Gestalt in psicologia, per la quale il fenomeno dell’integrità era fondamentale.
Kurt Lewin nelle sue opere ha sottolineato l'influenza dei fattori situazionali sul comportamento individuale. Ad esempio, in uno dei suoi studi più famosi, invitò i soggetti nel suo ufficio e, scusandosi, se ne andò con la richiesta di aspettare un po'. In questo momento l'esperimento è effettivamente iniziato: Levin ha registrato ciò che le persone stavano facendo in sua assenza. E si è scoperto che, indipendentemente dal sesso, dall'età, dallo status o dalle caratteristiche personali, c'erano azioni che tutti i soggetti eseguivano (ad esempio, tutti suonavano il campanello sul tavolo). Oppure un altro suo esperimento, più vicino all'argomento del nostro studio: tre gruppi di scolari erano impegnati in un circolo di creazione di giocattoli con gli insegnanti, uno dei quali aveva uno stile autoritario, un altro democratico e il terzo permissivo. 6 settimane dopo l'inizio dell'esperimento, il comportamento degli studenti durante le lezioni, inizialmente simile, ha cominciato a differire notevolmente.
Pertanto, in questo studio è possibile osservare l'influenza di fattori situazionali, come il comportamento dell'insegnante, sul rendimento degli studenti.
Presentiamo la classificazione degli stati mentali compilata da N.D. Levitov. .
Stati personali e situazionali; "Nel primo, le proprietà individuali di una persona sono principalmente espresse, nel secondo - le caratteristiche della situazione, che spesso causano reazioni insolite per lui in una persona." Va notato qui che una delle domande da affrontare la nostra ricerca è la questione del posto dello stato di coinvolgimento in questo continuum. Stiamo studiando l'influenza di fattori sia situazionali che personali nel tentativo di scoprire cosa è maggiormente responsabile del verificarsi di questa condizione.
Condizioni che hanno un effetto positivo o negativo su una persona. Come già accennato, lo stato di ingaggio è indissolubilmente legato all’attività in cui si realizza. Di conseguenza, il "segno" di influenza su una persona è in gran parte determinato dalle specificità di questa attività, nonché dai motivi e dagli obiettivi dietro di essa. Se assumiamo che l'attività sia costruttiva (ad esempio educativa), allora, tra le altre cose, possiamo notare la funzione psicoterapeutica dello stato di coinvolgimento associato alla concentrazione dell'attenzione sul presente, l'esperienza di fiducia nei propri sentimenti (che K. Rogers in un senso più ampio chiama il sentimento organismico), un senso emergente di potere e competenza, che consente una maggiore autostima.
Esiste anche una divisione degli stati in più profondi e più superficiali, lunghi e brevi, più o meno coscienti. A seconda delle caratteristiche situazionali e personali, l’impegno in una particolare attività può collocarsi in punti diversi di questo continuum.
Oltre agli stati di coscienza “normali”, gli autori distinguono gli stati di coscienza espansi e contratti (SS), che Kardash paragona rispettivamente a un telescopio e a un microscopio. SS ristrette: “nelle forme lievi, accompagnano un'attività mentale intensa o un lavoro che richiede un alto grado di concentrazione” - in alcuni casi possono includere anche uno stato di coinvolgimento. Questa aggiunta ci ricorda il ruolo dell’attenzione nel creare uno stato di coinvolgimento.
1.3 Il coinvolgimento come stato motivazionale
Ma prima di iniziare ad analizzare le idee moderne sulla motivazione e cercare il luogo del coinvolgimento in esse, vorrei parlare dell'approccio dell'attività in psicologia. Ciò può sembrare illogico o addirittura inappropriato, tuttavia, in primo luogo, senza parlare della gerarchia delle attività e della gerarchia dei motivi che la determinano come base della personalità, il concetto di motivazione mi sembra in qualche modo separato dalla realtà, e in secondo luogo, la comprensione dell'attuazione delle attività come base dell'esistenza umana è in gran parte determinato per me dall'importanza della questione studiata: il coinvolgimento nelle attività; in terzo luogo, le attività educative saranno considerate anche dal punto di vista dell'approccio all'attività.
1.3.1 Il problema dell'attività nella psicologia domestica
Gli insegnamenti di K. Marx hanno dato un contributo importante allo sviluppo della psicologia russa. In esso, i ricercatori sovietici scoprirono idee come la proposizione sulla natura sociale psiche umana, sulla coscienza come forma qualitativamente speciale della psiche e, naturalmente, sull'attività, l'attività sensoriale come base della cognizione umana, la loro connessione inestricabile. “Le premesse con cui cominciamo non sono arbitrarie, non sono dogmi; queste sono premesse reali dalle quali si può astrarre solo con l'immaginazione. Questi sono gli individui reali, le loro attività e le condizioni materiali della loro vita...” - cita le opere di Marx ed Engels di A.N. Leontyev.
Successivamente, queste opinioni costituirono la base della visione del mondo, sviluppata e rivelata nelle opere di molti psicologi. Il concetto culturale e storico di L.S. si distingue. Vygotskij. Le idee iniziali della sua teoria sono nate dall'analisi delle caratteristiche dell'attività specificamente umana: lavoro svolto con l'ausilio di strumenti, e anche sociale. Da qui si deducono logicamente due punti correlati che, secondo Vygotsky, dovrebbero costituire la base della scienza psicologica. Questa è la struttura strumentale dell'attività umana e la sua inclusione nel sistema di relazioni con altre persone. Uno strumento, uno strumento, media l'attività umana socialmente determinata e per utilizzare uno strumento è necessario imparare a farlo, cioè adottare l'esperienza di altre persone. Pertanto, nel processo di attività dello strumento, una persona “assorbe” tradizioni culturali e storiche. C'è un processo di interiorizzazione, che consiste nel fatto che attività esterne costituisce il piano interiore della coscienza. Non si traduce nel piano interno della coscienza, ma piuttosto lo forma; Questa comprensione è fondamentalmente diversa da molti altri concetti, in cui la coscienza è intesa come qualcosa “senza qualità”. Secondo Vygotskij la coscienza è il riflesso del soggetto della realtà della sua attività, di se stesso, ed è formata dalla società. Pertanto, a suo avviso, le funzioni mentali superiori possono apparire solo nell'interazione di una persona con una persona - come interpsicologiche, e solo allora possono essere eseguite dall'individuo in modo indipendente e persino perdere la loro componente esterna, trasformandosi in intrapsicologiche.
Scrive S.L. Rubinstein: “La coscienza è sempre un essere cosciente. La coscienza di un oggetto è determinata dal suo rapporto con l'oggetto della coscienza. Si forma nel processo della pratica sociale. La mediazione della coscienza da parte di un oggetto è la vera dialettica dello sviluppo storico dell'uomo. Nei prodotti dell’attività umana – essenzialmente sociale – la coscienza non solo si manifesta, ma attraverso di essi si forma”.
Studente e seguace di Vygotskij, A.N. Leontiev, ha continuato a sviluppare l'approccio dell'attività nella psicologia russa. L’essenza di questo approccio è che l’attività è inclusa come anello intermedio nello schema “impatto di un oggetto => cambiamento negli stati attuali del soggetto”. L’attività, cioè, media la connessione tra, in termini di comportamentismo, stimolo e risposta, il che consente ai ricercatori di allontanarsi dai concetti meccanicistici, in cui il termine “coscienza” non trova alcun posto, e da quelli idealistici, in cui questa Il concetto è speculativo e non è considerato oggetto di ricerca psicologica.
L’attività, secondo Leontyev, è “un sistema che ha una struttura, transizioni e trasformazioni interne e un proprio sviluppo”. Alexey Nikolaevich sottolinea ripetutamente che è impossibile rimuovere l'attività dal sistema di relazioni sociali, perché l'ambiente sociale dell'individuo determina i suoi obiettivi, mezzi, motivazioni, metodi di attività, nonché le condizioni in cui si svolge. “La società produce le attività degli individui che la compongono.” L'attività è sempre oggettiva. Inoltre, l'oggetto appare in due forme: come oggetto materiale oggettivamente esistente e come immagine mentale. Questa proprietà dell'attività permette di dedurne la struttura: afferentazione iniziale => processi effettori che entrano in contatto con l'ambiente => correzione e arricchimento dell'immagine originale. Cioè, ci sono connessioni reciproche tra il processo di attività e il suo oggetto: inizialmente l'oggetto dirige l'attività (viene creata un'immagine mentale), quindi l'attività cambia l'oggetto, che a sua volta porta ad un aggiustamento dell'immagine creata in precedenza , e così via. Va detto che la natura oggettiva della psiche si estende non solo ai processi cognitivi, ma anche alla sfera dei bisogni emotivi.
"L'attività è inclusa nel processo stesso di riflessione mentale, nel contenuto stesso di questo processo, nella sua generazione", scrive Leontyev. Di conseguenza, entra nel campo di studio della psicologia come elemento generatore di un'immagine mentale. Inoltre, ci sono connessioni reciproche tra l'attività e la riflessione mentale della realtà, come discusso sopra. Pertanto, è l’attività che funge da collegamento tra il mondo esterno e la psiche dell’individuo. Leontyev chiama questa la funzione di “posizionare il soggetto nella realtà oggettiva e trasformarlo nella forma della soggettività”.
Parlando di attività, A.N. Leontyev identifica la sua struttura, cioè le sue parti costitutive. In primo luogo, egli sostiene, in realtà non esiste un'unica attività umana astratta; essa è divisa in molte attività diverse. L'attività è necessariamente motivata, cioè si basa su un motivo, che a sua volta si basa su un bisogno. Inoltre, nel processo di sviluppo storico, è stato necessario differenziare le attività, dividerle in elementi separati (la base della divisione del lavoro). È così che sono apparse le azioni: processi subordinati alle idee sull'obiettivo che deve essere raggiunto. Cioè, un'attività è una catena di azioni interconnesse, spesso eseguite in una sequenza rigorosa. La formazione dell'obiettivo dell'azione avviene attraverso la verifica dell'attività: solo agendo attivamente una persona può valutare in modo più obiettivo le sue capacità. A questo livello, il motivo trasferisce parte dei suoi “poteri”: svolge ancora la funzione di motivazione, ma la funzione di direzione è svolta dall'obiettivo. C'è anche da dire che la stessa attività può essere implementata in azioni diverse, e la stessa azione può essere inclusa nella struttura di attività completamente diverse. Inoltre, la stessa azione può essere eseguita in condizioni diverse, quindi in modi diversi. Pertanto, viene introdotto il concetto di operazione: il metodo per eseguire un'azione. Ad esempio, una vite può essere svitata con un cacciavite o manualmente: sarà la stessa azione (inclusa, ad esempio, nell'attività di riparazione di una bicicletta), ma sarà suddivisa in diverse operazioni a seconda delle condizioni esistenti. Ed è anche importante notare che tutti gli elementi dell'attività sono in costante interazione tra loro, quindi la struttura viene continuamente trasformata. Nell'ambito dell'apprendimento, un'azione può diventare automatica e diventare un'operazione, oppure, al contrario, può acquisire un motivo e diventare un'attività. E un'attività che ha perso il suo motivo, al contrario, può diventare un'azione nell'ambito di un'altra attività.
1.3.2 Gerarchia delle attività come base della personalità
Quando si parla del problema della personalità, i ricercatori affrontano alcune difficoltà. Il paradosso principale è che la personalità è allo stesso tempo mutevole e costante. È mutevole perché le componenti incluse nelle sue caratteristiche - tratti caratteriali, obiettivi, valori, alcune proprietà psicofisiologiche, ecc. - cambiano nel corso della vita. Tuttavia, stiamo parlando di una certa continuità e della presenza di qualcosa in comune attraverso l'ontogenesi. La maggior parte degli autori concorda su due caratteristiche principali della personalità: l'unità e il ruolo dell '"autorità governativa". Per quanto riguarda gli altri, invece, continuano a imperversare i contrasti tra le scuole. UN. Leontyev, in particolare, offre la sua versione della soluzione al problema: alla base della personalità, lui, secondo le sue opinioni, pone una gerarchia di attività. Cosa significa questo? Leontyev ritiene che la base della personalità siano le relazioni di natura sociale con il mondo, che si realizzano in attività oggettive. Questa visione aiuta a risolvere il problema dell'inclusione o non inclusione di qualsiasi proprietà individuale nella struttura della personalità. La stessa proprietà può essere significativa o insignificante per una persona nelle condizioni di un'attività specifica, che, a sua volta, può occupare un certo posto in sistema comune attività. Di conseguenza, ogni singola proprietà può diventare molto importante se è importante per condurre attività. Ad esempio, la velocità di reazione è fondamentale per un velocista professionista, ma non per un contabile, quindi nel primo caso sarà inclusa nelle caratteristiche della personalità, ma nel secondo no. Man mano che la personalità si sviluppa, le attività umane entrano in relazioni gerarchiche tra loro. E per comprendere la struttura di una personalità, è necessario capire qual è per essa il collegamento principale e centrale, e cosa serve solo come mezzo per realizzare la cosa principale; è necessario studiare lo sviluppo delle attività e le loro connessioni tra loro. Ancora una volta, per individui diversi, le stesse attività possono avere significati completamente diversi: occupare un posto centrale e, di conseguenza, rendere di fondamentale importanza tutte le proprietà personali e individuali associate alla loro attuazione, oppure trovarsi alla periferia o generalmente essere relegate al rango di Azioni.
Ma, come è noto, ogni attività è stimolata e diretta da un motivo, quindi dietro la gerarchia delle attività c'è una gerarchia di motivi. Il problema dei motivi e della motivazione sarà discusso più in dettaglio nel paragrafo successivo, parlando tuttavia delle opinioni di A.N. Leontyev, alcune disposizioni dovrebbero essere menzionate. In primo luogo, chiama motivo l'oggetto del bisogno; dice che i bisogni “astratti”, “non oggettivati” sono prerequisiti per l'attività, ma in futuro, in relazione ai bisogni “oggettivati”, l'attività è primaria. Inoltre, nel contesto di questo lavoro, è interessante la sua posizione secondo cui la base genetica dell'attività umana è la discrepanza tra motivazioni e obiettivi. Al contrario, la loro coincidenza è piuttosto un'eccezione: ciò avviene o per l'acquisizione di una forza motivante indipendente da parte del bersaglio, o come risultato della consapevolezza dei motivi, trasformandoli in motivi di obiettivo (di solito i motivi non vengono realizzati). Infine, Leontyev parla della duplice funzione dei motivi. In base a ciò, distingue i motivi di formazione del significato (quelli che danno un significato personale a un'attività) e i motivi di incentivazione (che svolgono il ruolo di fattori di incentivazione positivi o negativi, ma privi di una funzione di formazione del significato). È questa divisione che egli pone alla base della gerarchia dei motivi. Gli stessi motivi possono formare significato nell'ambito di un'attività e solo incentivi nell'ambito di un'altra, tuttavia, i motivi che formano significato occupano sempre un posto più alto nella gerarchia, sebbene non sempre siano realizzati.
1.3.3 Il concetto di motivazione, motivo. Motivazione “interna” ed “esterna”.
La motivazione, secondo E.P. Ilyin, è “il processo dinamico di formazione delle motivazioni”. Il motivo, a sua volta, è "una formazione psicologica complessa che incoraggia azioni e azioni coscienti e funge da base (e giustificazione) per esse". Nel suo libro esamina in dettaglio le idee di vari ricercatori sull'essenza del motivo. Ciascuna delle teorie monistiche di cui parla ha i suoi vantaggi e svantaggi. L'identificazione del motivo e del bisogno spiega la presenza di energia per svolgere un'attività, ma non permette di comprendere perché si sceglie questo particolare oggetto e metodo per soddisfare il bisogno; cioè si perde la funzione guida del motivo. La teoria opposta, che considera il motivo come un obiettivo (oggetto della soddisfazione di un bisogno secondo Leontiev), al contrario, dimentica il significato del bisogno stesso; Inoltre, è impossibile spiegare perché viene eseguita un'azione: dopo tutto, la ragione della stessa azione può essere esigenze diverse. Anche la motivazione, l'intenzione, le proprietà personali, lo stato non possono essere identificati con il motivo. Solo in combinazione tra loro possono formare una formazione così complessa come motivo. Considerando le fasi della formazione della motivazione, quando lo stimolo è un bisogno biologico dell'individuo, Ilyin identifica 3 fasi della formazione della motivazione. Il primo è la formazione di un motivo primario e astratto. In questa fase avviene la formazione dei bisogni dell'individuo (consapevolezza di un bisogno organico) e appare la spinta all'attività di ricerca. Di conseguenza, la seconda fase è l'attività di ricerca esterna o interna (associata all'utilizzo di oggetti reali o delle loro immagini). C'è una valutazione della situazione, comprese le condizioni per raggiungere l'obiettivo, la correlazione con i principi morali, la valutazione delle proprie capacità e anche la probabilità di raggiungere il successo con varie opzioni di azione. Nella terza fase viene selezionato un obiettivo specifico e si forma l'intenzione di raggiungerlo. Pertanto, nel processo di formazione del motivo, vediamo come tutti i concetti sopra elencati, che sono stati identificati con il motivo da alcuni autori, sono inclusi nella sua struttura.
Il processo di motivazione, secondo A.A. Faizullaev, è diviso in 5 fasi: consapevolezza del motivo, accettazione del motivo (accettazione, inclusione del motivo nel sistema di valori, norme, atteggiamenti), attuazione del motivo, consolidamento del motivo, attualizzazione del motivo.
Esiste una diffusa divisione della motivazione in “esterna” e “interna”. I termini sono messi tra virgolette perché la correttezza del loro utilizzo è piuttosto controversa. Ilyin dice che queste parole significano, in generale, che il comportamento è determinato da stimoli esterni ed interni e che la motivazione in senso stretto è sempre determinata internamente. E in questo caso è più corretto usare i termini motivazione “organizzata internamente” (intrinseca) e motivazione “organizzata esternamente” (estrinseca).
H. Heckhausen individua 6 concetti che definiscono e spiegano il fenomeno della motivazione intensa. Secondo la prima, qualsiasi motivazione è considerata organizzata internamente, il cui scopo non è quello di soddisfare bisogni biologici (da questo punto di vista è intrinseca anche la motivazione socialmente imposta). Secondo il secondo, la motivazione organizzata internamente è associata al desiderio che il corpo raggiunga un livello ottimale di eccitazione (fisiologico o psicologico). Da un terzo punto di vista, sono considerate intrinsecamente motivate solo le tipologie di attività “senza scopo”, cioè svolte esclusivamente per il bene dell'attività stessa (solo poche tipologie di attività rientrano in questa definizione - ad esempio, alcune tipologie di giochi o esperienze estetiche).
Il quarto approccio propone come concetto chiave il motivo dell '"autoaffermazione" (la terminologia dell'autore, De Charms) - tutte le azioni che una persona compie secondo la sua libera volontà, soggettivamente al di fuori dell'influenza della società, affermando il suo diritto, la sua capacità di indipendenza, sono considerati intrinsecamente motivati (“È la creatura che trema...”) Il quinto concetto definisce la motivazione intrinseca attraverso l'omogeneità dell'azione e del suo scopo: se lo scopo dell'azione, il suo beneficio, è non tematicamente correlata all'azione stessa, la motivazione è considerata estrinseca. E infine, come sesto concetto, Heckhausen chiama l'approccio di Csikszentmihalyi, la cui chiave è il concetto di gioioso assorbimento nell'azione ed è questa esperienza che accompagna l'attività che gioca un ruolo importante.
1.4 Caratteristiche delle attività educative. Caratteristiche dell'allenamento di danza
L’attività educativa in questo lavoro è intesa come sinonimo di apprendimento, cioè “il processo di acquisizione e consolidamento (o cambiamento esistente) delle modalità di attività di un individuo. I risultati dell'insegnamento sono elementi dell'esperienza individuale (conoscenze, abilità, competenze)"
L'attività educativa in senso stretto (nell'approccio di Elkonin-Davydov, nato dal concetto di A.N. Leontiev) è intesa solo come un processo di apprendimento accademico: padroneggiare le conoscenze teoriche a scuola o all'università. Questa considerazione non è adatta a questo studio, perché l'attenzione principale in esso è rivolta allo studio delle caratteristiche dell'insegnamento della danza, e in quest'area l'enfasi è posta sulla padronanza, principalmente, di abilità e abilità, mentre la conoscenza teorica è un'aggiunta. Tuttavia, poiché il concetto di A.N. Leontiev è uno dei fondamenti teorici di questo lavoro; consideriamo l'insegnamento della danza dal punto di vista della struttura generale delle attività educative della scuola Elkonin-Davydov.
L'attività educativa ha la seguente struttura: bisogno - compito - motivazioni - azioni - operazioni. Il compito specifico delle attività educative è l’assimilazione degli studenti metodo generale soluzioni. Nel contesto della formazione nella danza, si tratta dello sviluppo di un principio generale del movimento in una danza, che viene poi utilizzato in varie combinazioni di movimenti. Di conseguenza, la necessità è il desiderio di assimilare questo principio generale. Le motivazioni - le “giustificazioni”, per cui le persone vogliono imparare a ballare - variano certamente da persona a persona, ma ci sono quelle che sono più caratteristiche dell'imparare a ballare. Questo è il piacere del processo stesso della danza (lo stesso tipo di intensa motivazione), il desiderio di avere un bell'aspetto / sentirsi bene, il desiderio di esibirsi in pubblico, il desiderio semplicemente di divertirsi comunicando e interagendo con altre persone.
Azione: eseguire un singolo movimento (ad esempio, un “passo principale”); operazione - movimenti di singole parti del corpo (gambe, braccia, fianchi, scapole, ecc.) che fanno parte di un movimento di danza. La differenza rispetto ad altri tipi di attività qui è che è importante quali operazioni vengono utilizzate per eseguire l'azione, quindi le operazioni qui sono intese come parti più frazionarie dell'azione.
Come nel processo di comprensione di una particolare teoria, nel processo di apprendimento della danza c'è un movimento costante dal particolare al generale e dal generale al particolare - dalla comprensione della geometria generale del movimento alle operazioni particolari che ne determinano le caratteristiche, grazie alla cui correzione, a sua volta, si crea l'idea originale del movimento nel suo insieme - ecc. Il processo di apprendimento della danza comprende sia il pensiero figurativo (quando la comprensione delle caratteristiche del movimento avviene con l'aiuto di esempi e confronti) sia il pensiero verbale (quando l'apprendimento avviene attraverso la denominazione di singole operazioni), ma il ruolo principale appartiene comunque al visivo ed efficace. Tuttavia, a seconda delle caratteristiche individuali dello studente, l'insegnante può collegare varie risorse al lavoro di padronanza del materiale.
Partiamo dal presupposto che uno stato di coinvolgimento possa essere raggiunto nelle attività di apprendimento. Per fare questo, secondo la teoria di Csikszentmihalyi, devono essere soddisfatte 3 condizioni: complessità ottimale dei compiti assegnati (a seconda dell'insegnante e dello studente, la sua capacità di regolare autonomamente la complessità fissando obiettivi personali), fornire un feedback rapido (a un dipende in misura maggiore dall'insegnante) e la disponibilità di obiettivi chiari (l'obiettivo più generale nel processo di apprendimento è solitamente chiaro, è importante che l'insegnante comprenda e articoli gli obiettivi più specifici dell'attività).
1.5 Coinvolgimento e attenzione post-volontaria
M. Csikszentmihalyi ha sottolineato il ruolo chiave della concentrazione nell'esperienza del flusso. Ciò non sorprende, dato che, secondo L.M. Wecker, l'attenzione è un processo mentale trasversale che integra componenti mentali, emotive e volitive in un'unica struttura, cioè l'attenzione prende parte a tutti i processi e fenomeni mentali.
Tuttavia, in questo caso, c'è un ulteriore significato di attenzione in relazione a questa proprietà generale: una delle sue forme è un substrato mentale necessario, per così dire, per l'emergere del coinvolgimento.
Yu.B. Dormashev e V.Ya. Romanov nel suo libro offre un'analisi dell'attenzione dalla posizione dell'approccio dell'attività. Dal loro punto di vista, “l'attenzione è un atto mirato al sistema di attività fisiologico-funzionale (FFS). L'atteggiamento della FSF nei confronti delle attività si rivela in due direzioni. Da un lato, l’attività determina la composizione, la dinamica e le proprietà della FSF; d’altro canto, i modelli e le proprietà propri della FFS determinano gli aspetti dinamico-formali dell’attività e impongono restrizioni su di essa.” Diverse forme di attenzione, scrivono gli autori, agiscono con capacità diverse nell’organizzazione dell’attività del soggetto.
L'attenzione involontaria è simile al livello delle operazioni nel sistema di attività. Un fattore importante nella comparsa dell'attenzione involontaria è il motivo. Gli autori dividono l’attenzione involontaria in forzata ed emotiva. Il primo è un fattore disorganizzante nell’attuale FSS e ne attualizza un altro nella mente; innescato in risposta a stimoli e condizioni ambientali incondizionati e biologicamente specificati. L'attenzione emotiva ha lo stesso effetto, ma può essere innescata sia da condizioni esterne che interne (bisogno insoddisfatto, attrazione, ecc.).
L'attenzione volontaria sorge a livello delle azioni. L'obiettivo qui è focalizzare selettivamente l'attenzione su qualche oggetto scelto consapevolmente. La motivazione qui agisce come una delle condizioni per l'emergere dell'attenzione volontaria, e in questo caso può essere eccessiva, avendo un effetto disorganizzante (la legge Yerkes-Dodson, ad esempio, è ampiamente nota).
Infine, il livello più alto, l'attenzione post-volontaria, viene raggiunto quando la motivazione si sposta verso l'obiettivo. L'attenzione post-volontaria è legata all'attività in questa considerazione. I suoi tratti caratteristici sono l'assenza o una significativa diminuzione dello sforzo volontario, un aumento dell'interesse e dell'assorbimento nell'attività, la completa concentrazione su di essa, il piacere. Oggettivamente, questa condizione è associata a un forte aumento della produttività del lavoro.
Allontanandosi da una considerazione esclusivamente basata sull'attività, possiamo aggiungere che è l'attenzione a creare nel soggetto una sensazione di complessità ottimale del compito (ponendo nel suo campo solo un certo numero di parametri del compito e di condizioni esterne), e senza concentrazione a lungo termine dell'attenzione su un campo limitato di stimoli, l'emergere dell'assorbimento nell'attività è in linea di principio impossibile.
È anche importante notare che la capacità di gestire la propria attenzione caratterizza una personalità autotelica, una personalità capace di ristrutturarsi vasta gamma attività in modo che diventino interessanti.
.6 Il coinvolgimento come caratteristica del percorso di vita di un soggetto
Una delle condizioni necessarie per l'emergere del coinvolgimento, come notato sopra, è l'attività del soggetto. Inoltre, il tema della temporaneità del coinvolgimento come stato mentale nel sistema della personalità e, di conseguenza, della possibilità che il coinvolgimento diventi un tratto caratteriale da uno stato situazionale è già stato toccato più di una volta.
Nelle opere degli psicologi russi della metà del XX secolo, il tema dell'uomo come soggetto del viaggio della vita è stato discusso in dettaglio: una persona attiva, creativa, selettiva e altamente coinvolta nella vita. “…l’esistenza è partecipazione al processo della “vita”. Vivere significa cambiare e restare, agire e soffrire, persistere e cambiare”, scrive S.L. Rubinstein. “Quindi l’uomo come soggetto è il creatore della propria storia, l’arbitro del percorso della sua vita in determinate condizioni socio-economiche. Egli avvia e realizza attività specificamente umane: creative, morali, libere, responsabili, ecc. In questo senso l'attività del soggetto è sempre creativa (almeno in misura minima)..." - sostiene A.V. Brushlinsky
Una persona è libera, ha la propria volontà e l'essenza di ciò è che la totalità delle influenze esterne ed interne non potrà mai determinare completamente il comportamento di S.L. Rubinstein: “...in una persona inclusa in una situazione c'è qualcosa che la porta oltre i limiti della situazione in cui è inclusa. La situazione è solo una delle componenti che determina le sue azioni. Una persona è un essere che ha un progetto, un piano, un compito, un obiettivo, distingue una situazione, evidenziando in essa le condizioni correlate con le esigenze.
“Con le mie azioni esplodo continuamente, cambio la situazione in cui mi trovo, e allo stesso tempo vado continuamente oltre me stesso. Questo andare oltre se stessi non è una negazione della mia essenza, come pensano gli esistenzialisti, è la sua formazione e allo stesso tempo la realizzazione della mia essenza; non negazione di sé e divenire, ma divenire e realizzazione…. La mia azione in un certo senso mi nega, ma in un altro mi trasforma, mi rivela e mi realizza”. L'approccio esistenziale è abbastanza vicino, secondo me, alle idee sviluppate da Leontyev, Brushlinsky, Rubinstein, Ananyev. Uno dei concetti chiave della psicologia e della filosofia esistenziale è il concetto di responsabilità: per la propria vita e il proprio destino, nonché per la vita e il destino di tutta l’umanità. J.-P. Sartre nella sua opera “L'esistenzialismo è umanesimo” scrive che la filosofia esistenziale è la più ottimista: non parla di alcuna predeterminazione iniziale delle azioni umane - né biologica né sociale, ma, al contrario, sottolinea che l'uomo sceglie il proprio destino, crea la tua vita e influenza anche la vita dell’intera società. L'esistenza precede l'essenza: una persona "prima esiste, incontra, appare nel mondo e solo allora è determinata"
L'approccio umanistico, come sappiamo, differisce dall'approccio esistenziale per il presupposto che l'essenza precede ancora l'esistenza - che ogni persona è bella per natura e il suo compito è realizzare questo potenziale inizialmente dato. Carl Rogers nei suoi libri sottolinea che la caratteristica principale di una "buona vita" dal punto di vista di uno psicoterapeuta è l'inclusione di una persona in essa nel presente, il sentimento di essa come un processo, e non uno "stato di essendo." Ha anche sottolineato l'aumento soggettivo dei gradi di libertà e, di conseguenza, l'emergere della creatività. È anche importante notare qui la funzione psicoterapeutica del coinvolgimento: come stato di concentrazione sul presente, consente di scartare per un po 'pensieri ed esperienze irrilevanti - di conseguenza, quindi, lasciando questo stato e ricordandoli di nuovo, una persona ha l'opportunità di ristrutturare la situazione; e anche la focalizzazione sull'attività stessa richiede una certa fiducia in se stessi, e l'esperienza di tale fiducia, a sua volta, può essere estrapolata ad altri ambiti della vita.
Nata da un approccio umanistico, la psicologia positiva è caratterizzata dal fatto che i suoi rappresentanti cercano di rispondere alla domanda su cosa rende felice una persona, a differenza di molte aree che studiano ciò che rende una persona infelice. Di conseguenza, nell'ambito di questo approccio, vengono sviluppati concetti come felicità (M. Argyle), ottimismo (M. Seligman), nonché lo stato di flusso già descritto secondo Csikszentmihalyi.
Menzioniamo qui questa direzione della moderna psicologia occidentale perché è ideologicamente vicina alla ricerca di risposte alle domande che hanno dato slancio alla stesura di quest'opera.
Conclusioni sul primo capitolo.
In questo lavoro per impegno intendiamo lo stato del flusso nel senso ampio del termine secondo Csikszentmihalyi. Cioè, il coinvolgimento è uno stato mentale che sorge nel processo di attività vigorosa ed è caratterizzato da una fusione di azione e consapevolezza, concentrandosi su un campo limitato di stimoli, un senso di competenza e piacere dal processo di attività.
Dalla definizione di coinvolgimento come stato mentale, ne consegue che 2 gruppi di fattori possono influenzare il suo verificarsi: personale e situazionale, e anche che lo studio del coinvolgimento può essere effettuato utilizzando metodi oggettivi e soggettivi.
Consideriamo lo stato di coinvolgimento come il risultato di uno spostamento della motivazione verso l'obiettivo nel concetto di A.N. Leontiev o come concetto di motivazione intensa secondo Heckhausen, nonché come tipo di attenzione post-volontaria.
L'impegno come tratto della personalità lo è la proprietà più importante l'uomo come soggetto della vita.
2. Procedura e metodi della ricerca
Studio dei fattori che contribuiscono all'emergere di uno stato di coinvolgimento nelle attività educative
Oggetto di studio: studenti che studiano danza e studenti universitari.
Oggetto della ricerca: stato di coinvolgimento
Ipotesi di ricerca.
Principali ipotesi.
Esiste una relazione tra gli indicatori dello stato funzionale prima e durante la lezione e la gravità del coinvolgimento nelle attività educative.
. Il “desiderio di lavorare” e la “soddisfazione per la fase passata” sono interconnessi con la gravità del coinvolgimento nelle attività educative.
Gli indicatori di significato e gli orientamenti di vita sono interconnessi con la gravità del coinvolgimento
Ipotesi particolari.
Esiste una relazione tra la dinamica del coinvolgimento e la dinamica della performance.
Esiste una relazione tra le azioni dell’insegnante e il coinvolgimento degli studenti
Il tasso di coinvolgimento dei soggetti field-indipendenti è in media superiore a quello dei soggetti field-dependent.
Gli obiettivi della ricerca:
Considera lo stato attuale del problema del coinvolgimento nella psicologia nazionale e straniera
2.Studiare i fattori situazionali e personali che contribuiscono all'emergere di uno stato di coinvolgimento nelle attività educative
3.Determinare le modalità per valutare lo stato di coinvolgimento nelle attività di apprendimento
.Identificare le differenze tra gli indicatori di coinvolgimento soggettivo nelle attività educative degli studenti e degli studenti di danza
2.1 Campione di studio
Il campione di studio era composto da 27 persone che studiavano in studi di ballo da sala e solisti latini, tra cui 8 giovani e 19 ragazze, età media 22,3 anni, istruzione - istruzione superiore o incompleta.
Va notato che ci sono alcune specificità della formazione di ballo in questi due gruppi: ballo liscio in coppia, quindi la squadra è mista per genere (8 ragazzi e 8 ragazze hanno preso parte a questo studio), solista latino, come suggerisce il nome, si balla da sole e con un team prettamente femminile (in questo caso, 11 ragazze). Questo, ovviamente, determina una motivazione specifica dei partecipanti. Tuttavia, il numero di studenti in gruppi è troppo piccolo per studiarli separatamente, quindi in questo studio abbiamo deciso di trascurare alcune caratteristiche dell'insegnamento delle danze in coppia e in solista.
Il campione comparativo era composto da studenti del secondo anno della Facoltà di Biologia e Scienze del Suolo dell'Università Statale di San Pietroburgo, venuti ad una lezione di psicologia. Il campione era composto da 61 persone, tra cui 20 ragazzi e 41 ragazze, l'età media era di 19,5 anni.
2.2 Metodi di ricerca
La tecnica del "Termometro", autore Yu. Kiselev (utilizzata per valutare lo stato funzionale durante una lezione - sottoscale "Stato", "Attività", "Umore" - e per studiare il fattore "atteggiamento situazionale verso l'attività", sottoscale "Desiderio di lavoro" e "Soddisfazione per la fase passata")
Scheda di prova per la valutazione differenziale dello stato funzionale, autori V.A. Doskin, N.A. Lavrentieva, V.B. Sharai e M.P. Mirošnikov. (utilizzato per valutare lo stato funzionale ad inizio lezione)
Metodologia degli orientamenti di vita significativi, autore: D.A. Leontiev (utilizzato per studiare il significato e gli orientamenti di vita dei soggetti, comprende le sottoscale “Obiettivi nella vita”, “Processo di vita”, “Efficacia della vita”, “Locus of Control-I”, “Locus of Control-Life”, integrale indicatore “Significato della vita”")
La tecnica delle "figure nascoste" di Thurstone (utilizzata per determinare lo stile cognitivo "dipendenza dal campo/indipendenza dal campo")
Metodo di osservazione standardizzato (utilizzato per valutazione oggettiva stato di coinvolgimento nelle attività di apprendimento)
Metodo di intervista standardizzato (utilizzato per identificare la motivazione, nonché i fattori che soggettivamente influenzano l'emergere di uno stato di coinvolgimento)
2.3 Procedura di studio
Per condurre questo studio è stato sviluppato un questionario originale volto a misurare lo stato di coinvolgimento, inteso sulla base dell'approccio di M. Csikszentmihalyi. Il questionario è composto da 5 domande chiuse, una delle quali è associata alla componente cognitiva del coinvolgimento, una alla componente emotiva e tre scoprono come soggettivamente sono soddisfatte le condizioni per l'emergere del coinvolgimento: obiettivi chiari, complessità ottimale del compito , la presenza di feedback.
Per testare il funzionamento del questionario è stato prima condotto uno studio pilota, sono state apportate alcune modifiche, dopodiché ha preso la sua forma definitiva.
La parte principale della ricerca si è svolta presso l'Università statale di San Pietroburgo “Casa della gioventù del distretto di Primorsky” nello studio di ballo da sala e solista latino, dove l'autore di questo diploma è l'insegnante.
Lo studio si è svolto durante due lezioni regolari per ciascuno dei due gruppi. All'inizio della lezione gli studenti hanno compilato una mappa degli stati funzionali. Tre volte durante la lezione, tutti, al segnale dell'insegnante (il segnale è stato dato a intervalli di tempo approssimativamente uguali), hanno compilato il questionario dell'autore e la tecnica del “Termometro” (questo ha richiesto circa un minuto di tempo, il che ha reso possibile possibile non disturbare troppo il corso della lezione). Durante la compilazione di questi metodi, agli intervistati sono state fornite istruzioni chiare per lasciarsi guidare dal loro stato al momento della richiesta di compilazione del questionario.
Durante le lezioni era presente anche un osservatore che ha condotto osservazioni standardizzate e fornito una valutazione esperta del coinvolgimento degli studenti. Per fare ciò, ogni minuto registrava lo stato di ogni studente e le azioni dell'insegnante.
Sono state individuate 7 categorie di azioni dell'insegnante: “dà un compito a tutti”, “dà un compito a qualcuno in particolare”, “dà feedback a tutti”, “dà feedback a qualcuno in particolare”, “osserva tutti”, “osserva qualcuno in particolare", "occupata con i suoi affari". Le condizioni degli studenti rientravano in una delle quattro categorie: on; non incluso: “congelamento” (guardare “nello spazio”, mancanza di movimento, ecc.); non compreso: attività estranea (conversazione, giocherellare con il telefono, guardarsi allo specchio); non incluso: completamento automatico dell'attività (movimenti lenti, sguardo assente).
Criteri per l'inclusione degli studenti: concentrazione (sguardo concentrato, espressioni facciali come espressione di lavoro interno - non rivolto alle persone); attività (movimenti energetici\parlare al punto).
Dopo aver completato la parte principale dello studio, i partecipanti hanno completato la tecnica Thurstone e il test SJO di Leontiev, e gli intervistati con i livelli di impegno più alto e più basso in media, dopo diverse lezioni, hanno preso parte a una breve intervista standardizzata volta a scoprire la loro motivazione educativa e il loro proprie idee sui fattori che aiutano/ostacolano il coinvolgimento nelle classi.
- Perché/perché balli?
- Cosa ti aiuta a partecipare alle tue lezioni di danza e cosa ti ostacola?
- Cosa si può fare, secondo te, per rendere le lezioni _più efficaci per te_?
I ragazzi hanno risposto alle domande per iscritto.
Inoltre, è stato condotto uno studio sul coinvolgimento nelle attività educative degli studenti del secondo anno della Facoltà di Biologia e Scienze del Suolo dell'Università Statale di San Pietroburgo (anche durante la sessione di lezione, che si è tenuta presso il ruscello, l'insegnante tre volte è stato chiesto agli studenti di compilare il questionario dell'autore sul coinvolgimento nelle attività didattiche).
2.4 Metodi matematici e statistici di elaborazione dei dati
Criterio di Kolmagorov-Smirnov
Utilizzato per testare la normalità della distribuzione
Coefficiente di correlazione di Pearson
Utilizzato per calcolare le correlazioni tra indicatori presentati su una scala metrica.
Coefficiente di correlazione di Spearman.
Utilizzato per calcolare le correlazioni tra gli indicatori presentati nella scala di classificazione.
.5 Fattori di coinvolgimento
Fattori situazionali.
Stato funzionale all'inizio della lezione.
È costituito da tre componenti: stato, attività, umore. La condizione comporta una valutazione della salute fisica, del livello di veglia/sonnolenza, di stanchezza fisica e psicologica. Partiamo dal presupposto che questo sia un fattore essenziale, poiché lo stato mentale e fisico rappresenta la base su cui hanno luogo tutti gli altri processi.
L’attività implica uno stato di disponibilità/impreparazione a svolgere le proprie attività. È un indicatore importante perché il coinvolgimento è uno stato possibile solo con l'azione attiva del soggetto.
L'indicatore “umore” comprende lo stato emotivo del soggetto in questo momento. L'umore deve essere preso in considerazione durante l'analisi, poiché lo stato emotivo è uno sfondo necessario della vita mentale e influenza tutti i processi che si verificano nella psiche.
Stato, attività, umore sono indicatori strettamente correlati ed è spesso difficile isolare l'influenza di uno solo di essi. Pertanto, chiameremo fattore di coinvolgimento uno stato funzionale che includa tutti e 3 questi componenti.
2.Stato funzionale durante la lezione.
Include anche indicatori di condizione, attività e umore, misurati utilizzando la tecnica del "termometro".
3.Atteggiamento verso l'attività.
Include 2 indicatori del metodo "Termometro": "Desiderio di lavorare" e "Soddisfazione per la fase passata". Partiamo dal presupposto che il primo indicatore sia molto significativo nell'emergere di uno stato di coinvolgimento, necessario, anche se non sufficiente, perché una persona senza voglia di lavorare, quando deve farlo, solitamente non mostra attività e non prova gioia . Per quanto riguarda il secondo indicatore, è necessario sottolineare la natura biunivoca della possibile relazione: da un lato, la soddisfazione per la fase passata può essere una conseguenza del coinvolgimento, ma, dall'altro, se una persona è soddisfatta con quanto già fatto, sarà più disponibile ad affrontare la parte successiva (anche se esistono anche casi opposti), quindi, con più probabilmente saranno coinvolti nell'attività.
4.Attività di un insegnante.
Partiamo dal presupposto che varie azioni dell'insegnante durante una lezione possano influenzare il livello di coinvolgimento del gruppo. Riteniamo che articolare obiettivi chiari, stabilire compiti di difficoltà ottimale e fornire feedback rapidi promuova un maggiore coinvolgimento del gruppo, mentre l’assenza di una o più di queste condizioni lo ostacola. Abbiamo anche identificato diverse categorie di azioni dell'insegnante durante una lezione e prevediamo di correlarle con lo stato di coinvolgimento del gruppo.
5.Dinamica della prestazione.
Partiamo dal presupposto che durante la lezione ci sia una certa dinamica di alti e bassi di impegno associata al work in progress e alla fatica.
Fattori personali.
- Indicatori misurati attraverso il Questionario sul significato e gli orientamenti di vita.
Questionario D.A. Leontiev comprende 5 sottoscale e un indicatore integrale del significato della vita.
Sottoscale: "Obiettivi nella vita" - caratterizza se il soggetto ha obiettivi nella vita e una prospettiva temporale.
Il “processo vitale” è la tendenza del soggetto a godersi la vita nel presente. Questa sottoscala ci sembra particolarmente importante per questo studio, poiché essere nel presente è una delle principali caratteristiche del coinvolgimento)
L’“efficacia della vita” è il grado di soddisfazione per l’attuale fase della vita.
"Locus of control-self" - caratterizza la tendenza ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e dei propri stati, piuttosto che attribuirla all'ambiente (la proprietà misurata ha un significato vicino ai concetti di internalità e luogo di controllo interno). che si tratta di un fattore significativo che influenza in modo stabile una manifestazione di coinvolgimento, perché le persone interne sono solitamente più attive nell'interagire con la situazione, poiché credono che dipenda di più da loro. Gli esterni, al contrario, si affidano maggiormente alla volontà dell'ambiente e del destino; accettano passivamente la maggior parte delle loro manifestazioni, senza cercare di cambiare o ristrutturare.
“Locus of control – life” – riflette la convinzione del soggetto nella capacità fondamentale di controllare il proprio destino.
La “significatività della vita” è un indicatore che riflette il livello generale di coerenza nella vita, la capacità di vivere nel presente, fissare obiettivi per il futuro e il senso di capacità di controllare il proprio destino. Si presuppone che le persone con un maggiore senso di significato nella vita abbiano una comprensione più riflessiva dei propri obiettivi e significati, quindi sappiano meglio cosa stanno facendo e perché; di conseguenza, se sono venuti per imparare a ballare, allora capiscono meglio delle persone con punteggi bassi i motivi che li hanno spinti a farlo, e quindi sono più capaci di lottare per i propri obiettivi.
- Stile cognitivo “Dipendenza dal campo-indipendenza dal campo”
Lo stile cognitivo è una preferenza cognitiva stabile caratteristica di un dato individuo, manifestata nell'uso predominante di determinati metodi di elaborazione delle informazioni, quelli che corrispondono più da vicino alle capacità e inclinazioni psicologiche della persona.
Dipendenza/indipendenza dal campo: la capacità di superare un contesto complesso.
Partiamo dal presupposto che lo stile cognitivo di un individuo, dipendenza/indipendenza dal campo, influenza l'emergere di uno stato di coinvolgimento, poiché per identificare compiti di un certo livello di complessità in una situazione, rilevare feedback e fissare obiettivi significativi individualmente, è necessario spesso è necessario ristrutturare la situazione. Tuttavia, l'influenza della dipendenza/indipendenza dal campo è piuttosto ambigua, poiché per l'intervistato è puramente individuale quella che è una figura che isola dallo sfondo con diversi gradi di successo.
- Motivazione per l'apprendimento.
Viene studiato utilizzando il metodo dell'intervista standardizzata.
Abbiamo considerato le questioni relative alle specificità della motivazione educativa nel primo capitolo. Qui possiamo solo sottolineare ancora una volta che le questioni relative alla motivazione sono intrecciate e indissolubilmente legate a tutti i fattori personali di coinvolgimento.
3. Risultati della ricerca empirica
3.1 Principali risultati
Il coinvolgimento in attività educative tra gli studenti di danza è stato del 61%, tra gli studenti di biologia - 24%.
Una differenza così significativa nel livello di coinvolgimento può essere spiegata con i seguenti motivi: secondo l'approccio Csikszentmihalyi da noi adottato, il coinvolgimento è inteso come gioioso assorbimento in un'attività, cioè, parlando nei termini di A.N. Leontyev, c'è uno spostamento delle motivazioni verso il gol. In altre parole, lo stato di coinvolgimento nel nostro approccio è caratterizzato dal trarre piacere principalmente dall'attività stessa e non dai suoi risultati. E tutti gli intervistati del campione di danza parlano di questa motivazione. Per quanto riguarda gli studenti di biologia, per loro il corso di psicologia è di formazione generale, cioè non legato ai loro interessi professionali, ma la frequenza è obbligatoria; Quindi, molto probabilmente, la loro motivazione è esterna e legata all'ottenimento di crediti e all'assenza di sanzioni disciplinari, e non al vero piacere di studiare la materia. Inoltre, durante la lezione di psicologia, durante la quale è stata svolta la ricerca, gli studenti erano impegnati a compilare ed elaborare metodi psicologici, che di per sé, senza investire ulteriore significato, è (soprattutto l'elaborazione) un lavoro piuttosto meccanico.
Il rapporto tra indicatori di coinvolgimento soggettivo e oggettivo.
I valori medi del coinvolgimento soggettivo e oggettivo sono rispettivamente 0,61 e 0,67. Correlazione r=0,5, p=0,05
Va notato che poiché il metodo principale per misurare il coinvolgimento soggettivo era il questionario dell’autore, era importante per noi garantirne una validità sufficiente. Pertanto, oltre al metodo già descritto di misurazione del coinvolgimento soggettivo e oggettivo in due delle quattro classi, abbiamo chiesto ai soggetti, dopo aver compilato i questionari, di stimare in percentuale il loro coinvolgimento nell'ultimo periodo della lezione (in contrapposizione a al questionario, che valutava al momento il coinvolgimento), contestualmente al coinvolgimento degli intervistati di ciascuno di loro, sono stati valutati nel tempo da 2 esperti. Anche in questo caso è stata ottenuta una valutazione soggettiva e oggettiva del coinvolgimento (è stato preso il valore medio dell'opinione degli esperti). Oltre a verificare la validità del questionario (la correlazione tra la valutazione soggettiva del coinvolgimento degli intervistati in percentuale e quella ottenuta utilizzando il questionario è stata pari a 0,4), abbiamo ottenuto un risultato interessante: considerando il loro coinvolgimento nel tempo, gli intervistati lo hanno valutato significativamente più alti rispetto agli esperti (rispettivamente in media 86% e 68%). Dato che la valutazione degli esperti è più vicina agli indicatori ottenuti utilizzando gli altri due metodi di misurazione, concludiamo che gli intervistati hanno sovrastimato il loro coinvolgimento nella lezione in retrospettiva. Ci conferma inoltre che utilizzare un questionario era una soluzione migliore per i nostri scopi rispetto a porre una domanda diretta.
È inoltre necessario commentare il fatto che la valutazione oggettiva e soggettiva selezionata dell'impegno non sono identiche, sebbene siano correlate tra loro. Ciò è facile da spiegare considerando il flusso come uno stato mentale: in particolare, N.D. Levitov ha scritto che lo stato mentale di una persona non può essere adeguatamente valutato senza l’uso dell’autovalutazione, poiché le stesse manifestazioni possono indicare stati diversi; l’insufficienza delle sole auto-valutazioni è dovuta, ad esempio, a diversi livelli di riflessività degli intervistati, a fattori di desiderabilità sociale, ecc. Il fatto che l'engagement medio del gruppo, misurato con metodi diversi, sia risultato pressoché identico, è una prova indiretta a favore del fatto che entrambi i metodi hanno misurato lo stesso fenomeno.
Il rapporto tra gli indicatori dello stato funzionale all'inizio della lezione e quelli ottenuti durante la lezione con gli indicatori di coinvolgimento soggettivo.
Non è stata riscontrata alcuna correlazione statisticamente significativa tra gli indicatori “Stato”, “Attività”, “Umore” ottenuti all'inizio della lezione e gli indicatori di coinvolgimento soggettivo.
Questi risultati non confermano l'ipotesi formulata prima dell'inizio dello studio circa la relazione tra indicatori di stato funzionale e indicatori di coinvolgimento nelle attività educative. Tuttavia, in questo caso, a nostro avviso, il rifiuto dell'ipotesi è un risultato più interessante della sua conferma. Dopotutto, risulta che non è stata riscontrata alcuna influenza sull'emergere del coinvolgimento dallo stato iniziale dell'individuo che è venuto in classe; lo stato funzionale è uno dei fattori situazionali considerati nel lavoro e, in base alla deviazione della sua influenza, possiamo assumere un maggiore contributo all'emergere del coinvolgimento di altri fattori, compresi quelli personali.
La relazione tra gli indicatori delle scale “Desiderio di lavorare” e “Soddisfazione per la fase passata” della metodologia “Termometro” con indicatori di coinvolgimento soggettivo.
È stata riscontrata una relazione statisticamente significativa tra gli indicatori “Desiderio di lavorare” e coinvolgimento soggettivo r=0,5, p=0,05, e tra gli indicatori “Soddisfazione per la fase passata” e coinvolgimento soggettivo r=0,6, p=0,01.
Riteniamo che questo risultato sia importante, soprattutto tenendo conto, come sopra descritto, della mancanza di una relazione statisticamente significativa tra indicatori di coinvolgimento soggettivo e stato funzionale. Sulla base del confronto di questi risultati, nonché dell'analisi dei dati qualitativi, che verranno forniti di seguito, possiamo ipotizzare una maggiore influenza dei fattori motivazionali e dei fattori associati all'autoregolazione volitiva sull'emergere del coinvolgimento personale.
La relazione tra la dinamica degli indicatori medi di coinvolgimento del gruppo e le idee teoriche sulla dinamica della performance.
Utilizzando una valutazione oggettiva del coinvolgimento, è stata rilevata la dinamica complessiva del livello di coinvolgimento del gruppo durante la lezione.
Qui l'ascissa mostra il tempo (in minuti dall'inizio della lezione), l'asse y mostra la quota di coinvolgimento del gruppo (0 - nessuno è coinvolto, 1 - tutti sono coinvolti), il blu indica coinvolgimento, il rosa indica dispersione. Il grafico è stato ottenuto sulla base dei dati di una lezione di un gruppo di ballo da sala, ma è tipico per tutte le classi di entrambi i gruppi; la distribuzione dei risultati è uniforme.
Questo tipo di curva, con un aumento all'inizio, un calo alla fine e due plateau, il primo dei quali è più lungo e più alto, è caratteristico di tutte e quattro le attività. L'aspetto di tale curva è, in generale, simile alla nota curva di prestazione, il che indica indirettamente l'adeguatezza di tale metodo di misurazione.
Nei momenti di calo del coinvolgimento complessivo si osserva un aumento della dispersione: ciò significa che il gruppo non si stacca del tutto dal lavoro, ma una parte di esso continua l'attività.
La relazione tra azioni dell’insegnante e coinvolgimento degli studenti.
Sulla base dell'analisi delle dinamiche di gruppo, sono state individuate le relazioni tra le azioni dell'insegnante e il coinvolgimento degli studenti.
Tutte le azioni dell'insegnante sono state registrate e divise dall'osservatore in 7 gruppi: 1 - “dà un compito a tutti”, 2 - “dà un compito a qualcuno in particolare”, 3 - “dà un feedback a un gruppo”, 4 - "dà feedback a qualcuno in particolare", 5 - "guarda il gruppo", 6 - "guarda qualcuno in particolare", 7 - "occupato con i suoi affari". Queste azioni dell'insegnante possono essere suddivise in 3 gruppi: quelle rivolte al gruppo, quelle rivolte ai singoli individui e quelle rivolte ad attività estranee allo svolgimento della lezione.
Va detto che quando si registrano le azioni dell’insegnante una volta al minuto, gran parte di ciò che riguarda il lavoro individuale non viene preso in considerazione, poiché richiede molto meno tempo.
-In totale, il tempo di osservazione è stato di 301 minuti (2 gruppi di 2 sessioni). Il livello medio di coinvolgimento degli studenti è del 67%.
-Tra le azioni dell'insegnante, la maggior parte del tempo di lezione - 39% - è stata l'osservazione del compito (38% - per l'intero gruppo, 1% - per qualcuno in particolare) 36% - spiegazione del compito e dimostrazione della corretta esecuzione del compito esercizi (31% - per l'intero gruppo, 5% - individualmente), 21% - fornire feedback (15% - a tutto il gruppo, 6% - individualmente) e il 4% delle volte - attività non finalizzata allo svolgimento di una lezione ( ad esempio, l'installazione delle attrezzature)
-I tassi più alti di coinvolgimento medio del gruppo sono stati registrati quando l'insegnante ha osservato il gruppo e gli individui che completavano il compito (rispettivamente 75% e 72%). È curioso che focalizzare l’attenzione su qualcuno in particolare non abbia influenzato sostanzialmente il grado di coinvolgimento nel lavoro del gruppo.
-Il coinvolgimento medio del gruppo più basso è stato osservato, il che è naturale, nei momenti in cui l'insegnante era distratto dall'insegnamento della lezione - 48%. Si può notare che non è fondamentalmente diverso dal coinvolgimento di gruppo, ad esempio quando si riceve feedback da un gruppo (51%) o da qualcuno in particolare (53%). Tuttavia, dietro l’indicatore di coinvolgimento nel momento della distrazione dell’insegnante si nasconde una realtà leggermente diversa: in questi momenti il gruppo “ha preso una decisione” nel suo insieme: in circa la metà dei casi, quasi tutto il gruppo ha preso una pausa, oppure, al contrario, ha continuato a lavorare. Questa decisione è stata influenzata da fattori come il momento della lezione - all'inizio o alla fine, cioè l'affaticamento generale, o da cosa esattamente era distratto l'insegnante, o quanto fosse interessante il compito su cui si stava lavorando in quel momento era.
La relazione tra indicatori oggettivi del partner e coinvolgimento del partner nella formazione di danza
Nei balli di coppia è stata trovata una relazione tra gli indicatori di coinvolgimento nell'attività del partner e del partner.
Un metodo oggettivo di registrazione del coinvolgimento ci ha permesso di ottenere dati sul coinvolgimento o disimpegno di ciascuna persona in ogni minuto della sessione. Abbiamo confrontato la presenza di coinvolgimento durante l'intera lezione per il partner e il partner, quindi abbiamo confrontato la proporzione risultante di corrispondenze di stato con la proporzione di corrispondenze di condizione in tutte le altre coppie di casi.
Si è scoperto che la frequenza delle corrispondenze di condizioni (vale a dire, coinvolgimento/disimpegno congiunto) in una coppia era superiore alla frequenza delle corrispondenze in coppie casuali. Tuttavia, questi risultati, a causa del loro numero limitato, non ci consentono di trarre una conclusione statisticamente significativa e sono offerti a livello di trend.
- Valori medi di coinvolgimento nelle attività formative dei singoli intervistati.
Analizzando i risultati, è stata confermata l'ipotesi che non solo gli indicatori medi di coinvolgimento del gruppo variano in determinati momenti della lezione, ma esiste anche un indicatore medio di coinvolgimento di un singolo intervistato durante l'intera lezione. Se misurato mediante l'osservazione (un metodo oggettivo), il coinvolgimento medio degli individui durante la sessione variava dal 40 all'80% e secondo l'autovalutazione dal 7 al 100%. Il metodo self-report, in questo caso, dà risultati più approssimativi, perché le misurazioni, a differenza del metodo oggettivo, non sono state effettuate durante l'intera sessione, ma solo tre volte durante una sessione di allenamento. La differenza di valori si spiega con il fatto che la misura oggettiva può essere classificata come scala assoluta, mentre la misura soggettiva può essere classificata come scala ad intervalli.
- La relazione tra indicatori di coinvolgimento soggettivo e indicatori della metodologia LSS D.A. Leontyev.
Sono state identificate relazioni statisticamente significative (tutte al livello di significatività p = 0,05, coefficiente di correlazione di Spearman) tra gli indicatori medi di coinvolgimento soggettivo su un numero di classi e le seguenti scale della metodologia:
“Processo vitale” p=0,6
“Locus of control-I” p=0,5
“Significato della vita” p=0,5
Abbiamo più volte notato l'importanza di una tale proprietà dello stato di coinvolgimento come concentrazione dell'attenzione del soggetto sui processi che si verificano nel momento presente. Tuttavia, l'indicatore sulla scala "Processo di vita" non riflette lo stato, ma l'orientamento dell'individuo verso la vita nel presente, "qui e ora", cioè un orientamento personale verso il piacere derivante dal processo di vita. La relazione tra l'indicatore medio del coinvolgimento soggettivo (cioè un indicatore di uno stato mentale manifestato relativamente stabilmente) e l'atteggiamento della personalità ci riporta alla conversazione sulla posizione intermedia degli stati mentali nella struttura della personalità e sulla possibilità di influenzare attraverso su manifestazioni individuali più stabili.
Abbiamo fornito la logica della possibilità di una relazione tra il coinvolgimento e le scale “Locus-I” e “Significatività della vita” in dettaglio nel secondo capitolo, quindi lasceremo questi commenti per la discussione dei risultati. L'indicatore "Produttività della vita" è associato alla soddisfazione derivante dalla parte passata del percorso di vita e la sua relazione con l'indicatore di coinvolgimento può essere dovuta al fatto che le persone che sperimentano costantemente questo stato, in primo luogo, sono più soddisfatte della propria vita, poiché ne traggono più piacere e, in secondo luogo, poiché lo stato di coinvolgimento è solitamente accompagnato da un aumento della produttività, è possibile che le persone effettivamente “riescano a fare di più” rispetto a coloro che sperimentano raramente lo stato di coinvolgimento.
- La relazione tra un livello più elevato di indipendenza dal campo e altro ancora alte prestazioni coinvolgimento.
Non è stata trovata alcuna relazione statisticamente significativa tra gli indicatori di coinvolgimento soggettivo e la dipendenza dal campo-indipendenza dal campo.
Secondo me, motivo principale Ecco che per una corretta comprensione del lavoro dello stile cognitivo nell'aspetto dell'insegnamento della danza, è importante capire cosa distingue una determinata materia dal campo, qual è una figura per ciascuna e qual è il contesto. Questo ci reindirizza alla questione della motivazione per la formazione: intendo dire che per una persona che cerca di migliorare la tecnologia e una persona che è arrivata a comunicare con il sesso opposto, gli aspetti chiave e di fondo sono completamente diversi.
Pertanto, sebbene l'ipotesi non sia stata confermata statisticamente, sulla base dell'analisi delle risposte dei soggetti alle domande dell'intervista, sono state scoperte alcune differenze interessanti tra le risposte degli intervistati field-dependent e field-independent.
I dipendenti e gli indipendenti del campo differiscono in ciò che impedisce loro di raggiungere i propri obiettivi. I soggetti dipendenti dal campo, in un modo o nell'altro, come fattore di interferenza, evidenziano principalmente l'atmosfera, cioè ciò che viene creato dall'ambiente: per alcuni è la mancanza di autoritarismo dell'insegnante (“costringendoli a lavorare sodo”), per per altri è soggettivamente amichevole o ostile l'umore della squadra, per alcuni l'umore non lavorativo di coloro che li circondano. I soggetti indipendenti dal campo, indipendentemente dal proprio coinvolgimento/discoinvolgimento, rispondono alla domanda su cosa impedisce loro di impegnarsi nel lavoro – cosa che, in generale, nulla glielo impedisce. Inoltre, in risposta alla terza domanda, gli indipendenti del settore non coinvolti parlano di fattori che potrebbero aiutarli, mentre quelli coinvolti qui dicono anche che, secondo loro, è già abbastanza efficace.
Pertanto, a nostro avviso, l’ipotesi sulla relazione tra stile cognitivo e coinvolgimento può essere riformulata per condurre uno studio più sfumato.
Analisi dell'intervista.
Innanzitutto, facciamo un'analisi generale dei dati ottenuti, per poi concentrarci sui singoli casi.
Nelle risposte degli intervistati è stato evidenziato tutta la linea vari motivi per ballare: piacere dal processo di danza, piacere dall'ascoltare e muoversi al ritmo della tua musica preferita, piacere estetico; mantenimento della forma fisica, comunicazione (con gli amici o con il sesso opposto), distrazione dai problemi della vita, “mostrarsi” (desiderio di essere al centro dell'attenzione, esibirsi in pubblico), miglioramento nella danza e nell'espressione di sé.
Il motivo più comune era trarre piacere dal processo di danza stesso, che di per sé contribuisce all'emergere di uno stato di coinvolgimento, poiché l'attenzione al processo è una delle condizioni necessarie per esso; inoltre molto spesso (nella metà dei casi) si incontra il motivo “fuggire dai problemi della vita”: anche questo parla del desiderio di immergersi nel momento presente, perché in questo caso ci riferiamo proprio ai problemi della vita il passato o il futuro che sono fuori dalla porta della sala. È interessante notare che il motivo “mantenere la forma fisica” è stato riscontrato soprattutto tra coloro che erano costantemente non coinvolti, e il motivo "espressione di se"solo per coloro che sono costantemente coinvolti (anche se non per tutti).
Nella risposta alla seconda domanda sono stati citati come fattori di aiuto: la musica, il proprio buon umore, l'atmosfera nella squadra (per alcuni è importante la cordialità, per altri l'umore per una causa comune), così come il tempo, vestiti eleganti, novità in classe. Come interferente - proprio brutta sensazione, umore, atmosfera nella squadra (ostile o non lavorativa).
È interessante notare che il benessere appare esclusivamente come un fattore interferente; Risulta che lo stato fisico nel caso generale può essere considerato una condizione necessaria, ma non sufficiente.
Le risposte alla domanda su cosa potrebbe aumentare l'efficacia della lezione si sono rivelate molto individuali e, a mio avviso, non ha senso considerarle separatamente dalle risposte dell'intervistato ad altre domande; Passiamo quindi all’analisi dei singoli casi.
Da un punto di vista pratico, cioè sia come ricercatore che come insegnante che conduce lezioni con queste persone, mi sembra più importante considerare casi di coinvolgimento stabile e basso.
Ne darò 3. Nella prima, l'intervistato cita come obiettivi delle lezioni un migliore benessere (emotivo e fisico) e il “mostrarsi” (partecipando a concerti o feste). Cita un maggiore autoritarismo dell’insegnante (“costringere le persone a lavorare”) e un maggiore feedback come cose che possono aumentare l’efficienza.
Il locus of control esterno è qui evidente (il che è confermato dagli indicatori che utilizzano il metodo LSS). Inoltre, vediamo che soggettivamente non è soddisfatta una delle condizioni necessarie affinché si verifichi il coinvolgimento: ricevere un feedback rapido.
Un altro intervistato cita come motivazioni il piacere derivante dal processo di danza e di auto-miglioramento; i problemi fuori dalla sala da ballo le impediscono di impegnarsi nel lavoro, e aumentare la complessità dei compiti potrebbe aumentare la sua efficienza (parla di analizzare sfumature tecniche, imparando nuovi movimenti e nuove danze).
Qui è necessario fare una prenotazione che tra tutti gli studenti in studio, questo intervistato ha la più grande “esperienza” di danza; quindi, si scopre che i compiti che sono piuttosto difficili e interessanti per gli altri non lo sono per lei.
Vorrei anche attirare l'attenzione sul mancato rispetto soggettivo di un'altra condizione per l'emergere del coinvolgimento: la complessità non ottimale del compito.
E infine, nella risposta del terzo intervistato, come motivo dell'esercizio si può identificare una componente “sportiva”: cioè, è importante raggiungere un risultato: la competizione, “essere migliore di qualcuno”. Vorrebbe gareggiare in gare di ballo liscio o partecipare a concerti dove possa anche mettersi in mostra. Suggerisce la definizione degli obiettivi come fattore per migliorare le sue prestazioni (ad esempio, frequentare un corso di danza era un incentivo sufficiente per migliorare).
È importante notare 2 punti qui. In primo luogo, l'assenza di un'altra condizione necessaria per l'emergere del coinvolgimento: obiettivi chiari.
E in secondo luogo, qui osserviamo una motivazione estrinseca pronunciata - motivazione mirata non al processo, ma a obiettivi esterni ad esso, che in questo caso possono essere generalizzati condizionatamente come riconoscimento.
Per non ignorare del tutto i casi di coinvolgimento stabile, li riassumerò brevemente. Nella risposta della maggior parte degli intervistati si può notare che pongono l'attività di danza in una delle posizioni di rilievo nella gerarchia delle attività (“Ballo perché questa è la vita per me. Se non balli, le tue gambe sono sprecato =)”). Ciò indica una forte motivazione all’esercizio. Gli intervistati costantemente coinvolti, proprio come tutti gli altri, potrebbero avere alcuni ostacoli nel raggiungere il coinvolgimento; citano anche fattori che potrebbero rendere le lezioni più efficaci per loro. Ma nelle loro risposte, tutte le caratteristiche negative passano in secondo piano: il livello di motivazione è sufficiente per poter ristrutturare la situazione per se stessi in una più coerente con gli obiettivi personali.
3.2 Discussione dei risultati
Lo studio empirico ha quindi prodotto alcuni risultati inaspettati ai quali vorremmo prestare maggiore attenzione. Intendo innanzitutto l'assenza di relazioni significative tra indicatori di coinvolgimento soggettivo e indicatori di stato funzionale. Questi dati quantitativi sono confermati anche dai dati delle interviste: la condizione fisica è menzionata solo come fattore di disturbo (problemi di salute), e solo in pochi soggetti; tuttavia, circa la metà dei soggetti parla dell'umore come di un fattore facilitante o ostacolante. Mi sembra che questo problema richieda ancora ulteriori verifiche. Ma va detto che tali risultati, nonostante la confutazione dell'ipotesi, portano una certa soddisfazione: con una diminuzione del numero di fattori situazionali significativi, aumenta la probabilità che il verificarsi del coinvolgimento sia determinato da caratteristiche personali.
Per quanto riguarda le proprietà personali, si possono tracciare interessanti paralleli tra la correlazione degli indicatori di coinvolgimento soggettivo e “Soddisfazione per la fase passata” (“Termometro”) - una caratteristica situazionale - e la correlazione tra l'indicatore medio di coinvolgimento per una serie di attività - cioè una caratteristica un po' più stabile - e la "Performance life" (SJO). Questi 2 indicatori riflettono la manifestazione della stessa relazione - coinvolgimento e soddisfazione per i risultati della performance - solo su una scala temporale diversa.
In generale, tali relazioni suggeriscono (questo è stato ripetuto più di una volta in questo lavoro!) sulla possibilità di influenzare i cambiamenti nelle qualità personali di una persona attraverso i cambiamenti negli stati mentali. Vorrei ricordare ancora una volta C. Rogers e il suo postulato secondo cui una “buona vita” è un processo, non un risultato. Ciò significa che aiutando una persona a raggiungere uno stato di coinvolgimento nelle attività educative, gli diamo una preziosa esperienza di questa esperienza, che può trasferire in altri ambiti e, infine, consolidare come una delle caratteristiche dello stile individuale: il coinvolgimento nella vita .
Questo studio ha esaminato il coinvolgimento in un'attività educativa abbastanza specifica come la formazione nella danza. La sua specificità rispetto a quella accademica risiede, in primo luogo, nel fatto che qui viene effettuata la padronanza dei principi generali del movimento, e non del pensiero, in secondo luogo, nel fatto che la scelta di questa attività è del tutto volontaria, in terzo luogo, alla lezione è presente un numero relativamente piccolo di studenti (10-15).
Tuttavia, nonostante la specificità, mi sembra che l’approccio alle attività di apprendimento proposto in questo studio sia applicabile anche all’istruzione scolastica e universitaria. I principi di obiettivi chiari, feedback rapido e difficoltà ottimale dei compiti sono abbastanza semplici, ma allo stesso tempo, come ha dimostrato l'analisi delle interviste, il mancato rispetto degli stessi complica significativamente il compito di coinvolgere gli studenti.
Il fatto che l’impegno in una lezione dipenda sia dallo studente che dall’insegnante è abbastanza ovvio. Ciò è stato notato dagli studenti delle classi 10 e 11 durante l'analisi dei modi per migliorare l'efficacia delle lezioni scolastiche. (a seconda delle caratteristiche personali, la “responsabilità” per l'efficacia della lezione è stata distribuita da un rapporto del 20-80% a favore dello studente all'80-20% inverso a favore dell'insegnante) Cosa impedisce agli insegnanti di applicare questi principi ? In primo luogo, il formato di insegnamento tradizionale, che fa ben poco per incoraggiare l’attività degli studenti. Circa i vantaggi di un più moderno approccio individuale Molto è già stato scritto sull’insegnamento tradizionale.
Ma ci sono anche fattori esterni che influenzano le attività degli insegnanti. Questo è l'atteggiamento generale nei confronti della professione docente nella struttura educativa e i requisiti per essa. È una verità consolidata che il lavoro di insegnamento è mal retribuito nel nostro Paese. Lo stesso vale anche per il fatto che di conseguenza vi si recano pochi giovani specialisti. Tuttavia, a giudicare da un sondaggio condotto tra i presidi delle scuole della città di Vorkuta, la situazione non è cambiata affatto negli ultimi tempi. Inoltre, ad esso si è aggiunto un altro fattore: le montagne di scritti burocratici necessari che sono ricaduti sugli insegnanti in connessione con l'emergere di nuovi requisiti del Ministero della Pubblica Istruzione. Uno degli insegnanti della scuola secondaria ha notato che, a causa della necessità di scrivere costantemente relazioni, gli insegnanti non hanno tempo per prepararsi per le lezioni. Ma il danno principale dei rapporti, secondo me, non è nemmeno questo, ma la loro soggettiva insensatezza. È facile, facendo il lavoro delle scimmie giorno dopo giorno, mantenere l'ispirazione e l'entusiasmo per il lavoro vero? Si scopre che gli insegnanti dimenticano il motivo per cui sono venuti a lavorare in una scuola o in un'università, lasciando solo un comportamento "rinforzato" - l'imitazione dell'attività. E un tale sentimento di insensatezza del proprio lavoro viene necessariamente trasmesso agli studenti.
Conclusioni sul terzo capitolo.
Non è stata riscontrata alcuna correlazione statisticamente significativa tra gli indicatori “Stato”, “Attività”, “Umore” ottenuti all'inizio della lezione e gli indicatori di coinvolgimento soggettivo.
La relazione tra gli indicatori “Stato” e “Umore” ottenuti durante la lezione e gli indicatori di coinvolgimento soggettivo è stata riscontrata a livello di trend statistico.
È stata riscontrata una relazione statisticamente significativa tra gli indicatori “Desiderio di lavorare” e coinvolgimento soggettivo r=0,5, p=0,05, e tra gli indicatori “Soddisfazione per la fase passata” e coinvolgimento soggettivo r=0,6, p=0,01.
Sono state identificate relazioni statisticamente significative (tutte al livello di significatività p = 0,05, coefficiente di correlazione di Spearman) tra gli indicatori medi di coinvolgimento soggettivo (commento su un numero di classi) durante un numero di classi e le seguenti scale della metodologia:
“Processo vitale” p=0,6
“Prestazioni di vita” p=0,5
“Locus of control-I” p=0,5
“Significato della vita” p=0,5
Sono state riscontrate differenze tra gli indicatori medi del gruppo di coinvolgimento nelle attività educative tra gli studenti di biologia e gli studenti di danza (le medie erano rispettivamente 0,24 e 0,61).
Non è stata trovata alcuna relazione statisticamente significativa tra gli indicatori di coinvolgimento soggettivo e la dipendenza dal campo-indipendenza dal campo. Tuttavia, sulla base dell'analisi dei dati delle interviste, c'è motivo di pensare all'influenza significativa di questo stile cognitivo sulle caratteristiche dell'emergere del coinvolgimento nelle attività educative. (un commento)
6.Sono state identificate le caratteristiche della motivazione (nello specifico) e i fattori che interferiscono con l'emergere del coinvolgimento degli intervistati con indicatori alti e bassi di coinvolgimento soggettivo nelle attività educative. Il motivo dell'autoespressione è caratteristico esclusivamente per coloro che sono costantemente coinvolti nell'attività ed è assente tra coloro che non sono coinvolti nell'attività. (commento sulla pratica).
7. Utilizzando dati di osservazione standardizzati, sono stati ottenuti e analizzati dati sulle dinamiche generali dello stato di coinvolgimento del gruppo durante la lezione e il suo rapporto con le azioni dell'insegnante.
Conclusione.
Questo articolo ha esaminato lo stato del coinvolgimento e i fattori che ne influenzano la comparsa.
Sulla base dei risultati dello studio dello stato attuale del problema del coinvolgimento, è stata formulata una definizione di questo concetto (basata sull'approccio del ricercatore americano M. Csikszentmihalyi e sugli sviluppi nazionali nel campo dello studio degli stati mentali), ed è stata formulata un'ipotesi fatto circa l’influenza di fattori situazionali e personali sull’emergere del coinvolgimento.
Durante lo studio empirico sono state confermate alcune ipotesi, ad esempio, sulla relazione tra indicatori di coinvolgimento e significato e orientamenti di vita di un individuo, e alcune sono state confutate, ad esempio, sulla relazione tra livello di coinvolgimento e indicatori di funzionalità stato. A nostro avviso, numerose ipotesi necessitano di ulteriori verifiche, ad esempio l'ipotesi sulla relazione tra indipendenza dal campo e tassi di coinvolgimento più elevati.
Sono stati ottenuti anche alcuni risultati interessanti relativi alla dinamica del livello di coinvolgimento e alla sua dipendenza dalle azioni dell'insegnante (si scopre che quando l'insegnante fornisce un feedback, il gruppo è coinvolto solo al 50%) e alle caratteristiche della motivazione (l'unico motivo che può essere rintracciato nella maggior parte delle risposte degli intervistati "stabilmente coinvolti" ed è completamente assente tra gli "stabilmente non coinvolti" - questo è il motivo dell'espressione di sé).
In generale, il lavoro solleva più domande che risposte: vengono solo delineate le indicazioni per possibili ulteriori approfondimenti; tuttavia, a nostro avviso, il problema del coinvolgimento nelle attività è profondo, interessante e sfaccettato e merita di essere studiato.
Studente di danza motivazionale per il coinvolgimento
Elenco delle fonti
1. Y. Douglas e A. Hargadon, "Il principio del piacere: immersione, coinvolgimento, flusso". In Atti dell'undicesima conferenza ACM su ipertesto e ipermedia (San Antonio, maggio 2000), ACM Press, pp. 153-160
ERIC M. EISENBERG “Jamming: trascendenza attraverso l'organizzazione” “Ricerca sulla comunicazione” 1990 17: 139-164
3. Mary Ellen Gordon, Kim McKeage, Mark Alexander Fox “Efficacia del marketing relazionale: il ruolo del coinvolgimento” psicologia e marketing
M. Argyle “Psicologia della felicità”, San Pietroburgo: Peter, 2003
5. AV. Brushlinsky “Psicologia del soggetto” San Pietroburgo, “Aletheia”, 2003
L.M. Wekker “Psiche e realtà” Casa editrice “Sense”. Mosca, 1998
Vlasova 13 -19 “Gestione del personale: come attrarre, trattenere, motivare dipendenti di valore - 2011” Seconda conferenza scientifica e pratica regionale, abstract
Dormashev Yu.B., Romanov V.Ya. Psicologia dell'attenzione. - M.: Trivola, 1995.
Zimnyaya I.A. “Psicologia pedagogica”, M.: Logos, 2004
EP Ilyin “Motivazione e motivazioni” Editore: Peter, 2000
. "Psicologia". Manuale. Ed. AA. Krylova. M.: 2000.
Levitov, ND Sugli stati mentali di una persona - M.: Educazione, 1964
UN. Leontyev “Attività. Coscienza. Personalità” Casa editrice “Sense”, 2005.
SÌ. Leontiev “Test sugli orientamenti sul significato della vita” 2a edizione, casa editrice “Smysl”, 2006
. “Lo stile umano: analisi psicologica” / ed. AV. Libina. M.: Smysl, 1998
B. Meshcheryakov, V. Zinchenko “Grande dizionario psicologico” M.: Prime-Euroznak, 2003.
INFERNO. Nasledov “Metodi matematici della ricerca psicologica. Analisi e interpretazione dei dati" San Pietroburgo. "Discorso". 2004
Prokhorov A.O. "Metodi per la diagnosi e la misurazione degli stati mentali dell'individuo", Casa editrice : PER SE
. "Psicologia degli Stati". Lettore. Ed. A.O. Prokhorova - San Pietroburgo: Rech, 2004.
K. Rogers “Una visione della psicoterapia. Il divenire dell'uomo", M.: "Il progresso", 1994.
Rubinshtein S.L. "Fondamenti di psicologia generale"? 2a ed. (1946) - San Pietroburgo: Pietro, 2002
Rubinshtein S.L. L'uomo e il mondo. Mosca: Nauka, 1997
M. Seligman “Nuova psicologia positiva” M.: Casa editrice Sofia, 2006
Sokolova, Mishchenko, Ponomarev “formazione di un sottosistema di misurazione e analisi...”
M.V. Falikman “Attenzione” “Psicologia generale” ed. B.S. Bratusya. T.4. M., 2006
H. Heckhausen “Motivazione e attività”
Khimich Y. “Evoluzione dei concetti di gestione del marketing” (259-262) “Gestione dello sviluppo dei sistemi socio-economici” raccolta di opere di giovani scienziati, UlSTU, 2011
Kholodnaya M.A. "Stili cognitivi. Sulla natura della mente individuale." 2a ed. - San Pietroburgo: Pietro, 2004
M. Csikszentmihalyi “In Search of Flow” Casa editrice “Basic Books”, 1998
Csikszentmihalyi M. “Flusso. Psicologia dell’esperienza ottimale” Casa editrice “Smysl”, 2012.
Tutoraggio
Hai bisogno di aiuto per studiare un argomento?
I nostri specialisti ti consiglieranno o forniranno servizi di tutoraggio su argomenti che ti interessano.
Invia la tua candidatura indicando subito l'argomento per conoscere la possibilità di ottenere una consulenza.