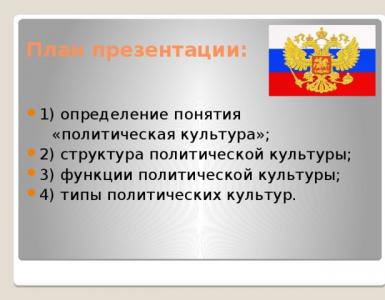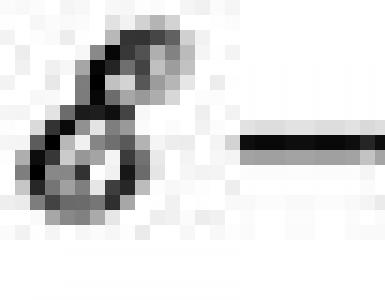Corteccia sensoriale. Area sensoriale della corteccia cerebrale
19. Funzioni della neocorteccia, significato funzionale della prima e della seconda zona somatosensoriale, zone motorie della corteccia emisferi cerebrali(loro localizzazione e significato funzionale). Multifunzionalità delle aree corticali, plasticità funzionale della corteccia.
Corteccia somatosensoriale- un'area della corteccia cerebrale responsabile della regolazione di alcuni sistemi sensoriali. La prima area somatosensoriale si trova sul giro postcentrale direttamente dietro il profondo solco centrale. La seconda area somatosensoriale si trova su parete superiore solco laterale che separa i lobi parietale e temporale. In queste aree si trovano i neuroni termorecettivi e nocicettivi (dolorifici). Prima zona(I) è abbastanza ben studiato. Qui sono rappresentate quasi tutte le aree della superficie corporea. Come risultato di una ricerca sistematica, è stato ottenuto un quadro abbastanza accurato delle rappresentazioni del corpo in quest'area della corteccia cerebrale. Nelle fonti letterarie e scientifiche tale rappresentazione è chiamata “omuncolo somatosensoriale” (per i dettagli vedere l'unità 3). La corteccia somatosensoriale di queste zone, tenendo conto della sua struttura a sei strati, è organizzata sotto forma di unità funzionali - colonne di neuroni (diametro 0,2 - 0,5 mm), dotate di due proprietà specifiche: distribuzione orizzontale limitata dei neuroni afferenti e orientamento verticale dei dendriti delle cellule piramidali. I neuroni di una colonna sono eccitati da recettori di un solo tipo, cioè terminazioni recettoriali specifiche. L'elaborazione delle informazioni nelle colonne e tra di esse viene eseguita gerarchicamente. Le connessioni efferenti della prima zona trasmettono le informazioni elaborate alla corteccia motoria (è assicurata la regolazione in feedback dei movimenti), alla zona associativa parietale (è assicurata l'integrazione delle informazioni visive e tattili) e al talamo, ai nuclei della colonna dorsale, al midollo spinale (è assicurata la regolazione efferente del flusso di informazioni afferenti è assicurato). La prima zona fornisce funzionalmente una precisa discriminazione tattile e una percezione cosciente degli stimoli sulla superficie del corpo. Seconda zona(II) è stato meno studiato e occupa molto meno spazio. Filogeneticamente, la seconda zona è più antica della prima ed è coinvolta in quasi tutti i processi somatosensoriali. I campi recettivi delle colonne neurali della seconda zona si trovano su entrambi i lati del corpo e le loro proiezioni sono simmetriche. Quest'area coordina le azioni delle informazioni sensoriali e motorie, ad esempio, quando si palpano oggetti con entrambe le mani.
Aree motorie (movimento) della corteccia
Il giro centrale anteriore (anteriore al solco Rolandico) e le sezioni posteriori adiacenti del primo e del secondo giro frontale costituiscono la zona motoria della corteccia cerebrale. Il nucleo dell'analizzatore motorio è il giro centrale anteriore (campo 4). Una caratteristica citoarchitettonica dell'area 4 è l'assenza dello strato IV di cellule granulari e la presenza nello strato V di cellule piramidali giganti di Betz, i cui lunghi processi, come parte del tratto piramidale, raggiungono i neuroni intermedi e motori del midollo spinale .
Nell'area del giro centrale anteriore ci sono centri di movimento per gli arti opposti e per la metà opposta del viso e del busto (Fig.).
Il terzo superiore del giro è occupato dai centri motori arti inferiori, e soprattutto si trova il centro del movimento del piede, sotto di esso c'è il centro del movimento della parte inferiore della gamba, e ancora più in basso è il centro del movimento della coscia.
Il terzo medio è occupato dai centri di movimento del corpo e arto superiore. Sopra gli altri si trova il centro del movimento della scapola, poi della spalla, dell'avambraccio e, ancora più in basso, della mano.
Il terzo inferiore del giro centrale anteriore (area tegmentale - opercolo) è occupato dai centri motori del viso, dei muscoli masticatori, della lingua, palato fine e laringe.
Poiché le vie motorie discendenti si intersecano, l'irritazione di tutti questi punti provoca la contrazione dei muscoli del lato opposto del corpo. Nella zona motoria, l'area più grande è occupata dai muscoli delle mani, del viso, delle labbra, della lingua e l'area più piccola è occupata dal busto e dagli arti inferiori. La dimensione della rappresentazione motoria corticale corrisponde all'accuratezza e alla sottigliezza del controllo dei movimenti di una determinata parte del corpo.
La stimolazione elettrica o chimica delle aree del campo 4 provoca una contrazione coordinata di gruppi muscolari rigorosamente definiti. L'estirpazione di qualsiasi centro è accompagnata dalla paralisi del corrispondente segmento muscolare. Questa paralisi dopo qualche tempo viene sostituita da debolezza e limitazione dei movimenti (paresi), poiché in molti casi atti motori può essere eseguita attraverso vie non piramidali o attraverso l’attività compensatoria dei meccanismi corticali sopravvissuti.
Corteccia premotoria
Anteriormente alla zona motoria si trova la cosiddetta zona premotoria della corteccia, che occupa i campi 6 e 8. Anche questa zona è caratterizzata dall'assenza dello strato IV, ma nello strato V, a differenza del campo 4, non ci sono quasi cellule piramidali giganti . L'area premotoria è strettamente connessa con i nodi sottocorticali e costituisce una parte importante dei sistemi extrapiramidali della corteccia, che raggiungono i centri motori finali solo dopo il passaggio alle formazioni sottostanti della corteccia.
Il campo 6, a differenza del campo 4, garantisce l'attuazione non di movimenti elementari, ma di complessi complessi motori automatizzati. Il campo 8 è il centro oculomotore, la cui irritazione porta ad una deviazione combinata della testa e degli occhi nella direzione opposta.
I campi motore e premotore hanno connessioni ben sviluppate che li uniscono in un unico complesso. Gli impulsi afferenti che raggiungono la regione precentrale arrivano principalmente lungo le vie che partono dal cervelletto, attraverso il nucleo rosso e il talamo, fino alla corteccia. Ciò garantisce la circolazione degli impulsi attraverso i sistemi cortico-sottocorticali extrapiramidali.
Stimolazione elettrica singole aree il campo 6 provoca movimenti della testa e del busto nella direzione opposta all'emisfero irritato. Questi movimenti sono coordinati e sono accompagnati da cambiamenti nel tono muscolare. In risposta alla stimolazione di una delle aree del campo 6, si verificano movimenti di deglutizione, cambiamenti improvvisi nella respirazione e urla.
La rimozione chirurgica di piccole aree della zona premotoria nell'uomo (durante interventi neurochirurgici) porta a una compromissione delle capacità motorie, sebbene vengano preservati i movimenti fini della mano.
La rimozione di alcune aree della zona premotoria della corteccia cerebrale porta alla comparsa di riflessi che non sono caratteristici di un adulto sano. Pertanto, dopo aver rimosso l'area premotoria della corteccia, da cui dipendono i movimenti della mano, si verifica un riflesso di presa potenziato: un leggero tocco tattile sul palmo provoca un forte movimento di presa. Assomiglia al riflesso di prensione nei neonati nel periodo precedente la maturazione funzionale del tratto piramidale.
Quando viene rimossa l'area in cui si trova la rappresentazione del muscolo della gamba nella corteccia motoria o premotoria, negli adulti appare il riflesso di Babinski.
L'irritazione di diversi punti del campo 8 (e del campo 19 - lobo occipitale) è accompagnata da movimenti volontari dell'occhio (campo 19 - fissazione dell'occhio sull'oggetto in questione).
Area motoria supplementare
L'area motoria aggiuntiva si trova sulla superficie interna dell'emisfero vicino alla rappresentazione sensomotoria della gamba. Il diametro di quest'area non supera 1-2 cm Irritazione varie parti mostra che in questa zona sono rappresentati i muscoli di tutte le parti del corpo. Quando viene stimolata l'area motoria supplementare, si osservano cambiamenti nella postura, accompagnati da movimenti bilaterali delle gambe e del busto. Spesso, quando quest'area viene stimolata, si verificano varie reazioni autonomiche: cambiamenti nella larghezza delle pupille, aumento della frequenza cardiaca, ecc. Si presume che la zona aggiuntiva svolga un ruolo ausiliario nel controllo della postura umana, che viene eseguita dal motore e le aree premotorie.
Area motoria terziaria i movimenti volontari sono in realtà qualsiasi corteccia che si trova di fronte alla corteccia motoria e premotoria. Questa cosiddetta regione prefrontale occupa circa il 25% dell'intera corteccia cerebrale ed è filogeneticamente la formazione cerebrale più recente. Diverse connessioni effettrici e afferenti assicurano il ruolo decisivo della corteccia prefrontale nell'organizzazione dell'attività umana cosciente e orientata agli obiettivi.
Quando parliamo di plasticità cerebrale, spesso intendiamo la sua capacità di cambiare sotto l'influenza dell'apprendimento o del danno. I meccanismi responsabili della plasticità sono diversi e la sua manifestazione più perfetta nel danno cerebrale è la rigenerazione. Il cervello è una rete estremamente complessa di neuroni che entrano in contatto tra loro attraverso formazioni speciali: le sinapsi. Possiamo quindi distinguere due livelli di plasticità: macro e micro. Il livello macro comporta cambiamenti nella struttura della rete del cervello che consente la comunicazione tra gli emisferi e tra le diverse regioni all'interno di ciascun emisfero. A livello micro, i cambiamenti molecolari avvengono nei neuroni stessi e nelle sinapsi. Ad entrambi i livelli, la plasticità cerebrale può manifestarsi rapidamente o lentamente. Questo articolo si concentrerà principalmente sulla plasticità a livello macro e sulle prospettive della ricerca sulla rigenerazione del cervello.
Localizzazione delle funzioni nella corteccia grande cervello
Caratteristiche generali. In alcune aree della corteccia cerebrale si concentrano prevalentemente i neuroni che percepiscono un tipo di stimolo: regione occipitale– luce, lobo temporale – suono, ecc. Tuttavia, dopo la rimozione delle zone di proiezione classiche (uditive, visive), i riflessi condizionati agli stimoli corrispondenti sono parzialmente preservati. Secondo la teoria di I.P. Pavlov, nella corteccia cerebrale c'è un "nucleo" dell'analizzatore (estremità corticale) e neuroni "sparsi" in tutta la corteccia. Concetto moderno la localizzazione delle funzioni si basa sul principio di multifunzionalità (ma non di equivalenza) dei campi corticali. La proprietà della multifunzionalità consente all'una o all'altra struttura corticale di essere coinvolta nella fornitura di varie forme di attività, realizzando al contempo la funzione principale, geneticamente intrinseca (O.S. Adrianov). Il grado di multifunzionalità delle varie strutture corticali varia. Nei campi corteccia associativaè più alta. La multifunzionalità si basa sull'ingresso multicanale delle eccitazioni afferenti nella corteccia cerebrale, sulla sovrapposizione delle eccitazioni afferenti, soprattutto a livello talamico e corticale, sull'influenza modulatrice di varie strutture, ad esempio i nuclei aspecifici del talamo, i gangli della base sulla funzioni corticali, l'interazione delle vie di eccitazione cortico-sottocorticali e intercorticali. Utilizzando la tecnologia dei microelettrodi, è stato possibile registrare in varie aree della corteccia cerebrale l'attività di neuroni specifici che rispondono agli stimoli di un solo tipo di stimolo (solo luce, solo suono, ecc.), cioè esiste una rappresentazione multipla di funzioni nel corteccia cerebrale .
Attualmente è accettata la divisione della corteccia in zone (aree) sensoriali, motorie e associative (non specifiche).
Aree sensoriali della corteccia. Le informazioni sensoriali entrano nella corteccia di proiezione, le sezioni corticali degli analizzatori (I.P. Pavlov). Queste zone si trovano principalmente nei lobi parietale, temporale e occipitale. Le vie ascendenti alla corteccia sensoriale provengono principalmente dai nuclei sensoriali relè del talamo.
Aree sensoriali primarie - queste sono zone della corteccia sensoriale, la cui irritazione o distruzione provoca cambiamenti chiari e permanenti nella sensibilità del corpo (nuclei degli analizzatori secondo I.P. Pavlov). Sono costituiti da neuroni monomodali e formano sensazioni della stessa qualità. Nelle zone sensoriali primarie di solito c'è una chiara rappresentazione spaziale (topografica) delle parti del corpo e dei loro campi recettoriali.
Le zone di proiezione primaria della corteccia sono costituite principalmente da neuroni del 4o strato afferente, caratterizzati da una chiara organizzazione topica. Una parte significativa di questi neuroni ha la più alta specificità. Ad esempio, i neuroni nelle aree visive rispondono selettivamente a determinati segni di stimoli visivi: alcuni - alle sfumature di colore, altri - alla direzione del movimento, altri - alla natura delle linee (bordo, striscia, pendenza della linea). , eccetera. Tuttavia, va notato che le zone primarie delle singole aree corticali comprendono anche neuroni multimodali che rispondono a diversi tipi di stimoli. Inoltre, ci sono neuroni la cui reazione riflette l'influenza di sistemi non specifici (limbico-reticolari o modulanti).
Aree sensoriali secondarie situati attorno alle aree sensoriali primarie, meno localizzate, i loro neuroni rispondono all'azione di numerosi stimoli, cioè sono multimodali.
Localizzazione delle zone sensoriali. L'area sensoriale più importante è Lobo parietale giro postcentrale e la parte corrispondente del lobulo paracentrale sulla superficie mediale degli emisferi. Questa zona è designata come area somatosensorialeIO. Qui c'è una proiezione della sensibilità della pelle sul lato opposto del corpo dai recettori tattili, del dolore, della temperatura, della sensibilità interocettiva e della sensibilità del sistema muscolo-scheletrico - dai recettori muscolari, articolari e tendinei (Fig. 2).
Riso. 2. Schema degli omuncoli sensoriali e motori
(secondo W. Penfield, T. Rasmussen). Sezione degli emisferi sul piano frontale:
UN– proiezione della sensibilità generale nella corteccia del giro postcentrale; B– proiezione sistema motorio nella corteccia del giro precentrale
Oltre all'area somatosensoriale I, ci sono area somatosensoriale II di dimensioni minori, situato al confine dell'intersezione della scanalatura centrale con il bordo superiore Lobo temporale, nella profondità della scanalatura laterale. Qui la precisione della localizzazione delle parti del corpo è meno pronunciata. Una zona di proiezione primaria ben studiata lo è corteccia uditiva(campi 41, 42), che si trova nella profondità del solco laterale (corteccia del giro temporale trasversale di Heschl). Alla corteccia di proiezione Lobo temporale vale anche per il centro analizzatore vestibolare nel giro temporale superiore e medio.
IN Lobo occipitale situato area visiva primaria(corteccia di parte del giro sfenoide e del lobulo linguale, area 17). Qui c'è una rappresentazione topica dei recettori retinici. Ogni punto della retina corrisponde ad una propria area della corteccia visiva, mentre la zona punto maculare ha un’area di rappresentanza relativamente ampia. A causa della decussazione incompleta delle vie visive, le stesse metà della retina vengono proiettate nell'area visiva di ciascun emisfero. La base è la presenza di proiezioni retiniche in entrambi gli occhi in ciascun emisfero visione binoculare. Vicino al campo 17 c'è una corteccia area visiva secondaria(campi 18 e 19). I neuroni di queste zone sono multimodali e rispondono non solo alla luce, ma anche agli stimoli tattili e uditivi. La sintesi avviene in quest'area visiva vari tipi sensibilità, sorgono immagini visive più complesse e il loro riconoscimento.
Nelle zone secondarie, i principali sono il 2o e 3o strato di neuroni, per i quali la parte principale delle informazioni sull'ambiente e sull'ambiente interno del corpo, ricevute nella corteccia sensoriale, viene trasferita per ulteriore elaborazione alla corteccia associativa , dopo di che viene avviata (se necessario) una reazione comportamentale con la partecipazione obbligatoria della corteccia motoria.
Aree della corteccia motoria. Esistono zone motorie primarie e secondarie.
IN zona motoria primaria (giro precentrale, campo 4) sono presenti neuroni che innervano i motoneuroni dei muscoli del viso, del tronco e degli arti. Ha una chiara proiezione topografica dei muscoli del corpo (vedi Fig. 2). Il modello principale di rappresentazione topografica è che la regolazione dell'attività dei muscoli che forniscono i movimenti più accurati e vari (parola, scrittura, espressioni facciali) richiede la partecipazione di ampie aree della corteccia motoria. L'irritazione della corteccia motoria primaria provoca la contrazione dei muscoli del lato opposto del corpo (per i muscoli della testa la contrazione può essere bilaterale). Se questo zona corticale si perde la capacità di eseguire movimenti fini e coordinati degli arti, in particolare delle dita.
Area motoria secondaria (campo 6) si trova sia sulla superficie laterale degli emisferi, davanti alla circonvoluzione precentrale (corteccia premotoria), sia sulla superficie mediale, corrispondente alla corteccia della circonvoluzione frontale superiore (area motoria supplementare). In termini funzionali, la corteccia motoria secondaria ha un ruolo dominante rispetto alla corteccia motoria primaria, svolgendo funzioni motorie superiori associate alla pianificazione e alla coordinazione dei movimenti volontari. Qui si registra in massima misura il negativo in lento aumento. potenziale di prontezza, che si verificano circa 1 s prima dell'inizio del movimento. La corteccia dell'area 6 riceve la maggior parte degli impulsi dai gangli della base e dal cervelletto ed è coinvolta nella ricodificazione delle informazioni sul piano dei movimenti complessi.
L'irritazione della corteccia dell'area 6 provoca movimenti coordinati complessi, ad esempio rotazione della testa, degli occhi e del busto nella direzione opposta, contrazioni cooperative dei flessori o degli estensori sul lato opposto. Nella corteccia premotoria ci sono centri motori associati alle funzioni sociali umane: il centro del discorso scritto sezione posteriore giro frontale medio (campo 6), centro motorio del linguaggio di Broca nella parte posteriore del giro frontale inferiore (campo 44), che fornisce la prassi del linguaggio, così come il centro motorio musicale (campo 45), che fornisce la tonalità del discorso e la capacità di cantare . I neuroni della corteccia motoria ricevono input afferenti attraverso il talamo dai recettori muscolari, articolari e cutanei, dai gangli della base e dal cervelletto. La principale uscita efferente della corteccia motoria ai centri motori staminali e spinali sono le cellule piramidali dello strato V. I lobi principali della corteccia cerebrale sono mostrati in Fig. 3.

Riso. 3. Quattro lobi principali della corteccia cerebrale (frontale, temporale, parietale e occipitale); vista laterale. Contengono le aree motorie e sensoriali primarie, aree motorie e sensoriali di ordine superiore (secondo, terzo, ecc.) e la corteccia associativa (non specifica)
Aree corticali associative(corteccia non specifica, intersensoriale, interanalizzatrice) comprendono aree della nuova corteccia cerebrale che si trovano intorno alle zone di proiezione e accanto alle zone motorie, ma non svolgono direttamente funzioni sensoriali o motorie, pertanto non possono essere attribuite funzioni prevalentemente sensoriali o motorie; i neuroni di queste zone hanno grandi capacità di apprendimento. I confini di queste aree non sono chiaramente definiti. La corteccia associativa è filogeneticamente la parte più giovane della neocorteccia, che ha ricevuto il maggiore sviluppo nei primati e nell'uomo. Negli esseri umani costituisce circa il 50% dell’intera corteccia o il 70% della neocorteccia. Il termine "corteccia associativa" è nato in connessione con l'idea esistente che queste zone, a causa delle connessioni cortico-corticali che le attraversano, collegano le aree motorie e allo stesso tempo fungono da substrato per le funzioni mentali superiori. Principale aree associative della corteccia sono: corteccia parieto-temporo-occipitale, prefrontale lobi frontali e l'area associativa limbica.
I neuroni della corteccia associativa sono polisensoriali (polimodali): rispondono, di regola, non a uno (come i neuroni delle zone sensoriali primarie), ma a diversi stimoli, cioè lo stesso neurone può essere eccitato dalla stimolazione di stimoli uditivi, visivi, pelle e altri recettori. La natura polisensoriale dei neuroni della corteccia associativa è creata da connessioni cortico-corticali con diverse zone di proiezione, connessioni con i nuclei associativi del talamo. Di conseguenza, la corteccia associativa è una sorta di collettore di varie eccitazioni sensoriali ed è coinvolta nell'integrazione delle informazioni sensoriali e nel garantire l'interazione delle aree sensoriali e motorie della corteccia.
Le aree associative occupano il 2° e il 3° strato cellulare della corteccia associativa, dove si incontrano potenti flussi afferenti unimodali, multimodali e non specifici. Il lavoro di queste parti della corteccia cerebrale è necessario non solo per la riuscita sintesi e differenziazione (discriminazione selettiva) degli stimoli percepiti da una persona, ma anche per il passaggio al livello della loro simbolizzazione, cioè per operare con i significati delle parole e usarle per il pensiero astratto, per la natura sintetica della percezione.
Dal 1949 è diventata ampiamente nota l'ipotesi di D. Hebb, che postula come condizione per la modificazione sinaptica la coincidenza dell'attività presinaptica con la scarica di un neurone postsinaptico, poiché non tutta l'attività sinaptica porta all'eccitazione del neurone postsinaptico. Sulla base dell'ipotesi di D. Hebb, si può presumere che i singoli neuroni delle zone associative della corteccia siano collegati in vari modi e formino insiemi cellulari che distinguono "sottomodelli", cioè corrispondenti a forme unitarie di percezione. Queste connessioni, come notato da D. Hebb, sono così ben sviluppate che è sufficiente attivare un neurone e l'intero insieme viene eccitato.
Il dispositivo che agisce come regolatore del livello di veglia, oltre a modulare e aggiornare selettivamente la priorità di una particolare funzione, è il sistema modulante del cervello, spesso chiamato complesso limbico-reticolare, o sistema di attivazione ascendente . A formazioni nervose Questo apparato comprende i sistemi cerebrali limbici e aspecifici con strutture attivanti e inattivanti. Tra le formazioni attivanti si distinguono principalmente la formazione reticolare del mesencefalo, l'ipotalamo posteriore e il locus coeruleus nelle parti inferiori del tronco encefalico. Le strutture inattivanti includono l'area preottica dell'ipotalamo, i nuclei del rafe nel tronco cerebrale e la corteccia frontale.
Attualmente, sulla base delle proiezioni talamocorticali, si propone di distinguere tre principali sistemi associativi del cervello: talamoparietale, talamofrontale E talamotemporale.
Sistema talamotoparietale rappresentato da zone associative della corteccia parietale, da cui ricevono i principali input afferenti gruppo posteriore nuclei associativi del talamo. La corteccia associativa parietale ha uscite efferenti ai nuclei del talamo e dell'ipotalamo, alla corteccia motoria e ai nuclei del sistema extrapiramidale. Le principali funzioni del sistema talamoparietale sono la gnosi e la prassi. Sotto gnosi comprendere la funzione di vari tipi di riconoscimento: forma, dimensione, significato degli oggetti, comprensione del linguaggio, conoscenza dei processi, modelli, ecc. Le funzioni gnostiche includono la valutazione delle relazioni spaziali, ad esempio la posizione relativa degli oggetti. Nella corteccia parietale c'è un centro di stereognosi, che fornisce la capacità di riconoscere gli oggetti al tatto. Una variante della funzione gnostica è la formazione nella coscienza di un modello tridimensionale del corpo (“diagramma corporeo”). Sotto prassi comprendere l'azione mirata. Il centro della prassi è situato nel giro sopracorticale dell'emisfero sinistro; assicura la memorizzazione e l'attuazione di un programma di atti motori automatizzati.
Sistema talamobico rappresentato da zone associative della corteccia frontale, che ricevono il principale input afferente dal nucleo associativo mediodorsale del talamo e da altri nuclei sottocorticali. Il ruolo principale della corteccia associativa frontale è ridotto all'avvio di meccanismi sistemici di base per la formazione di sistemi funzionali di atti comportamentali intenzionali (P.K. Anokhin). La regione prefrontale gioca ruolo principale nello sviluppo di strategie comportamentali. L'interruzione di questa funzione è particolarmente evidente quando è necessario cambiare rapidamente l'azione e quando passa del tempo tra la formulazione del problema e l'inizio della sua soluzione, ad es. Gli stimoli hanno tempo per accumularsi e richiedono un'adeguata inclusione in una risposta comportamentale olistica.
Sistema talamotemporale. Alcuni centri associativi, ad esempio la stereognosi, la prassi, comprendono anche delle aree corteccia temporale. Situato nella corteccia temporale centro uditivo Discorso di Wernicke, situato nelle parti posteriori del giro temporale superiore dell'emisfero sinistro. Questo centro fornisce la gnosi del linguaggio: riconoscimento e memorizzazione del discorso orale, sia il proprio che quello degli altri. Nella parte centrale del giro temporale superiore c'è un centro per il riconoscimento dei suoni musicali e delle loro combinazioni. Al confine dei lobi temporale, parietale e occipitale è presente un centro di lettura che consente il riconoscimento e la memorizzazione delle immagini.
Un ruolo significativo nella formazione degli atti comportamentali è giocato dalla qualità biologica della reazione incondizionata, vale a dire dal suo significato per la conservazione della vita. Nel processo di evoluzione, questo significato è stato fissato in due opposti stati emotivi- positivo e negativo, che in una persona costituisce la base delle sue esperienze soggettive: piacere e dispiacere, gioia e tristezza. In tutti i casi, il comportamento diretto all'obiettivo è costruito in conformità con lo stato emotivo emerso durante l'azione dello stimolo. Durante le reazioni comportamentali di natura negativa, tensione nelle componenti autonome, soprattutto del sistema cardiovascolare, in alcuni casi, soprattutto nelle situazioni cosiddette di conflitto continuo, può raggiungere grande forza, che causa una violazione dei loro meccanismi regolatori (nevrosi vegetativa).
Questa parte del libro esamina le principali questioni generali dell'attività analitica e sintetica del cervello, che ci consentiranno di passare nei capitoli successivi alla presentazione di questioni specifiche della fisiologia dei sistemi sensoriali e dell'attività nervosa superiore.
La corteccia sensoriale è una piccola parte del cervello situata tra la corteccia motoria e il lobo parietale. È questa parte del cervello che è responsabile delle sensazioni e delle percezioni corporee. Tutti i nostri impulsi tattili, visivi, uditivi e olfattivi nascono nell'area sensoriale della corteccia cerebrale. Concentrazione massima il liquido cerebrospinale viene raggiunto dove avevamo una fontanella durante l'infanzia. I taoisti credono che l'indurimento di questa area morbida inizi il processo attraverso il quale sperimentiamo ogni sensazione come propria. Da bambini ci sentiamo stimolo esterno, ma non sono in grado di riconoscere ciascuna sensazione separatamente.
I taoisti chiamano quest'area una cavità Bai Gui, in cui, quando si sperimentano stati mentali intensi, tutte le sensazioni sono concentrate e la mente può comprendere la purezza assoluta - l'illuminazione della coscienza.
Nel Taoismo, quest'area del cervello viene stimolata sia visualizzando la luce sulla sommità della testa, sia fissandola con l'occhio interiore, il cui scopo è aumentarne il livello di percezione. Questa zona è importante non solo dal punto di vista del ripristino della giovinezza e del raggiungimento dell'illuminazione della coscienza, ma anche perché è attraverso di essa che lo spirito lascia il corpo al momento della morte.
Quando la corteccia sensoriale viene stimolata intensamente, la capacità del corpo di ricevere sensazioni fisiche e mentali aumenta notevolmente. Questa maggiore sensibilità alla sensazione si riflette anche nella risposta dell'ipotalamo all'intensa eccitazione sessuale; L'ipotalamo invia un segnale alla ghiandola pituitaria affinché rilasci gonadotropine sistema endocrino.
Ciò si verifica solo se la persona ha sperimentato un intenso stato di natura estatica, che è alla base di quasi tutte le esperienze trascendentali descritte nei trattati sulla meditazione e sullo yoga. Il sesso, essendo una fonte di energia, fornisce il meglio e di più mezzi efficaci per sperimentare un tale stato.
Il midollo spinale e il cervello sono completamente circondati liquido cerebrospinale, ed è questo liquido, secondo i taoisti, ad essere responsabile del passaggio dell'energia sessuale dai reni al cervello. L'effetto dell'illuminazione è causato da una combinazione di aumento della temperatura sanguigna e movimento dell'energia sessuale che raggiunge la sommità della testa. Non dimenticare che gran parte di questo fluido si trova nell'area sensoriale della corteccia cerebrale.
Sia le Tigri che i Taoisti si sforzano di stimolare la corteccia sensoriale. I metodi possono differire leggermente, ma l’obiettivo finale è lo stesso. La tigre raggiunge l'illuminazione della coscienza assorbendo l'energia sessuale maschile, che nei libri taoisti è chiamata il ripristino dello yin attraverso lo yang. Un uomo taoista raggiunge l'illuminazione restituendo l'energia sessuale al cervello o ripristinando lo yin attraverso lo yang.
La Tigre, attraverso la piena concentrazione sulla stimolazione orale del pene dell'uomo, può raggiungere uno stato di ricettività suprema, il cui risultato è la capacità della Tigre di assorbire l'energia sessuale maschile e sperimentare la trasformazione spirituale. Significato principale consiste in una maggiore stimolazione della ghiandola pituitaria e dell'ipotalamo in modo che rispondano al limite delle loro capacità e producano ormoni in grado di ripristinare la giovinezza.
Orgasmo
Dopo aver discusso il modo in cui la scienza occidentale e l'alchimia spirituale taoista vedono il processo di assorbimento dell'energia, possiamo ora parlare più in dettaglio dell'orgasmo stesso.
Immediatamente prima o immediatamente dopo l'orgasmo, la coscienza umana è in uno stato di elevata ricettività. Durante l'orgasmo, il tempo si ferma e tutto sistema nervoso si concentra sulle sensazioni e sulla secrezione dei fluidi sessuali.
Più intenso è l'orgasmo, più ricche e luminose saranno le sensazioni e le percezioni.
Anche l'orgasmo stimola attivamente Lobo occipitale cervello (che controlla la vista) e riduce l’attività della corteccia motoria (che controlla i movimenti volontari). Durante l'orgasmo percepiamo e sentiamo il mondo attraverso sensazioni intensamente concentrate. I colori ci sembrano più luminosi e la nostra coscienza è piena di immagini luminose. Il corpo non controlla più i movimenti volontari, ma realizza solo quelli che contribuiscono all'orgasmo. Anche i centri uditivi e della parola del cervello sono in uno stato di maggiore attività.
Per quanto riguarda l'aumento dell'acuità dell'udito e della vista, molti fallimenti sessuali si verificano proprio perché partner sessuale dice alcune parole inappropriate durante l'orgasmo del secondo partner. Una persona in questo momento è così sensibile che le parole di insulto o disapprovazione penetrano molto profondamente nella coscienza e influenzano il suo comportamento sessuale in futuro. Ecco perché, come imparerai più avanti, durante il rapporto sessuale la Tigre mostra sempre una profonda approvazione per il pene del suo partner, per la qualità del suo sperma e per le sue azioni.
Dopo l'orgasmo, l'intero corpo entra in uno stato di riposo e quindi la maggior parte dei sessuologi lo considera un tranquillante. Ciò accade perché l'ipofisi, che controlla anche la produzione di ormoni calmanti, li invia immediatamente al sistema endocrino, che è la difesa naturale dell'organismo contro sensazioni troppo intense e prolungate. La reazione agli ormoni calmanti è più pronunciata negli uomini che nelle donne, poiché il corpo di queste ultime è più adatto agli orgasmi multipli; di solito per il rilascio della ghiandola pituitaria corpo femminile ormoni calmanti, è necessario più di un orgasmo. Ciò spiega il fatto che le donne possono essere molto energiche dopo l'orgasmo perché sono ancora sotto l'influenza delle gonadotropine.
Anche gli uomini possono avere orgasmi multipli, ma ciò accade solo quando la stimolazione successiva è sufficientemente intensa e tra l'orgasmo e la nuova eccitazione passa un certo tempo, necessario affinché gli ormoni calmanti perdano l'attività. L'intensità del primo orgasmo determina la quantità di ormoni dormienti rilasciati dalla ghiandola pituitaria nel corpo.
Per gli uomini che eiaculano frequentemente, gli ormoni calmanti hanno sempre meno effetto man mano che invecchiano. Per testare gli effetti di questi ormoni, un uomo deve trattenere l'eiaculazione per circa due settimane. Quindi durante l'eiaculazione gli sarà difficile non chiudere gli occhi. Questi ormoni calmanti sono necessari per ripristinare la giovinezza maschile, quindi l'eiaculazione non dovrebbe verificarsi frequentemente. Successivamente, durante l'eiaculazione, questi ormoni avranno un effetto più forte sull'intero sistema endocrino. La tigre trae beneficio non solo dal suo orgasmo, ma anche da quello del suo partner. Aumentando l'intensità dell'orgasmo, l'uomo può raggiungere uno stato di ricettività suprema in cui assorbe sia l'orgasmo che l'energia sessuale. Ci riesce concentrandosi interamente sulla massima eccitazione e sull'orgasmo dell'uomo, nel senso che tutta la sua attenzione è focalizzata sul suo pene e sullo sperma. Come un bambino eccitato e impaziente prima di aprire il regalo di compleanno, lei geme in attesa del suo orgasmo. Tenendo il suo pene a una distanza di cinque-sette centimetri dal viso, guarda direttamente la punta del pene e, quando lo sperma viene rilasciato, immagina come l'energia del suo orgasmo penetri direttamente nel pene. parte in alto la testa, quando un uomo finisce di eiaculare, chiude gli occhi e muove le pupille su e giù, come se stesse guardando da vicino la parte superiore del cervello. Rivolge tutta la sua attenzione alla sensazione del calore del suo seme sul viso. Con la punta del pene in bocca, succhia nove volte (molto delicatamente e senza forza se il pene è troppo sensibile) e immagina ancora l'energia del pene di lui che penetra nella parte superiore della sua testa.
In queste pratiche lei è coinvolta al massimo usa la sua immaginazione. Quando invecchiamo e facciamo esperienza influenza negativa ambiente e la pressione sociale, perdiamo la capacità di usare la nostra immaginazione. L’immaginazione è uno degli strumenti più potenti che noi esseri umani, purtroppo, utilizziamo troppo raramente. IN infanzia la fantasia ci impedisce di distinguere gli amici immaginari da quelli reali e rende possibile immaginare visivamente e vividamente tutti i nostri obiettivi e speranze. Invecchiando usiamo sempre meno la nostra immaginazione, sebbene sia coinvolta nella formazione di esperienze religiose: percepiamo il nostro Dio come una persona reale e vivente. A questo proposito chiamiamo fede l'immaginazione, ma funziona esattamente allo stesso modo.
Il bambino usa l'immaginazione più spesso del pensiero razionale, il che distrugge il potere dell'immaginazione. La tigre bianca usa al massimo la sua immaginazione e di conseguenza è in grado di percepire l'energia sessuale come qualcosa di completamente materiale. Dobbiamo ricordare che tutto ciò che esiste nel mondo è l'incarnazione materiale di un'idea.
Proprio come alcuni atleti, uomini d'affari e star del cinema di successo del passato adolescenza sognavano di diventare ricchi e famosi, sentendo che ciò sarebbe certamente accaduto, le Tigri immaginano e percepiscono se stesse come se avessero già raggiunto la giovinezza e l'immortalità - e sono assolutamente sicure che ciò accadrà. Usando la sua immaginazione, Tigress è in grado di aumentare l'intensità non solo del proprio orgasmo, ma anche di quello del suo partner e ricreare l'atmosfera spirituale e stato fisico della sua giovinezza.
Tigress aumenta l'intensità delle sue sensazioni sessuali utilizzando uomini chiamati Green Dragons. Lo fa per sfuggire alla routine conseguenza negativa lungo termine rapporti sessuali con un partner, in cui l'intensità delle sensazioni molto spesso diminuisce gradualmente nel tempo. Inoltre, come dice il proverbio, l’intimità genera disprezzo. Con un uomo desiderio sessuale si realizzerà nel sesso, il cui scopo sarà la procreazione e non la rinascita spirituale. Avendo perso la voglia di rinascita, non riesce più a cambiare. Tigre usa anche altri uomini per eccitare il suo partner principale, il Drago di Giada, in modo che anche lui, guardandola fare l'amore con loro, possa aumentare il suo orgasmo. Pertanto, aumentare l'intensità del suo orgasmo e di quello del suo partner è la chiave per Tigress per purificare, preservare e ripristinare la giovinezza. Da questo punto di vista il sesso diventa medicina.