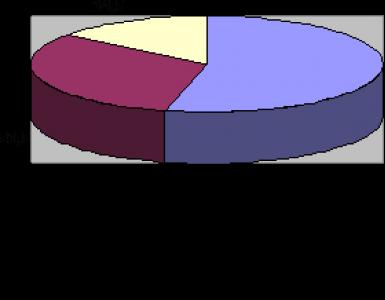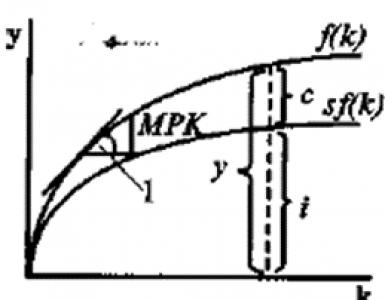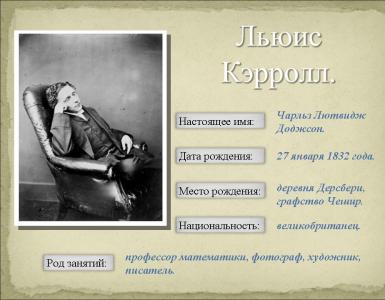Cause di maggiore sensibilità agli odori. Le cause dei disturbi dell'olfatto e del gusto sono disturbi del gusto e dell'olfatto. Trattamenti tradizionali per l'aumento degli odori
Ormoni della ghiandola pituitaria anteriore.
Il tessuto ghiandolare del lobo anteriore produce:
– l’ormone della crescita (GH), o somatotropina, che colpisce tutti i tessuti del corpo, aumentandone l’attività anabolica (cioè i processi di sintesi dei componenti dei tessuti corporei e aumentando le riserve energetiche).
– ormone stimolante i melanociti (MSH), che potenzia la produzione di pigmento da parte di alcune cellule della pelle (melanociti e melanofori);
– ormone stimolante la tiroide(TSH), che stimola la sintesi degli ormoni tiroidei nella ghiandola tiroidea;
– ormone follicolo-stimolante (FSH) e ormone luteinizzante (LH), correlati alle gonadotropine: la loro azione è mirata alle gonadi .
– la prolattina, a volte indicata come PRL, è un ormone che stimola la formazione delle ghiandole mammarie e l’allattamento.
Ormoni dell'ipofisi posteriore
– vasopressina e ossitocina. Entrambi gli ormoni sono prodotti nell'ipotalamo ma vengono immagazzinati e rilasciati nel lobo posteriore della ghiandola pituitaria, che si trova inferiore all'ipotalamo. La vasopressina mantiene il tono vasi sanguigni ed è ormone antidiuretico influenzando il metabolismo dell’acqua. L'ossitocina provoca le contrazioni dell'utero e ha la proprietà di “rilasciare” il latte dopo il parto.
Ormoni tiroidei e paratiroidei.
La ghiandola tiroidea è situata nel collo ed è composta da due lobi collegati da uno stretto istmo. quattro ghiandole paratiroidi solitamente situati in coppia - sulle superfici posteriore e laterale di ciascun lobo ghiandola tiroidea, anche se a volte uno o due potrebbero essere leggermente disallineati.
I principali ormoni secreti dalla tiroide normale sono la tiroxina (T4) e la triiodotironina (T3). Una volta nel flusso sanguigno, si legano, saldamente ma in modo reversibile, a specifiche proteine plasmatiche. Il T4 si lega più fortemente del T3 e non viene rilasciato così rapidamente, quindi agisce più lentamente ma dura più a lungo. Gli ormoni tiroidei stimolano la sintesi proteica e la disgregazione dei nutrienti per rilasciare calore ed energia, con conseguente aumento del consumo di ossigeno. Questi ormoni influenzano anche il metabolismo dei carboidrati e, insieme ad altri ormoni, regolano la velocità di mobilitazione degli acidi grassi liberi dal tessuto adiposo. In breve, gli ormoni tiroidei hanno un effetto stimolante processi metabolici. L’aumento della produzione di ormoni tiroidei causa tireotossicosi e, quando sono carenti, si verifica ipotiroidismo o mixedema.
Un altro composto trovato nella ghiandola tiroidea è lo stimolante tiroideo ad azione prolungata. È una gammaglobulina e può causare uno stato di ipertiroidismo.
L'ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi è chiamato ormone paratiroideo, o ormone paratiroideo; mantiene costante il livello di calcio nel sangue: quando diminuisce, viene rilasciato l'ormone paratiroideo che attiva il trasferimento del calcio dalle ossa al sangue fino a quando il livello di calcio nel sangue ritorna normale. Un altro ormone, la calcitonina, ha l’effetto opposto e viene rilasciato quando i livelli di calcio nel sangue sono elevati. In precedenza si credeva che la calcitonina fosse secreta dalle ghiandole paratiroidi, ma ora è stato dimostrato che viene prodotta nella ghiandola tiroidea. L'aumento della produzione dell'ormone paratiroideo provoca malattie ossee, calcoli renali, calcificazione tubuli renali, ed è possibile una combinazione di queste violazioni. La carenza di ormone paratiroideo è accompagnata da una significativa diminuzione del livello di calcio nel sangue e si manifesta con una maggiore eccitabilità neuromuscolare, spasmi e convulsioni.
Ormoni surrenalici.
Le ghiandole surrenali sono piccole strutture situate sopra ciascun rene. Sono costituiti da uno strato esterno chiamato corteccia e da una parte interna chiamata midollo. Entrambe le parti hanno le proprie funzioni e in alcuni animali inferiori sono strutture completamente separate. Ciascuna delle due parti delle ghiandole surrenali gioca ruolo importante come va? in buone condizioni e nelle malattie. Ad esempio, uno degli ormoni midollari, l'adrenalina, è necessario per la sopravvivenza poiché fornisce una reazione al pericolo improvviso. Quando ciò avviene, l'adrenalina viene rilasciata nel sangue e mobilita le riserve di carboidrati per il rapido rilascio di energia, aumenta la forza muscolare, provoca la dilatazione delle pupille e la costrizione dei vasi sanguigni periferici. Pertanto, le forze di riserva sono dirette alla "fuga o alla lotta" e, inoltre, la perdita di sangue viene ridotta a causa della vasocostrizione e della rapida coagulazione del sangue. L’adrenalina stimola anche la secrezione di ACTH (cioè l’asse ipotalamo-ipofisi). L’ACTH, a sua volta, stimola la corteccia surrenale a rilasciare cortisolo, con conseguente aumento della conversione delle proteine in glucosio, necessario per ricostituire le riserve di glicogeno nel fegato e nei muscoli utilizzati nella risposta all’ansia.
La corteccia surrenale secerne tre gruppi principali di ormoni: mineralcorticoidi, glucocorticoidi e steroidi sessuali (androgeni ed estrogeni). I mineralcorticoidi sono l'aldosterone e il desossicorticosterone. La loro azione è principalmente associata al mantenimento equilibrio salino. I glucocorticoidi influenzano il metabolismo dei carboidrati, delle proteine, dei grassi e anche i meccanismi di difesa immunologica. I più importanti tra i glucocorticoidi sono il cortisolo e il corticosterone. Gli steroidi sessuali che svolgono un ruolo ausiliario sono simili a quelli sintetizzati nelle gonadi; questi sono deidroepiandrosterone solfato, D 4 -androstenedione, deidroepiandrosterone e alcuni estrogeni.
Un eccesso di cortisolo porta a gravi disturbi metabolici, causando ipergluconeogenesi, cioè ipergluconeogenesi. eccessiva conversione delle proteine in carboidrati. Questa condizione, nota come sindrome di Cushing, è caratterizzata dalla perdita di massa muscolare, da una ridotta tolleranza ai carboidrati, ad es. ridotto apporto di glucosio dal sangue ai tessuti (che si manifesta con un aumento anomalo della concentrazione di zucchero nel sangue quando proviene dal cibo), nonché demineralizzazione delle ossa.
L'eccessiva secrezione di androgeni da parte dei tumori surrenalici porta alla mascolinizzazione. I tumori surrenalici possono anche produrre estrogeni, soprattutto negli uomini, portando alla femminilizzazione.
L'ipofunzione (attività ridotta) delle ghiandole surrenali si verifica in forma acuta o forma cronica. La causa dell'ipofunzione è grave, in rapido sviluppo infezione batterica: Può danneggiare la ghiandola surrenale e provocare uno shock profondo. Nella forma cronica, la malattia si sviluppa a causa della distruzione parziale della ghiandola surrenale (ad esempio, a causa di un tumore in crescita o di tubercolosi) o della produzione di autoanticorpi. Questa condizione, nota come morbo di Addison, è caratterizzata da grave debolezza, perdita di peso, pressione bassa, disordini gastrointestinali, aumento della necessità di sale e pigmentazione della pelle. La malattia di Addison, descritta nel 1855 da T. Addison, divenne la prima malattia endocrina riconosciuta.
L'adrenalina e la norepinefrina sono i due principali ormoni secreti dalla midollare del surrene. L’adrenalina è considerata un ormone metabolico a causa dei suoi effetti sull’immagazzinamento dei carboidrati e sulla mobilizzazione dei grassi. La norepinefrina è un vasocostrittore, cioè restringe i vasi sanguigni e aumenta la pressione sanguigna. La midollare del surrene è strettamente connessa al sistema nervoso; quindi, la norepinefrina viene rilasciata nervi simpatici e agisce come un neuroormone.
Con alcuni tumori si verifica un'eccessiva secrezione di ormoni midollare del surrene (ormoni midollari). I sintomi dipendono da quale dei due ormoni, adrenalina o norepinefrina, viene prodotto nell'organismo Di più, ma molto spesso si verificano attacchi improvvisi di vampate di calore, sudorazione, ansia, palpitazioni e così via mal di testa e ipertensione arteriosa.
Ormoni testicolari.
I testicoli (testicoli) hanno due parti, essendo ghiandole a secrezione sia esterna che interna. Come le ghiandole secrezione esterna producono sperma, e la funzione endocrina è svolta dalle cellule di Leydig in essi contenute, che secernono ormoni sessuali maschili (androgeni), in particolare D 4 -androstenedione e testosterone, il principale ormone maschile. Le cellule di Leydig producono anche piccole quantità di estrogeni (estradiolo).
I testicoli sono sotto il controllo delle gonadotropine. La gonadotropina FSH stimola la formazione degli spermatozoi (spermatogenesi). Sotto l'influenza di un'altra gonadotropina, l'LH, le cellule di Leydig rilasciano testosterone. La spermatogenesi avviene solo quando c'è una quantità sufficiente di androgeni. Gli androgeni, in particolare il testosterone, sono responsabili dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari negli uomini.
La violazione della funzione endocrina dei testicoli si riduce nella maggior parte dei casi a un'insufficiente secrezione di androgeni. Ad esempio, l’ipogonadismo è una diminuzione della funzione testicolare, inclusa la secrezione di testosterone, la spermatogenesi o entrambi. La causa dell'ipogonadismo può essere una malattia dei testicoli, o - indirettamente - compromissione funzionale ghiandola pituitaria
L'aumento della secrezione di androgeni si verifica nei tumori a cellule di Leydig e porta a sovrasviluppo caratteristiche sessuali maschili, soprattutto negli adolescenti. A volte i tumori testicolari producono estrogeni, causando femminilizzazione. Nel caso di un raro tumore dei testicoli, il coriocarcinoma, vengono prodotte così tante gonadotropine corioniche umane che l'analisi di una quantità minima di urina o di siero dà gli stessi risultati delle donne in gravidanza. Lo sviluppo del coriocarcinoma può portare alla femminilizzazione.
Ormoni ovarici.
Le ovaie hanno due funzioni: sviluppare gli ovuli e secernere ormoni. Gli ormoni ovarici sono gli estrogeni, il progesterone e il D4-androstenedione. Gli estrogeni determinano lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari femminili. L'estrogeno ovarico, l'estradiolo, viene prodotto nelle cellule del follicolo in crescita, la sacca che circonda l'ovulo in via di sviluppo. Come risultato dell'azione sia dell'FSH che dell'LH, il follicolo matura e si rompe, rilasciando l'ovulo. Il follicolo rotto si trasforma quindi nel cosiddetto. corpo luteo, che secerne sia estradiolo che progesterone. Questi ormoni, agendo insieme, preparano il rivestimento dell'utero (endometrio) per l'impianto di un ovulo fecondato. Se non avviene la fecondazione il corpo luteo subisce una regressione; allo stesso tempo, la secrezione di estradiolo e progesterone si interrompe e l'endometrio si stacca, causando le mestruazioni.
Sebbene le ovaie contengano molti follicoli immaturi, durante ogni ciclo mestruale solo uno di essi matura e rilascia un uovo. I follicoli in eccesso subiscono uno sviluppo inverso durante tutto il processo periodo riproduttivo la vita della donna. Follicoli e residui degenerati corpo luteo diventano parte dello stroma, il tessuto di supporto dell'ovaio. In determinate circostanze, specifiche cellule stromali vengono attivate e secernono il precursore degli ormoni androgeni attivi - D 4 -androstenedione. L'attivazione dello stroma si verifica, ad esempio, nella sindrome dell'ovaio policistico, una malattia associata ad un'ovulazione compromessa. Come risultato di questa attivazione, viene prodotto un eccesso di androgeni, che può causare irsutismo (grave pelosità).
La ridotta secrezione di estradiolo si verifica con il sottosviluppo delle ovaie. Anche la funzione ovarica diminuisce durante la menopausa, poiché la fornitura di follicoli si esaurisce e, di conseguenza, diminuisce la secrezione di estradiolo, che è accompagnata da una serie di sintomi, i più caratteristici dei quali sono le vampate di calore. La produzione eccessiva di estrogeni è solitamente associata ai tumori ovarici. Numero più grande disturbi mestruali causata da uno squilibrio degli ormoni ovarici e da disturbi dell’ovulazione.
Ormoni della placenta umana.
La placenta è una membrana porosa che collega l'embrione (feto) alla parete dell'utero materno. Secerne gonadotropina corionica umana e lattogeno placentare umano. Come le ovaie, la placenta produce progesterone e numerosi estrogeni.
Gonadotropina corionica (CG).
L'impianto di un ovulo fecondato è facilitato dagli ormoni materni: estradiolo e progesterone. Il settimo giorno dopo la fecondazione, l'embrione umano si rafforza nell'endometrio e riceve nutrimento dai tessuti materni e dal flusso sanguigno. Il distacco dell'endometrio, che provoca le mestruazioni, non si verifica perché l'embrione secerne hCG, che preserva il corpo luteo: l'estradiolo e il progesterone che produce mantengono l'integrità dell'endometrio. Dopo l'impianto dell'embrione, la placenta inizia a svilupparsi, continuando a secernere hCG, che raggiunge la sua concentrazione massima intorno al secondo mese di gravidanza. La determinazione della concentrazione di hCG nel sangue e nelle urine è la base dei test di gravidanza.
Lattogeno placentare umano (PL).
Nel 1962, la PL è stata trovata in alte concentrazioni nel tessuto placentare, nel sangue che scorre dalla placenta e nel siero del sangue periferico materno. Il PL si è rivelato simile, ma non identico, all'ormone della crescita umano. È un potente ormone metabolico. Influendo sul metabolismo dei carboidrati e dei grassi, favorisce la conservazione dei composti contenenti glucosio e azoto nel corpo della madre e garantisce così che il feto riceva una quantità sufficiente di sostanze nutritive; allo stesso tempo provoca la mobilitazione degli acidi grassi liberi, la fonte di energia del corpo materno.
Progesterone.
Durante la gravidanza, il livello di pregnandiolo, un metabolita del progesterone, aumenta gradualmente nel sangue (e nelle urine) della donna. Il progesterone viene secreto principalmente dalla placenta e il suo principale precursore è il colesterolo del sangue materno. La sintesi del progesterone non dipende dai precursori prodotti dal feto, a giudicare dal fatto che praticamente non diminuisce diverse settimane dopo la morte dell'embrione; la sintesi del progesterone continua anche nei casi in cui il feto è stato rimosso in pazienti con gravidanza ectopica addominale, ma la placenta è stata preservata.
Estrogeni.
Le prime segnalazioni di alti livelli di estrogeni nelle urine di donne incinte apparvero nel 1927, e presto divenne chiaro che tali livelli venivano mantenuti solo in presenza di un feto vivo. Successivamente è stato rivelato che con anomalie fetali associate a uno sviluppo compromesso delle ghiandole surrenali, il contenuto di estrogeni nelle urine della madre è significativamente ridotto. Ciò ha suggerito che gli ormoni surrenalici fetali fungono da precursori degli estrogeni. Ulteriori studi hanno dimostrato che il deidroepiandrosterone solfato, presente nel plasma fetale, è il principale precursore di estrogeni quali estrone ed estradiolo, e il 16-idrossideidroepiandrosterone, anch'esso di origine fetale, è il principale precursore di un altro estrogeno prodotto dalla placenta, l'estriolo. Così, scarico normale L'estrogeno nelle urine durante la gravidanza è determinato da due condizioni: le ghiandole surrenali fetali devono sintetizzare i precursori la giusta quantità e la placenta li converte in estrogeni.
Ormoni pancreatici.
Il pancreas effettua la secrezione sia interna che esterna. La componente esocrina (relativa alla secrezione esterna) lo è enzimi digestivi, che sotto forma di precursori inattivi entrano nel duodeno attraverso il dotto pancreatico. La secrezione interna è assicurata dalle isole di Langerhans, rappresentate da diversi tipi di cellule: le cellule alfa secernono l'ormone glucagone, le cellule beta secernono insulina. L'effetto principale dell'insulina è l'abbassamento dei livelli di glucosio nel sangue, attuato principalmente in tre modi: 1) inibizione della formazione di glucosio nel fegato; 2) inibizione nel fegato e nei muscoli della degradazione del glicogeno (un polimero del glucosio, che l'organismo può convertire in glucosio se necessario); 3) stimolazione dell'utilizzo del glucosio da parte dei tessuti. Porta a un'insufficiente secrezione di insulina o alla sua maggiore neutralizzazione da parte degli autoanticorpi alto livello glicemia e lo sviluppo del diabete mellito. L'effetto principale del glucagone è quello di aumentare i livelli di glucosio nel sangue stimolandone la produzione nel fegato. Sebbene l’insulina e il glucagone mantengano principalmente i livelli fisiologici di glucosio nel sangue, anche altri ormoni – l’ormone della crescita, il cortisolo e l’adrenalina – svolgono un ruolo significativo.
Ormoni gastrointestinali.
Ormoni tratto gastrointestinale– gastrina, colecistochinina, secretina e pancreozimina. Si tratta di polipeptidi secreti dalla mucosa del tratto gastrointestinale in risposta a una stimolazione specifica. Si ritiene che la gastrina stimoli la secrezione di acido cloridrico; la colecistochinina controlla lo svuotamento della cistifellea, mentre la secretina e la pancreozimina regolano la secrezione del succo pancreatico.
Neuroormoni
– un gruppo di composti chimici secreti dalle cellule nervose (neuroni). Questi composti hanno proprietà simili agli ormoni, stimolando o inibendo l'attività di altre cellule; questi includono i fattori di rilascio precedentemente menzionati, nonché i neurotrasmettitori, la cui funzione è quella di trasmettere gli impulsi nervosi attraverso la stretta fessura sinaptica che separa una cellula nervosa dall'altra. I neurotrasmettitori includono dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, istamina, acetilcolina e acido gamma-aminobutirrico.
A metà degli anni '70 furono scoperti numerosi nuovi neurotrasmettitori che hanno effetti analgesici simili alla morfina; si chiamano “endorfine”, cioè "morfine interne". Le endorfine sono in grado di legarsi a speciali recettori nelle strutture cerebrali; Come risultato di questo legame, vengono inviati impulsi al midollo spinale che bloccano la conduzione dei segnali di dolore in arrivo. L'effetto analgesico della morfina e degli altri oppiacei è senza dubbio dovuto alla loro somiglianza con le endorfine, che ne garantiscono il legame con gli stessi recettori antidolorifici.
Ormoni ipofisari sono descritti in dettaglio nell'articolo fisiopituitaria. Qui elencheremo solo i principali prodotti della secrezione ipofisaria.
Ormoni della ghiandola pituitaria anteriore. Il tessuto ghiandolare del lobo anteriore produce:
– l’ormone della crescita (GH), o somatotropina, che colpisce tutti i tessuti del corpo, aumentandone l’attività anabolica (cioè i processi di sintesi dei componenti dei tessuti corporei e aumentando le riserve energetiche).
– ormone stimolante i melanociti (MSH), che potenzia la produzione di pigmento da parte di alcune cellule della pelle (melanociti e melanofori);
– ormone stimolante la tiroide (TSH), che stimola la sintesi degli ormoni tiroidei nella ghiandola tiroidea;
– ormone follicolo-stimolante (FSH) e ormone luteinizzante (LH), correlati alle gonadotropine: la loro azione è mirata alle gonadi (Guarda anche RIPRODUZIONE UMANA).
– la prolattina, a volte indicata come PRL, è un ormone che stimola la formazione delle ghiandole mammarie e l’allattamento.
Ormoni dell'ipofisi posteriore– vasopressina e ossitocina. Entrambi gli ormoni sono prodotti nell'ipotalamo ma vengono immagazzinati e rilasciati nel lobo posteriore della ghiandola pituitaria, che si trova inferiore all'ipotalamo. La vasopressina mantiene il tono dei vasi sanguigni ed è un ormone antidiuretico che influenza il metabolismo dell'acqua. L'ossitocina provoca le contrazioni dell'utero e ha la proprietà di “rilasciare” il latte dopo il parto.
Ormoni tiroidei e paratiroidei. La ghiandola tiroidea è situata nel collo ed è composta da due lobi collegati da uno stretto istmo (cm . TIROIDE). Le quattro ghiandole paratiroidi si trovano solitamente in coppia, sulle superfici posteriore e laterale di ciascun lobo della ghiandola tiroidea, sebbene a volte una o due possano essere leggermente spostate.
I principali ormoni secreti dalla tiroide normale sono la tiroxina (T4) e la triiodotironina (T3). Una volta nel flusso sanguigno, si legano, saldamente ma in modo reversibile, a specifiche proteine plasmatiche. Il T4 si lega più fortemente del T3 e non viene rilasciato così rapidamente, quindi agisce più lentamente ma dura più a lungo. Gli ormoni tiroidei stimolano la sintesi proteica e la disgregazione dei nutrienti, rilasciando calore ed energia, con conseguente aumento del consumo di ossigeno. Questi ormoni influenzano anche il metabolismo dei carboidrati e, insieme ad altri ormoni, regolano la velocità di mobilitazione degli acidi grassi liberi dal tessuto adiposo. In breve, gli ormoni tiroidei hanno un effetto stimolante sui processi metabolici. L’aumento della produzione di ormoni tiroidei provoca tireotossicosi e, quando sono carenti, si verifica ipotiroidismo o mixedema.
Un altro composto trovato nella ghiandola tiroidea è lo stimolante tiroideo ad azione prolungata. È una gammaglobulina e può causare uno stato di ipertiroidismo.
L'ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi è chiamato ormone paratiroideo, o ormone paratiroideo; mantiene costante il livello di calcio nel sangue: quando diminuisce, viene rilasciato l'ormone paratiroideo che attiva il trasferimento del calcio dalle ossa al sangue fino a quando il livello di calcio nel sangue ritorna normale. Un altro ormone, la calcitonina, ha l’effetto opposto e viene rilasciato quando i livelli di calcio nel sangue sono elevati. In precedenza si credeva che la calcitonina fosse secreta dalle ghiandole paratiroidi, ma ora è stato dimostrato che viene prodotta nella ghiandola tiroidea. L’aumento della produzione dell’ormone paratiroideo causa malattie ossee, calcoli renali, calcificazione dei tubuli renali ed è possibile una combinazione di questi disturbi. La carenza di ormone paratiroideo è accompagnata da una significativa diminuzione del livello di calcio nel sangue e si manifesta con una maggiore eccitabilità neuromuscolare, spasmi e convulsioni.
Ormoni surrenalici. Le ghiandole surrenali sono piccole strutture situate sopra ciascun rene. Sono costituiti da uno strato esterno chiamato corteccia e da una parte interna chiamata midollo. Entrambe le parti hanno le proprie funzioni e in alcuni animali inferiori sono strutture completamente separate. Ciascuna delle due parti delle ghiandole surrenali svolge un ruolo importante sia nella salute normale che nella malattia. Ad esempio, uno degli ormoni midollari, l'adrenalina, è necessario per la sopravvivenza poiché fornisce una reazione al pericolo improvviso. Quando ciò avviene, l'adrenalina viene rilasciata nel sangue e mobilita le riserve di carboidrati per il rapido rilascio di energia, aumenta la forza muscolare, provoca la dilatazione delle pupille e la costrizione dei vasi sanguigni periferici. Pertanto, le forze di riserva sono dirette alla "fuga o alla lotta" e, inoltre, la perdita di sangue viene ridotta a causa della vasocostrizione e della rapida coagulazione del sangue. L’adrenalina stimola anche la secrezione di ACTH (cioè l’asse ipotalamo-ipofisi). L'ACTH, a sua volta, stimola la corteccia surrenale a rilasciare cortisolo, con conseguente aumento della conversione delle proteine in glucosio, necessario per ricostituire le riserve di glicogeno nel fegato e nei muscoli utilizzati nella reazione ansiosa.
La corteccia surrenale secerne tre gruppi principali di ormoni: mineralcorticoidi, glucocorticoidi e steroidi sessuali (androgeni ed estrogeni). I mineralcorticoidi sono l'aldosterone e il desossicorticosterone. La loro azione è associata principalmente al mantenimento dell'equilibrio salino. I glucocorticoidi influenzano il metabolismo dei carboidrati, delle proteine, dei grassi e anche i meccanismi di difesa immunologica. I più importanti tra i glucocorticoidi sono il cortisolo e il corticosterone. Gli steroidi sessuali che svolgono un ruolo ausiliario sono simili a quelli sintetizzati nelle gonadi; questi sono deidroepiandrosterone solfato, 4 -androstenedione, deidroepiandrosterone e alcuni estrogeni.
Un eccesso di cortisolo porta a gravi disturbi metabolici, causando ipergluconeogenesi, cioè ipergluconeogenesi. eccessiva conversione delle proteine in carboidrati. Questa condizione, nota come sindrome di Cushing, è caratterizzata dalla perdita di massa muscolare, da una ridotta tolleranza ai carboidrati, ad es. ridotto apporto di glucosio dal sangue ai tessuti (che si manifesta con un aumento anomalo della concentrazione di zucchero nel sangue quando proviene dal cibo), nonché demineralizzazione delle ossa.
L'eccessiva secrezione di androgeni da parte dei tumori surrenalici porta alla mascolinizzazione. I tumori surrenalici possono anche produrre estrogeni, soprattutto negli uomini, portando alla femminilizzazione.
L'ipofunzione (attività ridotta) delle ghiandole surrenali si verifica in forma acuta o cronica. L'ipofunzione è causata da un'infezione batterica grave e in rapido sviluppo: può danneggiare la ghiandola surrenale e portare a uno shock profondo. Nella forma cronica, la malattia si sviluppa a causa della distruzione parziale della ghiandola surrenale (ad esempio, a causa di un tumore in crescita o di tubercolosi) o della produzione di autoanticorpi. Questa condizione, nota come morbo di Addison, è caratterizzata da grave debolezza, perdita di peso, bassa pressione sanguigna, disturbi gastrointestinali, aumento del fabbisogno di sale e pigmentazione della pelle. La malattia di Addison, descritta nel 1855 da T. Addison, divenne la prima malattia endocrina riconosciuta.
L'adrenalina e la norepinefrina sono i due principali ormoni secreti dalla midollare del surrene. L’adrenalina è considerata un ormone metabolico a causa dei suoi effetti sull’immagazzinamento dei carboidrati e sulla mobilizzazione dei grassi. La norepinefrina è un vasocostrittore, cioè restringe i vasi sanguigni e aumenta la pressione sanguigna. La midollare del surrene è strettamente connessa al sistema nervoso; Pertanto, la norepinefrina viene rilasciata dai nervi simpatici e agisce come un neuroormone.
Con alcuni tumori si verifica un'eccessiva secrezione di ormoni midollare del surrene (ormoni midollari). I sintomi dipendono da quale dei due ormoni, adrenalina o noradrenalina, viene prodotto in maggiore quantità, ma i più comuni sono attacchi improvvisi di vampate di calore, sudorazione, ansia, palpitazioni, ma anche mal di testa e ipertensione.
Ormoni testicolari. I testicoli (testicoli) hanno due parti, essendo ghiandole a secrezione sia esterna che interna. In quanto ghiandole esocrine, producono spermatozoi e la funzione endocrina è svolta dalle cellule di Leydig in esse contenute, che secernono ormoni sessuali maschili (androgeni), in particolare 4 -androstenedione e testosterone, il principale ormone maschile. Le cellule di Leydig producono anche piccole quantità di estrogeni (estradiolo).
I testicoli sono sotto il controllo delle gonadotropine ( vedi sopra capitolo ORMONI PITUITARI). La gonadotropina FSH stimola la formazione degli spermatozoi (spermatogenesi). Sotto l'influenza di un'altra gonadotropina, l'LH, le cellule di Leydig rilasciano testosterone. La spermatogenesi avviene solo quando c'è una quantità sufficiente di androgeni. Gli androgeni, in particolare il testosterone, sono responsabili dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari negli uomini.
La violazione della funzione endocrina dei testicoli si riduce nella maggior parte dei casi a un'insufficiente secrezione di androgeni. Ad esempio, l’ipogonadismo è una diminuzione della funzione testicolare, inclusa la secrezione di testosterone, la spermatogenesi o entrambi. La causa dell'ipogonadismo può essere una malattia dei testicoli o, indirettamente, un fallimento funzionale della ghiandola pituitaria.
Nei tumori a cellule di Leydig si verifica un aumento della secrezione di androgeni e porta ad un eccessivo sviluppo dei caratteri sessuali maschili, soprattutto negli adolescenti. A volte i tumori testicolari producono estrogeni, causando femminilizzazione. Nel caso di un raro tumore dei testicoli, il coriocarcinoma, vengono prodotte così tante gonadotropine corioniche umane che l'analisi di una quantità minima di urina o di siero dà gli stessi risultati delle donne in gravidanza. Lo sviluppo del coriocarcinoma può portare alla femminilizzazione.
Ormoni ovarici. Le ovaie hanno due funzioni: sviluppare gli ovuli e secernere ormoni (Guarda anche RIPRODUZIONE UMANA). Gli ormoni ovarici sono gli estrogeni, il progesterone e il 4 -androstenedione. Gli estrogeni determinano lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari femminili. L'estrogeno ovarico, l'estradiolo, viene prodotto nelle cellule del follicolo in crescita, la sacca che circonda l'ovulo in via di sviluppo. Come risultato dell'azione sia dell'FSH che dell'LH, il follicolo matura e si rompe, rilasciando l'ovulo. Il follicolo rotto si trasforma quindi nel cosiddetto. corpo luteo, che secerne sia estradiolo che progesterone. Questi ormoni, agendo insieme, preparano il rivestimento dell'utero (endometrio) per l'impianto di un ovulo fecondato. Se non avviene la fecondazione il corpo luteo subisce una regressione; allo stesso tempo, la secrezione di estradiolo e progesterone si interrompe e l'endometrio si stacca, causando le mestruazioni.
Sebbene le ovaie contengano molti follicoli immaturi, durante ogni ciclo mestruale solo uno di essi matura e rilascia un uovo. I follicoli in eccesso subiscono uno sviluppo inverso durante tutto il periodo riproduttivo della vita di una donna. I follicoli degenerati e i resti del corpo luteo diventano parte dello stroma, il tessuto di supporto dell'ovaio. In determinate circostanze, specifiche cellule stromali vengono attivate e secernono il precursore degli ormoni androgeni attivi - 4 -androstenedione. L'attivazione dello stroma si verifica, ad esempio, nella sindrome dell'ovaio policistico, una malattia associata ad un'ovulazione compromessa. Come risultato di questa attivazione, viene prodotto un eccesso di androgeni, che può causare irsutismo (grave pelosità).
La ridotta secrezione di estradiolo si verifica con il sottosviluppo delle ovaie. Anche la funzione ovarica diminuisce durante la menopausa, poiché la fornitura di follicoli si esaurisce e, di conseguenza, diminuisce la secrezione di estradiolo, che è accompagnata da una serie di sintomi, i più caratteristici dei quali sono le vampate di calore. La produzione eccessiva di estrogeni è solitamente associata ai tumori ovarici. La maggior parte dei disturbi mestruali è causata da uno squilibrio degli ormoni ovarici e da disturbi dell’ovulazione.
Ormoni della placenta umana. La placenta è una membrana porosa che collega l'embrione (feto) alla parete dell'utero materno. Secerne gonadotropina corionica umana e lattogeno placentare umano. Come le ovaie, la placenta produce progesterone e numerosi estrogeni.
Gonadotropina corionica umana (HG). L'impianto di un ovulo fecondato è facilitato dagli ormoni materni: estradiolo e progesterone. Il settimo giorno dopo la fecondazione, l'embrione umano si rafforza nell'endometrio e riceve nutrimento dai tessuti materni e dal flusso sanguigno. Il distacco dell'endometrio, che provoca le mestruazioni, non si verifica perché l'embrione secerne hCG, che preserva il corpo luteo: l'estradiolo e il progesterone che produce mantengono l'integrità dell'endometrio. Dopo l'impianto dell'embrione, la placenta inizia a svilupparsi, continuando a secernere hCG, che raggiunge la sua concentrazione massima intorno al secondo mese di gravidanza. La determinazione della concentrazione di hCG nel sangue e nelle urine è la base dei test di gravidanza.
Lattogeno placentare umano (PL). Nel 1962, la PL è stata trovata in alte concentrazioni nel tessuto placentare, nel sangue che scorre dalla placenta e nel siero del sangue periferico materno. Il PL si è rivelato simile, ma non identico, all'ormone della crescita umano. È un potente ormone metabolico. Influendo sul metabolismo dei carboidrati e dei grassi, favorisce la conservazione dei composti contenenti glucosio e azoto nel corpo della madre e garantisce così che il feto riceva una quantità sufficiente di sostanze nutritive; allo stesso tempo provoca la mobilitazione degli acidi grassi liberi, la fonte di energia del corpo materno.
Progesterone. Durante la gravidanza, il livello di pregnandiolo, un metabolita del progesterone, aumenta gradualmente nel sangue (e nelle urine) della donna. Il progesterone viene secreto principalmente dalla placenta e il suo principale precursore è il colesterolo del sangue materno. La sintesi del progesterone non dipende dai precursori prodotti dal feto, a giudicare dal fatto che praticamente non diminuisce diverse settimane dopo la morte dell'embrione; la sintesi del progesterone continua anche nei casi in cui il feto è stato rimosso in pazienti con gravidanza ectopica addominale, ma la placenta è stata preservata.
Estrogeni. Le prime segnalazioni di alti livelli di estrogeni nelle urine di donne incinte apparvero nel 1927, e presto divenne chiaro che tali livelli venivano mantenuti solo in presenza di un feto vivo. Successivamente è stato rivelato che con anomalie fetali associate a uno sviluppo compromesso delle ghiandole surrenali, il contenuto di estrogeni nelle urine della madre è significativamente ridotto. Ciò ha suggerito che gli ormoni surrenalici fetali fungono da precursori degli estrogeni. Ulteriori studi hanno dimostrato che il deidroepiandrosterone solfato, presente nel plasma fetale, è il principale precursore di estrogeni quali estrone ed estradiolo, e il 16-idrossideidroepiandrosterone, anch'esso di origine fetale, è il principale precursore di un altro estrogeno prodotto dalla placenta, l'estriolo. Pertanto, la normale escrezione di estrogeni nelle urine durante la gravidanza è determinata da due condizioni: le ghiandole surrenali fetali devono sintetizzare i precursori nella quantità richiesta e la placenta deve convertirli in estrogeni.
Ormoni pancreatici. Il pancreas effettua la secrezione sia interna che esterna. La componente esocrina (legata alla secrezione esterna) sono gli enzimi digestivi, che sotto forma di precursori inattivi entrano nel duodeno attraverso il dotto pancreatico. La secrezione interna è assicurata dalle isole di Langerhans, rappresentate da diversi tipi di cellule: le cellule alfa secernono l'ormone glucagone, le cellule beta secernono insulina. L'effetto principale dell'insulina è l'abbassamento dei livelli di glucosio nel sangue, attuato principalmente in tre modi: 1) inibizione della formazione di glucosio nel fegato; 2) inibizione nel fegato e nei muscoli della degradazione del glicogeno (un polimero del glucosio, che l'organismo può convertire in glucosio se necessario); 3) stimolazione dell'utilizzo del glucosio da parte dei tessuti. Una secrezione insufficiente di insulina o la sua maggiore neutralizzazione da parte degli autoanticorpi porta a livelli elevati di glucosio nel sangue e allo sviluppo del diabete mellito. L'effetto principale del glucagone è quello di aumentare i livelli di glucosio nel sangue stimolandone la produzione nel fegato. Sebbene l’insulina e il glucagone mantengano principalmente i livelli fisiologici di glucosio nel sangue, anche altri ormoni – l’ormone della crescita, il cortisolo e l’adrenalina – svolgono un ruolo significativo.
Ormoni gastrointestinali. Ormoni del tratto gastrointestinale: gastrina, colecistochinina, secretina e pancreozimina. Si tratta di polipeptidi secreti dalla mucosa del tratto gastrointestinale in risposta a una stimolazione specifica. Si ritiene che la gastrina stimoli la secrezione di acido cloridrico; la colecistochinina controlla lo svuotamento della cistifellea, mentre la secretina e la pancreozimina regolano la secrezione del succo pancreatico.
Neuroormoni– un gruppo di composti chimici secreti dalle cellule nervose (neuroni). Questi composti hanno proprietà simili agli ormoni, stimolando o inibendo l'attività di altre cellule; questi includono i fattori di rilascio precedentemente menzionati, nonché i neurotrasmettitori, la cui funzione è quella di trasmettere gli impulsi nervosi attraverso la stretta fessura sinaptica che separa una cellula nervosa dall'altra. I neurotrasmettitori includono dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, istamina, acetilcolina e acido gamma-aminobutirrico.
A metà degli anni '70 furono scoperti numerosi nuovi neurotrasmettitori che hanno effetti analgesici simili alla morfina; si chiamano “endorfine”, cioè "morfine interne". Le endorfine sono in grado di legarsi a speciali recettori nelle strutture cerebrali; Come risultato di questo legame, vengono inviati impulsi al midollo spinale che bloccano la conduzione dei segnali di dolore in arrivo. L'effetto analgesico della morfina e degli altri oppiacei è senza dubbio dovuto alla loro somiglianza con le endorfine, che ne garantiscono il legame con gli stessi recettori antidolorifici.
Oggi sono conosciuti più di centocinquanta tipi di ormoni, ognuno dei quali è estremamente importante per funzionamento normale corpo: se la produzione di almeno uno di essi si discosta dalla norma, ciò porterà a molto problemi seri con la salute, fino alla morte. Ciò accade perché le funzioni degli ormoni sono principalmente quelle di controllare il metabolismo, lo sviluppo, la crescita dei tessuti, delle cellule e altri processi vitali del corpo.
Le sostanze biologicamente attive note come ormoni sono prodotte dalle ghiandole interne e secrezione mista. Gli organi endocrini sono chiamati ghiandole che secernono le sostanze attive direttamente nel sangue e non hanno dotti escretori verso l'esterno. Questi includono la ghiandola pituitaria, le ghiandole surrenali, la ghiandola tiroidea e le ghiandole paratiroidi.
Le ghiandole a secrezione mista sono responsabili della secrezione non solo degli ormoni, ma anche di altre sostanze, e quindi rimuovono le sostanze che producono sia nel sangue che in un'altra parte del corpo o all'esterno. Questi includono il pancreas, le gonadi, lo stomaco, Timo, placenta, che non solo sono responsabili della produzione di ormoni, ma svolgono anche altre funzioni non legate al funzionamento del sistema endocrino.
Le sostanze biologicamente attive svolgono le seguenti funzioni nel corpo:
- attivare o inibire la crescita cellulare;
- controllare il processo naturale di decadimento cellulare;
- influenzare l'umore (apatia, allegria, ottimismo, depressione);
- regolare il metabolismo;
- migliorare o inibire il funzionamento del sistema immunitario;
- sono responsabili della funzione riproduttiva: partecipano alla formazione dei caratteri sessuali secondari, lavoro coordinato organi genitali, preparare il corpo durante la pubertà, preparare alla menopausa, influenzare desiderio sessuale;
- sono responsabili di reazioni tempestive in situazioni stressanti e pericolose per la vita;
- causare sentimenti di fame e sazietà;
- influenzare la sintesi e le funzioni di altri ormoni.
Gli ormoni interagiscono con il corpo attraverso recettori appositamente progettati per loro, che si trovano su ciascuna cellula bersaglio. Ottengono l'effetto desiderato modificando la velocità reazioni chimiche che si verificano sotto l'influenza o la sintesi di enzimi (come vengono solitamente chiamate le molecole proteiche). Inoltre, questa influenza è così grande che l'ormone, penetrando nella cellula bersaglio, modifica non più dell'1% delle proteine e dell'RNA, il che è sufficiente per creare l'effetto desiderato.
Tipi di ormoni
Il lavoro del sistema endocrino è completamente sotto l'influenza del sistema nervoso centrale, che è direttamente collegato all'ipotalamo, che controlla il lavoro delle ghiandole endocrine e a secrezione mista. Lo fa attraverso la ghiandola pituitaria, che è una ghiandola endocrina che si trova in una tasca della parte a forma di cuneo del cranio, conosciuta come sella turcica.
Gli ormoni, la cui attività è influenzata dall'ipotalamo, sono divisi in tre gruppi in base alla loro struttura chimica. Il primo, che comprende le sostanze biologicamente attive sintetizzate dall'ipotalamo, comprende peptidi e proteine. Vengono prodotti anche nel lobo anteriore dell'ipofisi, nell'ipotalamo, nel pancreas (insulina, glucagone).


Il secondo gruppo comprende i derivati degli amminoacidi che sono derivati della tirosina. I più conosciuti sono gli ormoni tiroidei, nonché l'epinefrina e la norepinefrina, che vengono prodotti nella midollare del surrene. Il terzo gruppo è costituito dagli ormoni steroidei, prodotti dal colesterolo. Sono prodotti dalle gonadi e dalla corteccia surrenale.
Ogni tipo di ormone colpisce solo determinate cellule o tipi di metabolismo. Inoltre, accade spesso che lo stesso tessuto sia esposto all'influenza di diversi tipi di ormoni contemporaneamente, che possono avere l'effetto opposto o creare un ambiente favorevole per il lavoro di un altro ormone.
Ad esempio, le sostanze sintetizzate dalla tiroide interagiscono con gli androgeni e gli estrogeni, migliorando il funzionamento sistema riproduttivo. Pertanto, il risultato finale dipende non da uno, ma da tutti i tipi di ormoni sotto l'influenza dei quali si trovava la cellula, nonché dallo stato degli organi interni e dall'età.


La maggior parte delle sostanze biologicamente attive sono caratterizzate dal fatto che sono solubili in acqua e non si legano alle proteine trasportatrici (ad eccezione degli ormoni sessuali, degli ormoni tiroidei e di alcuni altri).
Inoltre, molti di loro iniziano a influenzare il corpo solo dopo essersi collegati ai recettori orientati verso di loro, che possono trovarsi sia nel nucleo della cellula che sulla sua superficie.
Un'altra caratteristica degli ormoni è che il livello delle sostanze biologicamente attive fluttua costantemente e nelle donne dipende non solo dall'età, ma anche dall'ora del giorno; ciclo mensile.
Funzioni dell'ipotalamo
Le sostanze biologicamente attive prodotte dall'ipotalamo sono neuroormoni: questa parte del cervello, oltre a regolare il funzionamento del sistema endocrino, è anche strettamente connessa con il sistema nervoso centrale. Quando stimoli esterni o interni influenzano determinati recettori, i segnali a riguardo vengono immediatamente inviati alla centrale sistema nervoso, vengono captati dall'ipotalamo e reagiscono producendo alcuni neuroormoni.
Alcuni di essi sono progettati per stimolare la sintesi degli ormoni della ghiandola pituitaria anteriore, noti come ormoni di rilascio. Altri svolgono la funzione opposta: quando l'ipotalamo riceve un segnale per ridurre la sintesi degli ormoni ipofisari, inizia a produrre statine, che ne inibiscono la produzione.
Il terzo gruppo di sostanze biologicamente attive prodotte dall'ipotalamo sono chiamati ormoni del lobo posteriore della ghiandola pituitaria. Questi includono vasopressina e ossitocina. Il primo regola l'escrezione dell'acqua da parte dei reni, il secondo influenza il comportamento sessuale umano, favorisce la contrazione dell'utero durante il parto e rimuove il latte dal seno, che si forma sotto l'influenza della prolattina, un ormone ipofisario.

Entrano ossitocina e vasopressina Indietro ghiandola pituitaria, dove rimangono per qualche tempo. Quando si accumula una certa quantità, entrano nel flusso sanguigno e iniziano a svolgere le loro funzioni, regolando la produzione di ormoni da parte degli organi controllati dall'ipotalamo.
Quindi, appare lo schema dell'ipotalamo nel seguente modo. Sotto l'influenza di vari processi che si verificano all'interno del corpo o durante ambiente esterno, l'ipotalamo aumenta la produzione di ormoni che, entrando nella ghiandola pituitaria, stimolano la produzione di alcune sostanze biologicamente attive.
Quelli, a loro volta, vengono inviati alle ghiandole, il cui lavoro hanno lo scopo di controllare e, stimolandole, aumentano la sintesi degli ormoni, che, dopo essere stati rilasciati nel sangue, vengono inviati agli organi bersaglio, si legano ai recettori destinati a loro, penetrano nella cellula, provocando le reazioni desiderate.
Un processo simile si verifica quando è necessario ridurre la produzione di ormoni. Dopo che l'ipotalamo riduce la sintesi dei neuroormoni, smettono di stimolare le cellule bersaglio, il che porta ad una diminuzione dell'attività delle ghiandole sotto il suo controllo.
Il lavoro della ghiandola pituitaria
L'organo centrale del sistema endocrino è la ghiandola pituitaria. È attraverso di esso che l'ipotalamo agisce sulle ghiandole endocrine e a secrezione mista. L'effetto esatto degli ormoni del lobo anteriore della ghiandola pituitaria sul loro lavoro può essere monitorato nella seguente tabella:
| Ormone ipofisario | Impatto |
| Stimolante della tiroide (TSH) | Controlla il funzionamento della ghiandola tiroidea, influenzandone i recettori e, a seconda della situazione, riducendo/aumentando la produzione di triiodotironina e tiroxina prodotte dalla ghiandola tiroidea. |
| Adrenocorticotropo (ACTH) | Interagisce con la corteccia surrenale, influenzando principalmente la produzione di cortisolo, cortisone e corticosterone. Insieme a loro aumenta contemporaneamente la produzione di androgeni ed estrogeni da parte delle ghiandole surrenali. |
| Somatropico | Influisce direttamente sullo sviluppo e sulla crescita lineare di una persona, sul rinnovamento cellulare, sul loro sviluppo, accelera la sintesi proteica, favorisce la scomposizione dei grassi e la formazione di glucosio. |
| Prolattina | Si attiva durante la gravidanza, preparando le ghiandole mammarie all'allattamento, e favorisce la formazione del latte dopo il parto. |
Inoltre, gli ormoni ipofisari sono responsabili della funzione riproduttiva umana. Nelle donne, sotto l'influenza dell'ormone follicolo-stimolante, inizia la prima fase del ciclo mensile. L'FSH favorisce la maturazione dell'ovulo nel follicolo, aumenta la quantità di estrogeni e inizia a preparare il corpo alla gravidanza.
Nella seconda metà del ciclo viene in primo piano l’ormone luteinizzante (LH). Quando il suo valore contemporaneamente all'FSH raggiunge i valori massimi, ciò provoca l'ovulazione (il rilascio di un ovulo dal follicolo). Quindi, sotto la sua influenza, si forma il corpo luteo, che inizia a produrre progesterone e continua a preparare il corpo al concepimento.
 Nel corpo maschile, FSH e LH regolano la sintesi del testosterone. L'FSH influenza le cellule del Sertoli, inducendole a produrre proteine leganti gli androgeni, che trasportano il testosterone alle cellule germinali. Colpisce anche la produzione di peptidi che aumentano la sensibilità dei recettori delle cellule di Leiding all'ormone luteinizzante, che attiva la produzione di testosterone. Quanto all'LH, stimola la sintesi dell'ormone maschile da parte delle cellule responsabili di ciò.
Nel corpo maschile, FSH e LH regolano la sintesi del testosterone. L'FSH influenza le cellule del Sertoli, inducendole a produrre proteine leganti gli androgeni, che trasportano il testosterone alle cellule germinali. Colpisce anche la produzione di peptidi che aumentano la sensibilità dei recettori delle cellule di Leiding all'ormone luteinizzante, che attiva la produzione di testosterone. Quanto all'LH, stimola la sintesi dell'ormone maschile da parte delle cellule responsabili di ciò.
Ormoni di base
La ghiandola endocrina più grande è la tiroide: la sua lunghezza nell'adulto va da 2,5 a 3 cm. La ghiandola tiroidea si trova nella parte inferiore del collo e sintetizza gli ormoni contenenti iodio (tiroide) e la calcitonina.
Le sostanze prodotte dalla ghiandola tiroidea prendono parte a tutti i processi vitali del corpo: lo sviluppo, la crescita, lo stato fisico e mentale di una persona dipendono dal loro corretto funzionamento. Con una carenza di ormoni tiroidei l'intelligenza si deteriora; se un bambino nasce con una patologia, se la terapia non viene intrapresa tempestivamente, svilupperà cretinismo o demenza.
Un gran numero di tipi diversi gli ormoni sono prodotti dalle ghiandole surrenali. La maggior parte delle sostanze che producono sono responsabili della risposta tempestiva del corpo a situazioni stressanti e pericolose per la vita. Una volta attivati, gli ormoni influenzano il corpo in modo tale da dargli ulteriore forza per risolvere situazioni difficili: i vasi sanguigni si restringono, la pressione sanguigna aumenta, la frequenza cardiaca accelera e aumenta il livello di glucosio, da cui il corpo estrae energia.
La midollare del surrene produce adrenalina e norepinefrina, che consentono, nei momenti di pericolo, di prendere rapidamente decisioni e superare ostacoli che una persona normalmente non sarebbe in grado di superare. La corteccia surrenale produce gli ormoni dello stress, i glucocorticoidi, che sono più attivi in situazioni stressanti ma meno pericolose. Qui vengono prodotti anche gli ormoni sessuali, responsabili della formazione dei caratteri sessuali secondari, che preparano il corpo all'età riproduttiva.

La concentrazione di glucosio nel sangue dipende dal corretto funzionamento del pancreas. Le cellule beta dell'organo, note come isole di Langerhans, producono insulina. Non appena la quantità di glucosio inizia a superare la norma, la sua produzione viene attivata e lo zucchero viene ridotto, altrimenti si sviluppa il diabete. Produce anche un ormone che riduce l'acidità. succo gastrico dopo che il cibo lascia lo stomaco nell'intestino.
Gli ormoni prodotti dalle ghiandole sessuali – androgeni ed estrogeni – svolgono un ruolo enorme nello sviluppo del corpo. Sono responsabili della funzione riproduttiva umana, quindi non solo la capacità di concepire di una persona, ma anche il suo carattere, comportamento e aspetto dipende in gran parte da loro. Se le gonadi li producono quantità insufficiente o in eccesso, questo è irto di infertilità, diminuzione della libido, mancanza di desiderio sessuale e altri problemi.
Da cosa dipende il lavoro degli ormoni?
L'armonia con cui le ghiandole endocrine producono ormoni, interagiscono tra loro e influenzano il funzionamento del corpo dipende da molte ragioni. Dipende innanzitutto dalla salute degli organi che li producono, nonché dalla regolazione del cui lavoro è mirata l'azione degli ormoni.
L'alcol e il fumo hanno un effetto negativo sul funzionamento delle ghiandole endocrine. Avvelenano il corpo, il che influisce negativamente sulla salute umana ed è pericoloso funzione riproduttiva: i figli di alcolisti hanno spesso difetti di sviluppo, malattie gravi, demenza.
Affinché il corpo funzioni correttamente e in modo armonioso, è necessario monitorare la propria salute. Se i risultati dei test mostrano deviazioni delle sostanze biologicamente attive dalla norma, è necessario determinarne la causa. Ad esempio, la mancanza o l’eccesso di androgeni, estrogeni e ormoni tiroidei è spesso causa di infertilità. Le malattie del pancreas possono causare il diabete; in molti casi è impossibile eliminarlo completamente, soprattutto nella forma insulino-dipendente.
Il livello degli ormoni cambia sempre con lo sviluppo di un adenoma, un tumore benigno che inizia a sintetizzare ulteriormente sostanze biologicamente attive. Tumore maligno, a seconda del tipo cellule cancerogene, può aumentare o diminuire la produzione di ormoni. In questo caso il trattamento deve essere iniziato immediatamente.
Conoscere i propri livelli ormonali è importante per una donna tanto quanto monitorare il peso, la pressione sanguigna e l'emoglobina. I tuoi livelli ormonali determinano il tuo aspetto e le tue sensazioni. Diamo uno sguardo più da vicino al ruolo svolto dagli ormoni nel corpo di una donna.
Cosa sono gli ormoni?
Gli ormoni sono sostanze natura organica, dotato di elevata attività fisiologica, destinato a controllare le funzioni e regolare i principali sistemi dell'organismo. Vengono secreti dalle ghiandole endocrine e rilasciati nel flusso sanguigno del corpo e viaggiano attraverso il flusso sanguigno fino alla loro “destinazione”, cioè agli organi a cui è direttamente diretta la sua azione. Lo stesso ormone può avere più organi verso i quali è diretta la sua azione.IN corpo sano deve esserci un equilibrio ormonale dell'intero sistema endocrino nel suo insieme (tra le ghiandole endocrine, il sistema nervoso e gli organi su cui è diretta l'azione degli ormoni). Se il funzionamento di uno dei componenti del sistema endocrino viene interrotto, il funzionamento dell'intero corpo, compreso il sistema riproduttivo, cambia, quindi la capacità di concepire diminuisce.
Maggiori informazioni sugli ormoni
Estrogeni prodotto nelle ovaie. Fino all'adolescenza, questo ormone viene secreto in piccole quantità. Con l'inizio della pubertà, salto improvviso produzione di estrogeni - nelle ragazze, il seno si forma, la figura acquisisce una piacevole forma arrotondata. Gli estrogeni accelerano il processo di rinnovamento cellulare nel corpo, riducono la secrezione sebo, preserva l'elasticità e la giovinezza della pelle, dona lucentezza e volume ai nostri capelli. Questo ormone, importante per l'organismo femminile, protegge tra l'altro i vasi sanguigni dai depositi. placche di colesterolo, e, quindi, previene lo sviluppo dell'aterosclerosi.L'eccesso di estrogeni può causare un eccessivo senso di pienezza nella parte inferiore dell'addome e nelle cosce. Inoltre, i medici associano vari tumori benigni a un eccesso di questo ormone femminile.
La sua carenza spesso provoca un aumento della crescita dei peli in luoghi indesiderati: sul viso, sulle gambe, sulle braccia. Se manca questo ormone, la donna invecchia più velocemente: la pelle è più soggetta a rughe e sbiadimento, i capelli diventano opachi e senza vita, ecc.
Questo ormone viene somministrato il 3-7° giorno del ciclo (a seconda dello scopo dello studio). Lo studio viene effettuato a stomaco vuoto.
Estradiolo- ha un effetto su tutti gli organi femminili, favorisce lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari: la formazione delle ghiandole mammarie, la distribuzione Grasso sottocutaneo, l'emergere della libido. Il suo ruolo è particolarmente importante nello sviluppo della mucosa uterina e nella sua preparazione alla gravidanza: la crescita dello strato funzionale dell'utero, che raggiunge il suo spessore massimo entro la metà del ciclo. Questo ormone viene secreto dal follicolo in maturazione, dal corpo luteo dell'ovaio, dalle ghiandole surrenali e persino dal tessuto adiposo sotto l'influenza di FSH, LH e prolattina. Nelle donne, l'estradiolo garantisce la formazione e la regolazione della funzione mestruale e lo sviluppo dell'ovulo. L'ovulazione avviene 24-36 ore dopo un picco significativo di estradiolo. Dopo l'ovulazione, il livello dell'ormone diminuisce e si verifica un secondo aumento di ampiezza minore. Poi c'è una diminuzione della concentrazione dell'ormone, che continua fino alla fine della fase luteinica. L'estradiolo è responsabile dell'accumulo di grasso nel corpo femminile, anche durante la gravidanza.
Produzione insufficiente di estradiolo nelle donne età fertile può manifestarsi come vampate di calore, disturbi autonomici, aumento pressione sanguigna, come avviene durante la menopausa fisiologica. Oltre a questo, lo svantaggio di questo ormone minaccia la crescita eccessiva dei capelli tipo maschile, approfondimento della voce, mancanza di mestruazioni.
Tuttavia, un eccesso di estradiolo lo è brutto segno. Forte aumento gli estrogeni possono portare alla formazione processi tumorali negli organi del sistema riproduttivo femminile. Ecco perché è necessario un monitoraggio regolare di questo ormone e, a seconda delle indicazioni mediche, può essere assunto durante l'intero ciclo ormonale.
Ormone follicolo stimolante (FSH) regola l'attività delle gonadi: favorisce la formazione e la maturazione delle cellule germinali (uova e sperma), influenza la sintesi degli ormoni sessuali femminili (estrogeni). Se c'è una carenza nella produzione di questo ormone, si notano malattie della ghiandola pituitaria e incapacità di concepire.
Concentrazione massima L'FSH si osserva a metà del ciclo, che porta all'ovulazione. Questo ormone viene somministrato dal 2 all'8 (a seconda dello scopo dello studio) giorno del ciclo. Allo stesso tempo, per determinare la crescita del follicolo, è più consigliabile assumere questo ormone nei giorni 5-7 del ciclo. Lo studio viene effettuato a stomaco vuoto. 3 giorni prima dello studio è necessario escludere forte esercizio fisico, entro 1 ora prima - fumo e stress emotivo.
Ormone luteinizzante (LH)- garantisce il completamento del processo di maturazione dell'ovulo nel follicolo e dell'ovulazione (il rilascio di un ovulo femminile maturo dall'ovaio), la formazione del “corpo luteo” con la secrezione dell'ormone progesterone.
L'ormone luteinizzante (LH) viene somministrato allo stesso modo dell'FSH nei giorni 3-8 del ciclo mestruale. Lo studio viene effettuato a stomaco vuoto.
Progesterone- questo ormone è coinvolto nella maturazione e nella preparazione dell'utero alla gravidanza, sotto la sua influenza la mucosa dell'utero “si scioglie” e “si idrata”. In generale, il progesterone è “l'ormone delle donne incinte” ed è attivamente coinvolto nello sviluppo dell'ovulo e nel suo posizionamento nell'utero; Inoltre, il progesterone colpisce il sistema nervoso, le ghiandole sebacee e mammarie.
Quando il suo livello diminuisce nella seconda metà del ciclo mestruale, la donna avverte qualche disagio: possono comparire dolore al basso ventre e alle ghiandole mammarie, irritabilità, pianto e talvolta depressione.
Quando i livelli di progesterone sono bassi, manca l’ovulazione. Possono verificarsi lunghi ritardi e problemi con il concepimento e la gravidanza. Un aumento del progesterone può provocare la formazione di una cisti del corpo luteo e irregolarità mestruali. Questo ormone viene studiato nei giorni 19-21 del ciclo mestruale. Si consiglia di condurre lo studio a stomaco vuoto.
Testosterone- ormone sessuale maschile, prodotto dalle ovaie e dalle ghiandole surrenali nelle donne. Una diminuzione dei livelli di testosterone può causare irregolarità mestruali, sudorazione eccessiva e pelle grassa. Quando ce n'è in eccesso, puramente caratteristiche maschili: peli sul viso e sul petto, abbassamento della voce. Donne con aumento del testosterone di solito hanno una corporatura maschile: altezza media, bacino stretto, spalle larghe.
Superare il livello di questo ormone è pericoloso per le donne incinte, poiché può causare un aborto spontaneo precoce. La concentrazione massima di testosterone è determinata nella fase luteale e durante il periodo dell'ovulazione, cioè nella prima metà del ciclo mestruale. Si consiglia di effettuare lo studio nei giorni 3-7 del ciclo mestruale, a stomaco vuoto.
Ormone prolattina secreto dalla ghiandola pituitaria. Assicura la crescita e l'ingrossamento delle ghiandole mammarie, la produzione di latte durante l'allattamento. I livelli di prolattina subiscono un evidente cambiamento periodico durante il giorno: un aumento durante la notte (associato al sonno) e una successiva diminuzione. Un aumento della prolattina si osserva anche durante una serie di condizioni fisiologiche, ad esempio durante l'alimentazione, la tensione muscolare, lo stress, i rapporti sessuali, la gravidanza, periodo postpartum, stimolazione del seno. Per determinare il livello di questo ormone è importante fare un'analisi nella fase follicolare (2-6 giorni del ciclo) e luteinica del ciclo mestruale (21 giorni del ciclo) rigorosamente a stomaco vuoto e solo in Mattina. Immediatamente prima del prelievo il paziente deve restare a riposo per circa 30 minuti, poiché la prolattina è un ormone dello stress: l'ansia o anche una leggera attività fisica possono influenzarne il livello.
Durante la fase luteale, i livelli di prolattina sono più alti che durante la fase follicolare. Livello aumentato L'ormone prolattina può causare dolore alle ghiandole mammarie prima e durante le mestruazioni e persino lo sviluppo della mastopatia. Aumento patologico Questo ormone blocca l'ovulazione e quindi interferisce con il concepimento.
Ormoni androgeni- principalmente ormoni maschili, ma sono prodotti anche in piccole quantità nelle donne, responsabili della libido e dello sviluppo del tessuto osseo e muscolare, della maturazione dei follicoli nelle ghiandole ovariche. Con un aumento della concentrazione di ormoni androgeni, si verificano spesso disfunzione ovarica e infertilità; maggiore crescita peli sul corpo di una donna, crescita dei capelli “di tipo maschile”, abbassamento della voce. Con la carenza di androgeni nel corpo femminile, la vitalità diminuisce.
Tutti gli ormoni androgeni vengono rilasciati nei giorni 2-8 del ciclo mestruale. Lo studio viene effettuato a stomaco vuoto.
Va inoltre ricordato che, oltre a ormoni riproduttivi, anche altri ormoni prendono parte alla regolazione del ciclo mestruale, perché nel corpo esiste un'interdipendenza funzionale tra molte ghiandole endocrine. Queste connessioni sono particolarmente pronunciate tra la ghiandola pituitaria, le ovaie, le ghiandole surrenali e la tiroide. Nelle donne con grave ipo e iperfunzione della tiroide, la funzione mestruale è compromessa e talvolta il ciclo mestruale è completamente soppresso.
La ghiandola tiroidea produce due importanti ormoni Tiroxina (T4) E Triioditironina (T3). Questi ormoni regolano i processi metabolici, i carboidrati, le proteine, i processi mentali e funzione sessuale. Ma l'intensità della produzione di questi ormoni è regolata dall'ormone Stimolante della tiroide (TSH), che, come gli ormoni sessuali, è prodotto dalla ghiandola pituitaria. I cambiamenti nella sua concentrazione sono un indicatore di malattie della tiroide.
Se ci sono disturbi nella concentrazione degli ormoni tiroidei, la donna diventa irritabile, piagnucolosa e si stanca rapidamente. Le deviazioni sono estremamente pericolose indicatori ormonali tiroide per le donne in gravidanza e in allattamento.
La diagnosi delle malattie della tiroide viene effettuata a stomaco vuoto. 2-3 giorni prima del prelievo del sangue per l'analisi, si consiglia di interrompere l'assunzione di farmaci contenenti iodio e 1 mese di ormoni tiroidei (salvo istruzioni speciali dell'endocrinologo curante), nonché di limitare l'attività fisica e stress psico-emotivo alla vigilia dello studio.
Tutti questi ormoni influenzano...
In genere, le donne ricordano gli ormoni solo una volta al mese - durante “ giorni critici"quando c'è uno sbalzo d'umore, un aumento dell'appetito, ecc. sintomi spiacevoli. Ma gli ormoni controllano quasi tutti gli aspetti dell’attività del nostro corpo, quindi anche i piccoli squilibri influenzano l’intero corpo. Da loro dipendono l'acutezza del pensiero e la capacità fisica del corpo di far fronte a diversi carichi sul corpo. Influenzano l'altezza e il fisico, il colore dei capelli e il timbro della voce. Controllano il comportamento e il desiderio sessuale. Ha anche un effetto molto forte sullo stato psico-emotivo (variabilità dell'umore, tendenza allo stress). Una produzione insufficiente ed eccessiva di queste sostanze può causare diverse condizioni patologiche, poiché regolano la funzione di tutte le cellule dell'organismo.Motivi della violazione livelli ormonali può variare: a seconda della disponibilità malattie gravi organi e sistemi all’influenza di fattori esterni. Come fattori esterni considerare lo stress, la stanchezza cronica, turni frequenti zone climatiche eccetera. Molto spesso, i disturbi ormonali sono provocati dall'uso irrazionale di farmaci ormonali.
Malattie che possono essere una conseguenza e causa dello sviluppo di uno squilibrio ormonale: fibromi uterini, aterosclerosi, sindrome dell'ovaio policistico, formazioni fibrocistiche nella ghiandola mammaria, emicrania, menopausa precoce.
Se parliamo di giovani donne, lo squilibrio ormonale è, di regola, un'interruzione del funzionamento del corpo e deve essere trattato. Molto spesso, dopo il parto si verifica uno squilibrio ormonale e nella maggior parte dei casi queste anomalie ritornano alla normalità senza ulteriori interventi. Ma lo squilibrio ormonale dopo un aborto richiede attenzione speciale, le sue conseguenze possono essere le più imprevedibili.
Una categoria speciale sono le donne di età superiore ai quaranta anni, quando i disturbi nella produzione ciclica degli ormoni sono causati dall'avvicinarsi della menopausa fisiologica. Durante questo periodo, la formazione delle uova si interrompe gradualmente e la concentrazione dell'ormone estrogeno diminuisce significativamente. Tipicamente, queste anomalie si manifestano con sudorazione notturna, irritabilità, grave affaticamento, maree. Questa condizione è ben compensata dalla terapia ormonale sostitutiva, contro la quale le manifestazioni cliniche sono ridotte al minimo. In questo caso, lo squilibrio ormonale stesso è causato da fattori naturali, quindi non può essere curato.