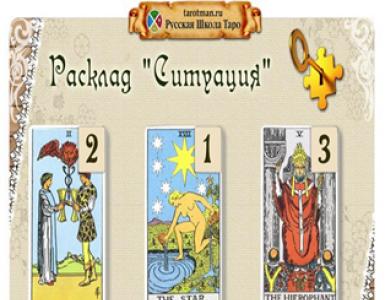Scale di valutazione dell'intensità del dolore. Scala del dolore nella medicina estrema
Nome dell'inventore:
Adashinskaya G.A. (RU), Meizerov E.E. (RU), Fadeev A.A. (RU)
Nome del titolare del brevetto:
Adashinskaya Galina Alekseevna (RU), Meizerov Evgeniy Emelyanovich (RU), Fadeev Alexander Alekseevich (RU)
Indirizzo di posta:
117279, Mosca, st. Miklouho-Maklaya, 55a, CJSC "Ditta "Centro per i servizi brevettuali", brevetto. p. G.G. Sluzhenko
Data di inizio del brevetto:
11.08.2003
Il know-how di sviluppo, ovvero questa invenzione dell'autore, si riferisce al campo della medicina, in particolare alla psicologia medica. Il paziente viene testato su sette scale: frequenza, durata, intensità, percezione sensoriale del dolore, attitudine emotiva al dolore, livello di nevroticismo, livello di adattabilità, e i risultati vengono valutati sulle scale elencate da 0 a 6 punti. In questo caso, le scale della percezione sensoriale e dell'atteggiamento emotivo, i livelli di nevroticismo e l'adattabilità vengono valutate secondo le tabelle riportate nella descrizione. Inoltre, la gravità della componente psicogena del dolore viene valutata dalla scelta del colore da parte del paziente in base ad almeno tre scelte dell'intensità del suo dolore: "dolore al momento del test", "nessun dolore", "dolore forte" secondo con le tabelle riportate nella descrizione. Successivamente, i risultati del test valutano la gravità Dolore paziente qualitativamente e quantitativamente. Allo stesso tempo, su una scala di frequenza, la comparsa del dolore viene valutata da “il dolore appare una volta ogni pochi giorni o meno spesso” a “dolore costante”. Su una scala di durata, il dolore viene classificato da “dolore transitorio” a “dolore costante”. La scala dell’intensità del dolore varia da “dolore molto lieve” a “dolore insopportabile”. Sulla scala del livello di nevroticismo, il principale fattori comportamentali- ansia, labilità emotiva, aggressività, depressione, psicogenia, ipocondria. Il metodo consente di aumentare l'affidabilità della valutazione del dolore, che si ottiene espandendo la descrizione verbale del dolore.
DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE
La presente invenzione riguarda la medicina, la psicologia medica e può essere utilizzata per la valutazione differenziata delle condizioni di un paziente durante Assistenza psicologica per scopi di ricerca. L'uso del metodo di valutazione del dolore verbale-proiettivo è indicato per una valutazione rapida del dolore di varia origine con lo scopo di diagnosi differenziale e chiarimenti diagnosi terapeutica, con lo scopo di selezione individuale metodo e tattica della terapia del dolore, al fine di compilare schemi individuali analgesia dell'agopuntura ed effetti riflessi terapeutici, nonché per valutare la dinamica del trattamento e l'efficacia dei farmaci.
Misurare il dolore sembra essere un insieme complesso di problemi. La percezione individuale del dolore è influenzata da fattori demografici, sesso, età, caratteristiche etniche, nonché emotive e stato fisico paziente. Inoltre, l'insorgenza del dolore è strettamente correlata al sociale e fattori psicologici. Le difficoltà che i pazienti incontrano nel descrivere la loro condizione complicano la diagnosi, soprattutto se il dolore è di natura psicogena. Questi pazienti vengono sottoposti a numerosi ulteriori studi diagnostici e terapeutici. La mancanza di criteri chiari per la sensazione del dolore e di metodi per misurare il dolore porta a frequenti errori diagnostici, esperti e deontologici.
Per la valutazione qualitativa e quantitativa del dolore, metodi psicologici, tenendo conto del fattore di autovalutazione soggettiva del dolore da parte del paziente, nonché dell'analisi del medico delle componenti comportamentali e affettive del dolore.
Questi metodi includono l’autovalutazione da parte del paziente dell’intensità del dolore su una scala di valutazione a 5 punti, dove 1 punto significa lieve, dolore lieve, e 5 punti - dolore insopportabile. Un altro modo per valutare l’intensità del dolore è il metodo visivo. scala analogica, secondo il quale, ad esempio, su una linea retta lunga 10 cm con valori estremi di "nessun dolore" - "il dolore è molto forte", il paziente nota l'intensità del dolore (Korolenko T.P., Pavlenko S.S. Oggettivazione del dolore e la sua valutazione. // Rivista "Il dolore e il suo trattamento", 1995, n. 2, pp. 7-9).
Il più vicino nell'essenza tecnica all'invenzione proposta è un metodo per valutare il dolore utilizzando il McGill Pain Questionnaire (ibid.). Il questionario viene compilato dal paziente insieme al medico e riflette i sentimenti e le sensazioni del paziente questo momento. Il questionario è composto da 102 parole - determinanti del dolore - descrittori. Tutti i descrittori sono divisi in quattro classi:
1. Una classe di descrizioni sensoriali del dolore in termini temporali e spaziali, in termini di pressione, temperatura, ecc.
2. Una classe di descrizioni affettive (emotive) del dolore in termini di tensione, paura e manifestazioni vegetative.
3. Una classe di definizioni valutative del dolore, che riflettono una valutazione soggettiva del dolore sperimentato.
4. Classe di varie descrizioni del dolore.
Queste classi sono divise in 20 sottoclassi, costituite da parole simili nel significato, ma che differiscono per l'intensità del dolore che trasmettono o per sfumature particolarmente importanti per il paziente.
Ad ogni parola descrittiva viene assegnato un valore numerico corrispondente alla sua posizione nella sottoclasse e la loro somma costituisce l'indice del tipo di dolore. Il questionario contiene anche una valutazione generale dell'intensità del dolore al momento dello studio, definita come un numero da 0 a 5, associato alle seguenti parole: 0 - nessun dolore, 1 - lieve, leggero dolore, 2 - sensazione di disagio, 3 - dolore irritante, 4 - dolore terribile, terribile, 5 - dolore insopportabile, insopportabile.
Nonostante il fatto che quando si elaborano le scale di riflessione sensoriale ed emotivo-affettiva del dolore, indicatore quantitativo, non riflette la specificità della sindrome dolorosa del paziente e non corrisponde alla gravità della condizione. Quindi, ad esempio, tre caratteristiche selezionate del dolore: indifferente, non disturbante e insignificante danno gli stessi significati della scelta di tre definizioni, come spaventoso, tormentoso, terribile. Ciò è dovuto al fatto che i punti sulla scala vengono calcolati solo in base al numero di parole selezionate, ad es. senza tener conto del loro significato semantico. Il questionario utilizzato non tiene conto delle differenze valutazione soggettiva dolore per uomini e donne. Questo metodo di valutazione non contiene una mappa della localizzazione del dolore, che consente di riflettere l'argomento e la migrazione del dolore sul corpo umano. Inoltre, il metodo non consente di valutare i cambiamenti nel comportamento del paziente e il grado in cui la comparsa del dolore dipende da fattori ambiente esterno.
La presente invenzione si basa sul compito di sviluppare un metodo per la valutazione del dolore che fornisca una valutazione qualitativa e quantitativa della condizione dei pazienti con varie forme sindrome del dolore espandendo la descrizione verbale del dolore, riflettendo il livello conscio della percezione del dolore, e utilizzo simultaneo un simbolo di colore non verbale, la cui scelta associativa riflette il livello subconscio della percezione del dolore.
Il problema è risolto dal fatto che nel metodo di valutazione del dolore mediante test:
Il paziente indica l'area di localizzazione del dolore sul corpo, che serve per determinare l'area interessata dal dolore, che consente di determinare l'argomento del dolore significativo per fare una diagnosi e il grado della sua distribuzione;
Rileva almeno una caratteristica indicata sulla scala di valutazione verbale che determina la frequenza del dolore;
Seleziona almeno una delle definizioni della durata degli attacchi di dolore indicate nella scala di valutazione verbale;
Seleziona almeno una delle definizioni di intensità del dolore (la componente conscia della percezione del dolore) e almeno due colori, uno di preferenza e l'altro di rifiuto, da una scala di valutazione dell'intensità del dolore verbale basata sui colori di preferenza precedentemente identificati /rigetto a seconda dell'intensità del dolore e della forma della sindrome dolorosa gruppi diversi pazienti (la scelta associativa del colore riflette l'atteggiamento nei confronti del dolore associato al livello subconscio della percezione del dolore);
Fornisce una risposta positiva o negativa a ciascuna delle affermazioni incluse sia nella scala del nevroticismo e tenendo conto dei principali fattori comportamentali, il cui cambiamento è associato alla presenza di una sindrome dolorosa nel paziente, sia nella scala della menzogna, che determina il grado di sincerità del paziente;
Seleziona almeno uno dei fattori in ciascuna delle scale di modalità che identificano i fattori ambientali che provocano o intensificano il dolore;
Allo stesso tempo, i questionari di prova per valutare la percezione sensoriale e l'atteggiamento emotivo nei confronti del dolore contengono, rispettivamente, 46 e 25 parole descrittive, ciascuna delle quali ha il proprio coefficiente di ponderazione dell'intensità del dolore in punti ottenuti nel corso della nostra ricerca, riflettendo la semantica significato del descrittore e differenze di genere nella percezione del dolore;
Il numero di punti viene calcolato utilizzando le scale e, sulla base dei risultati del test, viene presentata una valutazione integrale quantitativa e qualitativa della sensazione di dolore.
Nel metodo proposto, il dolore è inteso come un fenomeno complesso a più livelli che interessa vari livelli riflessione mentale: percettivo, emotivo; cognitivo, comportamentale. Processo difficile sensazioni, percezioni ed esperienze di dolore sono considerate incluse nel contesto di altre formazioni mentali e forme di attività del soggetto. Nel processo di ontogenesi, una persona assimila forme di manifestazione e percezione della fisicità culturalmente sviluppate, inclusa la malattia, pertanto i fenomeni psicosomatici possono essere compresi e considerati come complesse formazioni funzionali mentali mediate dai segni. Il colore ha un certo significato per una persona, sia biologico che sociale, e il significato del colore rimane abbastanza stabile, il che ci consente di considerarlo come portatore del codice della relazione tra soggetto e oggetto. Questa situazione si riflette nei fenomeni di preferenza e rifiuto del colore a seconda dell'intensità del dolore, nella somiglianza della scelta del colore per la sindrome del dolore somatogeno neurogeno, per il dolore acuto non patogeno nei bambini e nei soggetti sani e nella perversione del colore per la sindrome del dolore psicogeno .
Nel metodo secondo l'invenzione, per la prima volta, gli autori utilizzano:
Identificata categorizzazione cromatica semantica delle sensazioni di dolore intracettivo negli esseri umani, presentata sotto forma di scale di preferenza/rifiuto del colore a seconda dell'intensità del dolore e della forma della sindrome del dolore;
La somiglianza stabilita dei modelli di preferenza/rifiuto del colore dipende dall'intensità del dolore nei pazienti con neurogenicità, somatogenesi sindromi dolorose, nei bambini con dolore acuto non patogeno e persone sane, rappresentato per il dolore di elevata intensità - nero e grigio, per il dolore di moderata intensità - marrone e rosso, in assenza di dolore - giallo e verde;
Il fenomeno identificato della perversione del colore, identificato nei pazienti con sindrome da dolore psicogeno quando scelgono un colore in base all'intensità del dolore. Le preferenze di colore in questo gruppo sono rappresentate in caso di dolore di intensità elevata e moderata - giallo, viola, rosso, in assenza di dolore - grigio, verde.
Differenze di genere rivelate nella percezione del dolore negli uomini e nelle donne: a) autovalutazione delle sensazioni intracettive del dolore, b) autovalutazione dell'atteggiamento emotivo nei confronti del dolore, c) scelta quantitativa dei descrittori nella descrizione del dolore, d) manifestazioni di reazioni rabbiose a seconda della forma della sindrome dolorosa.
Sulla base dei fenomeni di somiglianza e perversione dei colori, nonché delle differenze di genere nella percezione del dolore identificate durante lo studio, gli autori hanno sviluppato per la prima volta un metodo rapido completo per valutare il dolore utilizzando il colore e scale verbali, che consente di identificare i pazienti con dolore con un alto grado di probabilità natura psicogena; prendere in considerazione per la prima volta le differenze di genere nella percezione del dolore; determinare quantitativamente (in punti/percentuale) la gravità delle componenti della sindrome del dolore su 7 scale, che coprono diversi livelli di dolore vissuti da una persona:
Nocicezione: scala di localizzazione del dolore, 1a scala di frequenza del dolore, 2a scala di durata del dolore, 3a scala di intensità del dolore verbale-colore;
Sensazione di dolore - 4a scala di percezione sensoriale del dolore;
Esperienza del dolore - 5a scala dell'atteggiamento emotivo al dolore;
Comportamento doloroso - 6a scala del nevroticismo e 0 scala della menzogna;
Livello di adattabilità - 7a scala di modalità, che rivela la dipendenza della gravità del dolore dall'ora del giorno, condizioni climatiche, dalla posizione corporea, dalle condizioni nutrizionali, dai fattori di stress;
Sulla base dei risultati dei test, viene presentata una valutazione integrale della sensazione di dolore.
 |
Il metodo proposto per la valutazione del dolore differisce in modo significativo da metodi conosciuti valutazione del dolore, poiché per la prima volta riflette contemporaneamente le caratteristiche della percezione del dolore di una persona diversi livelli psiche - nocicezione (sensibilità al dolore), percezione, emozioni, comportamento, adattabilità; consente per la prima volta una descrizione soggettiva della sensazione di dolore, tenendo conto delle differenze nella percezione del dolore da parte di uomini e donne, nonché di sistematizzarla in scale di fattori secondo le idee sulla manifestazione multidimensionale del dolore e quantificare la gravità di tutte le componenti della sindrome dolorosa in punti/percentuali su 7 scale. Per la prima volta, contemporaneamente alla descrizione verbale del dolore, il metodo creato utilizza un simbolo non verbale: il colore, così come i risultati ottenuti dagli autori criteri diagnostici scegliere o rifiutare un colore a seconda della forza del dolore e della forma della sindrome dolorosa. Per la prima volta, sulla base di questi criteri, sono state create scale cromatiche del dolore per le sindromi dolorose di vari agenti patogeni ed è stata sviluppata una scala verbale-cromatica per valutare l'intensità del dolore, consentendo una diagnosi differenziale espressa a seconda dell'appartenenza della sindrome dolorosa al dolore psicogeno. Pertanto, l'uso di un metodo per valutare il dolore consente al medico, già nelle prime fasi della diagnosi, di identificare il dolore di natura psicogena con un alto grado di probabilità, di ottenere una valutazione olistica, tenendo conto delle differenze di genere nella gravità dei componenti della sindrome del dolore su vari livelli la percezione del dolore da parte della persona, che ha importante quando si sceglie un metodo e una tattica di terapia del dolore. L'invenzione viene ulteriormente spiegata esempi concreti la sua realizzazione e i disegni allegati, sui quali: La Fig. 1 mostra un diagramma di una persona (vista posteriore) che indica l'area di localizzazione del dolore; Fig.2 - profilo del dolore del paziente L.; Fig.3 – modello dinamico – indicatore percentuale del dolore totale; Fig.4 - Profilo del dolore in pazienti neurologici prima e dopo un ciclo di neurostimolazione elettrica dinamica. Il metodo di valutazione del dolore secondo l'invenzione viene eseguito come segue. Prima dell’inizio del test, al paziente viene spiegata l’importanza dello studio. La scelta delle definizioni di dolore viene effettuata in sequenza da una scala all'altra. Prima di iniziare a lavorare con ciascuna scala, il suo contenuto viene spiegato al paziente o al soggetto del test e solo dopo che diventa evidente che il paziente ha capito tutto correttamente, iniziano i test. Nocicezione. Mappa della localizzazione del dolore. La scala è un diagramma del corpo umano da diverse angolazioni (anteriore, posteriore e laterale) e consente di indicare su di essa l'area di localizzazione del dolore e determinare la zona interessata dal dolore; indicare i punti di irradiazione del dolore verso altre parti del corpo; determinare dinamicamente i cambiamenti nell'area corporea associata al dolore, nonché identificare il tema della migrazione del dolore. Calcolo dei risultati. Per determinare l'area del dolore, vengono contati i metri quadrati completi. unità incluse nell'area del dolore, vengono contati i quadrati incompleti. unità, questo numero viene diviso per 2 e di conseguenza viene calcolata la somma: S dolore = S ni + S kj/2, dove S ni è la somma dei metri quadrati interi. unità, S kj/2 - la somma dei metri quadrati incompleti. unità (Fig. 1). |
 |
|
 |
|
 |
La Figura 1 mostra un esempio di rappresentazione del dolore nel paziente L.: una figura ombreggiata sulla sagoma di una persona è l'area del dolore; zona del dolore: 1 mq. unità. + 5/2 unità mq = 3,5 mq. unità
Nocicezione. 1. Scala della frequenza del dolore, che consente di valutare la frequenza del dolore e riflettere la dinamica dei suoi cambiamenti.
La base di misurazione della scala è una scala di valutazione verbale, che consente di valutare la frequenza del dolore da “il dolore appare una volta ogni pochi giorni” a “il dolore è costante”.
Il paziente seleziona e annota quelle caratteristiche che più corrispondono alla frequenza del suo dolore. Se ha difficoltà a scegliere, sceglie quelle descrizioni del dolore che sono più simili alla frequenza del dolore in lui o seleziona diversi indicatori della frequenza del dolore.
| Tabella 1 | ||
| Scala di valutazione verbale che determina la frequenza del dolore | ||
| Nocicezione. 1 scala | ||
| Frequenza del dolore | Punti | |
| 1.0 | Nessun dolore | 0 |
| 1.1 | Una volta ogni pochi giorni o meno | 1 |
| 1.2 | Quasi quotidianamente | 2 |
| 1.3 | Quotidiano | 3 |
| 1.4 | Quasi ogni ora | 4 |
| 1.5 | Il dolore è quasi costante | 5* |
| 1.6 | Costante | 6 |
| Un asterisco (*) indica la definizione scelta dal paziente. | ||
Calcolo dei risultati. L'indicatore della frequenza del dolore è il numero di punti indicati nella colonna opposta alla frequenza del dolore selezionata dal paziente.
Frequenza = S mj/n, dove S mj è la somma dei punti che valutano le definizioni selezionate, n è il numero di definizioni selezionate. Nell'esempio proposto, nel paziente L.: Frequenza = 5 punti. I risultati dei test sulla scala di frequenza (1) del verificarsi di attacchi dolorosi sono presentati in Fig. 2
La Figura 2 mostra il profilo del dolore del paziente L. L'ascissa mostra: 0 - scala delle bugie; 1 - scala della frequenza del dolore; 2 - scala della durata del dolore; 3 - scala dell'intensità del dolore; 4 - scala della percezione sensoriale del dolore; 5 - scala dell'atteggiamento affettivo-emotivo al dolore; 6 - scala del nevroticismo; 7 - scala di modalità; somme Il display è un indicatore integrativo delle sensazioni dolorose. Lungo l'asse delle ordinate - media punti dolenti.
Nocicezione 2. La scala dinamica della durata del dolore consente di determinare i cambiamenti nella durata degli attacchi di dolore nel paziente. La base di misurazione della scala è una scala di valutazione verbale, che consente di determinare la durata del dolore da “dolore transitorio” a “dolore costante”.
Il paziente sceglie la definizione di durata del dolore che più si avvicina alle sue sensazioni. Se ha difficoltà a scegliere, sceglie quelle definizioni della durata degli attacchi di dolore che sono più vicine alle sue sensazioni o diverse definizioni adatte.
| Tavolo 2 | ||
| Scala di valutazione verbale che determina la durata degli attacchi di dolore. | ||
| Nocicezione. 2 Scala | ||
| Durata degli attacchi di dolore | Punti | |
| 2.0 | Nessun dolore | 0 |
| 2.1 | Il dolore è fugace | 1 |
| 2.2 | Il dolore è di breve durata | 2 |
| 2.3 | Il dolore dura minuti | 3* |
| 2.4 | Il dolore dura per ore | 4* |
| 2.5 | Il dolore dura per giorni | 5 |
| 2.6 | Il dolore è costante | 6 |
| L'asterisco (*) indica le definizioni scelte dal paziente. | ||
Calcolo dei risultati. Un indicatore della durata del dolore è il numero di punti indicati nella colonna accanto alla durata degli attacchi di dolore scelti dal paziente.
Durata = S mj/n, dove S è la somma dei punti che valutano le definizioni selezionate, n è il numero di definizioni selezionate.
Nell'esempio proposto, nel paziente L. la durata del dolore è (3+4)/2 = 3,5 punti (Fig. 2).
Nocicezione. 3. La scala dell'intensità del dolore verbale-colore consente di determinare la dinamica dell'intensità del dolore del paziente; identificare con un alto grado di probabilità utilizzando la diagnostica espressa a colori il dolore di natura psicogena.
La base di misurazione della scala è una scala di valutazione verbale, che consente di valutare l’intensità del dolore da “dolore molto lieve” a “dolore insopportabile”, nonché la scelta associativa di preferenza/rifiuto del colore a seconda dell’intensità. L'analisi qualitativa nel confrontare le scelte cromatiche del paziente con scale di colori consente di determinare con un alto grado di probabilità la presenza di una predisposizione psicogena alla patologia del dolore e di descrivere il suo modello comportamentale (Tabella 3, 6,17).

Sono stati esaminati complessivamente 5 gruppi: 4 gruppi di pazienti con varie forme di sindrome dolorosa e un gruppo di controllo (persone praticamente sane).
Il gruppo 1 era composto da pazienti con sindrome da dolore neurogeno: 30 persone (14 donne, 16 uomini) di età compresa tra 18 e 70 anni. Il dolore neurogeno è stato studiato utilizzando un modello di sindrome del dolore fantasma - 27 pazienti (11 donne, 16 uomini) e nevralgia facciale nervo trigemino- 3 persone (donne).
Lo sviluppo di sindromi dolorose neurogene è attualmente associato a cambiamenti morfofunzionali sia nel nervo periferico danneggiato che nel sistema nervoso centrale.
Il gruppo 2 era composto da pazienti con sindrome dolorosa somatogena: 34 persone (18 donne, 16 uomini) di età compresa tra 18 e 65 anni. La sindrome del dolore somatogeno è stata presentata: dolore postoperatorio- 3 persone (1 donna, 2 uomini); addominali - 3 persone (1 donna, 2 uomini); dolori articolari- 5 persone (3 donne, 2 uomini); mialgia - 5 persone (1 donna, 4 uomini); dolore vertebrogenico - 7 persone (3 donne, 4 uomini); cefalgia - 11 persone (9 donne, 2 uomini).
Le sindromi dolorose che insorgono come risultato dell'attivazione dei recettori nocicettivi durante lesioni, infiammazioni, ischemia e stiramento dei tessuti sono classificate come sindromi dolorose somatogene.
Il 3o gruppo era composto da pazienti con sindrome da dolore psicogeno - 18 persone (9 donne, 9 uomini) di età compresa tra 18 e 60 anni. La sindrome del dolore psicogeno era rappresentata dalla conversione e disturbi depressivi, identificati nell'ambito di cefalgie (mal di testa da tensione), addominali, mialgie, dolori vertebrogenici. Tutti i pazienti di questo gruppo hanno attraversato un gran numero di esperienze diverse visite mediche, per cui non significativo disturbi fisiologici che può causare dolore costante.
Il gruppo 4 includeva bambini con dolore acuto. Questo gruppo è stato studiato utilizzando un modello complesso trattamento del corso secondo il metodo di I.A. Skvortsov dopo la procedura di iniezione terapeutica (farmacoterapia metamerica iniettabile) - 20 bambini (9 ragazze, 11 ragazzi) di età compresa tra 3 e 10 anni con vari forme di paralisi cerebrale e intelletto intatto.
Il gruppo di controllo comprendeva 64 persone (34 donne, 30 uomini) di età compresa tra 17 e 65 anni, che non avvertivano dolore al momento dell'indagine e senza malattie croniche. Studiando il gruppo di controllo, siamo partiti dal fatto che ogni persona praticamente sana, in un modo o nell'altro, ha una certa esperienza del dolore, che può essere considerata come una forma compressa di percezione del dolore, rappresentata dall'esperienza personale e sociale.
Sono stati esaminati un totale di 166 adulti e bambini (75 donne e 9 ragazze, 71 uomini e 11 ragazzi).
Per la ricerca è stato sviluppato un metodo verbale-colore per la valutazione del dolore, la cui base è stato un questionario sul dolore creato dagli autori, che consente di valutare il dolore utilizzando cinque fattori: scale, un metodo di ridimensionamento (scala visivo-digitale) e un esperimento di associazione dei colori che utilizza il metodo di selezione del colore da otto colori del test Luscher. La procedura di ricerca consisteva nel paziente (soggetto) che selezionava descrittori che descrivevano la natura sensoriale (ad esempio, “tirare”, “premere”, ecc.) ed emotiva (ad esempio, “irritante”, “straziante”, ecc.) della dolore, la loro valutazione su una scala visivo-numerica (da 0 - "nessun dolore" a 6 punti - "dolore insopportabile") a seconda dell'intensità del dolore provato, due scelte di colore - preferenza e rifiuto del colore a seconda dell'intensità del dolore il dolore. Sono stati utilizzati anche metodi diagnostica psicologica- Test Luscher, MMPI, reattivo e ansia personale Spielberger-Hanin, Inventario della rabbia di Spielberger.
Durante l'elaborazione statistica dei dati, sono stati utilizzati metodi di statistica matematica: statistica descrittiva, statistica di Pearson, Wilcoxon, Kendal, Spearman e il metodo della tavola incrociata per l'analisi delle tabelle di contingenza.
Lo studio è stato condotto presso la base ambulatoriale dell'Istituto di riflessologia del Centro scientifico clinico sperimentale federale metodi tradizionali diagnostica e cura del Ministero della Salute russo; V Centro Federale esame e riabilitazione delle persone disabili (Istituto centrale di ricerca di protesi e protesi) M3 della Federazione Russa, nel 3o dipartimento di ortopedia; presso il Centro scientifico e terapeutico per la prevenzione e il trattamento della disabilità psiconeurologica (STC PNI sotto la guida del professore, dottore in scienze mediche I.A. Skvortsov).
Durante lo studio del dolore utilizzando il metodo del colore verbale, in ciascuno dei cinque gruppi, sono stati ottenuti dati sulla frequenza della scelta del colore a seconda dell'intensità del dolore: nel gruppo 1 di pazienti con sindrome da dolore neurogeno, i colori preferiti erano 412 scelte , i colori di scarto erano 512 scelte; nel gruppo 2 di pazienti con sindrome dolorosa somatogena, le preferenze di colore ammontavano a 583 scelte, colori di rifiuto - 617 scelte; nel gruppo 3 di pazienti con sindrome dolorosa psicogena, i colori di preferenza ammontavano a 390 scelte, i colori di rifiuto - 376 scelte; nel gruppo 4 di bambini con dolore acuto non patogeno, i colori di preferenza ammontavano a 173 scelte, i colori di rifiuto - 254 scelte; nel gruppo di controllo, i colori di preferenza ammontavano a 507 scelte, i colori di rifiuto - 556 scelte.
Nel descrivere lo stato di "nessun dolore", i pazienti con sindromi dolorose neurogeniche, somatogene, i bambini con dolore acuto e le persone sane hanno preferito i colori giallo (47,9-55,8%) e verde (33-25%). I pazienti con sindrome da dolore psicogeno “colorano” l’assenza di dolore principalmente in grigio (43%), in meno grado- nei colori verde (17,8%), viola (15,4%). La preferenza per il grigio in assenza di dolore da parte dei pazienti con sindrome dolorosa psicogena è associata a stati di ansia, depressione (astinenza), labilità emotiva (irritabilità), mentre altri sono caratterizzati dal bisogno di azione, coinvolgimento emotivo e ottimismo.
Dolore “molto debole”, dolore “debole” nei gruppi con sindromi dolorose neurogeniche, somatogene, nel gruppo con dolore acuto non patogeno nei bambini sono semanticamente simili, mentre i colori preferiti per il dolore neurogeno e il dolore acuto nei bambini sono viola(32,4% e 30,4%, rispettivamente); nel gruppo con sindrome dolorosa somatogena sono preferiti il grigio (50% - 26%), il verde (15% - 17%) e il giallo (15,4%); nei pazienti con genesi del dolore psicogeno , le preferenze di colore associate al dolore “molto lieve” e “lieve” differiscono; per il dolore “molto lieve”, sono preferiti i colori verde (41,2%), grigio (23,5%) e rosso (17,6%); per il dolore “lieve” - rosso (22%), giallo (17,1%), il gruppo di controllo è caratterizzato anche da una differenza nella scelta del colore per il dolore “fugace” - giallo (30%), verde (24,2%), viola ( 21,2%) colori, per il dolore "lieve" - colori marrone (27,5%), viola (20,3%) e grigio (20,3%).
Le differenze identificate nella percezione del colore del dolore nei pazienti con dolore neurogeno e nei pazienti con dolore di origine somatogena riflettono differenze significative nel loro modello comportamentale del dolore. Pertanto, nei pazienti con dolore fantasma, il dolore “debole” provoca il comportamento labilità emotiva, irritabilità, stress emotivo, nei pazienti con dolore somatico - il comportamento assume un tentativo stenico di proteggersi da stimoli non necessari, per creare una zona di massimo comfort. I bambini con dolore acuto non patogeno sono caratterizzati anche da irritabilità e sbalzi d'umore. I pazienti con dolore psicogeno in questo caso sono caratterizzati da difficoltà di comunicazione e tendenze difensive. Le persone praticamente sane percepiscono il dolore “molto lieve” come uno stato favorevole e lo equiparano allo stato “nessun dolore”; il dolore “lieve” provoca una sensazione di disagio e lieve irritabilità. È interessante notare che nel gruppo di pazienti con sindrome dolorosa psicogena anche “dolore molto lieve” e “nessun dolore” (come nel gruppo di soggetti sani) sono “colorati” con gli stessi colori, cioè tale dolore non cambia il loro comportamento abituale.
Per il dolore di “gravità moderata”, tutti i gruppi sono caratterizzati da uno schema di colori simile: grigio, marrone, rosso/viola: per i pazienti con dolore di origine neurogena, i colori preferiti sono grigio (19%), marrone (19%) e viola (17,2%); per i pazienti con dolore somatogeno la scelta è tra i colori grigio (27,4%), marrone (22,6%) e rosso (19,8%); per i bambini con dolore acuto: colori grigio (25,5%), rosso (25,5) e marrone (20%); per le persone sane - i colori grigio (23,4%), marrone (18,8%) e viola (15,6%), ad eccezione della scelta del colore dei pazienti con dolore psicogeno - sono preferiti, come nel caso del dolore "debole", colori rosso (42,5%) e giallo (16,1%). Pertanto, il dolore di “intensità media” per tutti i gruppi, ad eccezione dei pazienti con dolore psicogeno, provoca uno stato di tensione, affaticamento, brutta sensazione, perdita degli schemi di vita abituali, ansia. Nei pazienti con dolore psicogeno, la precedente tendenza comportamentale - lo stress, manifestata da una pronunciata instabilità emotiva - si intensifica; c'è la sensazione della propria posizione di vittima, la propria parte di colpa viene trasferita agli altri e si manifesta il desiderio di dominio.
Il dolore "grave" nel gruppo di pazienti con dolore neurogeno provoca una preferenza per i colori rosso (38,1%), grigio (17,5%), in pazienti con dolore somatogeno - grigio (27,4%), marrone (23,8%) , rosso (17,6 %) colori, i bambini con dolore acuto non patogeno preferiscono il colore nero (51,6%), il gruppo di controllo - rosso (26,8%), nero (22,3%), grigio (17,9%) e nel gruppo con dolore psicogeno il colore la scelta rimane la stessa: giallo (25,6%), rosso (23,1%), viola (24,4%). Il dolore "grave" provoca aggressività, irritabilità, sensazione di impotenza, stress emotivo, l'emergere di tendenze psicosomatiche nel comportamento dei pazienti con dolore fantasma, nei pazienti con dolore somatico si intensifica componente depressiva nel comportamento, debolezza irritabile, grave disagio fisiologico e aumento dell'ansia; I bambini con dolore acuto sono caratterizzati dalla paura, mentre il gruppo di controllo è caratterizzato dalla comparsa di aggressività, ansia e paura. I pazienti con dolore psicogeno sono caratterizzati da precedenti tendenze comportamentali: incoerenza, ostinazione, autoritarismo, richiesta verso gli altri, repressione ragioni vere conflitto, la tendenza a vedersi nel ruolo di vittima, trasferendo la colpa agli altri.
In caso di dolore “molto grave”, i pazienti con sindrome dolorosa neurogena sono caratterizzati da una preferenza per i colori nero (35,4%), grigio (28,1%) e rosso (22,9%); nel gruppo con sindrome dolorosa somatogena, il nero (41,5 %) %) grigio (22,5%) e rosso (17,6%); per i bambini con dolore acuto, è stata rivelata una preferenza per il nero (50%), nel gruppo di controllo - i colori nero (50%) e rosso (29,6%), che è caratterizzato da uno stato di stress, tensione, possibili reazioni aggressive, resistenza passiva. Nei pazienti con sindrome da dolore psicogeno, il colore e i modelli comportamentali non cambiano: la scelta del colore è giallo (32,9%), rosso (21,9%) e viola (17,8%), tratti caratteriali comportamento - incoerenza, ostinazione, autoritarismo, esigente nei confronti degli altri, repressione delle vere cause del conflitto, tendenza a vedersi nel ruolo di vittima, trasferendo la colpa agli altri.
Il dolore “insopportabile” aumenta la tendenza a preferire il nero per tutti i gruppi: dolore neurogeno - colori nero (64,4%) e grigio (29,7%); dolore somatogeno - nero (74,7%), dolore acuto nei bambini - nero (51,6%); gruppo di controllo: colori nero (49,3%) e rosso (23,9%). Il dolore “insopportabile” provoca paura, ansia, depressione, un tentativo di proteggersi stimolo esterno, alto grado astenia (nera, colore grigio a), ricerca e bisogno di protezione.
Per i pazienti con sindrome da dolore psicogeno, il colore e i modelli comportamentali non cambiano in modo significativo: aumenta la tendenza a preferire i colori giallo (40,4%), rosso (21,3%) e viola (23,4%) e le precedenti tendenze comportamentali si intensificano. Pertanto, possiamo concludere che il dolore per i pazienti di questo gruppo è strettamente correlato alla compensazione per un'attenzione insufficiente nei loro confronti, all'evitamento di risolvere problemi, ecc., E l'assenza di dolore è associata alla paura di perdere l'attenzione, una sensazione di abbandono, delusione. e depressione, che, come è noto, è caratteristica delle malattie di origine psicogena.
Con l'obiettivo di analisi comparativa i risultati della preferenza del colore e delle scelte di rifiuto per ciascun gruppo sono stati sommati e normalizzati in base al numero di pazienti nel gruppo. Per determinare l'affidabilità della somiglianza/differenza dei modelli di colore a seconda della forma della sindrome del dolore, sono stati calcolati i coefficienti di correlazione tra i campioni (gruppi) - sono stati determinati i coefficienti di Kendal e di concordanza (t) correlazione di rango(r) Spearman, che ha permesso di identificare l'affidabilità delle somiglianze/differenze tra le scelte cromatiche a seconda della forma del dolore o dell'assenza di dolore. Una significativa somiglianza nelle scelte di preferenza/rifiuto del colore a seconda della gravità del dolore è stata rivelata tra gruppi di pazienti con sindrome del dolore neurogeno, sindrome del dolore somatogeno, dolore acuto non patogeno nei bambini e il gruppo di controllo. Per ciascuno di questi gruppi con una piccola quota le variazioni nella scelta del colore sono caratterizzate dalle seguenti preferenze di base: "dolore molto forte", "dolore insopportabile" - nero, "dolore moderato", "dolore grave" - grigio rosso, colori marroni, nel caso della scelta del colore del rifiuto, che equivale alla definizione di “nessun dolore”, i colori sono il giallo e il verde.
Secondo le statistiche di Kendel e Spearman, è stata rivelata una correlazione negativa nella scelta del colore tra gruppi di pazienti con dolore neurogeno, somatogeno, acuto non patogeno (nei bambini), il gruppo di controllo e il gruppo di pazienti con dolore di origine psicogena.
Nella scelta associativa del colore quando si valuta l'intensità del dolore per i pazienti con sindrome del dolore psicogeno, sono caratteristiche le perversioni cromatiche: "dolore grave", "dolore molto forte" e "dolore insopportabile" sono "colorati" in giallo, rosso, "dolore moderato" ” - giallo, colore rosso, “nessun dolore” - colore grigio (Tabella 3).
All'interno di ciascun gruppo, sono state rivelate differenze significative nella preferenza del colore a seconda dell'intensità del dolore, che ha permesso di determinare scale cromatiche di intensità del dolore per forme di dolore neurogenico, somatogeno e psicogeno, per dolore acuto non patogeno nei bambini e nelle persone sane .
I fenomeni scoperti di somiglianza delle scelte di colore in pazienti con sindromi dolorose neurogeniche e somatogene, in bambini con dolore acuto e soggetti sani e le differenze nelle scelte di colore in pazienti con sindrome da dolore psicogeno sono stati utilizzati nello sviluppo di una scala di colori verbali questo metodo valutazioni del dolore.
Per condurre test su questa scala, utilizzare un righello colorato contenente otto mini-carte colorate corrispondenti ai colori del test Luscher: 1 - blu, 2 - verde, 3 - rosso, 4 - giallo, 5 - viola, 6 - marrone, 7 - nero, 0 (8) - grigio (Tabella 4). Se non è possibile eseguire protocolli di ricerca in formato colore, vengono utilizzate le test card standard Luscher a 8 colori. Quando si effettua una diagnosi rapida del colore, ogni paziente deve avere almeno tre scelte: la prima scelta è l'associazione del colore al dolore che il paziente avverte al momento del test; la seconda scelta è l'associazione del colore con lo stato in cui “non c'è dolore”; terza scelta: associazioni di colore con il dolore più grave, ad es. con dolore “insopportabile” o “molto grave”.
Il paziente sceglie la definizione dell'intensità (forza) del dolore che lo caratterizza più accuratamente. Se ha difficoltà a scegliere, sceglie le definizioni più vicine ai suoi sentimenti o seleziona diverse definizioni. Secondo la scala dei colori, il paziente seleziona il colore a cui è associata la sua sensazione di dolore (colore di preferenza), indica il colore a cui associa l'assenza di dolore (“nessun dolore”), e seleziona il colore a cui associa il dolore “insopportabile (non può essere più forte). forse)” o “molto forte”.
Successivamente il paziente inserisce i nomi dei colori selezionati (numeri dei colori) nelle colonne del protocollo.

Calcolo dei risultati. L'indicatore dell'intensità del dolore è il numero di punti indicati nella colonna accanto alla definizione di intensità del dolore scelta dal paziente.
Intensità = S mj/n, dove: S mj è la somma dei punti che valutano le definizioni selezionate, n è il numero delle definizioni selezionate.
Nell'esempio 1, il paziente L. ha un'intensità del dolore I=(1+2)/2=1,5 punti (Fig. 2).
La scelta del colore del paziente L. è presentata nella Tabella 5. Dopo aver confrontato questa scelta con le scale di colore della Tabella 4, possiamo concludere sulla genesi somatogena del dolore nel paziente L.; il confronto di questi dati con la descrizione soggettiva del dolore permette permetterci di chiarire la diagnosi e determinare la scelta della terapia.
| Tabella 5 | ||||
| Esempio 1. Scelta del colore del paziente L. | ||||
| Intensità del dolore | Selezione della preferenza di colore | Selezione del colore di rifiuto | Diagnosi espressa | |
| 0 | Nessun dolore | Giallo | Nel paziente P. il dolore somatogeno provoca un tentativo stenico di proteggersi da stimoli non necessari (per creare una zona di massimo comfort) e può essere associato a limitazione forzata attività professionale e attività personale. | |
| 1 | Il dolore è molto lieve | Grigio verde | Verde giallo | |
| 2 | Il dolore è lieve | Grigio verde | Verde giallo | |
| 3 | Dolore moderato | |||
| 4 | Il dolore è grave | |||
| 5 | Il dolore è molto forte | |||
| 6 | Il dolore è insopportabile | Nero | Giallo | |
Un confronto tra la scelta del paziente M, presentata nell'esempio 2 (vedi Tabella 6) con le scale della Tabella 3, ci consente di formulare un'ipotesi sull'origine psicogena del suo dolore.
| Tabella 6 | ||||
| Esempio 2. Scelta del colore del paziente M. | ||||
| Intensità del dolore | Selezione della preferenza di colore | Selezione del colore di rifiuto | Diagnosi espressa | |
| 0 | Nessun dolore | Blu grigio | Il paziente M. soffre di un dolore di natura psicogena, che può essere per lui una forma inconscia di difesa psicologica e gli consente di evitare situazioni sfavorevoli condizioni sociali o relazioni. | |
| 1 | Il dolore è molto lieve | |||
| 2 | Il dolore è lieve | Rosso | Grigio | |
| 3 | Dolore moderato | rosso Giallo | Grigio, viola | |
| 4 | Il dolore è grave | |||
| 5 | Il dolore è molto forte | |||
| 6 | Il dolore è insopportabile | Giallo | Grigio | |
L'aspetto della preferenza nella scelta del colore per il dolore di alta intensità (“insopportabile” o “molto forte”) rosso, giallo e fiori viola può indicare una psicosomatizzazione del dolore nel paziente. Se, dopo ulteriori test, il paziente rivela alte prestazioni sulla scala del nevroticismo (vedi sotto) e/o sulla scala di valutazione dell'atteggiamento emotivo nei confronti del dolore, quindi questo fatto aumenta la probabilità di un'origine psicogena del dolore in un dato paziente.
Come risultato dello studio utilizzando il metodo del colore verbale, affidabile differenze di genere percezione e attitudine emotiva al dolore in pazienti con sindromi dolorose neurogeniche, somatogene, psicogene, in soggetti sani, e coefficienti di ponderazione sono stati ottenuti per ciascun descrittore in base al suo significato semantico separatamente per uomini e donne (Tabelle 7, 8, 9). Inoltre, lo studio ha raccolto nuove definizioni (descrittori) utilizzate dai pazienti per descrivere il dolore. Ciò ha permesso di espandere e integrare il vocabolario della descrizione delle sensazioni intracettive sulla scala della percezione sensoriale del dolore a 46 descrittori (Tabella 8), sulla scala dell'atteggiamento emotivo verso il dolore - fino a 25 descrittori (Tabella 9).
Per riassumere i risultati, è stata effettuata la somma degli indicatori di autovalutazione da parte di uomini e donne della percezione del dolore e dell'atteggiamento emotivo nei confronti del dolore - per gruppi di pazienti con sindromi dolorose neurogeniche, somatogene, psicogene e per il gruppo di controllo. Un'analisi statistica comparativa della valutazione del dolore (statistica di Pearson) ha rivelato una differenza significativa nella percezione del dolore da parte di uomini e donne sulla scala delle sensazioni sensoriali e sulla scala dell'atteggiamento emotivo nei confronti del dolore.
Sulla scala della percezione sensoriale del dolore, la differenza è che gli uomini sperimentano più spesso dolore di intensità bassa (21,2%) e moderata (22,6%), le donne rispettivamente (15,7%) e (19,6%). Le donne sperimentano più spesso e sperimentano emotivamente sensazioni di dolore più “gravi” - 18,3%, negli uomini il dolore “grave” è 8,73%. Sulla scala dell'atteggiamento emotivo nei confronti del dolore, pronunciato reazioni emotive Il dolore “molto lieve” è più comune negli uomini che nelle donne, mentre il dolore “moderato” negli uomini e nelle donne provoca manifestazioni emotive simili.
Oltre alle differenze nell'autovalutazione del dolore, in ciascun gruppo di pazienti sono state riscontrate differenze nei vocabolari intracettivi di uomini e donne nel descrivere le loro sensazioni dolorose, nonché differenze nel numero di descrittori selezionati sulle scale della percezione sensoriale e atteggiamento emotivo-affettivo nei confronti del dolore. Del resto è accertato che le donne, rispetto agli uomini, scelgono numero maggiore descrittori su entrambe le scale (Tabella 7). Pertanto, i risultati ottenuti confermano la differenza nella percezione del dolore tra uomini e donne.
| Tabella 7 | |||||
| Indicatori medi di selezione quantitativa dei descrittori in pazienti con sindromi dolorose neurogeniche, somatogene e psicogene | |||||
| NO. | Gruppo | Scala del dolore sensoriale | Scala emotiva. rapporto con il dolore | ||
| Marito. | Donne | Marito. | Donne | ||
| 1 | Sindrome del dolore neurogeno | 6,4 | 7,8 | 4,1 | 5 |
| 2 | Sindrome dolorosa somatogena | 6,1 | 7,3 | 4,9 | 5,3 |
| 3 | Sindrome del dolore psicogeno | 10,4 | 14,6 | 9,6 | 10,8 |
| 4 | Indicatore totale medio | 7,6 | 8,8 | 6,2 | 7,1 |
Un'analisi comparativa quantitativa e statistica del dolore ha mostrato una differenza significativa nella percezione del dolore da parte di uomini e donne sia sulla scala della sensazione sensoriale (Chi quadrato = 79,9, significatività = 0, grado di libertà = 6, pЈ 0,01) che sulla scala relazione su scala emotivo-affettiva con il dolore (Chi quadrato = 13,6, significatività = 0,0343, grado di libertà = 6, p<0,05).
I fatti accertati ci permettono di concludere che indicatori significativi delle differenze nella percezione del dolore da parte di uomini e donne sono differenze nell'autovalutazione delle sensazioni intracettive sperimentate e nella gravità dell'atteggiamento emotivo-affettivo nei confronti del dolore, che si riflette nel ottenuti i coefficienti di ponderazione semantica dei descrittori; così come una misura quantitativa della scelta dei descrittori che descrivono il dolore e gli atteggiamenti nei suoi confronti.
I risultati ottenuti sono stati utilizzati nello sviluppo di una scala di percezione sensoriale e di una scala di atteggiamento emotivo nei confronti del dolore.
Nocicezione. 4. La scala della percezione sensoriale del dolore consente di condurre un'analisi qualitativa e quantitativa della componente sensoriale del dolore, per chiarire il grado di cambiamenti patologici associati alla malattia. La scala contiene 46 descrittori che descrivono le sensazioni del dolore; nel calcolo degli indicatori quantitativi sulla scala, vengono presi in considerazione i coefficienti di ponderazione, che riflettono il significato semantico dei descrittori in base alle differenze di genere nella percezione del dolore e le caratteristiche della selezione quantitativa dei descrittori che tengono conto delle differenze di genere nella percezione del dolore (Tabelle 7, 8).
Il paziente sceglie le parole che caratterizzano le sue sensazioni di dolore. Se le sensazioni del dolore hanno una qualità complessa, seleziona diverse parole-caratteristiche corrispondenti ad esse. Se il paziente ha difficoltà a scegliere, sceglie le parole che descrivono il dolore più vicine alle sue sensazioni dolorose, ad es. diverse caratteristiche.
Calcolo dei risultati. I risultati dei test sulla scala di percezione del dolore sensoriale vengono calcolati utilizzando la formula:

dove n è il numero di descrittori selezionati, S n k è la somma dei punti di tutti i descrittori selezionati, K è un fattore di correzione che tiene conto del numero di quelli selezionati e n cр è l'indicatore totale medio della selezione quantitativa dei descrittori, pari al valore per gli uomini - 7, 6, per le donne - 8, 8 (Tabelle 7, 8).
Nell'esempio proposto, nel calcolo dei punti, vengono selezionate le chiavi per gli uomini (Tabella 8):
C = (2,5+2,6+2,5+3,9)/4 + 4/7,6=2,75+0,52=3,27 punti (Fig. 2).
| Tabella 8 | |||||||
| Descrittori del dolore | |||||||
| № | Sensazioni dolorose | Donne (punto) | Marito. (punto) | № | Sensazioni dolorose | Donne (punto) | Marito. (punto) |
| 4.0 | Nessun dolore | 0 | 0 | 4.23 | Strappare | 5,0 | 4,8 |
| 4.1 | Premendo | 2,9 | 2,5* | 4.24 | Strappo | 5,0 | 4,8 |
| 4.2 | Irritato | 2,5 | 1,7 | 4.25 | taglio | 4,5 | 3,8 |
| 4.3 | Rosicchiare | 3,1 | 2,9 | 4.26 | Tagliante | 4,2 | 3,5 |
| 4.4 | Scoppio | 4,0 | 2,7 | 4.27 | Colpo di frusta | 4,1 | 3,6 |
| 4.5 | Dolorante | 3,9 | 3,1 | 4.28 | Segare | 4,0 | 3,2 |
| 4.6 | contraente | 3,1 | 2,6* | 4.29 | Pizzicare | 3,5 | 3 |
| 4.7 | Compressivo | 3,3 | 2,7 | 4.30 | Mordere | 3,7 | 3,2 |
| 4.8 | Incatenamento | 3,7 | 2,7 | 4.31 | Tiro | 4,3 | 3,5 |
| 4.9 | Raschiare | 2,5 | 1,9 | 4.32 | Frizzante | 4,5 | 4,0 |
| 4.10 | Raschiare | 2,3 | 1,8 | 4.33 | Bruciando | 4,7 | 4,1 |
| 4.11 | Graffiare | 2,2 | 1,4 | 4.34 | Intelligente | 4,1 | 3,2 |
| 4.12 | Tosatore | 2,5 | 1,7 | 4.35 | Migratorio | 2,8 | 3,5 |
| 4.13 | Tirando | 2,7 | 2,5* | 4.36 | Parossistico | 4,5 | 4,4 |
| 4.14 | Sussultando | 3,6 | 3,3 | 4.37 | Superficiale | 4,7 | 2,0 |
| 4.15 | Dolorante | 3,4 | 3,0 | 4.38 | Profondo | 4,1 | 4,1 |
| 4.16 | Pulsante | 3,1 | 3,4 | 4.39 | ondulato | 2,8 | 2,8 |
| 4.17 | Perforazione | 3,8 | 3,9* | 4.40 | Battere | 4,5 | 5,5 |
| 4.18 | Perforazione | 3,6 | 3,5 | 4.41 | Monotono | 4,4 | 6,0 |
| 4.19 | Accoltellamento | 3,5 | 3,5 | 4.42 | Attutire | 4,9 | 6,0 |
| 4.20 | Formicolio | 5,3 | 4,7 | 4.43 | Torcendo | 4,5 | 4,5 |
| 4.21 | Pugnale | 4,9 | 4,1 | 4.44 | Intorpidire | 5,0 | 5 |
| 4.22 | Penetrante | 4,9 | 4,8 | 4.45 | Congelamento | 2,9 | 4,0 |
| 4.46 | Prurito | 2,7 | 6,0 | ||||
| Un asterisco (*) indica i descrittori scelti dal paziente che descrivono le sue sensazioni di dolore. | |||||||
Provare dolore. 5. La scala dell'atteggiamento emotivo nei confronti del dolore consente di valutare quantitativamente e qualitativamente la dinamica dell'atteggiamento soggettivo nei confronti del dolore. La scala contiene 25 descrittori che riflettono l’inclusione della sfera emotiva del paziente nel quadro interno dell’esperienza del dolore. Nel calcolare l'indicatore quantitativo, vengono prese in considerazione le caratteristiche delle differenze di genere nell'atteggiamento nei confronti del dolore (Tabella 9).
Il paziente sceglie definizioni che riflettono il suo atteggiamento nei confronti del dolore. Se ha difficoltà a scegliere, sceglie quelle definizioni più vicine al suo stato, ad es. seleziona diverse caratteristiche.
| Tabella 9 | |||||||
| Descrittori che riflettono l'atteggiamento emotivo nei confronti del dolore | |||||||
| N | Atteggiamento verso il dolore | Donne (punto) | Marito. (punto) | N | Atteggiamento verso il dolore | Donne (punto) | Marito. (punto) |
| 5.0 | nessun dolore | 0 | 0 | 5.13 | spaventoso | 4,1 | 4,2 |
| 5.1 | indifferente | 1,3 | 1,8 | 5.14 | tormentoso | 5,1 | 4,6 |
| 5,2 | insignificante | 3,2 | 2,1 | 5.15 | tormentoso | 5,0 | 4,1 |
| 5.3 | indisturbato | 1,0 | 2,7 | 5.16 | estenuante | 4,9 | 4,9 |
| 5.4 | distrazione | 3,1 | 3,3* | 5.17 | molesto | 5,1 | 4,1 |
| 5.5 | inquietante | 3,1 | 3,5* | 5.18 | terrificante | 5,5 | 4,9 |
| 5.6 | inquietante | 3,8 | 3,4* | 5.19 | doloroso | 5,2 | 5,5 |
| 5.7 | fastidioso | 4,2 | 3,8 | 5.20 | tormentoso | 5,3 | 4,5 |
| 5.8 | noioso | 4,5 | 3,7 | 5.21 | estenuante | 4,6 | 5,2 |
| 5.9 | fastidioso | 3,6 | 3,7 | 5.22 | allarmante | 5,6 | 6,6 |
| 5.10 | opprimente | 4,4 | 3,6 | 5.23 | strisciante | 5,9 | 4,5 |
| 5.11 | disgustato | 4,1 | 4,0 | 5.24 | pesante | 5,3 | 6,0 |
| 5.12 | doloroso | 4,5 | 4,6 | 5.25 | non definito Paura | 6,0 | 6,0 |
| Un asterisco (*) indica le definizioni scelte dal paziente che descrivono il suo atteggiamento nei confronti del dolore. | |||||||
Calcolo dei risultati. Il calcolo dei risultati del test sulla scala della percezione emotivo-affettiva del dolore viene effettuato secondo la formula:

dove n è il numero di descrittori selezionati, S n k è la somma dei punti di tutti i descrittori selezionati, K è un fattore di correzione che tiene conto del numero di descrittori selezionati e n cр è l'indicatore totale medio della selezione quantitativa dei descrittori, uguale al valore per gli uomini - 6,2, per le donne - 7,1 (vedi Tabella 7).
Nell'esempio proposto:
Nell'esempio proposto, nel calcolo dei punti, vengono selezionate le chiavi per gli uomini (Tabella 9):
E = (3,3+3,5+3,4)/3 + 3/6,2 =3,4+0,48=3,88 punti. (Fig.2).
Nota: durante i test sulle scale n. 1-5, i punti non vengono indicati sui moduli, perché Queste sono le chiavi per gli specialisti.
Per sviluppare una scala che rifletta il livello di cambiamento nel comportamento dei pazienti con varie forme di sindrome del dolore e dei bambini con dolore acuto, è stato condotto uno studio sugli stati emotivi, sulle caratteristiche comportamentali e personali utilizzando il test Mini-Mult, il test Luscher, il test Questionario di autovalutazione sull'ansia di Spielberger-Khanin e questionario sull'autostima, la gravità delle reazioni di rabbia di Spielberger.
È noto che il dolore acuto è solitamente considerato un segnale di allarme. Come risultato della sua influenza, si verificano vari cambiamenti emotivi e motivazionali, che sono di natura temporanea (fino all'eliminazione del fattore dannoso o alla guarigione dei tessuti). I risultati di uno studio condotto con il test Luscher sui bambini indicano che il dolore acuto provoca effettivamente stati emotivi negativi a breve termine, come irritabilità, aggressività, paura e un elevato livello di ansia, ma questi cambiamenti non sono sostenibili; dopo il trattamento, significativi si notano dinamiche positive nello stato emotivo dei bambini. Questi cambiamenti di condizione si riflettono nelle scelte di colore dei bambini a seconda dell'intensità del dolore che provano (Tabella 7).
È stato riscontrato che i pazienti con sindromi dolorose neurogeniche e somatogene sono caratterizzati, in vari gradi di gravità, da tratti di labilità emotiva, dimostratività, aggressività, ansia e umore ridotto. Per tali pazienti, il dolore (malattia) porta con sé una barriera o un significato contrastante, ciò è confermato nelle scelte cromatiche corrispondenti: per il dolore grave, viene data preferenza ai colori nero, grigio e rosso. Un paziente del genere non riesce sempre a mantenere il controllo sul suo comportamento e sulle sue emozioni. Spesso si verificano crolli, sensi di colpa, vergogna, diminuzione dell'autostima che portano alla depressione.
Nei pazienti con sindrome dolorosa psicogena si evita di risolvere problemi come "andare in malattia", reprimere i conflitti, incolpare l'esterno - in questo caso il dolore fornisce alcuni benefici, consente di ricevere più attenzione, riduce le richieste sul persona dagli altri, che ha un significato positivo. In questo caso la malattia permette di ottenere alcuni benefici, ma costringe a rinunciarne ad altri, ad esempio, ricevendo le attenzioni altrui in cambio di una limitazione della libertà. Pertanto, la combinazione di significati contrastanti e positivi in relazione al dolore (malattia) in questi pazienti è confermata nella loro scelta del colore, che si esprime nella preferenza principale per i colori giallo, viola e rosso.
Inoltre, è stato riscontrato che nei gruppi di pazienti con sindromi dolorose neurogeniche e somatogene, gli uomini sono caratterizzati da una pronunciata manifestazione di reazioni di rabbia e un ridotto livello di autocontrollo, mentre nel gruppo di pazienti con sindrome dolorosa psicogena, al contrario al contrario, le donne mostrano un alto livello di rabbia e un basso livello di autocontrollo. Una tale differenza nella manifestazione delle reazioni di rabbia può essere spiegata dal fatto che le donne con sindrome da dolore psicogeno hanno maggiori probabilità di mostrare comportamenti di colpa esteriore con lo spostamento delle vere cause del conflitto e il trasferimento della colpa all'ambiente.
La risposta del paziente al dolore è associata alla formazione di un “quadro interno della malattia” e comprende sviluppi emotivi, motivazionali e comportamentali, che spesso sono improduttivi e interferiscono con il trattamento della malattia. L'analisi del "quadro interno della malattia" e delle sue componenti deve essere presa in considerazione dal medico quando si effettua la diagnosi e si prescrive la terapia.
Per valutare la gravità dei cambiamenti comportamentali, è stata sviluppata una scala per valutare il livello di nevroticismo.
Comportamento doloroso. 6. La scala del nevroticismo consente di valutare il livello di nevroticismo e il grado di coinvolgimento delle componenti comportamentali nella gravità della sindrome dolorosa del paziente. Quando si diagnostica il livello di nevroticismo, vengono presi in considerazione i principali fattori comportamentali, i cui cambiamenti sono strettamente correlati alla presenza di dolore in una persona: ansia, labilità emotiva, aggressività, depressione, manifestazioni vegetative, ipocondria. La base per la selezione delle domande era il questionario MMPI e il questionario Spielberger (rabbia).
Il paziente acquisisce familiarità con tutte le 10 affermazioni fornite nella Tabella 1. Se l'affermazione si applica a lui, allora segna nella colonna "SI", se l'affermazione è falsa per lui, segna nella colonna "NO".
| Tabella 10 | |||
| Domande per valutare il livello di nevroticismo. | |||
| Domande | Risposte | ||
| 1. Ansia | SÌ | NO | |
| 6.1 | Ho un sonno agitato e interrotto e spesso faccio sogni inquietanti. | * | |
| 6.2 | Spesso mi preoccupo troppo delle piccole cose. | * | |
| 6.3 | A volte, senza una ragione particolare, mi sento ansioso o spaventato. | * | |
| 2. Labilità emotiva | |||
| 6.4 | Spesso il mio umore può cambiare con o senza una buona ragione. | * | |
| 6.5 | Spesso sento un nodo alla gola in situazioni che mi preoccupano. | * | |
| 6.6 | È difficile per me concentrarmi quando svolgo qualsiasi compito (lavoro). | * | |
| 3. Aggressione | |||
| 6.7 | Quando mi arrabbio, dico cose cattive. | * | |
| 6.8 | Mi irrito abbastanza facilmente. | * | |
| 6.9 | A volte ho difficoltà a controllare la mia rabbia. | * | |
| 4. Depressione | |||
| 6.10 | Spesso mi sento indifferente e stanco senza un motivo particolare. | * | |
| 6.11 | Ultimamente mi sento peggio che mai. | * | |
| 6.12 | Vorrei essere felice come sembrano esserlo gli altri. | * | |
| 5. Manifestazioni vegetative | * | ||
| 6.13 | Spesso in varie parti del corpo avverto una sensazione di bruciore, formicolio, formicolio e intorpidimento. | * | |
| 6.14 | A volte tremo o ho brividi. | * | |
| 6.15 | Ho attacchi di nausea e vomito. | * | |
| 6. Ipocondria | * | ||
| 6.16 | La maggior parte delle volte sento una debolezza generale. | ||
| 6.17 | Spesso mi sento come se avessi fatto qualcosa di brutto o sbagliato. | ||
| 6.18 | Raramente sono pieno di energia. | * | |
Calcolo dei risultati sulla scala del nevroticismo. Per determinare il livello di nevroticismo, si conta il numero di risposte positive, quindi la somma risultante viene divisa per 3, dove n è il numero di risposte "Sì", quindi il livello di nevroticismo = (S n)/ 3. Il maggiore è il risultato ottenuto, maggiore è il livello di nevroticismo.
Basso livello di nevroticismo - 1-2 punti; livello medio di nevroticismo - 2-4 punti; alto livello di nevroticismo - 4-6 punti.
Nell'esempio fornito, il paziente L., dopo i calcoli, il livello di nevroticismo è 4/3 = 1,33 punti (Fig. 2).
Un alto livello di nevroticismo indica una pronunciata eccitabilità emotiva, che porta alla comparsa di stati negativi come ansia, paura, tensione, irrequietezza e irritabilità. Un alto livello di nevroticismo può indicare una fissazione ipocondriaca sulle sensazioni somatiche, difficoltà di adattamento sociale associate a timidezza sociale, incertezza, confusione, dipendenza e mancanza di iniziativa. Un alto livello di nevroticismo, di regola, riduce significativamente l'efficacia di qualsiasi terapia. A questo proposito, è necessario tenere conto di questo fatto e includere nell’algoritmo del trattamento misure volte a normalizzare lo stato emotivo del paziente.
Un basso livello di nevroticismo indica stabilità emotiva, un background positivo di esperienze (calma, ottimismo) e coraggio sociale, che è un background favorevole per la terapia del dolore.
Ulteriori informazioni sulla scala del nevroticismo possono essere ottenute analizzando le risposte selezionate per i principali fattori: ansia, labilità emotiva, aggressività, depressione, manifestazioni vegetative, ipocondria; che aiuterà, se necessario, a selezionare metodi per un ulteriore esame psicologico approfondito del paziente.
Comportamento doloroso. 0. La scala della menzogna consente di determinare il grado di sincerità delle risposte del paziente. La base per la selezione delle domande è la scala della menzogna del test MMPI, nonché domande costruite che determinano l'accordo di alcune risposte sulle scale del test multidimensionale dei colori verbali. È importante che tutte le affermazioni sulla scala della menzogna siano presentate in un unico elenco insieme alle affermazioni sulla scala per valutare il livello di nevroticismo. Le affermazioni su entrambe le scale vengono presentate al paziente senza rubriche corrispondenti e in ordine casuale.
| Tabella 11 | |||
| Domande sulla scala della menzogna | |||
| SÌ | NO | ||
| 0.1 | Ultimamente ho avvertito dolore più di una volta ogni pochi giorni. | * | |
| 0.2 | Ultimamente, a volte soffro di attacchi di dolore di lunga durata. | * | |
| 0.3 | Ultimamente ho avuto attacchi di dolore insopportabilmente forti. | * | |
| 0.4 | A volte potrei spettegolare | * | |
| 0.5 | A volte vorrei giurare. | * | |
| 0.6 | Non mi piacciono tutti i miei amici. | * | |
Calcolo dei risultati sulla scala della menzogna. Per determinare i risultati sulla scala della menzogna, viene calcolato il numero totale di risposte positive: per la domanda n. 1 - alla risposta viene assegnato 1 punto se viene rilevata una discrepanza tra la risposta rispetto alla risposta sulla scala della nocicezione 1 (frequenza di dolore); per la domanda n. 2 - alla risposta viene assegnato 1 punto se c'è una discrepanza tra la risposta rispetto alla risposta sulla scala della nocicezione 2 (durata del dolore - il dolore dura per ore, giorni, è costante); alla domanda n. 3, alla risposta viene assegnato 1 punto se c'è una discrepanza tra la risposta rispetto alla risposta sulla scala della nocicezione 3 (gravità del dolore - forte, molto forte, insopportabile); per le domande 4-6 - la risposta “No” vale 1 punto. Più alto è il punteggio sulla scala della menzogna, meno affidabile è il test.
Calcolo dei risultati del test per il paziente L.
La domanda n. 1 vale 0 punti perché coincide con la risposta sulla scala della frequenza del dolore. La risposta del paziente L. sulla scala 1 è “Dolore costante”. Alla domanda n. 2 viene assegnato 0 punti, poiché coincide con la risposta sulla scala della durata del dolore. La risposta del paziente L. sulla scala 2 è “Il dolore dura per ore”. Alla domanda n. 3 viene assegnato 0 punti, poiché coincide con la risposta sulla scala verbale-cromatica dell'intensità del dolore. La risposta del paziente L. sulla scala 3 è “Dolore moderato” (vedi Tabelle 1, 3, 4). Il conteggio delle domande da 4 a 6 ha rivelato una risposta "No" alla domanda 6. Pertanto, la somma delle risposte sulla scala della menzogna per il paziente L. = 1 punto. Punteggi elevati su questa scala possono indicare risposte non sincere o che il paziente ha frainteso le istruzioni del test. Questo è un segnale da ripetere il test. Pertanto, i dati di questa scala sono necessari per l’analisi qualitativa e non vengono presi in considerazione nel calcolo dei punteggi medi e integrali del dolore.
Livello di adattabilità
L’adattabilità è il livello successivo dell’analisi complessa della percezione del dolore. Questo livello è associato allo sviluppo di una scala di modalità che consentono di valutare il grado di dipendenza e la gravità del dolore da fattori ambientali esterni. Durante l'esame ogni paziente doveva descrivere i fattori che gli avevano provocato il dolore. I dati ottenuti sono stati sistematizzati e presentati in una scala di modalità.
| Tabella 12 | ||||||
| 7.1. Il fattore “Time-Sleep” determina la dipendenza della comparsa o dell’intensificazione del dolore dall’ora del giorno. | ||||||
| Momenti della giornata | Orologio | |||||
| Notte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mattina | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* |
| Giorno | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* | 18* |
| Sera | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Insonnia | ||||||
Il paziente indica segnando con una croce in quali ore compare o si intensifica il dolore.
| Tabella 13 | ||||
| 7.2. Il fattore “Meteo” determina la dipendenza della comparsa o dell’intensificazione del dolore dalle condizioni meteorologiche. | ||||
| Tempo atmosferico | Freddo | Freddo | Caldo | Caldo |
| Soleggiato | ||||
| Prevalentemente nuvoloso | ||||
| Asciutto | ||||
| Umido | ||||
| Ventoso | ||||
| Piovere | ||||
| Nevicare | ||||
| Cambiamento del tempo | ||||
| Altro | ||||
Il paziente indica in che tempo appare o si intensifica il dolore.
| Tabella 14 | |||
| 7.3. Il fattore “Postura-Movimento” determina la comparsa o l’intensificazione del dolore dovuto alla postura o al movimento del corpo. | |||
| Pace | Movimento | ||
| Posa | Sdraiarsi | A piedi | Non dipende |
| Seduta* | Muovere | Altro | |
| Piegato | Tocco | ||
| in piedi | Pressione | ||
| Cambiare posizione | Alzarsi | ||
| Sedendosi | |||
| Tabella 15. | |||||||
| Fattori che determinano la comparsa o l'intensificazione del dolore a seconda dell'assunzione di cibo, delle condizioni generali e dell'esposizione a condizioni dannose. | |||||||
| 7.4. Fattore “Fame-Cibo” | 7.5. Fattore “Condizioni generali” | 7.6. Fattori dannosi | |||||
| 1 | Fame | 1 | Stanchezza generale | 1 | Rumore | ||
| 2 | Cibo piccante | 2 | 2 | Leggero | |||
| 3 | Cibo acido | 3 | 3 | Odore | |||
| 4 | Cibo dolce | 4 | Fatica | 4 | Lancio | ||
| 5 | Cibo freddo | 5 | Surriscaldare | 5 | Vibrazione | ||
| 6 | Cibo caldo | 6 | Raffreddamento | 6 | Altro | ||
| 7 | Alcol | 7 | Altro | 7 | |||
| 8 | Fumare | 8 | 8 | ||||
| 9 | Altro | 9 | 9 | ||||
Calcolo dei risultati. Il punteggio risultante sulla scala della modalità viene calcolato come segue: se il paziente nota (indica) uno o più punti nel fattore che può provocare sensazioni dolorose, a questo viene assegnato 1 punto. Alla fine vengono riassunti i punteggi di tutti i fattori che il paziente ha notato come fattori che provocano (aumentano) il suo dolore. Un’analisi qualitativa delle condizioni selezionate all’interno di ciascun fattore consentirà al medico di ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni del paziente.
Il paziente L. ha indicato solo un fattore, "Time-sleep", associato alla comparsa del dolore, di conseguenza il punteggio totale su questa scala di modalità è 1 (Fig. 2).
Al termine dei test, i risultati possono essere presentati in una versione tabellare e sotto forma di diagrammi che riflettono chiaramente la gravità e il rapporto di tutte le componenti del dolore a vari livelli di percezione mentale del dolore da parte di una persona (Fig. 3).
Nella figura 3. viene presentato un modello dinamico: un indicatore percentuale totale del dolore, che riflette l'esperienza del dolore di una persona a vari livelli mentali.

Calcolo dei risultati. Punteggio percentuale totale del dolore (Fig. 3).
Il test contiene 7 scale, in ciascuna delle quali il risultato del test è minimamente pari a zero, massimo pari a 6 punti, in totale, su tutte le scale si può valutare il dolore massimo = 7 scale × 6 punti. = 42 punti. Questo numero è considerato pari al 100%, rispettivamente, ciascuna scala è valutata ad un massimo di (100/6)%. Il risultato percentuale del test per ciascun livello (scala) viene calcolato utilizzando la formula (livello S)/42 × 100, dove livello S. - somma dei punti per livello (scala).
Un esempio di calcolo e presentazione dell'indicatore percentuale del dolore totale del paziente L.:
Livello di nocicezione Livello S = (5+3,5+1)/ 42 × 100 = 22,6%.
Livello della sensazione del dolore Livello S. sensazione = 3/43 × 100 = 7%.
Livello di esperienza del dolore Livello S. sopravvissuto = 2,5/42 × 100 = 5,9%.
Livello del comportamento doloroso Livello S. comportamento = 1,3/42 × 100 = 3%.
Livello di adattabilità Livello S. adattivo = 2/42 × 100 = 4,8%.
Percentuale totale = 22,7% + 7% + 5,9% + 3% + 4,9% = 43,5% o
Percentuale totale = (5+3,5+1+3+2,5+1,3+2)/42 × 100 = 43,5%.
Quando si effettua una valutazione rapida della sindrome del dolore, non è necessario testare il paziente su tutte le scale contemporaneamente. A discrezione del medico (ricercatore), è possibile un test incompleto del paziente, a seconda della diagnosi e della direzione della terapia prescritta, tuttavia, questo può essere di almeno 3 scale e scale (1-3) del livello di nocicezione (frequenza, durata, intensità del dolore, colore) sono obbligatori durante il test. scala).
Conclusioni basate sui risultati dei test del paziente L. (Tabella 16)
I test sono affidabili. Il paziente ha la sindrome del dolore somatogeno. Il dolore è localizzato nell'area T10 - S1. Il dolore è quasi costante, debole, pressante in natura. Peggiora al mattino e durante il giorno quando si è seduti. Il dolore provoca uno stato emotivo irritabile. Il dolore causa la limitazione forzata delle attività professionali e personali. L'elevata stabilità emotiva rivelata costituisce un contesto favorevole per la terapia del dolore. Nota: a seconda della profondità dell'analisi, i risultati del test consentono di trarre conclusioni più ampie sulle condizioni del paziente.
Per confermare l'adeguatezza dei risultati del test delle condizioni dei pazienti utilizzando il metodo proposto per la valutazione del dolore, è stato esaminato un gruppo di pazienti neurologici con dolore vertebrogenico - 21 pazienti (12 donne, 9 uomini) prima e dopo un ciclo di elettroriflessoterapia mediante stimolazione nervosa elettrica dinamica transcutanea (DENS).
Per oggettivare la dinamica delle condizioni dei pazienti durante la terapia, è stato effettuato uno studio completo su un gruppo di pazienti utilizzando il metodo di valutazione creato, l'ecografia Doppler (USD) e la cardiointervalometria variabile (VCIM) e il livello di potenziale cerebrale costante (CBP ) è stata valutata.
I test psicologici sono stati eseguiti utilizzando una versione computerizzata di questo metodo di valutazione del dolore, che è una componente importante del modulo psicodiagnostico del complesso hardware e software dell'ambulatorio di terapia del dolore.
Sulla base dei risultati dei test sui pazienti prima e dopo un ciclo di terapia DENS, sono state rivelate dinamiche positive significative, espresse in una diminuzione degli indicatori per tutte le componenti della sindrome del dolore, ad eccezione dell'indicatore di adattabilità sulla scala della modalità. L'effetto più pronunciato è stato osservato nel ridurre la frequenza, la durata e l'intensità del dolore, ad es. componenti associati alla nocicezione. Dopo il ciclo di trattamento, i pazienti hanno mostrato anche un miglioramento del loro stato emotivo, che si è espresso in una diminuzione del livello di nevroticismo e dell'atteggiamento affettivo nei confronti del dolore (Fig. 4).
La Figura 4 mostra la dinamica delle condizioni dei pazienti prima e dopo il ciclo di terapia DENS. L'ascissa mostra: 0 - scala delle bugie; 1 - scala della frequenza del dolore; 2 - scala della durata del dolore; 3 - scala dell'intensità del dolore; 4 - scala della percezione sensoriale del dolore; 5 - scala dell'atteggiamento affettivo-emotivo al dolore; 6 - scala del nevroticismo; 7 - scala di modalità; somme Il display è un indicatore integrativo delle sensazioni dolorose. L'asse y è il punteggio medio del dolore.
I test hanno permesso, nelle prime fasi dello studio, di identificare in questo gruppo di pazienti 5 persone il cui dolore “molto grave” era associato ai colori giallo e rosso (Tabella 17).
Il confronto dei dati sulla scelta del colore con la scala cromatica del test multidimensionale del dolore verbale-colore ci consente di formulare un'ipotesi sull'origine psicogena del dolore in questi pazienti. Ulteriori test psicologici utilizzando lo Spielberger-Khanin Anxiety Questionnaire e il test MMPI hanno confermato la presenza in questi pazienti di caratteristiche personali come un elevato livello di ansia personale, labilità emotiva (paziente N., paziente F.), stress (paziente G.) , (paziente L. .), elevata rigidità (paziente X.). I risultati ottenuti confermano l'ipotesi sulla natura psicogena del dolore in questi pazienti.
| Tabella 17 | ||||||
| Scelta del colore di pazienti neurologici con predisposizione psicogena alla sindrome del dolore | ||||||
| Intensità del dolore | Colore selezionato | |||||
| Paziente N. | Il paziente X. | Il paziente G. | Il paziente F. | Il paziente L. | ||
| 0 | Nessun dolore | Blu grigio. | Grigio verde. | Grigio, verde, giallo. | Verde, grigio, blu. | Verde, grigio, |
| 1 | Il dolore è molto lieve | |||||
| 2 | Il dolore è lieve | Viola. | ||||
| 3 | Dolore moderato | Viola, rosso. | Rosso, viola. | Viola, rosso. | Rosso | |
| 4 | Il dolore è grave | |||||
| 5 | Il dolore è molto forte | Giallo rosso. | Giallo rosso. | |||
| 6 | Il dolore è insopportabile | Viola, rosso. | Giallo rosso. | Giallo rosso. | Giallo rosso. | Rosso Giallo. |
I miglioramenti nelle condizioni dei pazienti durante un ciclo di terapia DENS sono confermati anche dai dati degli esami clinici e funzionali. Pertanto, l’affidabile dinamica positiva delle condizioni dei pazienti durante il trattamento, ottenuta dai risultati della valutazione del dolore utilizzando il metodo di valutazione del dolore creato, è confermata dai dati delle osservazioni cliniche e degli studi funzionali oggettivi.
Lo studio ha portato alla conclusione che il metodo sviluppato per la valutazione del dolore, sia qualitativamente che quantitativamente, riflette oggettivamente la gravità del dolore, la dinamica delle condizioni dei pazienti e può essere utilizzato nella clinica delle sindromi dolorose.
Sulla base dei risultati della ricerca, è stato sviluppato un metodo per la valutazione espressa del dolore, che consente al medico o allo psicologo di identificare con un alto grado di probabilità i pazienti con dolore di origine psicogena nelle prime fasi della diagnosi, di valutare, prendendo tenere conto delle differenze di genere, della gravità delle componenti della sindrome del dolore, che diventa importante quando si sceglie il metodo e la tattica della terapia del dolore.
Utilizzando questo metodo di valutazione del dolore, è possibile valutare con un alto grado di affidabilità la dinamica dei componenti della sindrome del dolore, l'influenza di vari fattori sui vari livelli di dolore vissuti da una persona, che ne consente l'utilizzo in la pratica diagnostica e terapeutica di un medico di qualsiasi specialità, nel lavoro psicoterapeutico e psicocorrettivo con pazienti con varie forme di sindrome del dolore, e anche come strumento per studiare il dolore nella ricerca scientifica.
Il metodo creato per valutare il dolore differisce significativamente dai metodi noti di valutazione del dolore in quanto per la prima volta, quando si valuta il dolore, viene utilizzato un sistema verbale-colore sviluppato, che rende possibile con un alto grado di probabilità identificare il dolore di un natura psicogena, descrivere la sensazione del dolore, tenendo conto delle differenze nella percezione del dolore da parte di uomini e donne, sistematizzare la sensazione del dolore su scale fattoriali in accordo con le idee sulla manifestazione multidimensionale del dolore e quantificare (in punti/percentuale) la gravità di tutti i componenti della sindrome del dolore su scale 7. Sulla base dei risultati dei test, viene presentata una valutazione integrale della sensazione di dolore. Il metodo contiene una mappa di localizzazione del dolore destinata alla determinazione visiva della zona e dell'area di localizzazione del dolore sul corpo umano. I risultati dei test sono presentati in versioni vuote e grafiche (Fig. 2, 3).
RECLAMO
1. Un metodo per valutare il dolore, caratterizzato dal fatto che il paziente viene testato su sette scale: frequenza, durata, intensità, percezione sensoriale del dolore, attitudine emotiva al dolore, livello di nevroticismo, livello di adattabilità e i risultati ottenuti sono valutato sulle scale elencate da 0 a 6 punti, in questo caso le scale della percezione sensoriale e dell'atteggiamento emotivo, i livelli di nevroticismo e adattabilità sono valutati secondo le tabelle 7-10, 12-15 riportate nella descrizione, e la gravità della componente psicogena del dolore viene inoltre valutata dalla scelta del colore da parte del paziente in base ad almeno tre scelte di intensità del suo dolore: "dolore al momento del test", "nessun dolore", "dolore forte" secondo le tabelle 3, 4 fornite nella descrizione, dopodiché, sulla base dei risultati del test, la gravità del dolore del paziente viene valutata qualitativamente e quantitativamente.
2. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la frequenza del dolore viene valutata da "il dolore appare una volta ogni pochi giorni o meno spesso" a "dolore costante".
3. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni 1 e 2, caratterizzato dal fatto che, su una scala di durata, il dolore viene valutato da "dolore transitorio" a "dolore costante".
4. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la scala dell'intensità del dolore è valutata da "dolore molto lieve" a "dolore insopportabile".
5. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la scala del livello di nevroticismo tiene conto dei principali fattori comportamentali: ansia, labilità emotiva, aggressività, depressione, psicogenia, ipocondria.
6. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che i fattori “tempo-sonno”, “tempo”, “postura-movimento”, “fame-cibo” sono selezionati come fattori ambientali che provocano o intensificano le sensazioni di dolore nella scala del livello di adattabilità ”, “condizione generale”, “fattori dannosi”.
Per valutare la gravità della sindrome del dolore, nonché l'efficacia della sua eliminazione, il cosiddetto scale di classificazione. La scala analogica visiva (VAS) è un segmento di linea retta lungo 10 cm, il cui inizio e fine riflettono l'assenza di dolore e il limite estremo della sua sensazione (Fig. 2.15).
Al paziente è stato chiesto di segnare un segmento di linea retta, il cui valore corrispondeva approssimativamente all'intensità del dolore avvertito. Dopo aver misurato l'area contrassegnata è stata determinata l'intensità condizionale del dolore in punti (corrispondenti alla lunghezza in cm). La scala di classificazione verbale è la stessa della VAS, ma con le valutazioni del dolore posizionate lungo una linea retta: debole, moderato, forte, ecc. La scala di valutazione numerica è la stessa linea retta su cui sono stampati i numeri da 0 a 10. Le valutazioni del dolore ottenute utilizzando scale orizzontali sono considerate le più obiettive. Correlano bene con la valutazione delle sensazioni del dolore e riflettono più accuratamente le loro dinamiche.
Abbiamo ottenuto le caratteristiche qualitative della sindrome del dolore utilizzando il questionario sul dolore di McGill (183). Questo test comprende 102 parametri del dolore, distribuiti in tre gruppi principali. Il primo gruppo (88 espressioni descrittive) è associato alla natura del dolore, il secondo (5 espressioni descrittive) all'intensità del dolore e il terzo (9 indicatori) alla durata del dolore. I parametri del primo gruppo sono distribuiti in 4 classi e 20 sottoclassi. La prima classe sono i parametri delle caratteristiche sensoriali (dolore “pulsante, lancinante, bruciante”, ecc.).
Riso. 2.15. Scale visive per la valutazione soggettiva del dolore
La seconda classe sono i parametri delle caratteristiche affettive (il dolore è “faticoso, terrificante, estenuante”, ecc.), la terza classe sono i parametri valutativi (il dolore è “irritante, sofferente, insopportabile”, ecc.), la quarta è quella mista sensoriale-sensoriale. parametri affettivi (dolore “fastidioso, straziante, tormentoso”, ecc.). Ogni indicatore nella sottoclasse è posizionato in base al suo valore di classificazione e ha un'espressione matematica ponderata (primo = 1, secondo = 2, ecc.). L'analisi successiva ha preso in considerazione il numero e la posizione in classifica dei parametri selezionati per ciascuna classe.
La valutazione quantitativa del dolore è stata effettuata utilizzando un dolorimetro (Kreimer A. Ya., 1966). Il principio di funzionamento del dolorimetro si basa sulla misurazione della pressione alla quale si manifesta il dolore nel punto esaminato. La misurazione della pressione viene registrata utilizzando un'asta con punta in gomma collegata ad un meccanismo a molla. Sulla superficie piana dell'asta è presente una scala graduata in 30 divisioni con incrementi di 0,3 kg/cm. L'entità dello spostamento dell'asta viene registrata utilizzando un anello di fissaggio.
I dati algesimetrici sono espressi in unità assolute - kg/cm. È stato considerato normale il grado di dolore di 9,2±0,4 kg/cm o più, rilevato in 30 persone praticamente sane. Per standardizzare gli indicatori, il coefficiente del dolore (KB), che mostra il rapporto tra i normali indicatori algesimetrici e gli indicatori corrispondenti nei punti oggetto di studio. Normalmente è pari ad una unità relativa. Il test è stato utilizzato anche durante il processo di trattamento per determinare l'efficacia del metodo di trattamento scelto.
L'approccio descritto ci ha permesso di effettuare una diagnosi differenziale obiettiva e, sulla base dei risultati di una diagnostica complessa, è stato selezionato un regime terapeutico e riabilitativo individuale nel periodo postoperatorio.
Per ragioni etiche, è consuetudine utilizzare solo metodi non invasivi per diagnosticare il dolore nei pazienti affetti da cancro. All'inizio è necessario studiare la storia del dolore (durata, intensità, localizzazione, tipo, fattori che aumentano o diminuiscono il dolore, momento in cui si è manifestato il dolore durante la giornata, analgesici utilizzati in precedenza e loro dosi ed efficacia). In futuro, dovrebbe essere effettuato un esame clinico del paziente per valutare la natura e l'entità del processo oncologico; esaminare lo stato fisico, neurologico e mentale del paziente. È necessario familiarizzare con i dati dei metodi di ricerca clinica e di laboratorio (esami del sangue clinici e biochimici, esami delle urine), che è importante per scegliere la combinazione più sicura di analgesici e agenti adiuvanti per un dato paziente (pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ECG, ecografia, radiografia, ecc.).
L'intensità della sindrome del dolore cronico viene valutata utilizzando una scala di valutazione verbale (verbale) (VRS), una scala analogica visiva (VAS) e questionari sul dolore. (Questionario sul dolore McGill, ecc.). Il più semplice e conveniente per l'uso clinico è ShVO a 5 punti, che viene compilato dal medico in base al paziente:
0 punti - nessun dolore,
1 punto - dolore lieve,
2 punti: dolore moderato,
3 punti: forte dolore,
4 punti: dolore insopportabile e grave.
Spesso usato scala analogica visiva (VAS) dell’intensità del dolore da 0 a 100%, che viene offerto al paziente, e lui stesso annota l'entità del suo dolore.
Queste scale permettono di quantificare la dinamica della sindrome del dolore cronico durante il trattamento.
La valutazione della qualità della vita di un paziente oncologico può essere effettuata in modo abbastanza oggettivo utilizzando Scala di attività fisica a 5 punti:
- 1 punto - attività fisica normale,
- 2 punti - leggermente ridotti, il paziente è in grado di visitare autonomamente un medico,
- 3 punti - moderatamente ridotto (riposo a letto inferiore al 50% del tempo diurno,
- 4 punti - significativamente ridotto (riposo a letto più del 50% del tempo diurno),
- 5 punti - minimo (riposo a letto completo).
Per valutare le condizioni generali di un malato di cancro, viene utilizzato Scala della qualità della vita di Karnofsky, dove la dinamica del grado di attività del paziente è misurata in percentuale:
| UN: Attività e prestazioni normali. Non è richiesta alcuna assistenza speciale. | 100% normale. Nessun reclamo. Nessun segno di malattia. |
| 90% Attività normale, segni e sintomi minori di malattia. | |
| 80% Attività normale, alcuni segni e sintomi di malattia. | |
| IN: Il paziente non è in grado di lavorare, ma può vivere a casa e prendersi cura di se stesso, è necessaria una certa assistenza. | 70% Il paziente si prende cura di se stesso, ma non riesce a svolgere le normali attività. |
| 60% Nella maggior parte dei casi il paziente si prende cura di se stesso. A volte hai bisogno di aiuto. | |
| 50% Sono necessarie cure mediche significative e frequenti. | |
| CON: Il paziente non può prendersi cura di se stesso. Sono necessarie cure ospedaliere. La malattia può progredire rapidamente. | 40% di invalidità. Sono necessari aiuto e supporto speciali. |
| 30% Invalidità grave. È indicato il ricovero in ospedale, sebbene non vi sia pericolo di vita. | |
| 20% Sono necessari il ricovero ospedaliero e le cure di supporto attive. | |
| 10% I processi fatali progrediscono rapidamente. | |
| 0% Morte |
Per una valutazione più dettagliata, un insieme insieme di criteri raccomandati dall’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore(IASP, 1994), inclusi i seguenti parametri:
- condizione fisica generale
- attività funzionale
- attività sociale,
- capacità di cura di sé
- capacità di comunicazione, comportamento familiare
- spiritualità
- soddisfazione per il trattamento
- progetti futuri
- funzioni sessuali
- attività professionale
Per valutazione della tollerabilità della terapia analgesica prendere in considerazione l'insorgenza di un effetto collaterale causato da un particolare farmaco (sonnolenza, secchezza delle fauci, vertigini, mal di testa, ecc.) e il grado della sua gravità su una scala a 3 punti:
0 - nessun effetto collaterale,
1 - debolmente espresso,
2 - moderatamente espresso,
3 - fortemente espresso.
Va ricordato che i pazienti con forme avanzate di tumore possono presentare sintomi simili agli effetti collaterali di molti analgesici (nausea, secchezza delle fauci, vertigini, debolezza), quindi è importante iniziare a valutare lo stato iniziale prima di iniziare la terapia analgesica o la sua correzione .
Per una valutazione approfondita del dolore, vengono utilizzati studi scientifici speciali metodi neurofisiologici(registrazione dei potenziali evocati, riflesso del flessore nocicettivo, studio della dinamica di un'onda negativa condizionata, sensometria, elettroencefalografia), viene determinato il livello plasmatico dei fattori di stress (cortisolo, ormone somatotropico, glucosio, beta-endorfina, ecc.). Recentemente è diventato possibile oggettivare il livello del dolore in base all'attività delle varie parti del cervello utilizzando tomografia ad emissione di positroni. Ma l’uso di questi metodi nella pratica quotidiana è limitato a causa della loro invasività e dei costi elevati.
Di interesse accademico test per la dipendenza da oppiacei con naloxone, che viene effettuato in cliniche specializzate con il consenso del paziente durante la terapia a lungo termine (più di un mese) con analgesici oppioidi. Nella pratica di routine non viene utilizzato perché può portare all'eliminazione dell'analgesia e allo sviluppo della sindrome da astinenza acuta.
Sulla base dei dati diagnostici vengono stabilite la causa, il tipo, l'intensità della sindrome del dolore cronico, la localizzazione del dolore, le complicanze associate e i possibili disturbi mentali. Nelle fasi successive di osservazione e terapia, è necessario rivalutare l'efficacia del sollievo dal dolore. In questo caso si ottiene la massima individualizzazione della sindrome del dolore, vengono monitorati i possibili effetti collaterali degli analgesici utilizzati e la dinamica delle condizioni del paziente.
Con questo semplice test potrete valutare in modo più obiettivo la gravità della sindrome dolorosa e la sua dinamica come risultato del trattamento, nonché ricevere semplici consigli che vi aiuteranno ad affrontare il dolore alla schiena e alle articolazioni.
Istruzioni per il test:
- Siediti e rilassati.
- Di seguito è riportata una scala del dolore analogica visiva. In alto ci sono le immagini che mostrano il dolore, e sotto ci sono le descrizioni del dolore. Clicca sull'immagine che corrisponde alla tua sensazione di dolore (alla schiena e alle articolazioni) in questo momento. Annota o ricorda il livello di dolore in punti. Durante la rivalutazione, confrontare questo indicatore con l'indicatore della gravità del dolore prima del trattamento.
- Continua a leggere per suggerimenti che ti aiuteranno ad affrontare il dolore alla schiena e/o alle articolazioni.
- Nessun dolore
- Dolore lieve
- Dolore moderato
- Forte dolore
- Intollerabile
Dolore
Nessun dolore
Le tue articolazioni e la tua schiena sono in buone condizioni. Si consiglia di mangiare cibi che fanno bene alle articolazioni e di fare esercizio quotidiano per mantenere la schiena e le articolazioni sane. Informazioni più dettagliate potete trovarle nei nostri articoli e consigli utili.
Dolore lieve
La terapia locale con farmaci (unguento Viprosal B®, Capsicam®, gel Valusal®) è raccomandata per il trattamento del dolore alla schiena e alle articolazioni (1-2 volte al giorno, per un massimo di 2 settimane), attuazione quotidiana di un complesso di esercizi terapeutici per la schiena e le articolazioni. Informazioni più dettagliate potete trovarle nei nostri articoli e consigli utili.
Dolore moderato
Si consiglia di utilizzare regolarmente farmaci locali con effetti analgesici e antinfiammatori (unguento Viprosal B® o unguento Capsicam® o gel Valusal®) 2-3 volte al giorno per 10-14 giorni. Se l'effetto è insufficiente, cambiare il farmaco esterno (corso ripetuto per 10-14 giorni). Ti aiuterà a decidere un rimedio
Si consiglia di consultare uno specialista che potrà prescrivervi un breve ciclo (5-7 giorni) di farmaci antinfiammatori non steroidei per via orale (diclofenac, ibuprofene, nimesulide, ecc.) o selezionare un regime terapeutico completo.
Forte dolore
A seconda della localizzazione del dolore: in caso di mal di schiena - unguento Capsicam® (2-3 volte al giorno fino a 10 giorni), in caso di dolore muscolare - Valusal® gel (2-3 volte al giorno fino a 10 giorni), in caso di dolori articolari - unguento Viprosal B® (1-2 volte al giorno per un massimo di 14 giorni). Ti aiuterà a decidere un rimedio
Come “ambulanza”, puoi assumere una compressa anestetica per via orale, disponibile in farmacia senza prescrizione medica.
È indicato un consulto con uno specialista, che potrà prescriverti un breve ciclo (5-7 giorni) di farmaci antinfiammatori non steroidei per via orale (diclofenac, ibuprofene, nimesulide, ecc.) e selezionare un regime terapeutico completo.
È necessario l'aiuto di un medico.
Prima dell'arrivo del medico, prendi una posizione orizzontale per... Potrebbe essere necessario riposare a letto per 2-3 giorni.
A seconda della localizzazione del dolore: in caso di mal di schiena - unguento Capsicam® (2-3 volte al giorno fino a 10 giorni), in caso di dolore muscolare - Valusal® gel (2-3 volte al giorno fino a 10 giorni), in caso di dolori articolari - unguento Viprosal B® (1-2 volte al giorno per un massimo di 14 giorni). Ti aiuterà a decidere il rimedio.
Come “ambulanza” si può assumere per via orale una compressa anestetica, acquistabile in farmacia senza prescrizione medica (fino a 2-3 volte al giorno).
La terapia complessa e il corso ottimale di trattamento con farmaci di vari gruppi farmacologici possono essere prescritti solo dal medico curante.
Scala analogica visiva (VAS)
La scala analogica visiva (VAS) è stata originariamente creata per l'uso in medicina: su di essa il paziente doveva valutare l'intensità del dolore attualmente provato. Utilizzando il metodo VAS, su una linea retta lunga 10 cm, il paziente rileva l'intensità del dolore. L'inizio della linea a sinistra corrisponde all'assenza di dolore, la fine del segmento a destra corrisponde al dolore insopportabile. Per comodità dell'elaborazione quantitativa, le divisioni vengono applicate sul segmento ogni centimetro. La linea può essere orizzontale o verticale.
L’utilizzo della VAS è abbastanza diffuso in ambito medico perché presenta i seguenti vantaggi:
1) il metodo consente di determinare l'effettiva intensità del dolore;
2) la maggior parte dei pazienti, anche i bambini (dai 5 anni in su), imparano facilmente e utilizzano correttamente la VAS;
3) l'utilizzo del VAS consente di studiare la distribuzione dei rating;
4) i risultati della ricerca sono riproducibili nel tempo;
5) valutazione più adeguata dell'effetto del trattamento rispetto alla descrizione verbale del dolore. La VAS è stata utilizzata con successo in molti studi per esaminare l’efficacia della terapia.
Tuttavia, il VAS presenta anche alcuni svantaggi rispetto ad altri metodi. Innanzitutto, i pazienti possono indicare la scala in modo abbastanza arbitrario. Spesso tali voti non riflettono la realtà e non corrispondono alle valutazioni verbali del dolore fornite dai pazienti stessi. In secondo luogo, è necessario misurare la distanza dal segno tracciato, il che richiede tempo e precisione e sono possibili anche errori di misurazione. In terzo luogo, la VAS è difficile da spiegare ai pazienti anziani che non comprendono la connessione tra la linea e la posizione del segno su di essa. Infine, la fotocopiatura a volte provoca una distorsione della linea, che influisce sulla misurazione. Pertanto, la VAS non è considerata il metodo ottimale per misurare l’intensità del dolore negli adulti e nei pazienti anziani, ma è raccomandata come metodo efficace nei bambini.
Come già accennato, in ambito medico l’utilizzo della VAS nei vari studi è molto più comune che in qualunque altro campo. In particolare, questo vale per la psicologia.
La scala analogica visiva fu descritta per la prima volta nel 1921 da Hayes & Patterson. . Solo dal 1969 è diventato oggetto di studio serio, dopo la pubblicazione dell’opera di Aitken, ancora oggi attuale, a causa dell’esiguo numero di opere dedicate alla VAS.
Aitken ha utilizzato questa scala nel suo studio per valutare i sentimenti dei pazienti con disturbo depressivo. Credeva che all'osservatore venisse imposto un sistema digitale mentre un sistema analogico sarebbe stato più appropriato.
Se persone diverse usano la stessa parola, ciò non significa che provino le stesse emozioni: questo vale anche per la posizione dei segni sulla scala. Un'emozione vissuta due volte più intensa non può essere correlata ad un valore moltiplicato per due. Si tende a limitare la divisione in categorie, poiché solitamente vengono utilizzate solo quelle più elementari. Ciò rende tali scale inefficaci nello studio di associazioni specifiche a determinati concetti, ad esempio la grandezza fisica di uno stimolo. Queste scale non sono in grado di evidenziare le sfumature dei sentimenti.
Aitken era convinto che le analogie dovessero essere visive e non semplicemente frasi, altrimenti valutazioni estreme (ad esempio 0 o 5) si sarebbero verificate troppo spesso (Yerkes & Urban 1906).
Nel suo studio, ai pazienti è stato chiesto di segnare ogni giorno per diverse settimane l'intensità della loro condizione su una scala analogica visiva. In questa situazione, la scala era infatti molto adatta per misurare i cambiamenti e valutarne l’importanza. Tuttavia, il dottor Raymond Levy (Dipartimento di Psichiatria, Middlesex Hospital Medical School, Londra) ritiene di aver sottovalutato tutte le difficoltà incontrate quando si lavora con tali scale. Sospettava che tali scale fossero particolarmente efficaci nel valutare i pazienti con sintomi lievi che sapevano esattamente cosa intendeva il medico e che iniziarono a usare la stessa terminologia. I pazienti affetti da forme di depressione sia moderate che più gravi hanno avuto difficoltà nel lavorare con queste scale.
Il dottor J.P. Watson (Maudsley Hospital, Londra) riteneva che i problemi legati alla definizione dei termini e delle scale presentati dal dottor Aitken non fossero diversi dai problemi legati all’utilizzo di qualsiasi scala di valutazione. Si chiese se il dottor Aitken avesse prove che i pazienti fornissero deliberatamente risultati che sapevano essere sbagliati.
Il dottor Aitken ha sottolineato l'importanza del punto del dottor Levy ed è d'accordo con il dottor Watson nel ritenere che esso si applichi a tutti i tipi di autovalutazione. Nella sua esperienza, i pazienti oggi usano parole come "depressione" senza pensarci, ma non c'è dubbio che le loro parole possano significare qualcosa di molto diverso da quello che intendevano gli psichiatri quando le usavano. È necessario chiarire l’esatta natura del sintomo, come indicato nella valutazione clinica di tutti i sintomi. Le bilance analogiche possono determinare con precisione ciò che i pazienti vogliono comunicare, ma non ciò che il medico intendeva.
Questo studio spiega in dettaglio perché la VAS può essere migliore, più conveniente, più affidabile e più valida rispetto alle misure con punteggi o divisioni limitate. Ovviamente, le persone che soffrono di depressione rientrano in diverse categorie, e l'uso di un “sistema digitale” può distorcere i risultati dal punto di vista del fatto che il paziente semplicemente non cerca di pensare all'intensità delle sue esperienze e ne sceglie una dei valori estremi. L'uso di scale simili, ma solo con una descrizione della condizione, dà ancora una volta la sensazione di scegliere per il paziente senza ottenere un risultato veramente affidabile. Tuttavia, questo è solo uno studio in cui l'argomento è uno stato psicologico abbastanza complesso da poter selezionare chiaramente il miglior sistema di misurazione per esso.
In generale non sono molti gli studi che mettono a confronto scale Likert e scale analogiche visive. Ad esempio, in uno studio condotto da Torrance, Feeny e Furlong, la VAS ha dimostrato di avere una maggiore affidabilità rispetto alla scala Likert. . Un altro studio di Flynn che confronta una scala Likert a 5 punti e 65 mm. La VAS, utilizzando l'esempio della misurazione del coping, mostra che i soggetti, quando rispondono alla stessa domanda, mostrano risultati più elevati quando lavorano con una scala Likert, rispetto alla VAS.
Jennifer A. Cowley e Heather Youngblood, nel loro studio in cui hanno confrontato le differenze nelle risposte su scale visive analogiche, numeriche e miste, riferiscono di aver trovato emotivamente più difficile utilizzare scale analogiche rispetto a quelle numeriche perché le divisioni venivano lasciate vuote, non conteneva spiegazioni.
Le scale in cui ciascuna divisione conteneva una spiegazione testuale dettagliata hanno mostrato risultati più affidabili rispetto a quelle in cui alcune divisioni contenevano lacune. Inoltre, il vantaggio di utilizzare dati numerici, ad esempio, quando si lavora con l'analisi variazionale, è che in questo caso è possibile valutare determinate interazioni variabili, cosa impossibile quando si lavora con dati non parametrici.
Tuttavia, alcuni ricercatori potrebbero preferire le scale analogiche perché, a differenza delle scale numeriche, possono utilizzare efficienti analisi statistiche parametriche.
Anche in questo studio sono state utilizzate scale miste: scale analogiche con l'aggiunta di varie divisioni: digitali o con spiegazioni testuali selettive. Allo stesso tempo, è stata preservata l'opportunità di inserire la propria valutazione in qualsiasi punto della scala.
Le scale miste qui hanno mostrato punteggi medi molto più alti rispetto alle scale analogiche. Inoltre, le risposte raccolte dalle scale numeriche e miste non differivano molto tra loro, mentre le risposte dalle scale analogica e numerica divergevano notevolmente.
Pertanto, possiamo concludere che la VAS, come la scala Likert, ha i propri pro e contro. Tuttavia, il primo studio, come l'ultimo, ha sollevato la domanda principale che potrebbe successivamente risolvere il problema della scelta di uno strumento di misura: possiamo misurare caratteristiche come depressione, ansia o qualsiasi altra condizione continua con scale ordinali? In questo caso dovremmo utilizzare una scala non parametrica, perché utilizzando una scala ordinale rischiamo di ottenere un risultato approssimativo e lontano dal vero atteggiamento del soggetto, oltre a perdere una notevole quantità di dati.
È possibile che la soluzione a questo problema sia anche l’idea di utilizzare scale miste. Dato che in molti studi numerici e misti producono voti medi più alti, i ricercatori potrebbero chiedersi se ciò dipenda dal fatto che la persona valuta senza riferimento o in conformità con le divisioni numeriche e testuali. Sebbene questo problema non sia ancora stato risolto, i ricercatori possono utilizzare scale miste per facilitare ai soggetti la compilazione del questionario, garantendo l'affidabilità dei risultati dell'analisi parametrica utilizzando dati analogici.