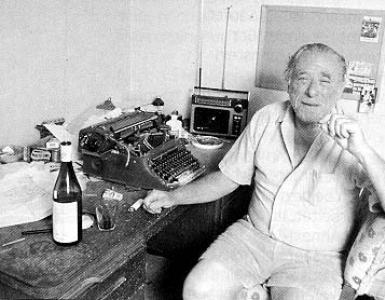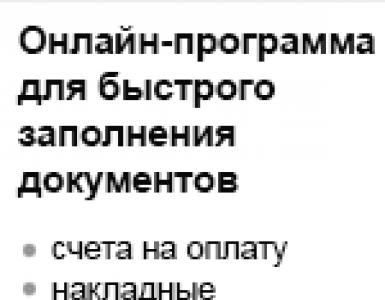Acuità visiva. Ragioni per un ridotto adattamento al buio
Alle funzioni principali analizzatore visivo includono la discriminazione di luminosità, colore, forma, dimensione degli oggetti osservati. La vista aiuta a regolare la posizione del corpo e a determinare la distanza da un oggetto.
L'occhio, come dispositivo ottico, è costruito come segue:
Fig. 1. Struttura dell'occhio: 1 – cornea; 2 – camera anteriore; 3 – iride; 4 – allievo; 5 – lente; 6 – corpo vitreo; 7 – retina; 8 – coroide; 9 – sclera; 10 – macchia gialla; 11 – punto cieco; 12 – corpo ciliare; 13 – nervo ottico.
1. Cornea - agisce come una struttura di rifrazione della luce (ben attrezzata terminazioni nervose– se toccato, si verifica il riflesso dell'ammiccamento).
2. Camera anteriore – situata tra la cornea e l'iride. La camera anteriore è piena di liquido.
3. Iride - contiene il pigmento che determina il colore degli occhi, regola la dimensione della pupilla e, di conseguenza, la quantità di luce che entra nell'occhio.
4. La pupilla è un foro nell'iride attraverso il quale la luce, bypassando la cornea e la camera anteriore, passa nell'occhio.
5. Il cristallino è una formazione biconvessa elastica trasparente che garantisce la focalizzazione dei raggi luminosi sulla retina.
6. L'umor vitreo è una sostanza semiliquida trasparente che mantiene la forma dell'occhio.
7. Retina - il guscio interno dell'occhio, costituito dai seguenti recettori: a) bastoncini - percepiscono la forma, sono responsabili della visione crepuscolare, situati alla periferia della retina nella quantità di 120 * 10 6; b) coni: percepiscono colori diversi, apparato per la visione diurna, numero - 6 * 10 6; c) neuroni: formano il nervo ottico con l'aiuto dei loro processi. La retina è la struttura finale che percepisce la luce.
8. Coroide - penetrata dai vasi sanguigni che forniscono sangue alla retina.
9. La sclera (tunica albuginea) è lo strato esterno dell'occhio. Protegge l'occhio dai danni e aiuta il bulbo oculare a mantenere la sua forma.
10. Macula: contiene solo coni. Zona di migliore visione. Di notte, la luce cade solo sulla macchia gialla, quindi una persona non può distinguere bene i colori al buio.
11. Il punto cieco è il punto della retina in cui il nervo ottico esce dall'occhio. Non ha fotosensibilità. Si trova asimmetricamente in occhi diversi.
12. Il corpo ciliare è un muscolo che regola il potere di rifrazione dei raggi da parte del cristallino.
13. Nervo ottico – percepisce l'eccitazione e la trasmette alla zona visiva della corteccia cerebrale, dove viene analizzata l'eccitazione e si formano le immagini visive.
Organi accessori dell'occhio:
· Sopracciglia – rimuovono il sudore dalla fronte;
· Palpebre – proteggono l'occhio dai raggi luminosi e dalla polvere. Il numero di ciglia è di circa 80 su ciascuna palpebra. Le ciglia cadono e ricrescono in 100 giorni.
· Apparato lacrimale: le lacrime inumidiscono, puliscono e disinfettano l'occhio. La quantità di lacrime prodotte è di circa 0,01 litri al giorno. Le lacrime liberano il corpo sostanze chimiche, associato a sovraccarico nervoso, il cui contenuto diminuisce del 40%. Gli uomini di solito sbattono le palpebre una volta ogni 5 secondi, le donne più spesso.
Per ottenere un'immagine nitida, la messa a fuoco deve essere sulla retina.

Fig.2. Reazione dell'iride ai cambiamenti di illuminazione.
La visione binoculare significa vedere con due occhi. Ti consente di sentire le immagini in rilievo degli oggetti, vedere la profondità e determinare la distanza dell'oggetto dall'occhio quando guardi gli oggetti con gli occhi sinistro e destro.
La diottria è la regolazione dell'occhio per produrre un'immagine chiara sulla retina a diverse distanze. Il processo di adattamento viene effettuato modificando la curvatura della lente. Quando si visualizzano oggetti vicini, la lente diventa più convessa, grazie alla quale i raggi degli oggetti convergono sulla retina. Quando si osservano oggetti a grande distanza, il muscolo ciliare è rilassato e i legamenti attaccati principalmente alle superfici anteriore e posteriore della capsula del cristallino sono tesi in questo momento, il che provoca la compressione del cristallino e il suo potere rifrattivo diventa minimo.
Il punto di visione più vicino è la distanza più breve dall'occhio alla quale l'oggetto è ancora chiaramente visibile.
Caratteristiche dell'età. Nei primi mesi dopo la nascita, il bambino vede gli oggetti nella loro immagine invertita. Fino ai 9-12 anni gli occhi di una persona sono lungimiranti. Il punto più vicino di visione chiara si allontana con l'età. A 10 anni dista meno di 7 cm dall'occhio, a 20 - 8,3 cm, a 30 - 11 cm, a 35 - 17 cm, e a 60-70 anni si avvicina a 80-100 cm.
Negli scolari più giovani, la miopia lieve è più comune, fino a 3D. Se la correzione non viene avviata in tempo, il processo potrebbe peggiorare.
Istituzione educativa di bilancio dello Stato federale
più alto formazione professionale
"Università pedagogica statale di Tomsk"
(TSPU)
approvo
________________________
Direttore dell'IC
"______" _______________ 2012
PROGRAMMA DI LAVORO DELLA DISCIPLINA ACCADEMICA (MODULO)
ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA
ORGANI DELL'UDITO, DELLA PAROLA E DELLA VISIONE
B.3 Ciclo professionale. B. 3. 00 Parte base
Modulo 2 “Fondamenti medici e biologici della difettologia”
^ INTENSITÀ DI LAVORO (IN UNITÀ DI CREDITO)4
Direzione della formazione Educazione speciale (difettologica).
Profilo formativo Logopedia 050700.62
Titolo di studio (laurea) laurea breve
^ Obiettivi di studio della disciplina (modulo)
Anatomia, fisiologia e patologia degli organi dell'udito, della parola e della vista è la scienza della struttura, del funzionamento degli organi dell'udito, della parola e della vista in condizioni normali e patologiche.Il corso è fondamentale per lo studio di molte discipline speciali della logopedia . Un insegnante di logopedista deve avere una buona conoscenza della struttura, delle funzioni, della regolazione e delle relazioni fisiologiche dell'apparato vocale e dei sistemi sensoriali. Solo in questo caso lo specialista è in grado di comprendere l'eziologia e la patogenesi dei disturbi del linguaggio e non del linguaggio vari tipi patologie, pianificare e svolgere con competenza lavoro correzionale e pedagogico.
Bersaglio: formazione di conoscenze sistematizzate sulla struttura, il funzionamento e le patologie più comuni degli organi dell'udito, della parola e della vista e il loro utilizzo nella scelta di metodi adeguati di correzione medica e pedagogica e di compensazione dei disturbi.
Compiti:
Studio della struttura degli organi dell'udito, della parola, della vista;
Studio della fisiologia degli organi dell'udito, della parola, della vista;
Studio delle caratteristiche legate all'età di questi organi nei bambini di età diverse;
Familiarizzazione con le patologie più comuni degli organi dell'udito, della parola, della vista e le cause della perdita dell'udito, della sordità, della parola e della vista;
Familiarizzazione con metodi per lo studio delle funzioni uditive, linguistiche e visive negli adulti e nei bambini;
Familiarizzazione con metodi di correzione e compensazione dell'udito e della vista per lo sviluppo della parola e lo sviluppo mentale del bambino.
^ Il posto della disciplina accademica (modulo) nella struttura del programma educativo principale.
Questa disciplina si basa su dati provenienti dall'anatomia e fisiologia umana, dalla neurofisiologia, dalla logopedia, dalla fisica e dalla psicologia. Fornisce formazione a specialisti che lavorano con bambini con problemi di udito, linguaggio e vista.
3. Requisiti per il livello di padronanza del programma.
Lo studente deve sapere:
struttura degli organi dell'udito, della parola, della vista;
basi fisiologiche dell'attività degli organi dell'udito, della parola, della vista;
caratteristiche legate all'età della struttura e del funzionamento degli organi dell'udito, della parola, della vista;
eziologia, patogenesi, clinica della patologia congenita e acquisita degli organi
Lo studente deve essere in grado di:
utilizzare modelli e tabelle anatomiche per determinare le varie strutture dei sistemi uditivo, visivo e vocale;
analizzare varie patologie delle parti periferiche dei sistemi uditivo, visivo e vocale e le cause che portano a disturbi persistenti;
svolgere trattamento, riabilitazione e lavoro pedagogico correzionale per patologie degli organi dell'udito, della parola, della vista;
Lo studente deve possedere:
modalità di orientamento nelle fonti di informazione professionali (riviste, siti web, portali educativi) per la conoscenza di sé e l'autosviluppo;
metodi semplici per studiare le funzioni uditive, vocali e visive nei bambini;
metodi di prevenzione, igiene, correzione e riabilitazione vari disturbi sistemi visivi, uditivi e linguistici negli adulti e nei bambini.
Lo studente deve possedere competenze culturali generali (GC):
possedere una cultura del pensiero, la capacità di generalizzare, analizzare, percepire informazioni, fissare un obiettivo e scegliere i modi per raggiungerlo (OK-1);
disponibilità ad usare metodi educazione fisica autoeducazione per aumentare le riserve adattive del corpo e migliorare la salute (OK-5);
la capacità di strutturare logicamente correttamente il discorso orale (OK-7);
capacità di lavorare con le informazioni nelle reti informatiche globali (OK-9);
consapevolezza del significato sociale della propria futura professione, possesso di motivazione allo svolgimento dell'attività professionale (GPC-1);
la capacità di assumersi la responsabilità dei propri risultati attività professionale(OPK-4);
capacità di interagire con bambini con disturbi del linguaggio, genitori, colleghi (GPC-6);
disponibilità a garantire la tutela della vita e della salute degli studenti nel processo educativo e nelle attività extrascolastiche (PC-8).
Capacità di analizzare aspetti legati all'età sviluppo degli organi di senso; Senso misure igieniche per la prevenzione delle malattie degli organi della vista, dell'udito e della parola; disponibilità ad applicare le conoscenze sulle caratteristiche dello studio della ricezione uditiva e visiva nelle attività professionali (PSK-2):
^ 4. Intensità lavorativa totale della disciplina (modulo) 4 unità di credito e tipologie di lavoro educativo.
| Tipo di lavoro educativo | Intensità del lavoro (secondo il curriculum) (ora) | Distribuzione per Semestri (secondo il curriculum) (ore) |
|||
| Totale | 1 2 3 |
||||
| Lezioni uditive | 72 | 72 | |||
| Lezioni | 36 | 36 | |||
| Lezioni pratiche e seminari | 36 | 36 | |||
| Seminari | |||||
| Lavori di laboratorio | |||||
| Altri tipi di attività in classe | |||||
| Lavoro indipendente | 72 | 72 | |||
| Progetto del corso (lavoro) | |||||
| Calcoli e lavori grafici | |||||
| Forme di controllo corrente | Prove, c/r | Prove, c/r | |||
| Forme di certificazione intermedia in conformità con il curriculum | Esame | Esame | |||
^ 5. Contenuti della disciplina accademica (modulo).
5.1 Sezioni della disciplina accademica (modulo).
| №p/p | Nome della sezione disciplinare (argomento) | ^ Tipi di lavoro educativo (ore) (secondo il curriculum) |
|||
| lezioni | pratico (seminari) | lavori di laboratorio | indipendente |
||
| 1. | Anatomia, fisiologia e patologia degli organi uditivi | 22
|
|||
| 2. | | 26 |
|||
| 3. | Anatomia, fisiologia e patologia degli organi visivi | 24
|
|||
| Ore totali | 36 | 36 | 72 |
||
5.2. Contenuti delle sezioni della disciplina (modulo).
^ 1. Anatomia, fisiologia e patologia degli organi uditivi.
Idee generali sui sistemi sensoriali (analizzatori). Struttura e funzioni dell'orecchio esterno, medio ed interno. Struttura dell'organo del Corti. Il suono, le sue caratteristiche, la propagazione del suono in un mezzo, il concetto di risonanza. Meccanismo di percezione vibrazioni sonore. Vie e parte corticale del sistema sensoriale uditivo. Conduzione ossea suono. Sensibilità del sistema sensoriale uditivo, adattamento uditivo, affaticamento uditivo. Caratteristiche legate all'età della struttura e del funzionamento dell'organo uditivo. Metodi di test dell'udito negli adulti e caratteristiche dei test dell'udito nei bambini. L'importanza dell'udito per lo sviluppo del linguaggio e lo sviluppo mentale generale.
Disturbi uditivi congeniti e acquisiti. Classificazione del deficit uditivo persistente nei bambini e caratteristiche del loro sviluppo del linguaggio. Metodi per compensare la funzione uditiva compromessa nei bambini. Preventivo di base e misure terapeutiche per la perdita dell'udito nei bambini.
^ 2. Anatomia, fisiologia e patologia degli organi della parola.
Discorso simile rimedio speciale comunicazione tra le persone . Il concetto di parti periferiche e centrali dell'apparato vocale. Sezione respiratoria dell'apparato vocale. Partecipazione degli organi respiratori alla funzione vocale. Caratteristiche della respirazione durante il discorso. Caratteristiche legate all'età del sistema respiratorio.
Sezione vocale dell'apparato vocale. La laringe, sua ubicazione, struttura, cartilagini della laringe. Cono elastico, corde vocali (false e vere), glottide. Muscoli esterni ed interni della laringe, loro significato, funzioni della laringe. Caratteristiche di età e sesso della laringe. Il meccanismo di formazione della voce, caratteristiche del meccanismo del sussurro, falsetto. Caratteristiche della voce: forza, altezza, timbro, estensione. Il concetto di registri. Caratteristiche dell'estensione vocale legate all'età.
Dipartimento articolatorio dell'apparato vocale. Organi di articolazione attivi e passivi. L'importanza per la pronuncia sonora delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche di labbra, gengive, denti, palato molle e duro, caratteristiche legate all'età di queste parti dell'apparato vocale. La struttura e le funzioni della lingua, i muscoli della lingua, il loro significato. Il ruolo del linguaggio nella funzione vocale. Sezione risonatore dell'apparato vocale. Il concetto di tubo di prolunga, le sue sezioni. La struttura e le funzioni della cavità nasale, dei seni paranasali, il loro significato. La struttura e le funzioni delle parti della faringe (rinofaringe, orofaringe, parte laringea). Anello linfoide faringeo, suo significato. Caratteristiche legate all'età della sezione risonante dell'apparato vocale. Caratteristiche dello studio degli organi del linguaggio nei bambini.
Patologia (anomalie dello sviluppo, lesioni e malattie) degli organi vocali nei bambini, caratteristiche cliniche e caratteristiche del decorso della malattia, impatto sulla voce e sulla formazione del linguaggio.
Il ruolo dell'insegnante e dell'educatore nel trattamento e nel lavoro correzionale dei disturbi del linguaggio nei bambini. L'importanza dell'ambiente sociale per lo sviluppo del linguaggio nei bambini.
^ 3. Anatomia, fisiologia e patologia degli organi visivi.
La struttura dell'occhio, l'apparato ausiliario dell'occhio. Sistema ottico occhi, costruendo un'immagine sulla retina. Sistemazione dell'occhio, suo meccanismo. Struttura e funzioni della retina. Significato funzionale dei bastoncelli e dei coni. Visione dei colori, acuità visiva, campo visivo, visione binoculare. Conduzione di percorsi del dipartimento corticale del sistema sensoriale visivo. Caratteristiche legate all'età della struttura e del funzionamento del sistema sensoriale visivo. Metodi per lo studio delle funzioni visive nei bambini.
Patologia congenita ed acquisita degli organi visivi. Cause profonde violazioni vista nei bambini. Il ruolo della percezione visiva nella formazione della parola nei bambini sordi e con problemi di udito e nei loro sviluppo psicofisico. Raccomandazioni oftalmologiche per il processo di allevamento ed educazione dei bambini con l'una o l'altra patologia visiva. Igiene e protezione della vista nei bambini. La connessione tra trattamento e riabilitazione e lavoro pedagogico correzionale in istituti speciali per bambini con disabilità visive.
5. 3. Esercitazioni pratiche
| NO. | Numero della sezione disciplinare | Nome lavoro pratico |
| Studio della struttura dell'orecchio esterno e medio. Studio della struttura dell'orecchio interno, struttura dell'organo del Corti. Studio dell'acuità uditiva utilizzando il sussurro e il parlato, i diapason... Confronto tra la conduzione del suono per via aerea e ossea nell'uomo, guardando il video “Hearing Analyser”. Studio della patologia dell'organo uditivo. Esami, seminario online sul tema: “Anatomia, fisiologia e patologia dell'organo uditivo”. |
||
| Studio della struttura del sistema respiratorio umano e del meccanismo dei movimenti respiratori. Studio della capacità vitale dei polmoni nell'uomo. Condurre il controllo della conoscenza intermedia. Studio della struttura della laringe, localizzazione e funzioni dei muscoli della laringe. Studio della struttura degli organi di articolazione. Studio della struttura delle cavità nasali, dei seni paranasali e delle loro caratteristiche legate all'età. Lavoro di prova, seminario online, test sull'argomento: "Anatomia, fisiologia e patologia degli organi del linguaggio". |
||
| Studio dell'acuità visiva secondo la tabella, visione dei colori nell'uomo. Studio dello stato della visione binoculare. Determinazione dei confini dei campi visivi incolori e a colori negli esseri umani. Seminario online sul tema: “Struttura e funzionamento del sistema sensoriale visivo”. Studio della patologia dell'organo della vista. |
Per il lavoro pratico c'è un laboratorio: Kazionova L.F., Nizkodubova S.V., Sedokova M.L. Fisiologia dell'uomo e degli animali "Attività nervosa superiore e sistemi sensoriali".
^ 6. Supporto didattico e metodologico della disciplina.
6.1 Letteratura di base:
1. Kazionova, L. F. Fisiologia dell'uomo e degli animali. “Attività nervosa superiore e sistemi sensoriali”: seminario / L. F. Kazionova, S. V. Nizkodubova, M. L. Sedokova; a cura di S. V. Nizkodubova. - Tomsk: Centro per i metodi educativi e la letteratura del TSPU, 2005. - 76 p.
2. Leontyeva, N. N. Anatomia e fisiologia corpo del bambino(fondamenti dello studio della cellula e dello sviluppo dell'organismo, del sistema nervoso, sistema muscoloscheletrico): manuale per le università / N. N. Leontieva, K. V. Marinova. – M: Educazione, 1986. - 287 p.
3. Sapin, M. R. Anatomia e fisiologia del bambino e dell'adolescente [Testo]: libro di testo per le università/M. R. Sapin, Z. G. Bryksina.-4a ed., rivisto. e aggiuntivi - M.: Academy, 2005.-432 p.:
5. Ovchinnikov, Yu.M. Malattie del naso, della faringe, della laringe e dell'orecchio: libro di testo. per gli istituti medici / Yu. M. Ovchinnikov, V. P. Gamov; - M.: Medicina, 2005. - 540 p.
^ 6.2 Ulteriori letture:
1. Neiman, L. B. Anatomia, fisiologia e patologia degli organi dell'udito e della parola: libro di testo. per l'istruzione superiore manuale istituzioni / L. B. Neiman, M. R. Bogomilsky; a cura di VI Seliverstov. Pedagogia correttiva. - M.: “Vlados”, 2003. - 224 p.
2. Sapin, M. R. Anatomia e fisiologia umana. Con le caratteristiche del corpo del bambino legate all'età [Testo]: libro di testo per università/M. R. Sapin, V. I. Sivoglazov. - 5a ed., rivista - M.: Academy, 2005. - 381, p.:
3. Podkolzina, Elena N. Orientamento spaziale dei bambini in età prescolare con disabilità visive [Testo]: supplemento alla rivista "Hoop": manuale metodologico/E. N. Podkolzina.-M.: LINK-PRESS, 2009.-169, p.:
Programmi per computer controllo della conoscenza intermedia e finale.
Risorse della sala didattica e metodologica “Museo Anatomico” (preparati naturali, manichini, tavolette, tavoli).
Strumenti per lo studio delle funzioni uditive e visive (diapason, spirometro, dispositivo per lo studio delle funzioni visive POZB-1, perimetro Forster, set di tabelle per determinare l'acuità visiva, visione dei colori).
Film video. Programmi informatici per il controllo della conoscenza intermedia e finale.
Quando si studia una disciplina, è utile visitarla http://window.edu.ru/ e un catalogo di risorse Internet http://www.edu.ru, biblioteca pedagogica http://www.pedlib.ru
^ 6.4. Supporto materiale e tecnico della disciplina (modulo).
| №p/p | Nome della sezione (argomenti) educativi disciplina (modulo) | Nome pacchetti software disposizione | Nome dei mezzi tecnici e audiovisivi utilizzati per dimostrare i materiali |
| 1. | Anatomia, fisiologia e patologia dell'organo uditivo | Serie di tavole di anatomia e fisiologia analizzatore uditivo, modelli e manichini dell'organo uditivo, diapason. | Video "Analizzatore dell'udito" |
| 2. | Anatomia, fisiologia e patologia degli organi della parola | Un insieme di tavole, modelli, disegni vari tipi patologia, spirometro | Test al computer sull'argomento. |
| 3. | Anatomia, fisiologia e patologia dell'organo della vista | Una serie di tavole sull'anatomia e la fisiologia dell'organo uditivo, modelli, modelli. Una serie di tabelle per determinare l'acuità visiva, la visione dei colori, un dispositivo per lo studio delle funzioni visive, il perimetro di Forster | Video “Visual Analyser”, test al computer. |
^ 7. Linee guida sull’organizzazione dello studio della disciplina
Per migliore assorbimento la disciplina richiede l'uso di una varietà di materiale illustrativo nelle lezioni frontali e nelle lezioni pratiche; condurre il monitoraggio attuale, intermedio e finale delle conoscenze degli studenti.
Riciclo sistematico (annuale). materiale delle lezioni corso della disciplina tenendo conto dei dati della scienza moderna.
Creazione di linee guida, compiti di prova per il controllo attuale, intermedio e finale delle conoscenze degli studenti sui supporti cartacei ed elettronici.
Preparazione di presentazioni di lezioni interattive, utilizzo durante le lezioni e lezioni pratiche filmati didattici, diapositive ed esperimenti dimostrativi.
Per padroneggiare efficacemente la disciplina, utilizzare materiali visivi (preparati umidi, manichini, compresse, ecc.) dal gabinetto anatomico metodologico - il museo TSPU - nei corsi teorici e pratici.
Condurre seminari interattivi durante le lezioni pratiche.
7.2. Linee guida per studenti
Per padroneggiare la disciplina, gli studenti necessitano per ciascuna sezione:
Studia le fonti letterarie ed evidenzia le idee principali in conformità con domande di controllo sotto forma di: curriculum, tesi, citazioni, appunti.
Preparare una presentazione orale della durata di 3-5 minuti, utilizzando materiali tratti da libri di testo, monografie, materiale didattico, esercizi pratici e risorse Internet.
Preparare un abstract sugli argomenti proposti, utilizzando il materiale informativo disponibile, tenendo conto dei progressi scientifici moderni e presentarlo su carta o mezzi elettronici.
Difendi il tuo punto di vista sulla questione in esame davanti al pubblico.
Risolvere problemi situazionali sull'argomento.
^ 8. Forme di monitoraggio continuo dei progressi e di certificazione intermedia degli studenti.
8.1 Argomenti degli abstract (relazioni, saggi));
Struttura, funzioni e patologia dell'orecchio esterno.
Struttura, funzioni e patologia dell'orecchio medio.
Struttura, funzioni e patologia dell'orecchio interno.
Caratteristiche e formazione dei bambini sordi e ipoudenti
Struttura, funzioni e patologia del dipartimento articolatorio dell'apparato vocale periferico
La struttura e le funzioni della laringe, il meccanismo di formazione della voce, il meccanismo del sussurro.
Patologia della sezione vocale dell'apparato vocale.
Struttura, funzioni e patologia della sezione risuonatrice dell'apparato vocale.
Caratteristiche di età e sesso della laringe.
La struttura dell'occhio. Sistema ottico dell'occhio.
Alloggio, suo meccanismo, caratteristiche dell'alloggio nei bambini.
Struttura, funzioni della retina, patologia della retina.
Miopia (miopia), cause della sua insorgenza, prevenzione, miopia nei bambini.
Visione dei colori e suoi disturbi.
Malattie dell'orbita oculare e delle palpebre. Strabismo.
Misure preventive e terapeutiche di base per i disturbi dell'udito e del linguaggio nei bambini.
8.2 Domande e compiti per il lavoro indipendente, compreso il lavoro indipendente di gruppo degli studenti.
1. Descrivi brevemente la struttura dell'analizzatore uditivo.
2. Descrivi la struttura dell'orecchio esterno. Quali funzioni svolgono le parti dell'orecchio esterno?
3. Quali sono le caratteristiche strutturali dell'orecchio medio? Che funzione svolgono gli ossicini uditivi?
4. Le sezioni periferiche di quali analizzatori si trovano nell'orecchio interno? Parlaci della parte periferica dell'analizzatore uditivo.
5. Caratteristiche delle proprietà fondamentali del suono.
6 Suoni del parlato e loro principali caratteristiche acustiche.
7. Quali tipi di trasmissione del suono conosci? Raccontaceli.
8. Qual è il significato fisiologico della percezione del suono?
9. Quali sono i principali indicatori della sensibilità dell'organo uditivo?
10. Evidenziare le fasi principali dello sviluppo della funzione uditiva nei bambini.
11. Quali malattie dell'orecchio esterno conosci? Come influiscono sulla funzione uditiva?
12. Descrivere brevemente le principali malattie dell'orecchio medio che portano a un danno uditivo persistente.
13. Quali malattie dell'orecchio interno conosci? Qual è il loro ruolo nel deficit uditivo?
14. Quali gruppi e su quale base possono essere divisi i bambini con problemi uditivi persistenti?
15. Caratteristiche della struttura del naso esterno e della cavità nasale.
16. Quali muscoli formano le labbra, le guance, cambiano la forma dell'apertura della bocca e muovono la mascella inferiore?
17. Come si trovano i denti nella mascella superiore e inferiore? Cos'è una formula dentale? Cos'è un morso?
18. Cos'è cielo solido e da cosa è formato?
19. Quali sono le funzioni palato fine?
20. Quali muscoli formano la lingua? Che tipo di movimento forniscono?
21. Quali sono le caratteristiche della struttura anatomica della faringe?
22. Quali cartilagini formano la laringe?
23. Apparato muscolare laringe (muscoli esterni ed interni).
24. Caratteristiche distintive della respirazione durante il discorso.
25. Capacità vitale polmoni, tipi di respirazione. Quale tipo di respirazione è più comune nelle donne, negli uomini e nei bambini?
26. Descrivi il meccanismo di formazione della voce.
27. Qual è il meccanismo del sussurro e del falsetto?
28. Raccontaci le principali proprietà della voce: forza, altezza, timbro. Da cosa dipendono?
29. Quali modalità di funzionamento della laringe conosci? Quali sono le loro differenze?
30. Cos'è un attacco sonoro? Che tipi di attacchi conosci? Quale attacco è igienicamente preferibile?
31. Cos'è la mutazione della voce? Quali sono le caratteristiche della mutazione nei ragazzi e nelle ragazze?
32. Come vengono esaminati gli organi del linguaggio nei bambini con difetti del linguaggio?
33. Raccontaci le principali malattie del naso e della cavità nasale. Come influiscono sui disturbi della voce e del linguaggio?
34. Cos'è il twang? Che tipi di nasalità conosci? Qual è la loro differenza?
35. Parlaci dei difetti delle fessure del labbro superiore e del palato, del loro effetto sulla funzione vocale.
36. Cosa sono le malocclusioni? Quali malocclusioni conosci, disturbi della pronuncia dei suoni?
37. Quali malattie della faringe conosci?
38. Parlaci delle malattie della laringe che portano a una compromissione della funzione vocale.
39. Raccontaci la struttura dell'analizzatore visivo.
40. Raccontaci della struttura e delle funzioni della membrana fibrosa dell'occhio.
41. Raccontaci della struttura e delle funzioni della coroide dell'occhio.
42. Quali sono le caratteristiche strutturali della retina?
43. Cos'è l'alloggio? Quali strutture oculari partecipano all’accomodazione? Caratteristiche di alloggio nei bambini.
44. Che tipologie di fotopigmenti conosci? Spiegare il meccanismo della fotoricezione.
45. Cos'è l'acuità visiva? Cos'è l'angolo di visione?
46. Quali metodi conosci per determinare l'acuità visiva?
47. Cos'è la percezione del colore?
48. Sistema ottico dell'occhio
49. Qual è la differenza tra rifrazione fisica e rifrazione clinica?
50. Quali errori di rifrazione conosci?
51. Raccontacelo cambiamenti legati all’età analizzatore visivo.
52. Cos'è una cataratta? Quali cambiamenti nelle strutture dell'occhio causano questa malattia?
53. Cosa viene definito disturbo della visione dei colori? A cosa sono dovuti?
54. Cos'è il glaucoma? I primi segni di glaucoma? Il disturbo di quale processo all'interno dell'occhio porta a questa malattia?
55. Parlaci delle malattie degli organi ausiliari dell'occhio che portano a disturbi della vista.
56. Fornire una classificazione delle disabilità visive.
57. Quali metodi di correzione della vista conosci?
8.3 Domande per autotest, dialoghi, discussioni, discussioni
1. Qual è la differenza tra un analizzatore uditivo e un organo dell'udito?
2. Espandi il ruolo percezione uditiva nello sviluppo del linguaggio.
3. Quali sono le principali cause della perdita permanente dell'udito?
4. Raccontaci i principali metodi oggettivi per lo studio della funzione uditiva.
5. Raccontacelo metodi soggettivi ricerca sull'udito in infanzia. Formulare il loro significato pratico.
6. Qual è il significato dell'udito residuo per i bambini sordi?
7. Raccontaci le principali misure per prevenire la perdita permanente dell'udito nei bambini.
8. Qual è la differenza tra la respirazione durante la formazione della voce?
9. Descrivi le fasi principali dello sviluppo del lato pronuncia del discorso nei bambini. Qual è la differenza nello sviluppo del linguaggio nei bambini con problemi di udito?
10. Quali misure conosci per prevenire i disturbi della voce e del linguaggio nei bambini?
11. Quali disturbi neuromuscolari possono portare a disturbi del linguaggio?
12. Espandi il ruolo dei tre blocchi funzionali del cervello nella formazione del linguaggio.
13. Caratterizzare lo stato del discorso orale con una diminuzione minima dell'acuità uditiva durante l'infanzia.
14. Qual è la differenza tra l'organo della vista e l'analizzatore visivo?
15. Cosa causa gli errori di rifrazione?
16. Cosa impatti negativi possono influenzare la formazione
Analizzatore visivo nel feto?
17. Quali disturbi visivi congeniti conosci?
18. Come la disabilità visiva può influenzare lo sviluppo della parola e l'istruzione superiore
Funzioni mentali nei bambini?
19. Parlaci della prevenzione del deficit visivo nei bambini
8.4. Esempi di prova
^ 1. La posizione migliore nell'occhio dei bambini e degli adulti è...
1. macula 2. punto cieco
3. corpo vitreo 4. cornea
2. La parte periferica del sistema sensoriale uditivo si trova in ...
1. orecchio esterno 2. orecchio interno
3. orecchio medio 4. corteccia temporale
^ 3. Nella cavità timpanica ci sono...
1. vestibolo e coclea 2. cellule ossee
3. ossicini uditivi 4. nervi uditivi e vestibolari
4. L'atresia del canale uditivo esterno è...
1. lesione al canale uditivo esterno
2. infiammazione del canale uditivo esterno
3. curvatura del canale uditivo esterno
4. fusione del canale uditivo esterno
^ 5.K sordità completa provoca malattie...
1. labirintite purulenta diffusa
2. labirintite limitata
3. catarrale otite media(tubootite)
4. perforazione residua nel timpano
^ 6. La tromba uditiva (di Eustachio) fornisce...
1. percezione delle vibrazioni sonore 2. capacità di distinguere l'altezza del suono
3. equalizzazione della pressione su entrambi i lati timpano
4. Determinazione della direzione del suono
^ 7. Quale errore di rifrazione dell'occhio è contrassegnato nella Figura 1 con il numero 2...
8. Nei bambini di età inferiore agli 8 - 10 anni, l'occhio è...
naturalmente miope
normale
astigmatico
naturalmente lungimirante
1. palatale 2. nasofaringeo
2. linguale 4. Tubo
1. aritenoide e cricoide
2. sfenoide e tiroide
3. epiglottide e sfenoide
4. tiroide e aritenoide
^ 11. Quando il muscolo aritenoideo trasversale si contrae, provoca...
^ 12. Il muscolo mento=glosso della lingua durante la contrazione...
1. spinge la lingua verso il basso 2. spinge la lingua in avanti
2. ritrae la lingua nella cavità orale
4. accorcia la lingua, piega la punta verso il basso
^ 13. Con paralisi del palato molle...
1. quando si pronunciano i suoni del parlato, l'aria passa solo attraverso il naso
2. quando si pronunciano i suoni del parlato, l'aria passa solo attraverso la bocca
3. L'aria passa attraverso la bocca e il naso quando si pronunciano i suoni del parlato
8.5. Elenco delle domande per la certificazione intermedia dell'esame
1. Caratteristiche generali dei sistemi di sensori (analizzatori).
2. La struttura dell'orecchio esterno, medio e interno.
3. Vie e divisione corticale del sistema sensoriale visivo.
4. Il suono, sue caratteristiche, Propagazione del suono nell'ambiente. Il concetto di risonanza.
5. Il meccanismo di comparsa delle sensazioni uditive.
6. meccanismo per percepire suoni di diverse altezze.
7. Conduzione del suono osseo
8. Sensibilità del sistema sensoriale uditivo. Adattamento uditivo, affaticamento uditivo.
9. Udito binaurale, il suo significato.
10. Caratteristiche legate all'età del sistema sensoriale uditivo.
11. Esame dell'udito nei bambini (sussurro e discorso ad alta voce, diapason, audiometro).
12. L'importanza dell'udito per lo sviluppo della parola nei bambini.
Anomalie dello sviluppo e malattie dell'orecchio esterno (atresia, tappi di cerume, corpi estranei), cause, trattamento.
Anomalie nello sviluppo del timpano. Danni al timpano, prevenzione, trattamento.
Qatar dell'orecchio medio, cause, caratteristiche della malattia, cambiamenti nell'udito, trattamento
Infiammazione cronica purulenta dell'orecchio medio (otite media purulenta cronica), cause, caratteristiche del decorso della prima e della seconda forma della malattia, trattamento, complicanze dopo la malattia.
Difetti e danni all'orecchio interno. Infiammazione dell'orecchio interno (labirintite), modalità di diffusione dell'infezione, labirintite diffusa (diffusa) e limitata, complicanze.
Malattie nervo uditivo, conduzione di percorsi e centri uditivi nel cervello.
Classificazione del deficit uditivo persistente nei bambini.
Caratteristiche dei bambini sordi (sordomuti e sordomuti tardivi).
Caratteristiche dei bambini con problemi di udito (ipoudenti). l’importanza della percezione uditiva per i bambini con problemi di udito.
Metodi per compensare la funzione uditiva compromessa nei bambini.
Misure preventive e terapeutiche di base per la perdita dell'udito nei bambini. Il rapporto tra cura e riabilitazione e il lavoro pedagogico correzionale.
24. Il concetto di parti periferiche e centrali dell'apparato vocale.
25. Caratteristiche della respirazione durante il discorso.
26. Sezione articolatoria dell'apparato vocale. Organi di articolazione attivi e passivi. Vestibolo della bocca, cavità orale, labbra, gengive, denti (da latte e permanenti), loro sostituzione, morso.
27. Struttura e funzioni del linguaggio. Muscoli della lingua, il loro significato. Il ruolo della lingua nella formazione dei suoni del parlato.
28. Sezione vocale dell'apparato vocale. La laringe, sua ubicazione, struttura, funzioni, cartilagini della laringe, cono elastico, corde vocali (false e vere) della laringe. Muscoli esterni ed interni della laringe, loro funzioni. Caratteristiche legate all'età della laringe. Il meccanismo di formazione della voce, caratteristiche del meccanismo del sussurro. Meccanismo del falsetto. Caratteristiche della voce: forza, altezza, timbro.
29 Il concetto di tubo di prolunga. Struttura del naso, cavità nasale, funzioni. Seni paranasali, il loro significato. La struttura della faringe, le sue sezioni, l'anello linfoide faringeo.
31. Malattie del naso: corizza, ragioni, ovviamente. Naso che cola cronico, cause, forme (semplici, ipertrofiche, atrofiche, allergiche), trattamento. L'effetto del naso che cola sulla voce e sulla formazione del linguaggio.
Nasale aperta e chiusa, cause, violazione della pronuncia dei suoni.
Difetti delle labbra e del palato, trattamento,
Difetti della lingua, delle mascelle, dei denti, conseguenze, trattamento.
Deformità cicatriziali della faringe, cause, conseguenze. Corpi estranei della faringe.
Mal di gola, cause, sintomi, decorso della malattia, trattamento, complicanze. Tonsillite cronica, cause, decorso, effetto sulla funzione vocale, trattamento.
Ipertrofia tonsille palatine, tonsilla nasofaringea, cambiamento di voce, cause, decorso della malattia, trattamento.
Patologie neuromuscolari: paralisi facciale, paralisi del nervo ipoglosso, paralisi del palato molle, paralisi del nervo ricorrente (unilaterale e bilaterale). Disturbi della fonazione dovuti a danni ai singoli rami del nervo ricorrente, trattamento.
Prevenzione dei disturbi della voce e del linguaggio nei bambini.
La struttura dell'occhio e l'apparato ausiliario dell'occhio.
Sistema ottico dell'occhio, che costruisce un'immagine sulla retina.
Sistemazione dell'occhio, suo meccanismo.
Struttura e funzioni della retina. Il ruolo dei bastoncelli e dei coni.
Visione dei colori. Acuità visiva, campo visivo, visione binoculare.
Vie di conduzione e parte corticale dell'analizzatore visivo.
Caratteristiche legate all'età della struttura e del funzionamento dell'analizzatore visivo.
Il ruolo della percezione visiva nella formazione del linguaggio nei bambini
Disturbi della visione dei colori
50. Strabismo, sue tipologie, compromissione della visione binoculare, cause, trattamento.
51. Patologia delle palpebre: blefarite, orzaiolo, cause, decorso della malattia, trattamento.
52. Congiuntivite, suoi tipi, trattamento.
8.7 Forme di controllo autonomo del lavoro
Consulenze programmate, prove, prove, esami.
Il programma di lavoro della disciplina accademica (modulo) è redatto in conformità con il curriculum dello stato federale standard educativo istruzione professionale superiore nel campo della formazione 050700.62 Educazione speciale (difettologica), “Logoterapia”.
Il programma di lavoro della disciplina accademica (modulo) è compilato:
Professore associato del Dipartimento di MBD Kazionova L.F.
Il programma di lavoro della disciplina accademica (modulo) è stato approvato in una riunione del dipartimento
Protocollo n. __ del ________________20
Testa Dipartimento di MBD _______________________ Nizkodubova S.V.
Il programma di lavoro della disciplina accademica (modulo) è stato approvato dalla commissione metodologica dell'Istituto di Cultura ___________________
Protocollo n. ___ del _______________20
Presidente della commissione metodologica della CE ____________ Baturina O.A.
Concordato:
Preside dell'Istituto _____________ Kayumova E.A.
OCCHIO
organo della vista che percepisce la luce. L'occhio umano è di forma sferica, il suo diametro è di ca. 25 mm. Il muro di questa sfera ( bulbo oculare) è costituito da tre membrane principali: quella esterna, rappresentata dalla sclera e dalla cornea; tratto vascolare medio: la coroide stessa e l'iride; e interno - retina. L'occhio ha strutture ausiliarie (appendici): palpebre, ghiandole lacrimali, così come i muscoli che forniscono i suoi movimenti.

Sclera e cornea. Lo strato esterno dell'occhio ha una funzione principalmente protettiva. La maggior parte di questo guscio è costituita dalla sclera (dal greco sclrs - duro). È opaco, il bianco dell'occhio è la sua parte visibile. Nella parte anteriore dell'occhio, la sclera si fonde con la cornea. La sclera e la cornea sono formate da tessuto connettivo e contengono cellule e fibre. La cornea è molto elastica e trasparente, non contiene vasi sanguigni. Davanti è coperto da un epitelio liscio aderente, che è una continuazione dell'epitelio della congiuntiva, che copre il bianco dell'occhio. Si ritiene che la trasparenza della cornea sia associata alla corretta disposizione delle fibre di cui è prevalentemente costituita. Queste fibre sono molto sottili, hanno quasi lo stesso diametro e sono disposte parallelamente tra loro, formando strutture reticolari tridimensionali. La trasparenza della cornea dipende anche dal grado di umidità e dalla presenza di muco. La curvatura della cornea, il principale tessuto focalizzante, influisce sull'acuità visiva: peggiora se il raggio di curvatura non è lo stesso ovunque. Questa condizione è chiamata astigmatismo; la sua forma debole si presenta così spesso che può essere considerata normale.
Tratto vascolare (uveale). Questo è lo strato intermedio del bulbo oculare; è pieno di vasi sanguigni e la sua funzione principale è nutrizionale. Nella coroide vera e propria, nel suo strato più interno, chiamato placca coriocapillare e situato vicino allo strato vitreo (membrane di Bruch), sono presenti vasi sanguigni molto piccoli che forniscono nutrimento alle cellule visive. Le membrane di Bruch separano la coroide dall'epitelio pigmentato retinico. La coroide è altamente pigmentata in tutte le persone tranne che negli albini. La pigmentazione rende opaca la parete del bulbo oculare e riduce la riflessione della luce incidente. Anteriormente, la coroide è solidale con l'iride, che forma una sorta di diaframma, o cortina, e separa parzialmente la parte anteriore del bulbo oculare dalla sua parte posteriore, molto più grande. Le due parti sono collegate attraverso la pupilla (il foro al centro dell'iride), che assomiglia ad una macchia nera.
Iride (iride). Dà colore agli occhi. Il colore degli occhi dipende dalla quantità e dalla distribuzione del pigmento nell'iride e dalla struttura della sua superficie. Il colore degli occhi azzurri è causato dal pigmento nero racchiuso in granuli. Negli occhi molto scuri, il pigmento è distribuito in tutta l'iride. Diverse quantità e distribuzione del pigmento, e non il suo colore, determinano il marrone, il grigio o il grigio colore verde occhio. Oltre al pigmento, l'iride contiene molti vasi sanguigni e due sistemi muscolari, uno dei quali restringe e l'altro dilata la pupilla quando l'occhio si adatta a diversi livelli di luce. Bordo anteriore la coroide, nel punto in cui è attaccata all'iride, forma da 60 a 80 pieghe disposte radialmente; sono chiamati processi ciliari (ciliari). Insieme ai muscoli ciliari (ciliari) situati sotto di loro, costituiscono il corpo ciliare (ciliare). Quando i muscoli ciliari si contraggono, la curvatura del cristallino cambia (diventa più rotonda), migliorando la messa a fuoco delle immagini di oggetti vicini sulla retina fotosensibile.
Lente. Dietro la pupilla e l'iride si trova il cristallino, che è una lente chiara, biconvessa, sostenuta da numerose fibre sottili attaccate vicino al suo equatore e ai bordi dei suddetti processi ciliari. La sostanza della lente è costituita da fibre trasparenti densamente raggruppate. La curvatura della superficie del cristallino è tale che la luce che lo attraversa viene focalizzata sulla superficie della retina. La lente è inserita in una capsula elastica (sacchetto), che le consente di ripristinare la sua forma originale quando la tensione delle fibre di sostegno si indebolisce. L'elasticità del cristallino diminuisce con l'età, riducendo la capacità di vedere chiaramente gli oggetti vicini e, soprattutto, rendendo più difficile la lettura.
Fotocamere anteriori e posteriori. Lo spazio davanti al cristallino e dove si attacca al corpo ciliare dietro l'iride è chiamato camera posteriore. Si collega alla camera anteriore, situata tra l'iride e la cornea. Entrambi questi spazi sono pieni di umore acqueo, un liquido simile nella composizione al plasma sanguigno, ma contenente pochissime proteine e caratterizzato da una concentrazione inferiore e variabile di sostanze organiche e organiche. minerali. L'umor acqueo viene costantemente sostituito, ma il meccanismo della sua formazione e sostituzione non è ancora conosciuto con precisione. La sua quantità è determinata dalla pressione intraoculare ed è sempre normale. Il luogo di formazione dell'umor acqueo sono i processi ciliari, ricoperti da un doppio strato di cellule epiteliali. Passando attraverso la pupilla, il liquido lava il cristallino e l'iride e cambia la sua composizione durante lo scambio che avviene tra loro. Dalla camera anteriore, passa attraverso il tessuto cellulare alla giunzione tra cornea e iride (chiamato angolo iridocorneale) ed entra nel canale di Schlemm, un vaso circolare in questa parte dell'occhio. Inoltre, attraverso vasi chiamati vene acquose, l'umore acqueo da questo canale entra nelle vene della superficie esterna dell'occhio. Dietro il cristallino, che riempie 4/5 del volume del bulbo oculare, si trova una massa trasparente: il corpo vitreo. È formato da una sostanza colloidale trasparente, che è un tessuto connettivo altamente modificato. La retina è lo strato interno dell'occhio adiacente al corpo vitreo. Durante lo sviluppo embrionale si forma a partire da un processo del cervello ed è essenzialmente una parte specializzata di quest'ultimo. Questa è la parte funzionale più importante dell'occhio, poiché è quella che percepisce la luce. La retina è costituita da due strati principali: uno strato sottile di pigmento rivolto verso la coroide e uno strato altamente sensibile tessuto nervoso, che, come una ciotola, circonda maggior parte corpo vitreo. Questo secondo strato è organizzato in modo complesso (sotto forma di diversi strati o zone) e contiene cellule fotorecettrici (visive) (bastoncelli e coni) e diversi tipi di neuroni con numerosi processi che li collegano alle cellule fotorecettrici e tra loro; assoni cosiddetti I neuroni gangliari formano il nervo ottico. Il punto di uscita del nervo è la parte cieca della retina, la cosiddetta. punto cieco. Ad una distanza di ca. 4 mm dall'angolo cieco, cioè molto vicino al polo posteriore dell'occhio c'è una depressione chiamata macula. La parte centrale più depressa di questo punto - la fovea centrale - è il luogo della messa a fuoco più accurata dei raggi luminosi e della migliore percezione degli stimoli luminosi, ad es. questa è l'area di migliore visione. I bastoncelli ed i coni, così chiamati per la loro forma caratteristica, si trovano nello strato più lontano dal cristallino; le loro estremità libere sensibili alla luce sporgono nello strato di pigmento (cioè sono dirette lontano dalla luce). La retina umana contiene ca. 6-7 milioni di coni e 110-125 milioni di bastoncelli. Queste cellule fotorecettrici sono distribuite in modo non uniforme. La fovea e la macula lutea contengono solo coni. Verso la periferia della retina il numero dei coni diminuisce e quello dei bastoncelli aumenta. La parte periferica della retina contiene esclusivamente bastoncelli. Il punto cieco non contiene fotorecettori. I coni forniscono visione diurna e percezione del colore; aste: crepuscolo, visione notturna. Lo strato pigmentato è costituito da cellule epiteliali con lunghi processi pieni di pigmento nero - melanina. Questi processi separano i bastoncelli dai coni gli uni dagli altri e il pigmento che contengono impedisce la riflessione della luce. L'epitelio pigmentato è anche ricco di vitamina A e svolge un ruolo significativo nella nutrizione e nel mantenimento dell'attività dei fotorecettori.


Connessioni neurali. La luce che cade sull'occhio passa attraverso la cornea, l'umor acqueo, la pupilla, il cristallino, il corpo vitreo e diversi strati della retina, dove colpisce i coni e i bastoncelli. Le cellule visive rispondono a questo stimolo generando un segnale che viaggia verso i neuroni retinici (cioè nella direzione opposta rispetto fascio di luce). La trasmissione del segnale dai recettori avviene attraverso le sinapsi situate nel cosiddetto. strato esterno in rete; l'impulso nervoso entra quindi nello strato reticolare intermedio. Alcuni neuroni di questo strato trasmettono l'impulso ulteriormente al terzo strato, quello gangliare, e alcuni lo usano per regolare l'attività varie parti retina. Le fibre gangliari (formano lo strato della retina più vicino al corpo vitreo, separato da esso solo da una sottile membrana) si dirigono verso il punto cieco e qui si fondono, formando il nervo ottico, che va dall'occhio al cervello. Gli impulsi nervosi lungo le fibre del nervo ottico entrano in aree simmetriche della corteccia visiva emisferi cerebrali dove si forma l'immagine visiva.

VISIONE
La visione è un processo che fornisce la percezione della luce. Vediamo gli oggetti perché riflettono la luce. I colori che distinguiamo sono determinati dalla quantità di spettro visibile che un oggetto riflette o assorbe. Quando le cellule della retina, coni e bastoncelli, sono esposte alla luce con lunghezze d'onda comprese tra 400 nm (viola) e 750 nm (rosso), sperimentano reazione chimica, a seguito del quale si verifica un segnale nervoso. Questo segnale raggiunge il cervello e crea una sensazione di luce nella coscienza di veglia.
Sistemi visivi. Nell'occhio umano (e in molti animali) esistono due sistemi di percezione della luce: coni e bastoncelli. Il processo visivo è meglio studiato usando come esempio i bastoncelli, ma c'è motivo di credere che avvenga in modo simile nei coni. Affinché si verifichi la reazione chimica che avvia il segnale nervoso, la cellula fotorecettrice deve assorbire l'energia luminosa. Per questo viene utilizzato il pigmento che assorbe la luce rodopsina (chiamato anche viola visivo) - un composto complesso formato come risultato del legame reversibile della lipoproteina scotopsina con una piccola molecola di un carotenoide che assorbe la luce - retinale, che è l'aldeide forma di vitamina A. Sotto l'influenza della luce, la rodopsina viene divisa in retinale e scotopsina. Dopo la cessazione dell'esposizione alla luce, la rodopsina viene immediatamente risintetizzata, ma parte della retina può subire ulteriori trasformazioni e per ricostituire il suo apporto nella retina è necessaria la vitamina A. Il processo descritto può essere considerato provato e non vi è dubbio che la rodopsina, in quanto composto fotosensibile dei bastoncelli, garantisce la visione almeno in condizioni di scarsa illuminazione. Se ci si sposta da un luogo molto illuminato ad uno poco illuminato, come accade quando si visita un teatro a mezzogiorno, l'interno inizialmente sembrerà molto buio. Ma dopo pochi minuti questa impressione passa e gli oggetti diventano chiaramente distinguibili. Durante l'adattamento al buio, la visione dipende quasi interamente dai bastoncelli, poiché funzionano meglio in condizioni di scarsa illuminazione. Poiché i bastoncelli sono daltonici, la visione in condizioni di scarsa illuminazione è praticamente incolore (visione acromatica). Se l'occhio viene improvvisamente esposto a una luce intensa, vediamo male durante un breve periodo di adattamento in cui i coni assumono il ruolo principale. Con una buona illuminazione possiamo distinguere chiaramente i colori, poiché la percezione del colore è una funzione dei coni.

Teorie della visione dei colori. La base per lo studio della visione dei colori fu posta da Newton, che la dimostrò con l'aiuto di un prisma luce bianca può essere scomposto in uno spettro continuo e, ricombinando i componenti dello spettro, è possibile ottenere nuovamente la luce bianca. Successivamente sono state proposte molte teorie per spiegare la visione dei colori. La teoria della visione dei colori di G. Helmholtz, modificando la teoria di T. Jung, è diventata classica. Afferma che tutti i colori si possono ottenere mescolando tre colori primari: rosso, verde e blu, e la percezione del colore è determinata sulla retina da tre diverse sostanze fotosensibili situate nei coni. Questa teoria fu confermata nel 1959, quando si scoprì che esistono tre tipi di coni nella retina: alcuni contengono pigmenti con il massimo assorbimento nella parte blu dello spettro (430 nm), altri - in quella verde (530 nm). , e altri - in rosso (560 nm). ). I loro spettri di sensibilità si sovrappongono parzialmente. L'eccitazione di tutti e tre i tipi di coni crea la sensazione bianco, "verde" e "rosso" - giallo, "blu" e "rosso" - viola. Tuttavia, la teoria di Helmholtz non ha fornito una spiegazione per una serie di fenomeni di percezione del colore (ad esempio, la sensazione del marrone o la comparsa di immagini residue di colore - le cosiddette immagini residue), che hanno stimolato la creazione di teorie alternative. Nel 19 ° secolo Il fisiologo tedesco E. Hering ha avanzato la teoria dei colori avversari, secondo la quale la percezione del colore si basa sull'antagonismo di alcuni colori: proprio come il bianco (composto da tutti i colori) è opposto al nero (l'assenza di colore), così il giallo è al blu e il rosso al verde. Negli ultimi decenni, quando è diventato possibile registrare l'attività dei singoli neuroni ed è stato possibile identificare i meccanismi inibitori nell'attività dei sistemi neurosensoriali, è diventato chiaro che questa teoria nel suo insieme descrive adeguatamente la funzione delle cellule gangliari e altro ancora. livelli alti sistema visivo. Pertanto, le teorie di Helmholtz e Hering, che per molto tempo erano considerati reciprocamente esclusivi, entrambi si sono rivelati fondamentalmente equi e si completano a vicenda se li consideriamo come una descrizione di diversi livelli di percezione del colore. Il daltonismo è spesso ereditario e viene solitamente trasmesso come carattere recessivo legato all'X. Si tratta di un difetto visivo molto comune: colpisce il 4-8% degli uomini e lo 0,4% delle donne nelle popolazioni europee. In molti casi il daltonismo si esprime solo con lievi deviazioni nella percezione del rosso e del verde; viene mantenuta la possibilità di selezionare tutti i colori miscelando opportunamente i tre colori primari. Questa forma di daltonismo è definita come visione tricromatica anormale. Un'altra forma di questa è la visione dicromatica: le persone con questa anomalia selezionano tutti i colori mescolando solo due colori primari. Molto spesso si verifica una violazione della percezione dei colori rosso e verde (il cosiddetto daltonismo), ma a volte - giallo e blu. La terza forma, estremamente rara, è la visione monocromatica, cioè completa incapacità di distinguere i colori. Molti animali non hanno una visione dei colori o la esprimono debolmente, mentre alcuni rettili, uccelli, pesci e mammiferi hanno una visione dei colori più o meno buona. Acuità visiva e cecità pratica. Per valutare lo stato della vista vengono utilizzati tre indicatori: acuità visiva, campo visivo e qualità della visione dei colori. L'acuità visiva è la capacità di distinguere i dettagli e la forma. Uno dei modi per valutarlo è il seguente: il soggetto deve, da una distanza prestabilita, determinare lo spazio minimo richiesto tra due linee parallele in cui non si fondono visivamente. In pratica, questo divario non viene misurato in pollici o millimetri, ma in “angolo di visione”, formato dai raggi provenienti da due linee parallele che convergono in un punto all'interno dell'occhio. Più piccolo è l'angolo, più nitida è la visione. Con una visione normale, l'angolo minimo è 1 minuto d'arco o 1/60 di grado. Questo valore è alla base della nota tabella alfabetica per testare l'acuità visiva. Ogni lettera della tabella corrisponde a 5 minuti d'arco se determinata da una distanza specifica, mentre lo spessore delle linee delle lettere è 1/5 della dimensione della lettera, cioè 1 minuto d'arco. Una lettera in una riga di tabella contrassegnata da 60 metri ha dimensioni che consentono a una persona con una vista normale di identificarla da una distanza di 60 metri; allo stesso modo, una lettera su una linea di 6 metri può essere identificata da una distanza di 6 metri con una vista normale. Il grado di acutezza visiva si calcola correlando la distanza dalla quale si effettua il test (numero del numeratore) con la distanza indicata per le lettere più piccole correttamente leggibili (numero del denominatore). La distanza standard per il test è di 6 metri. Se da questa distanza il soggetto legge correttamente le lettere di una linea di 6 metri, ha un'acuità visiva normale. Se da una distanza di 6 metri legge solo lettere che normalmente sono visibili da 24 metri, la sua acutezza visiva è 6/24. Il campo visivo è la capacità di ciascun occhio di percepire gli oggetti ai bordi dell'area visibile. Nel valutare questo indicatore, la dimensione, il colore e la posizione degli oggetti vengono presi in considerazione sia in gradi che nella direzione dal punto di vista centrale. La visione dei colori viene solitamente messa alla prova dalla capacità di distinguere tra rosso, verde e blu. Il concetto di cecità pratica serve a determinare la disabilità, valutando l'acuità visiva e il campo visivo; a volte viene presa in considerazione una combinazione di acuità visiva insufficiente e campo visivo ristretto.


Enciclopedia di Collier. - Società aperta. 2000 .
La natura ha dato all'uomo non solo la capacità di vedere chiaramente durante il giorno e di distinguere bene i colori. L'occhio umano è adattato anche alla visione crepuscolare. Lo sanno bene gli appassionati di caccia notturna, i turisti esperti, il personale militare e gli ufficiali dell'intelligence. Esistono tecniche speciali che possono migliorare la visione al buio, anche senza dispositivi per la visione notturna. Tuttavia, in alcune malattie degli occhi, al buio non è visibile nulla. Le caratteristiche della visione notturna e le loro anomalie saranno prese in considerazione da MedAboutMe.
Struttura della retina
La retina è composta da dieci strati di cellule. Quasi nella parte più esterna si trovano celle speciali capace di percepire il colore e la luce. Questi sono i fotorecettori: coni e bastoncelli. Differiscono per struttura e funzioni.
I primi sono responsabili della visione alla luce del giorno e della percezione dei colori. La maggior parte dei coni si trova nella parte centrale del fondo. E il luogo della migliore visione - la fovea centrale della retina - è costituito solo da loro. Quando è necessario considerare tutti i dettagli, una persona pone l'oggetto direttamente davanti agli occhi. In questo caso, il cervello riceve un'immagine a colori chiara formata nella fovea centrale della retina.
I bastoncelli sono responsabili della visione al buio e percepiscono bene il movimento. Questi fotorecettori sono raggruppati alla periferia del fondo. I bastoncini sono meno fitti dei coni. Ciò porta ad un minore potere risolutivo della retina al buio e quindi ad una visione peggiore.
I bastoncelli possono formare solo un'immagine in bianco e nero, ma hanno un'elevata fotosensibilità. Queste cellule sono quasi 100 volte più sensibili alla luce rispetto ai coni.
Cellule speciali della retina
“Nel corso dell’evoluzione, la retina di molti esseri viventi ha raggiunto il limite della sensibilità. Percepisce una quantità trascurabile di luce: un fotone. E questo è molto importante di notte, quando l’illuminazione viene misurata solo in pochi fotoni”, afferma Greg Field, professore associato di neurobiologia e ingegneria medica alla Duke University negli Stati Uniti.
Lo ha scoperto lo stesso gruppo di ricercatori caratteristiche interessanti cellule situate nello strato più interno della retina. Alcuni di loro percepiscono il movimento in una certa direzione. Quindi, ci sono cellule responsabili della cattura del movimento diretto verso il basso, a destra e così via.
Al buio, le cellule che rispondono al movimento verso l’alto cambiano il loro “comportamento”. Si attivano quando ci si muove in qualsiasi direzione. Motivo esatto questo fenomeno è ancora sconosciuto. Greg Field suggerisce che ciò è particolarmente necessario per quegli animali che potrebbero diventare vittime dei predatori. L'attività costante di tali neuroni consente di cogliere in tempo il suo salto nell'oscurità. Nell'uomo ci sono poche cellule di questo tipo, solo circa il 4%, ma nei roditori la loro quota raggiunge il 20-30%.
Meccanismo di percezione della luce

Una volta dentro l'occhio, il flusso luminoso viene focalizzato dalla cornea e dal cristallino in un punto della retina. Poi la luce attraversa tutti i suoi strati e solo nella parte esterna incontra i fotorecettori.
Il processo principale di percezione della luce avviene nel segmento esterno dei bastoncelli e dei coni. È una pila di dischi. Ogni disco è costituito da pigmento visivo circondato da una membrana. Nei bastoncelli è la rodopsina, nei coni è la iodopsina. La rodopsina è costituita dalla retina (una forma speciale di vitamina A) e dalla proteina opsina.
Il pigmento visivo è una sostanza speciale che può cambiare la sua struttura se esposta alla luce. Ciò innesca una serie di trasformazioni chimiche e porta alla formazione di un potenziale elettrico. Questo impulso viene trasmesso lungo il nervo ottico al cervello. Qui l'immagine si forma e si riconosce.
Quando si verifica un cambiamento improvviso dei livelli di luce, l’occhio non si adatta immediatamente alle nuove condizioni. Il processo di adattamento alla luce intensa è chiamato adattamento alla luce, mentre alla luce scarsa è chiamato adattamento all'oscurità. Esistere dispositivi speciali per registrare la sensibilità alla luce durante l'adattamento al buio. Si chiamano adattometri.
L'occhio si adatta rapidamente alla luce, bastano 1-3 minuti. Ma l’adattamento oscuro dura diverse ore. Pertanto per buona visione di notte dovresti aspettare almeno un'ora. In questo caso, dovresti evitare qualsiasi luce intensa, inclusa una torcia. Ciò consentirà all'occhio di adattarsi il più possibile alla scarsa illuminazione.
Si può uccidere con uno sguardo?
È interessante notare che l'occhio non solo può percepire le informazioni, ma anche influenzare il mondo che lo circonda. Così, nel 2003, un cacciatore canadese si ritrovò solo con un orso grizzly affamato. La pistola era fuori portata, la bestia era molto vicina. Per disperazione, il cacciatore, secondo lui, iniziò a guardarlo attentamente negli occhi. L'orso, contrariamente al solito, non distolse lo sguardo. Nessuno sa quanto durò questa scena, ma alla fine il predatore cadde morto. Dopo il racconto del cacciatore, l'animale è stato ritrovato ed è stata eseguita l'autopsia. Si è scoperto che è morto per un'emorragia cerebrale.
Ragioni per un ridotto adattamento al buio

I reclami di scarsa visione al buio possono essere causati da diversi motivi.
- Errori di rifrazione.
La vista della maggior parte delle persone non è perfetta. Una leggera miopia è particolarmente comune e l'astigmatismo è meno comune. E alcune persone non se ne rendono nemmeno conto. In condizioni di scarsa illuminazione, la pupilla si dilata e nell'occhio entrano molti più raggi obliqui. Gli errori di rifrazione esistenti impediscono loro di mettere a fuoco la retina e l'immagine risulta sfocata. Un uomo lamenta una scarsa visione al buio.
Questo fenomeno può essere paragonato all'effetto dei bicchieri bucati. Le loro aperture sono più strette della pupilla alla luce del giorno. Ciò conferisce una maggiore acuità visiva con gli occhiali. Pertanto, con una pupilla stretta puoi vedere meglio durante il giorno che con pupilla ampia di notte.
- Malattie degli occhi.
Esiste una sola malattia oftalmica che a lungo Questo è l'unico segno che appare. Questa è la retinite pigmentosa, nota anche come retinite pigmentosa.
Una scarsa visione notturna può accompagnare altre malattie. Ad esempio, infiammazione del nervo ottico, sua atrofia, infiammazione della retina con la parte adiacente della coroide, intraoculare corpo estraneo. Ma in questo caso ci saranno sicuramente altri segnali che indicano un problema. Ad esempio, ipovisione durante il giorno, scarsa discriminazione dei colori, lieve infiammazione dell'occhio.
- Mancanza di vitamina A nella dieta.
Da esso viene costruita la parte più importante del pigmento visivo rodopsina. Pertanto esso apporto insufficiente con il cibo porta a disturbi della visione notturna. L'ipovitaminosi è segnalata anche dalla desquamazione della pelle, dalla secchezza e dai capelli fragili, striatura trasversale unghia, congiuntivite frequente o stomatite.
Retinite pigmentosa
La causa della malattia non è conosciuta con precisione. Tuttavia, la maggior parte dei ricercatori lo associa a mutazioni nei geni che codificano per la rodopsina. La malattia è ereditaria.
L'essenza della malattia è la morte dei fotorecettori. Di solito vengono colpiti per primi i bastoncelli, ma esistono varianti della distrofia mista bastoncelli-cono. Di norma, il processo inizia dalla periferia del fondo. Lo strato più esterno della retina, l'epitelio pigmentato, è in stretto contatto con i bastoncelli e i coni. È responsabile del ripristino dei fotorecettori dopo l'assorbimento della luce e il loro fotoisolamento gli uni dagli altri.
Anche la struttura dell'epitelio pigmentato cambia. Le singole cellule si spostano negli strati interni della retina. Ciò rende molto difficile il funzionamento dei restanti fotorecettori.
La malattia si manifesta abbastanza presto. Nel 95% circa dei casi viene diagnosticata prima dei 30 anni. Il primo segno è una diminuzione della vista al buio. Molti pazienti non possono tollerare e luce luminosa. Quindi compaiono difetti del campo visivo. Un difetto tipico è la forma di un ampio anello, che lascia libero solo il centro e l'estrema periferia del campo visivo.
Il restringimento del campo visivo peggiora drasticamente l'orientamento nello spazio. Ma l'acuità visiva rimane elevata per molto tempo. La malattia progredisce gradualmente, portando alla completa cecità.
Metodi moderni di trattamento della malattia

Non esistono metodi efficaci per combattere la malattia. I metodi di terapia genica vengono sviluppati attivamente. La sua essenza è l'introduzione di virus modificati nella cavità oculare. Portano i geni “corretti” per le cellule fotorecettrici. I virus sono integrati nel genoma dei bastoncelli. Li ripristina lavoro normale. Questa procedura è stata eseguita per la prima volta in America nel marzo 2018. Il primo paziente era un ragazzo di tredici anni di nome Jack Hogan.
Tuttavia, la terapia genica è ancora in corso test clinici e non è ancora entrato nella pratica clinica. Inoltre, l'uso di cellule staminali e grandi dosi vitamina A.
Negli Stati Uniti, nel 2011, è stata sviluppata una speciale protesi retinica, Argus, per il trattamento di pazienti affetti da retinite pigmentosa. Viene installato chirurgicamente sul fondo. Il metodo viene utilizzato solo nelle fasi successive della malattia.
Naturalmente il dispositivo non fornisce una visione completa. Tuttavia, tutti i pazienti con protesi hanno notato miglioramenti nel riconoscimento degli oggetti e nella percezione degli oggetti in movimento. Attualmente Argus è installato in cliniche in Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia.
Pertanto, la visione al buio può essere notevolmente ridotta ragioni varie. Puoi iniziare andando dall'ottico più vicino per identificare gli errori di rifrazione. Se la loro correzione non produce risultati, è necessario sottoporsi ad un esame approfondito da parte di un oftalmologo competente.
Foto utilizzate da Shutterstock
Elena Steshenko, oculista
L'organo della vista è costituito dal bulbo oculare e dall'apparato ausiliario dell'occhio.
Bulbo oculare situato nell'orbita, che è formata dalle ossa del midollo e cranio facciale. Ha l'aspetto di un corpo sferico, più convesso davanti. Si distinguono i poli anteriore e posteriore. Il polo anteriore corrisponde al centro della cornea, cioè alla sua parte più convessa, il polo posteriore si trova leggermente lateralmente all'ingresso del nervo ottico nel bulbo oculare. Una linea retta che passa per i poli anteriore e posteriore è chiamata asse visivo dell'occhio. Questo asse, ad angolo acuto, interseca la linea retta che collega il centro della cornea con il luogo di migliore visione, che si trova nella zona della cosiddetta macula, situata nella parte inferiore del bulbo oculare. Il bulbo oculare ha membrane e mezzi oculari che rifrangono la luce. La membrana esterna è chiamata fibrosa, quella centrale è vascolare e quella interna è sensibile.
membrana fibrosa, a sua volta, è divisa in due sezioni: la posteriore, più grande, della tunica albuginea, o sclera, e
anteriore, più piccolo - cornea, o la cornea dell'occhio.
La coroide si trova dietro la membrana fibrosa del bulbo oculare. È consuetudine distinguere tre parti nella coroide: quella posteriore è la coroide stessa, quella centrale è il corpo ciliare e quella anteriore è l'iride.
Nello spessore del corpo ciliare è presente il muscolo ciliare. È costituito da fasci di fibre muscolari lisce che si trovano in tre direzioni: circolare, radiale e meridionale. Le fibre meridiane costituiscono la maggior parte del muscolo ciliare. Quando è teso, questo muscolo rilassa il legamento e, attraverso di esso, la capsula del cristallino, che, a causa della sua proprietà elastiche Allo stesso tempo, diventa più convesso, il che è necessario quando è necessario vedere oggetti a distanza ravvicinata. Quando il muscolo si rilassa, il corpo ciliare ritorna nella sua posizione originale, i legamenti ciliari si stringono e il cristallino diventa più piatto. IN vecchiaia l'elasticità del legamento e l'elasticità del cristallino diminuiscono, il che porta a disturbi della vista.
L'iride, cioè la parte anteriore della coroide, ha l'aspetto di un disco rotondo posizionato frontalmente con un foro al centro: la pupilla. È costruito da fibre muscolari in direzione circolare e radiale. Le fibre circolari costituiscono il muscolo costrittore pupillare (sfintere) e le fibre radiali costituiscono il muscolo dilatatore pupillare (dilatatore). L'iride funge da diaframma ottico situato all'interno del bulbo oculare. Sull'iride sono presenti:
superfici anteriori e posteriori. La superficie anteriore è chiaramente visibile attraverso la cornea. Ha un pigmento, la cui natura e quantità determina il colore degli occhi: quanto più ce n'è, più scuro sarà il colore degli occhi.
 La membrana sensibile (interna) del bulbo oculare è la retina, che si sviluppa come una conseguenza della sostanza del diencefalo e, nella sua origine, struttura e funzione, è solidale al nervo ottico. Secondo le tre parti della coroide, la retina adiacente è divisa nelle parti ottica, ciliare e dell'iride. La parte visiva si distingue per la massima complessità della sua struttura, in cui al microscopio si possono distinguere fino a una dozzina di strati. Uno degli strati contiene cellule visive a forma di bastoncello e di cono (bastoncelli e coni). I bastoncelli percepiscono la stimolazione della luce e i coni forniscono la capacità di distinguere i colori e le loro sfumature. I bastoncelli della retina presentano il cosiddetto viola visivo, o rodopsina, prodotto dalle cellule dello strato pigmentato. Alla luce il viola visivo si decompone, mentre al buio si riforma, conferendo all'intera retina un colore rosato.
La membrana sensibile (interna) del bulbo oculare è la retina, che si sviluppa come una conseguenza della sostanza del diencefalo e, nella sua origine, struttura e funzione, è solidale al nervo ottico. Secondo le tre parti della coroide, la retina adiacente è divisa nelle parti ottica, ciliare e dell'iride. La parte visiva si distingue per la massima complessità della sua struttura, in cui al microscopio si possono distinguere fino a una dozzina di strati. Uno degli strati contiene cellule visive a forma di bastoncello e di cono (bastoncelli e coni). I bastoncelli percepiscono la stimolazione della luce e i coni forniscono la capacità di distinguere i colori e le loro sfumature. I bastoncelli della retina presentano il cosiddetto viola visivo, o rodopsina, prodotto dalle cellule dello strato pigmentato. Alla luce il viola visivo si decompone, mentre al buio si riforma, conferendo all'intera retina un colore rosato.
Struttura della retina: /, //, /// - primo, secondo e terzo neurone della retina; / - strato di pigmento; 2 - strato di bastoncelli e coni; 3 - membrana del bordo esterno; 4 - strato granulare esterno; 5 - strato intergranulare esterno; 6 - strato granulare interno; 7 - strato intergranulare interno; 8 - cellule gangliari; 9 - fibre del nervo ottico; 10 - membrana del bordo interno.
Lo strato esterno della retina rivolto verso la coroide| bulbo oculare, contiene pigmento ed è un epitelio pigmentato collegato alla coroide molto più saldamente che ad essa strati interni la retina stessa, rivolta verso la cavità del bulbo oculare. Nella parte visiva della retina ci sono due luoghi che differiscono per struttura e caratteristiche funzionali: il capezzolo del nervo ottico e la macula. Il capezzolo ottico è il punto in cui il nervo entra nel bulbo oculare. Ha un diametro di circa 1,7 mm e si trova medialmente rispetto alla posizione dell'asse ottico del bulbo oculare. Macchia gialla (così chiamata perché ha colore giallastro) è il luogo della migliore visione. Il suo diametro è di circa 1 mm. Al centro della macchia c'è la fovea centrale, il luogo di massima sensibilità della retina alla stimolazione luminosa. Il capezzolo del nervo ottico, invece, che non ha né bastoncelli né coni, non percepisce la stimolazione luminosa ed è una sorta di punto cieco della retina, mentre le restanti due parti della retina, ciliare e iride, sono costruite in modo relativamente semplice. La parte dell'iride è costituita dall'epitelio pigmentato, di cui abbiamo già parlato, e la parte ciliare è costituita da due strati di cellule epiteliali (lo strato esterno è l'epitelio pigmentato).
Il bulbo oculare ha i seguenti mezzi trasparenti (rifrattivi): la cornea, il fluido delle camere anteriore e posteriore del bulbo oculare, il cristallino e il corpo vitreo. I raggi che entrano nell'occhio vengono rifratti e formano un'immagine inversa e ridotta sulla retina.
La camera anteriore del bulbo oculare è lo spazio tra la superficie posteriore della cornea, la superficie anteriore dell'iride e in parte la superficie anteriore del cristallino. Lo spazio tra la superficie posteriore dell'iride e la superficie anteriore del legamento ciliare, nonché in parte la superficie anteriore del cristallino, è chiamato camera posteriore del bulbo oculare. Entrambe le camere sono riempite con un liquido limpido, prodotto dai vasi sanguigni, presente in grandi quantità nei processi ciliari. Il liquido della camera anteriore, insieme alla cornea dell'occhio, forma una lente biconvessa di circa 30 diottrie, costituisce cioè un mezzo rifrangente per il passaggio dei raggi luminosi.
Il mezzo di rifrazione della luce più importante è la lente. È costituito da fibre di forma esagonale che corrono lungo i meridiani. La lente è racchiusa in una capsula trasparente. Lungo il bordo del cristallino è attaccato alla cintura ciliare, costituita da fibre che vanno al corpo ciliare. In apparenza, l'obiettivo è paragonato a lente biconvessa. La superficie anteriore della lente ha una convessità minore di quella posteriore. La sua dimensione anteroposteriore è di 3,7 mm. Quando la contrazione del muscolo ciliare riduce la tensione della capsula trasparente del cristallino, essa, grazie alle sue proprietà elastiche, diventa più convessa e la sua dimensione anteroposteriore può raggiungere 4,4 mm. Quando si guardano oggetti distanti, il cristallino si appiattisce, mentre quando si guardano oggetti vicini diventa più spesso. L'adattamento dell'occhio alla migliore visione a distanza ravvicinata e lontana è chiamato accomodamento. Negli animali che vivono nell'acqua, il cristallino ha una forma sferica , e le sue proprietà di rifrazione della luce sono più elevate che negli animali terrestri. Una persona nell'acqua non vede i contorni degli oggetti abbastanza chiaramente. Ciò è dovuto al fatto che le proprietà di rifrazione della luce dei mezzi trasparenti del suo occhio sono molto vicine alla proprietà di rifrazione della luce dell'acqua: quando i raggi passano dall'acqua direttamente all'occhio, la loro rifrazione risulta insignificante e il punto di intersezione non è già sulla retina, come al solito, ma dietro di essa.
L'intera cavità del bulbo oculare dietro il cristallino e il legamento ciliare è occupata dal corpo vitreo, che è adiacente alla retina. Davanti ha una depressione corrispondente alla forma della superficie posteriore della lente. Il corpo vitreo è una sostanza gelatinosa trasparente ricoperta guscio trasparente e costituito da sottili fibre di tessuto connettivo, proteine e acido ialuronico.
 Dispositivi ausiliari dell'occhio. A Gli organi ausiliari dell'occhio comprendono i muscoli, le palpebre, la congiuntiva e l'apparato lacrimale.
Dispositivi ausiliari dell'occhio. A Gli organi ausiliari dell'occhio comprendono i muscoli, le palpebre, la congiuntiva e l'apparato lacrimale.
1 - m., sollevando la palpebra superiore; 2 - bulbo oculare; 3 - bloccare; 4 - lago di lacrime; 5 - sacco lacrimale; 6 - dotto nasolacrimale; 7 - parete della cavità nasale; 8 - palpebra inferiore; 9 - ghiandole della cartilagine palpebrale; 10 - m. obliquo inferiore; 11 - tessuto adiposo; 12 - parete inferiore dell'orbita; 13 - retta inferiore; 14 - canalicoli escretori della ghiandola lacrimale; 15 - m. rettilineo laterale; 16 - retta superiore; 17 - ghiandola lacrimale; 18 - obliquo superiore m.
Il bulbo oculare è mosso da 6 muscoli: 4 muscoli retti e 2 muscoli obliqui. I muscoli si distinguono: retto superiore, inferiore, mediale e laterale e obliquo superiore e inferiore. Tutti questi muscoli sono costruiti da striati tessuto muscolare. Partono dall'anello del tendine comune, che si trova in profondità nell'orbita e copre il nervo ottico. L'unica eccezione è il muscolo obliquo inferiore più corto, che parte direttamente dal periostio della parete inferiore dell'orbita e arriva al bulbo oculare. I muscoli retti del bulbo oculare vanno anteriormente e sono attaccati nella regione del suo equatore, un po' davanti ad esso, crescendo fino alla membrana fibrosa del bulbo oculare. Il muscolo obliquo superiore corre lungo il bordo superomediale dell'orbita ed è portato da un tendine attraverso un'ansa fibrosa attaccata all'osso frontale. Dall'ansa, questo tendine corre ad angolo acuto verso l'esterno e aderisce alla membrana fibrosa del bulbo oculare dall'alto e un po' lateralmente dal suo piano mediano.
La funzione dei muscoli del bulbo oculare è che i muscoli obliqui lo ruotano attorno all'asse antero-posteriore, i muscoli retto mediale e laterale attorno all'asse verticale e i muscoli retto superiore e inferiore attorno all'asse trasversale. Pertanto, il bulbo oculare ha la capacità di ruotare attorno a tre assi reciprocamente perpendicolari. In pratica, grazie all'azione congiunta dei singoli muscoli, può ruotare attorno a qualsiasi asse passante per il suo centro. Quando si osservano oggetti distanti, gli assi ottici degli occhi sono più paralleli e si intersecano mentre continuano con un angolo più acuto rispetto a quando si osservano oggetti vicini.
L'intero bulbo oculare, insieme ai muscoli, si trova all'interno della cavità orbitale ed è circondato da tessuto adiposo. Le pareti dell'orbita sono rivestite di periostio. Fibra grassa separato dal bulbo oculare da uno strato di tessuto connettivo, chiamato guaina del bulbo oculare. Tra la vagina e lo strato fibroso della parete del bulbo oculare si trova uno spazio a forma di fessura, che ricorda la cavità di un'articolazione sferica. Tuttavia V A differenza delle cavità articolari, presenta cordoni sottili che collegano la fascia del bulbo oculare con la sua parete. I muscoli, avvicinandosi al bulbo oculare, attraversano questa fascia con i loro tendini.
Le palpebre sono strutture che proteggono il bulbo oculare dalla parte anteriore. Ci sono palpebre superiori e inferiori. La palpebra superiore è più grande di quella inferiore ed è molto più mobile grazie all'azione del muscolo che solleva la palpebra superiore, che è attaccato alla sua cartilagine. Le ciglia crescono lungo i bordi delle palpebre. Tra i bordi liberi delle palpebre superiore e inferiore è presente una fessura palpebrale. Il suo angolo esterno è affilato e quello interno è arrotondato e forma il cosiddetto lago lacrimale. All'interno di questo angolo c'è una piccola elevazione rosata: la caruncola lacrimale, contenente il tessuto adiposo e ghiandole sebacee. Lo scheletro di ciascuna palpebra è la cartilagine palpebrale. Le palpebre sono dotate di ghiandole cartilaginee e di ghiandole sebacee, la cui secrezione lubrifica i bordi secolo e ciglia. Appena sotto la pelle sulle palpebre c'è un muscolo che fa parte del muscolo orbicolare dell'occhio. È un antagonista del muscolo che solleva la palpebra superiore.
La congiuntiva è il rivestimento della mucosa superficie interna palpebra e parte del bulbo oculare. Il luogo in cui la congiuntiva passa dalle palpebre al bulbo oculare è chiamato fornice. Ci sono fornici superiori e inferiori della congiuntiva.
L'apparato lacrimale comprende la ghiandola lacrimale e il sistema dei dotti lacrimali. Si trova la ghiandola lacrimale V laterale angolo superiore orbite. Appartiene alle ghiandole tubolari alveolari e possiede da 5 a 12 canalicoli escretori, che si aprono nella zona del fornice superiore della congiuntiva, nella sua sezione esterna. La ghiandola lacrimale produce una secrezione che idrata il bulbo oculare quando le palpebre si chiudono.
Le lacrime scorrono lungo i dotti lacrimali verso l'angolo mediale dell'occhio. Quando le palpebre sono chiuse, tra loro si forma uno spazio di forma triangolare lungo la linea di chiusura, chiamato flusso lacrimale, attraverso il quale le lacrime cadono nel lago lacrimale e da lì nei canalicoli lacrimali. I canalicoli lacrimali superiore e inferiore decorrono medialmente e convergono, formando un'estensione: il sacco lacrimale, circondato da tessuto fibroso e aderisce all'osso lacrimale. La parte lacrimale del muscolo orbicolare dell'occhio è attaccata alla parete del sacco lacrimale che, una volta contratta, può espandere il sacco lacrimale e quindi facilitare l'aspirazione delle lacrime accumulate nei canalicoli lacrimali. Il sacco lacrimale prosegue verso il basso sotto forma di dotto nasolacrimale, che penetra nell'osso dotto nasolacrimale, aprendosi narice sotto la conca nasale inferiore.
L'afflusso di sangue alla retina e al nervo ottico viene effettuato dall'arteria retinica centrale, che entra nel bulbo oculare nello spessore del nervo ottico ed è un ramo dell'arteria oftalmica (un ramo dell'arteria carotide interna). Insieme a arteria centrale passa attraverso la vena centrale della retina.
All'equatore sono presenti 4 vene vorticose, che sboccano nelle vene oftalmiche, le quali confluiscono nel seno cavernoso.
L'innervazione del bulbo oculare (oltre al nervo ottico) è effettuata da rami appartenenti al sistema nervoso trigemino e dai rami del ganglio ciliare associato. Si è già discusso dell'innervazione della muscolatura liscia del bulbo oculare e dei muscoli estrinseci, costituiti da tessuto muscolare striato.
Il flusso delle informazioni visive. I raggi luminosi, passando attraverso i mezzi trasparenti e rifrangenti della luce del bulbo oculare, entrano nella retina, dove vengono percepiti dai suoi bastoncelli e coni. Le informazioni visive arrivano alle cellule bipolari, che trasmettono gli impulsi alle cellule gangliari della retina, che sono più grandi e hanno una sostanza tigroide ben definita nel citoplasma. I neuriti di queste cellule formano fasci di fibre che compongono il nervo ottico, il conduttore dell'analizzatore visivo. Dall'orbita, il nervo ottico passa attraverso il canale omonimo nel cranio, dove, alla base del cervello, nella zona della sella turcica, forma un chiasma incompleto, proseguendo nel tratto ottico. Le fibre del tratto ottico vanno al talamo visivo, dove si trova il terzo neurone del percorso, e poi alla parte centrale dell'analizzatore - al centro visivo della corteccia grande cervello, situato nel lobo occipitale lungo i bordi della barba dello sperone. Alcune fibre passano al corpo genicolato laterale e al collicolo superiore del quadrigemino. Grazie alla connessione di quest'ultimo con i nervi cranici e con quelli autonomi sistema nervosoÈ possibile regolare automaticamente la dimensione della pupilla e fissare gli occhi sull'oggetto in questione.